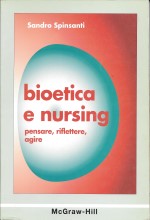
Sandro Spinsanti
BIOETICA E NURSING
Pensare, riflettere, agire
Presentazione di Annalisa Silvestro, Presidente Federazione Nazionale Collegi IPASVI
McGraw-Hill, Milano 2001
pp. 303
V
INDICE
pg
IX Presentazione
X Al lettore: "Che roba è diventare etico?"
Prima parte
1 ORIZZONTI DELLA BIOETICA
Capitolo 1
3 La biosfera
3 Quella sottile pellicola che copre la Terra...
7 Il potere sulla vita
12 Riscrivere le regole etiche
Capitolo 2
21 I sistemi sociali e sanitari
21 "Salute per tutti": utopia o politica?
27 La pressione dell'economia sui modelli sanitari
32 L'evoluzione del sistema sanitario in Italia
37 La valutazione etica dei sistemi sanitari
Capitolo 3
43 La medicina
43 A che cosa serve la medicina?
48 Cambiamenti di scenario: la medicina predittiva
51 Verso una medicina della persona
60 Il gioco delle libertà in medicina
72 Parole nuove per comportamenti nuovi
Seconda parie
83 LA TRAMA DELLE NORME
Capitolo 4
85 Le leggi
86 È adatta la legge a regolare il rapporto tra sanitario e paziente?
89 L'agenda del legislatore italiano
91 Un quadro europeo per la bioetica
Capitolo 5
95 La deontologia professionale
95 Significato e funzione del codice deontologico
97 Rapporto tra legge, deontologia, etica
99 Il codice deontologico degli infermieri
VI
Capitolo 6
103 L'etica
103 L'etica vissuta e l'etica come disciplina
104 I grandi orientamenti di fondo
109 Stagioni dell'etica in medicina
Capitolo 7
119 L'etica clinica
119 La ricerca di un metodo per la bioetica clinica
121 Una griglia per l'analisi di situazioni cliniche
Capitolo 8
127 La formazione in etica
127 L'etica come educazione dello sguardo
128 L'etica nella clinica: la figura e lo sfondo
131 Comitato di etica ed educazione al dialogo
Terza parte
135 PROBLEMI DI BIOETICA CLINICA
Capitolo 9
139 Il controllo della procreazione
139 L'orizzonte culturale delle nuove pratiche procreative
141 Controllo sociale e regolazione del desiderio procreativo
143 Per una pedagogia del giudizio etico
Capitolo 10
147 Gli inizi della vita
147 Nascere meglio
149 Un buon luogo per nascere
152 La responsabilità verso la vita non nata
156 Diagnosi prenatale e aborto terapeutico
157 Curare o non curare i neonati malformati?
Capitolo 11
161 Sessualità e terapia
161 L'identità sessuale: problemi antropologici
163 È lecito cambiare sesso?
164 Terapia farmacologica dell'impotenza
165 Le mutilazioni genitali femminili
Capitolo 12
169 AIDS e sieropositività
169 Le invasioni di campo della religione
171 Una malattia "demonizzata"
172 La sessualità al tempo dell'AIDS
175 Il segreto professionale sotto pressione
VII
Capitolo 13
179 Donazione di organi e trapianti
179 La marcia trionfale della medicina dei trapianti
181 La società si interroga
182 La cultura del dono
185 Deontologia ed etica a tutela dei trapianti
Capitolo 14
187 Terapia e assistenza ai malati oncologici
187 La dimensione etica
188 Etica e culture locali
191 Che cosa si può imparare vivendo con il cancro
Capitolo 15
195 Prevenzione e screening di massa
195 "Per il bene del paziente"?
196 Anche la prevenzione sotto il segno dell'autonomia
198 L'empowerment del cittadino nei confronti della prevenzione
Capitolo 16
201 Ospedale o domicilio?
201 Quando i sanitari giocano in trasferta...
204 Esigenze etiche delle cure a domicilio
207 Un codice deontologico per le cure domiciliari
Capitolo 17
211 La comunicazione della diagnosi
211 Parlare? Tacere? Mentire?
212 Il ruolo della famiglia nelle decisioni cliniche
Capitolo 18
219 Trattamento delle malattie mentali
219 Un dilemma etico
220 La psichiatria è al servizio della repressione?
221 Controllo del comportamento e consenso
223 Alcune terapie psichiatriche
225 Uso e abuso di farmaci e droghe
225 Bioetica e paradigmi della malattia mentale
Capitolo 19
229 La terapia del dolore
230 Uno scandaloso ritardo italiano
233 Le ragioni culturali
235 Le responsabilità dell'etica medica
236 Il nursing del dolore
Capitolo 20
239 Le cure palliative
239 Quando la medicina si fa materna
VIII
240 Medicina, non ars moriendi
241 Quando la comunicazione è il problema
244 Nella casa della parola c'è più della parola
Capitolo 21
247 La fine della vita
247 Il confine tra la vita e la morte
249 Il prolungamento medico della vita
251 Quando l'eutanasia è un programma politico
254 La volontà di morire
256 Scegliere un modello di morte
Capitolo 22
261 Ricerca e terapie sperimentali
261 Nuove regole per la ricerca
263 Il consenso del soggetto alla sperimentazione
265 Il controllo sociale
268 La ricerca con i bambini
Quarta parte
271 LE RISORSE PER LO STUDIO DELLA BIOETICA
Capitolo 23
275 I comitati nazionali per la bioetica
Capitolo 24
281 I centri di bioetica in Italia
281 Istituto di bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
282 Fondazione Lanza
283 Centro internazionale studi famiglia
284 Politeia
284 Società italiana di bioetica
285 Istituto italiano di bioetica
286 Istituto Giano
287 Consulta di bioetica
Capitolo 25
289 Corsi, scuole, diplomi
Capitolo 26
293 Enciclopedie e manuali di bioetica
Capitolo 27
297 Riviste di bioetica
301 Bibliografia
IX
PRESENTAZIONE
La lettura del libro di Sandro Spinsanti, agevole ma, al contempo, ricca di spunti e citazioni, induce a profonde riflessioni.
La bioetica ― disciplina dalle radici antiche eppure protagonista di un continuo rinnovamento ― tende a diventare il punto di riferimento e di orientamento nella quotidianità non solo come persone ma anche come infermieri.
Sandro Spinsanti affronta ― con maestria e semplicità ― un argomento difficile, a volte percepito come troppo "teorico" e quindi estraneo alla nostra vita di tutti i giorni e ci mostra come esso debba invece permeare ogni nostra azione.
Una prima sezione del volume ci introduce ai concetti di etica e bioetica; il linguaggio è semplice e lineare ma non mancano i riferimenti a personaggi cinematografici e a studiosi: dal celebre Dott. Tersilli di Alberto Sordi al compianto storico della medicina Mirko Grmek. Ognuno può trovarvi spunti di riflessione a seconda del proprio percorso culturale e personale, senza mai sentirsi "estraneo" a ciò che sta leggendo.
Procedendo lungo un cammino che dal generale scende progressivamente nello specifico l'autore arriva a considerare i problemi legati alla bioetica clinica. Sono qui trattati temi importanti, che ogni infermiere si trova prima o poi ad affrontare quali, ad esempio, l'assistenza ai malati di AIDS, la donazione di organi e i trapianti, la comunicazione della diagnosi, l'assistenza ai malati mentali o terminali. L'utilizzo di casi clinici, come situazioni esemplari per affrontare quella specifica tematica, testimonia l'intento dell'autore di fornire aderenze pratiche a un tema che, come si è già detto, tende a essere considerato spesso solo come "teoria".
Un'ultima sezione fornisce, alla fine del percorso di lettura, gli strumenti tecnici per accedere a tutte le risorse attualmente disponibili per lo studio della bioetica in Italia.
In conclusione, suggerirei Bioetica e nursing come un libro che tutti gli infermieri dovrebbero leggere, per allenare la loro capacità di pensare, per acquisire la capacità di riflettere e per improntare di conseguenza il loro agire.
Annalisa Silvestro
X
AL LETTORE:
"CHE ROBA È DIVENTARE ETICO?"
Questo libro parla di bioetica. Questo libro si rivolge agli infermieri. Ma non è un libro di bioetica per infermieri. Non nel senso, almeno, di una disciplina tagliata su misura per loro (un po' come avviene per i saperi che devono far parte dell'arsenale conoscitivo del medico, quando vengono ridotti alle dimensioni di una professione considerata "minore"...).
Ci deve essere una deontologia per ogni professione. Ci può essere un'etica professionale, modellata sulle specifiche responsabilità di professioni diverse. Non è accettabile, invece, che la bioetica venga lottizzata: per medici, per infermieri, per farmacisti, per biologi, per epidemiologi o per amministrativi della sanità.
Fino a ieri era corrente parlare di etica medica o di etica infermieristica. Oggi la bioetica invita a fare un salto: non è l'etica che deve modellarsi sulle diverse professioni; sono piuttosto queste che devono confrontarsi seriamente con la bioetica. Una professione non equivale all'altra; tutte sono sollecitate ad affacciarsi, dal punto di prospettiva che è loro proprio, sul nuovo panorama che offre quel fenomeno che chiamiamo "vita", in quanto sottoposto agli effetti delle azioni umane.
La vita la possiamo promuovere o danneggiare, migliorare o peggiorare, privilegiare qualche vivente a danno di altri. Le professioni della salute ― tra le quali si colloca quella dell'infermiere ― si dedicano a ristabilire le persone malate, a prevenire le minacce alla salute, ad accompagnare i progetti di vita dalla nascita alla morte. Per svolgere bene questo compito i professionisti hanno bisogno di acquisire quelle conoscenze specifiche che sono previste tradizionalmente dal loro curricolo formativo. Oltre a queste, oggi la professionalità dei sanitari deve dotarsi di etica. L’infermiere deve diventare etico.
"La Rosa. Miguilim domanda alla Rosa: 'Rosa, che roba è diventare etico?'. 'Bambino, non parlare di certe cose. Etico è tisico, queste malattie rodono il polmone, la persona diventa un filo, tossisce sempre, arriva a sputare sangue...' Miguilim si allontanava verso il granaio, restava intontito."
(Guimarãs Rosa, 1999, p. 49)
Nessun timore per gli infermieri che si accingono a leggere questo libro: diventando etici, non corrono nessuno dei pericoli che incombono sul piccolo Miguilim descritto dal grande romanziere brasiliano Joao Guimarães Rosa. Certo, la parola "etico" ha fatto una bella carriera nella lingua italiana. Dapprima ― come spiega Rosa all'angosciato Miguilim, che ha orecchiato la parola usata dagli adulti circa il suo stato di salute ― è stata utilizzata per descrivere il malato tisico (in quanto affetto da febbre continua consuntiva); è passata poi a designare certi farmaci
XI
(i farmaci "etici" sono quelli che possono essere dispensati solo dalla professione medica); infine è arrivata a significare un modo di esercitare la professione che presuppone un alto grado di consapevolezza. Per l'infermiere diventare etico non è una minaccia: è un alto ideale. Ma che significa ― appunto ― diventare etico?
L'esercizio di certe virtù (tutto ciò che presupponiamo implicitamente quando diciamo di qualcuno che è un "buon" medico, un "buon" infermiere...) è necessario, ma non è più sufficiente. Un professionista "etico" oggi deve sapere che la propria opera si esercita in un ambito gravido di conflitti e vincolato da norme; deve saper argomentare e giustificare le sue scelte; deve confrontarsi con sistemi di valori diversi dal proprio, con uguale diritto di cittadinanza in una società pluralista. È quanto questo libro offre all'infermiere e agli infermieri che si propongono con serietà l'obiettivo di "diventare etici".
Nell'obiettivo globale della formazione ― "sapere", "saper fare", "saper essere" ― la conoscenza meditata e personalizzata della bioetica si colloca piuttosto nell'ambito delle cose da "sapere". Non sostituisce il "saper fare" e tanto meno quel "saper essere" che dà forma morale a una persona. In altre parole, conoscere le argomentazioni con cui giustificare l'arresto di un intervento rianimatorio che può sfociare in "accanimento terapeutico" non dispensa dall'obbligo di sapere che cosa fare quando un malato va in arresto cardiaco, né dal comportarci in modo che ci qualifichi come una persona affidabile. Ma essere una persona "per bene" e avere le competenze tecniche oggi non basta più. L'etica è diventata parte integrante della formazione di un sanitario. Anche dell'infermiere, soprattutto in un'epoca in cui gli viene richiesta una formazione di livello universitario.
Nel consegnare il libro nelle mani dei lettori, l'Autore desidera esprimere almeno alcuni dei numerosi tributi di riconoscenza di cui è debitore. Al Consiglio di presidenza dell'IPASVI per averlo coinvolto, quale consulente, nel lavoro di rielaborazione del Codice deontologico degli infermieri italiani (1999). Lavorando fianco a fianco con il gruppo degli infermieri incaricati della redazione, nelle numerose rielaborazioni del Codice, ha potuto apprezzare l'alto grado di consapevolezza e maturità raggiunto dalla professione in Italia. È stato il miglior training per ripensare la bioetica dalla visione propria di chi offre al malato cure infermieristiche.
Un'altra situazione di apprendimento è stato per l'Autore il Corso di perfezionamento in bioetica, organizzato congiuntamente dall'istituto Giano e dall'università di Roma "Tor Vergata" (Diploma in scienze infermieristiche). Al Corso, giunto alla quinta edizione, hanno partecipato numerosi infermieri di ogni parte d'Italia (alcuni dei quali hanno già concluso il percorso pluriennale di formazione con il diploma, producendo significativi elaborati tanto in bioetica sistematica quanto in bioetica clinica). Un ringraziamento nominale va a quei partecipanti del corso che hanno contribuito a questo testo con alcuni dei casi clinici qui riportati: Fabio Bassetti, Edi Bonci, Stefania Davitti, Antonella Gioia.
Un ringraziamento del tutto particolare va al dott. Roberto Bucci, che coordina la didattica del corso di perfezionamento in bioetica. A lui si deve la Quarta parte del volume: "Le risorse per lo studio della bioetica". L'auspicio è che i lettori apprezzino l'ampliamento di orizzonti offerto da questi materiali nella stessa misura dei partecipanti al Corso.
Alla prof.ssa Paola Di Giulio ― una delle prime infermiere in Italia chiamata all'insegnamento universitario del nursing ― deve molto, oltre che l'Autore, anche il lettore. Suoi sono, infatti, gli aiuti al miglior utilizzo del volume che accompagnano la Prima e la Seconda parte. Paola Di Giulio ha accettato, infatti, di leggere il manoscritto e di corredarlo di una serie di annotazioni e domande, che derivano dalla sua conoscenza dei problemi etici che l’infermiere può incontrare nella pratica. Le sue annotazioni costituiscono una specie di "controcanto" al testo, che stimola il lettore a intervallare la lettura con proprie pause di riflessione e approfondimento.
La dott. ssa Christina Riebesell, esperta di arte italiana, collaboratrice scientifica presso la Bibliotheca
XII
Hertziana (Max Planck Institut, Roma), ha contribuito con la scelta e il commento di immagini tratte dal ricco patrimonio iconografico di alcuni ospedali storici (il Santo Spirito di Roma, l'Ospedale della Scala di Siena, l'Ospedale del Ceppo di Pistoia, la Congregazione di S. Martino dei Buonomini di Firenze). La cura degli infermi è stata tradizionalmente occasione per produrre non solo opere di carità, ma anche opere di bellezza.
Per poter giungere al lettore il libro è passato attraverso la qualificata assistenza segretariale della sig.ra Angela Rabacchi, che ha permesso alle numerose e tormentate redazioni di questo testo di giungere all'elaborazione compiuta, da sottoporre alla stampa, e ha beneficiato della consulenza e degli incoraggiamenti della dott.ssa Teresa Massara, della casa editrice McGraw-Hill.
Sandro Spinsanti
A Dagmar,
con gratitudine,
per un matrimonio
che pensieri e affetti condivisi
rendono l'avventura di una vita.
Bevor ich sterbe
Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen:
Es ist nicht warm
aber es könnte warm sein.
Erich Fried
Prima di morire
Parlare ancora
del calore della vita
perché almeno alcuni sappiano:
non fa caldo,
ma il caldo potrebbe esserci.
1
prima parte
ORIZZONTI DELLA BIOETICA
2
3
capitolo
1
LA BIOSFERA
QUELLA SOTTILE PELLICOLA CHE COPRE LA TERRA...
"Biosfera" e "bioetica" hanno in comune molto di più che una rassomiglianza semantica (le due parole sono formate giustapponendo rispettivamente "sfera" ed "etica" al termine che in greco indica "vita"). La bioetica è nata quando ci siamo accorti che la vita sulla Terra, nelle sue varie forme, costituisce un'unità; che questa vita è in pericolo per i comportamenti degli uomini; che di conseguenza dobbiamo modificare i nostri rapporti con i viventi, animali e piante comprese, se vogliamo sopravvivere.
Questo processo è recente. Almeno per il termine "bioetica" possiamo stabilire una data di origine, che risale a circa trent'anni fa. Appare per la prima volta nel 1971, nel titolo di un libro del biologo americano Van Renselaer Potter, che proponeva la bioetica come ponte verso il futuro (Bioethics. Bridge to the future). Quello che Potter intendeva per bioetica era un cambiamento culturale inteso come una mossa efficace per contrastare il flusso fatale che sembra portare l'umanità all'estinzione.
I naturalisti si domandano se l'estinzione non sia qualcosa di innato nel processo evolutivo. La maggior parte delle specie del passato, la cui evoluzione era controllata dalla selezione naturale, si sono estinte. Per gli uomini l'evoluzione può avere un corso diverso, purché decidano, contrariamente a quanto hanno fatto finora, di non proporsi solo fini immediati, come il guadagno economico o ciò che intendono per "progresso", ma anche un fine a lunga scadenza: la sopravvivenza, appunto. L'umanità deve proporsi ― tanto per essere concreti ― di fare quanto è necessario per arrivare all'anno 3000.
Anche se l'uomo si pone come fine la sopravvivenza della specie, si profila il dilemma tra rinunce da fare ora e spese da sostenere per avere benefici di cui saranno altri a usufruire. Si pensi per esempio agli interventi necessari per ridurre il buco dell'ozono, o alle limitazioni nel consumo dell'acqua per conservare le riserve idriche per le generazioni future.
La sopravvivenza è tutt'altro che sicura. Fino all'epoca della guerra fredda e della contrapposizione tra sistemi ideologici incompatibili ― il capitalismo da una parte e il blocco dei Paesi comunisti dall'altra ― abbiamo temuto che una conflagrazione atomica potesse mettere fine all'avventura della vita sulla Terra. Ora ci stiamo rendendo conto che il pericolo viene piuttosto da un'altra direzione: è la biosfera nel suo insieme che viene minacciata da comportamenti irresponsabili a cui tutti partecipano, ma la cui regia è nelle mani dei Paesi a maggiore sviluppo economico. Quando parliamo di biosfera ci riferiamo a quella sottile pellicola che copre il pianeta,
4
nella quale si trovano, ognuno nella propria nicchia, i sistemi viventi: gli animali ― dal batterio ai cetacei giganti ― e le piante. È una pellicola sottile (pesa solo un miliardesimo di tutto il pianeta), ma è quella che fa la preziosa differenza. L'uomo è inserito in essa, eppure con i suoi comportamenti è la peggiore minaccia per la sopravvivenza della biosfera. La sopravvivenza è il momento cruciale dell'evoluzione in cui il destino delle specie viventi non è più il frutto di un cieco gioco tra le forze della natura, ma passa nelle mani dell'uomo.
Lo sviluppo sostenibile, predicato dagli ambientalisti, e l'economia sostenibile (ipotizzata dal premio Nobel Amartya Sen) sono in contrasto con le attuali tendenze di evoluzione e sviluppo, tanto da essere considerati "utopie". Quali sono gli spazi per incorporare questi principi nelle politiche di sviluppo o locali? Sono destinati a essere praticati solo da minoranze?
Garantire la sopravvivenza della vita non è solo questione di scienza e di tecnologia. Per assicurare l'inversione di tendenza ― proponeva Potter trent'anni fa ― è necessaria una "bioetica". Presupponeva, d'accordo con altri pensatori ambientalisti, che ciò che chiamiamo "etica" ha conosciuto una scansione in tre fasi: quella in cui è stata invocata per regolare i rapporti tra gli individui; quella in cui si è occupata prioritariamente dei rapporti tra individui e società; e infine la fase attuale: l'uomo deve regolare i propri rapporti con gli animali e le piante, modificando gli atteggiamenti tradizionali nei confronti della natura. L'estensione dell'etica a questo terzo ambito è l'unica possibilità evolutiva e una necessità ecologica.
Schematizzando il processo che porta da una posizione filosofica teorica a un comportamento responsabile sanzionato dallo Stato, Potter prevedeva una sequenza costituita da cinque stadi:
1. il danno ambientale diventa visibile all'individuo comune e provoca indignazione morale;
2. la conoscenza di questi problemi si evolve in una nuova disciplina: la bioetica ambientale;
3. l'indignazione morale richiede contromisure preventive;
4. la pressione morale, unita all'informazione fattuale, genera delle direttive bioetiche;
5. queste sono convertite in sanzioni legali.
La bioetica, dunque, proposta originariamente da Potter è un intreccio di elementi diversi: presa di coscienza del pericolo che minaccia la biosfera, cambiamento della nostra filosofia della natura, sviluppo di comportamenti responsabili, vincoli e restrizioni posti dalla società all'intervento nell'ambito della biosfera.
L'intreccio tra pressioni locali, bene individuale e collettivo e pressioni di mercato è difficilmente districabile. La sequenza proposta da Potter generalmente si ferma al quarto stadio, in particolare per le misure ambientali. Il ruolo della bioetica è quello di aumentare le informazioni e suscitare dibattito oppure quello di modificare le leggi?
Il primo effetto della bioetica è, dunque, quello di far entrare piante e animali nella nostra coscienza. È un avvenimento di grande importanza: non assicura solo la premessa per la sopravvivenza della vita, ma è anche un avvenimento di grande importanza per la crescita spirituale dell'umanità, uno di quei gradini che segnano un salto di qualità. Intendiamo la presenza della natura nella coscienza nel duplice significato che ha il termine coscienza: come qualcosa di cui ci si accorge (quando si "prende coscienza" di qualcosa), e come una realtà che crea un obbligo morale cioè verso cui ci si sente obbligati (quando la coscienza ci spinge a comportarci in un modo o nell'altro).
Non vogliamo dire con questo che l'umanità solo oggi si renda conto di essere circondata dalla natura, vivente e non vivente, e di essere essa stessa una parte della natura: questa coscienza è antica quanto l'umanità stessa. Questa natura tuttavia era, per definizione, l'"oggetto"
5
che si contrapponeva al soggetto umano, un luogo da cui attingere le risorse necessarie per la sopravvivenza, e per alcuni occasione di contemplazione, di ispirazione poetica, di elevazioni religiose; ma non una fonte di interpellazione etica. Nella tradizione dell'occidente la natura non si rivolgeva alla coscienza morale dell'uomo.
Abbiamo un obbligo morale nei confronti di animali e piante di per sé o solo in funzione della nostra sopravvivenza? E se gli animali sono portatori di diritti, è corretto fare sperimentazioni su di loro (e quindi sottoporli a sofferenze) per trovare trattamenti che aumentino il benessere dell'uomo?
L'elaborazione di una dottrina dei doveri ― cioè la riflessione etica ― è avvenuta sempre intorno all'uomo come persona. È istruttivo considerare il posto che spetta agli animali e alle piante nei sistemi etici tradizionali: questi non parlano di un obbligo morale dell'uomo nei loro confronti; se un obbligo esiste, esso va ricondotto ai doveri che l'uomo ha verso se stesso (per esempio: non deve torturare gli animali, per non cedere alla crudeltà) o verso gli altri uomini (quando interferisce con il loro diritto di proprietà, distruggendo qualche parte della natura animata o inanimata che appartiene ad altri); ma dagli esseri naturali, che non siano altri esseri umani, non proviene alcuna interpellazione. Il "dialogo con la natura" ― a meno che non sia concepito come un momento di poesia o come una figura retorica ― è lasciato come esperienza alle culture più arcaiche, che non si sono ancora sottratte al fascino del sacro percepito negli avvenimenti naturali.
L'uomo si è collocato con prepotenza al centro del creato, considerando rilevante per l'etica solo ciò che si eleva all'altezza del suo sguardo. È stata già una difficile impresa innalzare a soggetto etico, che interpella e obbliga in un rapporto interpersonale, alcune categorie di persone appartenenti alla specie umana (gli schiavi, per lunghissimo tempo e in numerose culture; gli indios incontrati dai conquistadores in America; le donne, che nel Medioevo si sono viste contestare da alcuni teologi perfino l'anima...); per la natura non umana la possibilità di entrare in un rapporto con l'uomo che non fosse di utilizzazione strumentale sembrava esclusa a priori. L'uomo si considerava "signore e padrone della natura" (secondo la formula di Descartes); la regola fonda― mentale dell'etica razionalista stabilita da Kant (trattare l'"altro" come fine, non solo come mezzo) si applicava solo all'"altro" a cui veniva riconosciuto carattere umano, non ai viventi in genere.
Probabilmente sono in pochi oggi a sostenere posizioni radicali che negano agli animali qualsiasi rilevanza etica. Come punto di riferimento estremo, possiamo considerare il posto che il filosofo razionalista Spinoza attribuiva agli animali nella sua Ethica:
La legge che proibisce di ammazzare gli animali è fondata piuttosto sopra una vana superstizione e una femminea compassione, anziché sulla sana ragione. Il dettame della ragione di ricercare il nostro utile prescrive, bensì, di stringere rapporti di amicizia con gli uomini, ma non coi bruti o con le cose la cui natura è diversa dalla natura umana... E tuttavia io non nego che i bruti sentano, ma nego che per questa ragione non sia lecito provvedere alla nostra utilità o servirci di essi a nostro piacere, e trattarli come meglio ci conviene, giacché essi non si accordano per natura con noi, e i loro affetti sono per natura diversi dagli affetti umani.
Si va diffondendo un consenso sul fatto che il dibattito sul comportamento da tenere con gli animali deve essere sottratto alle divagazioni salottiere e alle contrapposizioni regolate più dal pathos che dalla ragione. Se ne deve parlare nella sede più appropriata, che è quella della riflessione filosofica. Tuttavia il contributo che può offrire la filosofia si dimostra deludente per chi cercasse orientamenti condivisi su larga base. I filosofi morali sono lontani dall'aver raggiunto un consenso sostanziale su questioni fondamentali, a cominciare da quella relativa allo statuto morale degli animali.
A un'analisi filosofica accurata, la nozione di "statuto morale" rivela due significati: uno
6
debole ― nel senso di avere rilevanza per la vita morale ― e uno forte: vale a dire, riconoscere che gli animali sono portatori di diritti. Nella prima accezione l'accordo tra gli studiosi sembra più facile da raggiungere: le concezioni più estreme, che hanno preteso di fondare il potere indiscriminato dell'uomo sugli animali ricorrendo a costrutti di tipo spiritualista (negando cioè l'anima immortale agli animali) o di un tipo razionalista (riservando la ragione in esclusiva all'uomo), sono sempre più difficili da sostenere.
Nessuna teoria etica è disposta ad avallare un comportamento insensato o deliberatamente crudele nei confronti degli animali, con argomenti tratti dall'uno o dall'altro arsenale ideologico. Tuttavia, a un certo punto il consenso si infrange: in caso di conflitto di interessi, alcuni sono più propensi a concedere all'uomo un ragionevole uso degli animali. Quando la vita umana può essere migliorata e la sofferenza dell'uomo diminuita mediante l'uso appropriato di creature non umane, la stragrande maggioranza degli umani continua ancora a votare per l'uomo.
È una via che invece non sono disposti a seguire i filosofi che riconoscono agli animali uno statuto morale in senso forte e parlano, di conseguenza, di diritti degli animali. Alcuni studiosi per promuovere la causa degli animali seguono una via cognitiva, trovando un forte alleato in Charles Darwin, che ha più volte asserito che non si riscontra alcuna fondamentale differenza tra l'uomo e i mammiferi superiori nelle loro facoltà mentali: non appare lecito, quindi, discriminare gli animali in quanto mancanti della ragione. La maggior parte dei filosofi, tuttavia, argomenta con categorie proprie della filosofia utilitarista ― secondo la quale le azioni sono moralmente giuste nella misura in cui tendono a produrre la più grande felicità per il più grande numero ― e fonda la protezione da accordare agli animali sulla loro capacità di sentire dolore.
Come si può conciliare il diritto alla vita dell'animale con il consumo alimentare di carni? Rispetta fino in fondo i diritti degli animali solo chi è vegetariano e chi non indossa indumenti di pelle e cuoio?
Secondo questi filosofi, per stabilire i confini della comunità morale bisogna riferirsi a una base più ampia di quella costruita su misura per l'essere umano adulto, razionale, sano, pienamente funzionante. Se utilizziamo non solo la razionalità, ma anche facoltà come l'empatia e la compassione, dovremmo riconoscere che la condizione sufficiente per far parte della comunità morale è quella di essere un soggetto vivente; e questa è una condizione che gli animali condividono con l'uomo. Le tesi più estreme in questa direzione sono quelle sostenute dal filosofo australiano Peter Singer, al quale si ispirano molti attivisti del movimento chiamato ― in analogia con altre situazioni di oppressione da riscattare ― Animal liberation : è immorale concedere alla sofferenza di un animale meno attenzione di quella che diamo alla stessa sofferenza ma di un essere umano (Singer, 1991).
L’attenzione agli animali non è un privilegio aristocratico riservato alle anime sensibili. Prima che l'etica si decidesse a riflettere seriamente sul nostro comportamento nei confronti degli animali ― facendo eco al duro monito già espresso dal teologo e filantropo Albert Schweiter: "Un'etica che si occupa solo degli esseri umani è disumana" ― la scienza stessa ha modificato il nostro sguardo. Ci riferiamo più precisamente a quella parte della scienza che, rinunciando a studiare gli animali per scopi utilitaristici, si è dedicata a osservarne i comportamenti nell'ambiente naturale (si pensi all'etologia e soprattutto all'opera di Konrad Lorenz, che ne è stato uno dei divulgatori più efficaci). "Per la prima volta nella storia della civiltà qualcuno interessato agli animali per conoscerli ― e non solo per nutrirsene, per mettere loro il giogo, cacciarli, imbalsamarli ― è stato in grado di ampliare con i mezzi della scienza le nostre conoscenze, e di trasmetterle in parte a un'opinione pubblica curiosa. Gli animali sono in qualche misura entrati nella realtà. Con l'aiuto impensato della televisione, Darwin ce l'ha fatta: gli abitanti della città hanno cominciato ad accorgersi della biosfera" (Midgley, 1985).
7
Questo è, dunque, il complesso cammino che la bioetica ci fa percorrere. Prendere coscienza della biosfera; introdurre gli animali nel mondo dell'uomo, riconoscendoli portatori di diritti e non solo utili oggetti di rapina; vedere nella natura non una riserva di risorse da sfruttare, ma un ambiente da rispettare e conservare (secondo l'alto invito dell'americano Aldo Leopold a fondare una "Land Ethics", cioè un'etica che riconosca il valore del paesaggio naturale): per acquisire questi nuovi atteggiamenti è stata necessaria più che una generica iniezione di buoni sentimenti nel modo di comportarsi tradizionale. Sull'orlo di una crisi che può rivelarsi fatale per la biosfera nel suo insieme, le coscienze più riflessive sono state indotte a una revisione profonda dei nostri comportamenti nei confronti della natura vivente.
Il modello razionalista dell'uomo che siamo abituati a coltivare presuppone implicitamente che la maturità emotiva comporti l'indifferenza verso il mondo animale e la natura: come se si diventasse uomini allontanandosi il più possibile dall'animalità (la bestia continua a essere usata come simbolo oscuro del male, del demoniaco, dell'antiumano...). La bioetica, rovesciando questo modello, ci invita a riscoprire un canale di comunicazione profonda con la natura, la capacità di percepire e di rispondere agli stati interiori di animali di altre specie, il respiro divino di tutto ciò che è vivente, nonché l'intreccio profondo tra la natura vivente e quella non vivente. Ci troviamo in compagnia di poeti, di scienziati ― almeno quelli tipo Konrad Lorenz ― e di bambini. E di santi, come Francesco d'Assisi.
IL POTERE SULLA VITA
Stagioni della genetica, stagioni dell'etica
Nessuna forma di potere che l'uomo ha potuto esercitare in passato sulla natura è paragonabile al dominio sulla vita che è stato reso possibile dalle scoperte recenti nel campo della genetica e dalla messa a punto di tecnologie che permettono di intervenire nel substrato più profondo della natura vivente. Come ha affermato il presidente americano Bill Clinton in occasione dell'annuncio della conclusione del Progetto Genoma, nel giugno 2000, abbiamo la sensazione di "leggere nel libro con cui Dio ha scritto la vita". Pur detraendo il tributo che una frase di questo genere fa alla retorica, rimane la consapevolezza di aver varcato una soglia nello sviluppo dell'umanità. A questo traguardo non siamo giunti improvvisamente. Possiamo riconoscere periodi ben differenziati nello sviluppo della genetica, ai quali corrispondono altrettante stagioni dell'etica. Ogni fase, infatti, della crescita del sapere e del potere dell'uomo sul meccanismo della trasmissione della vita ha mobilitato la riflessione etica in modo differente.
La genetica quale scienza dell'ereditarietà, tenuta a battesimo dall'abate Mendel poco più di un secolo fa, non ha mostrato subito le potenzialità di cui era dotata: come quegli alunni che sembrano scaldare i banchi di scuola per anni, finché un giorno escono dal bozzolo in maniera folgorante. Le scoperte di Mendel, riconosciute come leggi generali dell'ereditarietà solo all'inizio del XX secolo, sono apparse portatrici di conseguenze pratiche decenni più tardi, quando sono diventate la base teorica dell'eugenismo.
Questo movimento è nato come un progetto per migliorare la specie umana mediante un controllo della procreazione, favorendo la trasmissione dei caratteri ereditari auspicati e impedendo la riproduzione di quelli considerati negativi. Il dizionario Larousse del XX secolo, pubblicato nel 1928, attribuiva come fine alla "nuova scienza" dell'eugenismo quello di "eliminare gli indesiderabili e di conservare e perfezionare gli elementi sani e robusti".
Le basi scientifiche dell'eugenetica erano tutt'altro che solide. È bastata, tuttavia, la sola patina di scientificità perché nel periodo tra le due guerre mondiali programmi eugenetici fossero intrapresi dal governo nazista in Germania ― che si servì dell'eugenismo per giustificare la propria criminale politica razzista ― e altri ne fossero realizzati nei Paesi scandinavi e negli Stati
8
Uniti (con la stessa inconsistenza scientifica e nullità di risultati quanto al miglioramento della specie, ma con il totalitarismo nazista in meno). Gli errori del passato hanno gettato il discredito sui programmi eugenetici autoritari, inequivocabilmente condannati anche dal punto di vista morale, in quanto violano il fondamentale diritto della persona all'autodeterminazione.
Il diritto all'autodeterminazione comprende anche la scelta di accettare un rischio. Ma quale diritto ha un genitore di scegliere di accettare un rischio (o la certezza di una menomazione) per il figlio? Si veda il recente caso del ragazzo francese gravemente disabile, che attraverso il padre fa causa ai medici per non aver diagnosticato la sua disabilità e per averlo fatto nascere.
Se le scoperte di Mendel corrispondono alla preistoria e l'eugenismo alla storia antica della genetica (il miglioramento della specie mediante l'eliminazione dei tarati era, del resto, la politica sanitaria corrente anche a Sparta, con risultati molto meno brillanti, a quanto ci dice la storia della civiltà, di quelli ottenuti ad Atene...), la storia moderna della genetica comincia a metà degli anni Cinquanta del XX secolo, con l'identificazione del modo in cui si trasmettono i cromosomi e la scoperta della struttura molecolare del DNA. Gli anni seguenti furono segnati dal progressivo, paziente studio del modo in cui il "messaggio" ereditario, contenuto nel DNA dei cromosomi sotto forma di una successione di geni, poteva essere tradotto in proteine. Si trattava però ancora di conoscere il processo come avviene in natura, senza mettervi le mani; l'intervento dell'etica in questa fase ― superata la fascinazione dell'eugenismo quale misura politica autoritaria che ricorre alla costrizione per ottenere la trasmissione dei caratteri genetici ritenuti auspicabili ― non eccede l'interesse rivolto alle conoscenze scientifiche di base, senza alcun particolare segnale di allarme, in quanto di per sé neutre.
La "manipolazione" segna l'ultima tappa del progresso della genetica. Dopo appena cinque lustri ― i primi lavori di questo genere sono del 1973 ― gli scienziati hanno messo a punto una tecnica per introdurre all'interno del patrimonio ereditario di una cellula un frammento di DNA estraneo, ottenuto mediante sintesi chimica. Tecnicamente si parla in questo caso di "DNA ricombinante". Si tratta di molecole di DNA costruite al di fuori delle cellule viventi, che vengono congiunte a segmenti di DNA al fine di farli replicare in una cellula vivente.
Impadronirsi della chiave con cui si trasmettono i caratteri ereditari significa poter smontare la catena del DNA e pilotarne la ricostruzione a volontà. In pratica, l'elica del DNA (quel lunghissimo filamento che contiene le istruzioni di crescita per ogni organismo) viene tagliata per inserire altri frammenti, con informazioni diverse, che modificano lo sviluppo della cellula. È un lavoro di microchirurgia, in cui il bisturi viene sostituito da enzimi che attaccano e incidono il DNA, mentre dei batteri trasportano i geni scelti per la ricombinazione.
Le applicazioni possibili sono apparse le più varie: incroci tra piante diverse, nonché tra cellule vegetali e cellule animali; creazione di nuove specie vegetali, con caratteri modificati, come grano capace di crescere nel deserto oppure ortaggi che resistono al gelo; realizzazione in laboratorio di animali transgenici ― per così dire "su misura" ― per disporre di modelli sperimentali per la ricerca e l’osservazione in vitro dei meccanismi di azione di determinate patologie a base genetica, nonché come fornitori di organi per i trapianti (xenotrapianti); nel settore diagnostico-terapeutico, infine, creazione di sostanze organiche ― come l’interferone e l'ormone che regola la crescita ― e interventi terapeutici, grazie ai quali si trasferiscono geni tra organismi diversi per correggere, attivare o disattivare un gene difettoso o inserirne uno mancante perché trasmetta in modo corretto il suo codice.
Tuttavia, insieme alle promesse che fanno balenare l'ingegneria genetica come l'Eldorado dell'era tecnologica, si evidenziarono ben presto i dubbi. Si paventò il pericolo che le manipolazioni genetiche portassero alla creazione e moltiplicazione di germi patogeni nuovi, come batteri mutanti resistenti agli antibiotici e non trattabili con i mezzi farmacologici in nostro possesso. I problemi della sicurezza nei confronti di microrganismi geneticamente modificati smorzarono l'euforia
9
creata dall'ingegneria genetica e sollevarono l'interrogativo etico della liceità dell'intervento dell'uomo in processi biologici che modificano la natura stessa degli organismi viventi.
Il primo allarme nasceva nell'ambito stesso degli scienziati che si occupavano di ingegneria genetica. Nel luglio 1974 un gruppo di specialisti lanciava con una lettera aperta un appello all'autoregolazione e gli esperimenti di modificazione genetica degli organismi venivano congelati da una moratoria. Ma nella Conferenza di Asilomar, in California, tenutasi nel 1975, veniva decisa la ripresa dei lavori. In seguito le regolamentazioni e le misure precauzionali prese dai governi si sono succedute con ritmo discontinuo: a restrizioni e severi controlli hanno fatto seguito edulcorazioni permissive.
Una nuova fase dell'appello all'etica nell'ambito della genetica si è aperta nella primavera del 1997, con la notizia della clonazione di un mammifero a partire da una cellula differenziata di adulto (la pecora Dolly), ottenuta nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo (notizia apparsa su Nature del 27 febbraio 1997). La risonanza mondiale dell'evento è stata favorita dall’ipotesi di un’applicazione agli esseri umani della stessa tecnologia, per produrre a questo punto degli "uomini su misura" (Harris, 1997). La reazione generalizzata, tanto di istanze religiose ― come l'intervento del magistero cattolico nella persona del pontefice Giovanni Paolo II ― quanto di quelle politiche e secolari ― come il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che ha istituito una commissione per indagare sull'eticità di queste procedure e ha deliberato una moratoria sul finanziamento pubblico delle ricerche sulla clonazione umana ― è stata di condanna. In questa fase l'etica è apparsa sulla scena principalmente sotto forma di ampio coinvolgimento dell'opinione pubblica, mobilitazione di emozioni, pressioni per il controllo dell'attività degli scienziati, piuttosto che come ricerca di orientamenti per l'azione, attinti dalla riflessione filosofica.
Qualunque processo ha portato a modificazioni dell'ambiente e degli equilibri esistenti (si pensi all'inquinamento dello spazio e del nostro ambiente con le emissioni degli impianti di riscaldamento; all'estinzione i centinaia di specie animali e vegetali...). È proprio un prezzo inevitabile da pagare? La discontinuità nell'adozione di moratorie e misure precauzionali deriva da una valutazione dell'impatto ambientale o dalle pressioni del mercato?
La riflessione bioetica: nella continuità o nella novità?
Se ci limitiamo a osservare il tono generale del discorso etico che accompagna il vertiginoso sviluppo della genetica, sia tra filosofi e teologi di professione che tra il grande pubblico, possiamo ricondurre gli atteggiamenti prevalenti nei dibattiti a due modelli di fondo: il primo più centrato sulla novità dei problemi etici posti dalla nuova genetica, il secondo più sensibile alla continuità. Coloro che si orientano verso il primo modello tendono a sottolineare la rottura con il passato costituita dalla decodificazione del codice genetico dei viventi, accompagnata dalla possibilità tecnologica di intervenire su di esso.
Rispetto ai metodi selettivi tradizionali, evidenziano il ruolo attivo assunto dall'uomo: non si tratta più soltanto di incidere marginalmente nell'evoluzione delle specie viventi ― come fa un buon allevatore che favorisce, con incroci selezionati, lo sviluppo di una migliore razza animale o di una determinata varietà vegetale ― ma di diventare agente della propria evoluzione. Inoltre, quale che sia la novità qualitativa dei cambiamenti, l'accelerazione degli stessi è tale che non è possibile alcun confronto con quanto è avvenuto nei millenni precedenti. Questo approccio inclina verso una enfatizzazione delle conseguenze della nuova biologia: tanto positive (l'ingegnerizzazione della vita costituisce un salto di qualità nella lotta contro le patologie e permette di modellare i discendenti secondo i propri desideri, scegliendo i caratteri genetici dei nascituri), quanto negative (riassumibili nell'espressione retorica di "bomba biologica", che fa immaginare conseguenze tanto catastrofiche per le applicazioni della biologia quanto quelle dello sviluppo dell'energia atomica).
10
Il secondo modello ideale ama, invece, sottolineare la continuità: ciò che sta avvenendo con il contributo dell'ingegneria genetica non è essenzialmente diverso da quanto l'umanità ha conosciuto in passato. Questa visione induce a gettare acqua sul fuoco tanto degli entusiasmi, quanto delle preoccupazioni. Rispetto alle premesse mirabolanti, si fa notare che, in un riscontro preciso, la realtà dei fatti subisce un forte ridimensionamento. Di molte specie vegetali modificate con la biotecnologia ― per fare un esempio ― non sappiamo che uso fare: quelle selezionate nel corso del tempo sembrano rispondere ai nostri bisogni meglio di quelle ingegnerizzate. Nell'ambito delle applicazioni cliniche, l'intervento su cui si sono concentrati i maggiori sforzi, cioè la terapia genica del cancro (terapia in senso lato, in quanto gli interventi non mirano a ripristinare una normale funzione genica neoplastica, ma a potenziare le terapie esistenti, rendendo i soggetti meno sensibili alla tossicità dei chemioterapici) non hanno portato finora i risultati sperati.
Forse anche le minacce connesse con queste tecnologie non sono così gravi come si era paventato in un primo momento. Del resto, se ci manteniamo in una prospettiva storica, non riusciamo a prevedere niente di così tremendo che l'uomo non abbia già fatto senza l'ingegneria genetica. Ricordando gli orrori che l'umanità è stata capace di produrre, possiamo sentirci autorizzati a ritenere che il peggio non stia davanti a noi, ma piuttosto alle nostre spalle.
Questa sommaria tipologia degli orientamenti di fondo nei confronti della genetica si rivela utile per descrivere due corrispondenti atteggiamenti rispetto all'etica: uno che privilegia la novità, e l'altro che sottolinea la continuità. Nel primo modello viene enfatizzato il bisogno di una nuova etica, adeguata alla situazione inedita che si è venuta a creare. La "bioetica" ― neologismo che ha la stessa età anagrafica dell'ingegneria genetica, essendo stato proposto agli inizi degli anni Settanta, contemporaneamente all'acquisizione della capacità di intervenire attivamente sul patrimonio genetico della cellula ― viene a gran voce invocata come l'adeguata risposta al fatto che i progressi della biologia, e della genetica in particolare, ci hanno fatto entrare in una no man's land che richiede nuove regole etiche.
Una nuova regolamentazione è necessaria soprattutto nell'ambito della sperimentazione. Le norme, infatti, relative alla ricerca su soggetti umani che, con notevole fatica, sono state introdotte in ambito medico (quella linea che va dal Codice di Norimberga del 1946 alle Dichiarazioni dell'Associazione Medica Mondiale di Helsinki, nel 1962 ― e successivi emendamenti del 1975,1983 e 1989 ― relativa alle ricerche biomediche e che nella Comunità Europea ha prodotto la direttiva unitaria del 1990, rinnovata nel 1997, nota come Good Clinical Practice) non trovano applicazione nel campo di ricerche che hanno per oggetto non un paziente, ma del materiale genetico, ovvero degli embrioni.
Il dibattito su questi temi è stato caratterizzato soprattutto dalla disinformazione, che porta, di conseguenza, alla strumentalizzazione delle diverse posizioni. Il gap di conoscenze tra tecnici e laici diventa sempre più ampio e questo rende difficile un dibattito pubblico. La bioetica deve essere un dibattito tra esperti tecnici o deve coinvolgere anche la popolazione "laica"? Il ruolo della bioetica sta anche nella "democratizzazione" delle conoscenze?
In nome della bioetica sta avvenendo una mobilitazione generale sulla frontiera della nuova biologia, per prevenire che la genetica procuri dei gravi mali all'umanità, così come è avvenuto con la fisica. Non si tratta solo di standard relativi alla sicurezza del contenimento fisico e biologico degli organismi geneticamente modificati, ma fondamentalmente di una revoca dell'autorizzazione a controllare se stessi, senza rendere conto a nessuno, che la società ha tradizionalmente concesso a scienziati che fanno ricerca biologica e medica.
Il secondo atteggiamento che abbiamo individuato propende, invece, a minimizzare il bisogno di un'etica specifica, tagliata su misura, per la nuova biologia. Semmai è l'etica di sempre che è necessaria, per richiamare tutti i soggetti, secondo i diversi livelli di operatività, ad agire
11
con senso di responsabilità. Può essere sensato e opportuno farsi attraversare da una vena di sospetto nei confronti dell'interesse con cui, in diversi ambienti, viene promossa la bioetica quale nuova prassi di dibattito etico all'interno della società. La bioetica potrebbe essere piegata a svolgere una funzione ideologica, a servizio ― come ogni ideologia ― di interessi camuffati. L'ideologia offre una spiegazione deformata della realtà, non in quanto dice delle cose in sé false, ma perché nasconde i rapporti di potere su cui la realtà si fonda.
La bioetica come specializzazione dell'etica va incontro allo stesso processo a cui sono andate incontro le specializzazioni mediche: per approfondire lo sguardo sulla parte o sull'organo hanno perso di vista il paziente-uomo. È un processo inevitabile in tutte le forme di specializzazione? Spesso la medicina migliora il funzionamento dell'organo senza necessariamente migliorare la qualità di vita del paziente. Allo stesso modo la bioetica rischia di approfondire la discussione su un tema senza toccare le logiche generali che sono alla base del problema.
La bioetica sembra assecondare quel movimento che tende a indirizzare lo sguardo nel terreno dell'intimo, dei piccoli gruppi, delle relazioni corte o delle questioni ultime (dalle manipolazioni genetiche alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, all'eutanasia), lasciando però in ombra ciò che appartiene al terreno politico e sociale. Ciò che sta avvenendo nell'ambito della nuova biologia andrebbe forse più utilmente esplorato mediante interrogativi che nascano dall'etica dell'informazione (Come si parla della tecnologia genetica? Quante false notizie vengono diffuse? In che modo il pubblico viene informato su benefici e rischi propri delle bio-tecnologie? Come viene manipolata l'opinione pubblica per ottenere il consenso su progetti faraonici, scavalcando il momento del dibattito scientifico?), oppure richiamandosi all'etica economica (In base a quali criteri vengono distribuiti i fondi per la ricerca? Come vengono stabilite le priorità degli investimenti? Chi si arricchisce e chi si impoverisce in conseguenza dei brevetti legati alle biotecnologie?).
Per dirla riferendoci al grande codice morale che sta alla base della civiltà occidentale ― il Decalogo ―, la bioetica che è vivacemente presente nei mass media, mentre è portata a valutare i nuovi problemi in base al quinto e al sesto comandamento ("non uccidere", con riferimento anche alle forme embrionali di vita; "non fornicare", quale criterio per giudicare le nuove forme di riproduzione con l'aiuto della tecnologia biomedica), è distratta nei confronti del settimo e dell'ottavo, che proibiscono rispettivamente la menzogna e il furto... Questa distrazione sembra più voluta e pilotata ― ecco il ruolo dell'ideologia! ― che occasionale.
Le legittime riserve nei confronti di un uso ideologico e strumentale della bioetica non devono, tuttavia, indurci a trascurare le possibilità insite in un dibattito che sottolinei la novità, piuttosto che la continuità. La bioetica ― intesa, in senso estensivo, come riflessione che nasce dall'impatto che i progressi nelle scienze biologiche e le loro applicazioni tecnologiche hanno sull'ambiente, sulla pratica medica e sui comportamenti sociali ― può essere vista come un'occasione per imparare a esercitare la riflessione etica.
È necessario, preliminarmente, non dare per acquisito che noi sappiamo già che cosa significa pensare e agire eticamente. La novità delle biotecnologie può essere valorizzata per evidenziare il superamento dei modelli di pensiero tradizionali. Uno stimolo a utilizzare la novità per un rinnovamento anche dell'etica ci è fornito dalla constatazione della relativa inefficacia di questa disciplina a guidare le scelte. La nostra società esprime una diffusa richiesta di "leadership", di un'istanza morale che sappia indicare la giusta direzione nelle scelte che ci stanno di fronte. L'etica, come noi la conosciamo dalla tradizione filosofica e teologica, si dimostra inadeguata a tale compito. Invece di porsi autorevolmente davanti agli scienziati, ai ricercatori e ai politici, per mostrare il cammino, si colloca per lo più alle loro spalle per criticarli.
12
Compito dell'etica è indicare la "giusta" direzione, esplicitando i criteri su cui si basano alcune scelte o legittimare alcuni progressi? Se esistono più visioni etiche (per esempio quella cattolica e quella laica) possono esistere anche più possibilità di risposta e criteri di scelta. Qual è allora il ruolo dell'etica?
La figura più familiare all'opinione pubblica è quella del moralista che alla notizia dell'ennesima novità biotecnologica che sconvolge i nostri parametri di riferimento tradizionali ― ieri l'ingegneria genetica, oggi la clonazione di un animale ― scuote il "dito didattico" per ammonire che non è lecito. Questo relativo insuccesso dell'etica nell' assumere un magistero morale autorevole può essere assunto come occasione per fare una revisione del modo di condurre la riflessione etica. La bioetica non dovrebbe limitarsi a portare una nuova provincia sotto il dominio dell'etica; essa può costituire piuttosto l’occasione per immaginare un legame tra progresso scientifico ed etica che non sia solo quello del controllo.
RISCRIVERE LE REGOLE ETICHE
Sulla frontiera della nuova genetica
Nella nostra società non c'è solo un pluralismo di sistemi etici, ma anche una pluralità di funzioni dell'etica. Possiamo ipotizzare tre funzioni dell'etica: di controllo, di gestione e di legittimazione. In concreto, se osserviamo che cosa ci si intende quando nell'ambito della nuova genetica si fa appello all'etica, ci accorgiamo che dal suo intervento si aspettano almeno tre cose diverse. All'etica si domanda di definire i confini da non oltrepassare; di valutare prezzi da pagare e rischi da correre in rapporto ai benefici sperati; di stabilire un legame fra il piano operativo e gli alti valori ideali. Queste tre funzioni dell'etica non si escludono reciprocamente, ma possono offrire, agendo in sinergia, un orientamento efficace nell'ambito degli interventi genetici sull'uomo.
La funzione di controllo è diventata prioritaria nella fase attuale dello sviluppo della genetica e delle possibilità di intervento sulla struttura del vivente. Il controllo, con linee chiaramente tracciate tra ciò che si può fare e ciò che non si deve consentire, è finalizzato a impedire che la fattibilità diventi la sola ragione per cui una cosa sia fatta. La funzione di controllo dell'etica confina con la legge e tende a confondersi con essa. È una vicinanza svantaggiosa per l'etica, che rischia di non saper far valere la sua specificità. La morale non può sottostare alle regole della maggioranza, come invece riteniamo opportuno che avvenga per le leggi in regime di democrazia. La norma giuridica è a sua volta sottoposta a un giudizio etico; la legge deve confrontarsi con qualcosa che la supera, come per esempio i diritti dell'uomo (non basta che la legge sia voluta dalla maggioranza per essere una buona legge: così sarebbe ingiusta una legge "democratica" che, in nome della maggioranza bianca, togliesse i diritti civili ai neri!).
Le leggi variano da nazione a nazione, come anche i valori e le priorità date loro. Qualsiasi opinione su cosa sia morale o meno sarà sempre discutibile, perché sarà sempre possibile trovare alternative. Questo è un dato di fatto legato alla diversità degli esseri umani e del loro pensiero. Per questa inevitabile e legittima diversità non è possibile avere opinioni comuni condivise da tutti, né valori comuni. Anche cercare di evitare il dolore o la morte non sono necessariamente valori universali. Per esempio, un atleta soffre volutamente per migliorare la propria performance. Come anche, alcune persone si suicidano piuttosto che sopportare la vita in certe condizioni. È possibile creare un consenso etico?
Il consenso etico si forma e cresce mediante un paziente lavoro di ragione dialogica, grazie al quale nasce a poco a poco una sensibilizzazione e una sintonizzazione delle coscienze, tra soggetti che si parlano e si ascoltano reciprocamente. Il consenso di natura etica si misura sul fatto
13
che è frutto del dialogo e che può essere discusso. Tra le varie forme di dialogo necessarie per costituire il consenso etico, nessuna appare così urgente come il dialogo tra l'etica religiosa e l'etica laica. Malgrado le difficoltà di procedere a una delimitazione concreta del lecito, a causa delle diverse concezioni relative all'essere umano, un accordo di fondo si sta delineando in Occidente proprio sulla linea della difesa dell'uomo da interventi di manipolazione in contraddizione con i valori che sono riconosciuti tanto dalle tradizioni religiose, quanto da quelle secolari. La barriera posta a voce unanime alla clonazione dell'essere umano è un esempio chiaro di tale consenso.
Nell'ambito della funzione di gestione attribuita all'etica, il contributo che questa può dare è quello di rendere esplicite le scelte e i criteri sui quali si fondano. Più che porre divieti o linee da non oltrepassare ― come fa l'etica quando esercita la funzione di controllo ― la gestione chiede all'etica di sviluppare norme capaci di regolare un ordinato svolgimento delle nuove pratiche.
Per quanto importante sia il criterio della responsabilità nel valutare il passaggio all'azione ― come ha ripetutamente proposto il filosofo Hans Jonas proprio nell’ambito della nuova biologia (Jonas, 1990) ― non bisogna sottovalutare la continua urgenza di sottoporsi al criterio della razionalità. L'etica è e deve rimanere un luogo privilegiato dell'esercizio di una rigorosa ragione critica. Tanto più necessaria, quanto più la biologia contemporanea, a fronte di impressionanti risultati pratici, sembra essere carente di elaborazione razionale. Di fronte alla genetica sembra strutturarsi un nuovo "incanto del mondo" che lega le nostre facoltà critiche non meno delle concezioni arcaiche che consideravano la natura come dotata di poteri sovrumani; l'etica deve contribuire al necessario processo di disincanto.
Questo scrupoloso esercizio della ragione critica domanda anzitutto la sforzo di distinguere il vero dal falso. Non è un compito semplice, come sembrerebbe a prima vista. Lo dimostrano clamorose gaffe di notizie diffuse per vere e rivelatesi successivamente delle mistificazioni. È fin troppo facile ingannare un'opinione pubblica abituata ad attendersi dal fronte della tecnologia biologica successi sempre più mirabolanti che offuscano i precedenti, mentre le conoscenze specialistiche diventano così sofisticate che solo un numero sempre più ristretto di scienziati è in grado di controllarle.
Un secondo esercizio di razionalità consiste nel distinguere l'importante dall'accidentale. L'elenco di ciò che è possibile ottenere mediante l'ingegneria genetica assomiglia alla "lista della spesa", dove troviamo mescolati i cibi più disparati. Scegliere il colore degli occhi dei propri figli ― supposto che sia tecnicamente possibile ― non può essere messo sullo stesso piano della possibilità di prevenire una grave anomalia genetica.
È necessario inoltre differenziare il giudizio dalle emozioni. Di ingegneria genetica e affini si parla per lo più con un linguaggio evocativo-mitologico: opera di "apprendisti stregoni", "bomba biologica", creazione del super-uomo e dello "scimpanzuomo", "cibo Frankenstein" per gli organismi geneticamente modificati... È un linguaggio per lo più intimidatorio, fatto per creare forti emozioni ― di arresa alla ricerca nella speranza o di rifiuto di essa nella paura ― piuttosto che riflessione critica. Di fronte a stati d'animo di questo genere la funzione di "gestione" dell'etica è quella di resistere alle suggestioni del linguaggio evocativo e di non far prevalere le emozioni sulla conoscenza.
La terza funzione dell’etica ― quella che abbiamo chiamato di legittimazione ― ci porta a correlare le conoscenze genetiche di base e le applicazioni della bioingegneria con i più alti ideali umani, che registrano un consenso generale circa l'alto valore morale della terapia. La possibilità di correggere un difetto genetico mediante l'inserimento nel genoma di un individuo di una copia sana del gene difettoso ha aperto una nuova epoca nella storia della medicina. Esiste un accordo generalizzato, espresso da documenti ufficiali di comitati etici e da regolazioni legislative, a limitare ― almeno provvisoriamente ― tali interventi alle cellule somatiche, escludendo le cellule della linea germinale (una modifica del genoma di questo genere trasmetterebbe l'alterazione alla progenie). I motivi dell'esclusione sono di natura prudenziale: questi interventi non hanno una base sperimentale
14
sufficientemente solida, tale da giustificare l'applicazione all'uomo. La terapia genica umana sulla linea germinale non può essere però esclusa per principio (Munson, Davis, 1992).
Per quanto grandi siano le potenzialità della nuova genetica, questa non è autorizzata moralmente a perseguire ogni risultato possibile. Deve preoccuparsi di tutelare il valore personale, ovvero di garantire a ciascuno di poter aver stima di sé. Una condizione essenziale per questo è che all'uomo sia attribuito un valore personale senza altre qualificazioni, sulla base della semplice appartenenza alla specie umana: non di un'appartenenza condizionata a certe caratteristiche (razza, sesso, salute...).
Ciò impedisce che chiunque possa avanzare la pretesa di farsi giudice e decidere per chi valgano i diritti umani. Non si è cooptati come membri della società umana sulla base di determinate qualità, bensì ognuno vi entra in forza di un proprio diritto. La nuova biologia deve vigilare su questa condizione, che possiamo chiamare "proibizione di una definizione". La biologia ― in altre parole ― non deve prestarsi a un'operazione che porti a escludere qualcuno dal diritto di essere accettato come essere umano se non è in possesso di determinate caratteristiche, ritenute indispensabili per partecipare all'esistenza.
La biologia può, di per sé, non prestarsi a operazioni che portano a escludere dal diritto di essere accettati come esseri umani se non si è in possesso di determinate caratteristiche; ma crea nuove scoperte che possono essere usate in questo senso. L'etica deve vigilare a priori o lasciare che si creino le massime condizioni e potenzialità di sviluppo e vigilare poi sulla loro applicazione?
Non deve essere il corredo biologico che ci porta a definire l'umanità, ma semmai il contrario: i sentimenti di umanità ― che includono la pietas e la sollicitudo per coloro che sono meno dotati dalla natura, compresi coloro che hanno dei deficit genetici ― devono guidare la biologia a non mettere le sue conoscenze a servizio della selezione tra uomo e uomo.
La sperimentazione con gli animali
"Tutti gli animali sono uguali ma...
alcuni sono più uguali degli altri"
(G. Orwell, La fattoria degli animali)
La bioetica, intesa come nuova consapevolezza del fenomeno della vita, ha costretto a riaprire l'agenda del rapporto con gli animali. Il dibattito filosofico, in particolare quello che verte sullo statuto morale degli animali e sulla possibilità di rivendicare i loro diritti, è in situazione di stallo, tra opposti estremismi. Intanto, però, ci sono questioni urgenti che hanno bisogno di soluzioni immediate. Quella dell'uso degli animali per la sperimentazione biomedica è una di queste.
Il fronte di opposizione ha storicamente occupato una posizione forte nell'immaginario qualificandosi come "antivivisezionista", e quindi attribuendo agli avversari il proposito di essere "vivisezionisti". Il termine "vivisezione", esteso a includere anche interventi che nulla hanno a che fare con il "tagliare vivi" gli animali, getta un'ombra di gratuita crudeltà su tutte queste pratiche. Pur essendosi già formato nella seconda metà del XIX secolo, il movimento non ha ottenuto visibilità che un secolo più tardi, con il vivace dibattito sull'Animal liberation e soprattutto per le azioni disturbanti degli attivisti del gruppo People for the Ethical Treatment of Animals (in sigla: PETA).
Tuttavia la sperimentazione con gli animali continua a essere diffusissima, anche se non si dispone di cifre sicure. L'obiettivo della totale abolizione appare più che mai lontano. La posizione assolutista è costretta a riconoscere che l'attacco all'utilità medica e scientifica della medicina costruita sulla sperimentazione animale è fallito. Le argomentazioni non riescono a far breccia nella fiducia incondizionata nella scienza che nutre la maggioranza della popolazione.
15
L'insuccesso dei paladini dell'abolizione della sperimentazione animale non dipende dalla debolezza delle loro argomentazioni. Per quanto convincenti queste possano suonare, non bastano a modificare i comportamenti. Il giudizio morale relativo alle nostre azioni non dipende solo da una valutazione razionale, ma anche da sentimenti e interessi. Ciò vale anche per i comportamenti umani nei confronti degli animali.
Un'illustrazione convincente è stata fornita da una ricerca condotta in un laboratorio da uno psicologo americano, Herold Herzog, sullo "statuto morale" dei topi. Le affermazioni massimalistiche sui diritti degli animali si scontrano con un dato di fatto: come aveva già scoperto George Orwell ne La fattoria degli animali, alcuni animali sono "più uguali di altri"! Inevitabilmente, noi facciamo una distinzione tra parassiti, animali nocivi e animali da compagnia, e modelliamo i nostri comportamenti su tali categorie. Nel laboratorio studiato da Herzog, conformemente alla nostra tendenza ad assegnare ruoli ed etichette, i topi venivano suddivisi secondo una triplice tipologia: quelli "buoni", sui quali erano condotti gli esperimenti, venivano trattati secondo le norme "umanitarie" previste dai regolamenti federali americani; quelli "cattivi" (per lo più topi fuggiti dalle colture, che minacciavano di inquinare ― e quindi rendere inservibili per le ricerche ― quelli "buoni") erano destinati a essere catturati in modo crudele, facendoli invischiare su tavole rivestite di pece; e infine i "topi da mangime", allevati appositamente per nutrire serpenti dello stesso laboratorio.
La conclusione che possiamo trarre dallo studio è che la psicologia, meglio della filosofia, ci permette di capire come gli esseri umani arrivino alle decisioni morali, in quanto i giudizi etici sono intrecciati in una matassa inestricabile fatta di emozioni, logica e interessi. Il dibattito sull'uso degli animali nella ricerca, perciò, non potrà essere risolto in modo soddisfacente né ricorrendo unicamente alla logica, né facendo appello alle emozioni.
Maggiori possibilità di modificare i comportamenti degli sperimentatori hanno gli antivivisezionisti moderati. Questi cominciano col riconoscere alcune sperimentazioni molto più giustificabili di altre e si limitano a richiedere che, precedentemente a ogni esperimento, siano valutati i benefici che se ne ricavano in rapporto ai costi (includendo tra questi la sofferenza degli animali). Questo atteggiamento porterebbe a valutare i vantaggi reali che ci si può ragionevolmente aspettare dalla sperimentazione, prendendo in seria considerazione i valori contrapposti. Si eviterebbe così lo scontro frontale tra una fazione che, a giustificazione di tutto ― anche di atti di inspiegabile crudeltà e barbarie ― inalbera un ombrello protettore con la scritta "scienza", e la fazione contraria che condanna qualsiasi utilizzo sperimentale degli animali in nome dell'"etica".
Molto promettente nel cammino indicato dai moderati appare la "regola delle tre R", proposta come modello di autoregolamentazione. Le tre R sono, rispettivamente, le iniziali di Restriction (vale a dire, limitazione degli animali impiegati nella sperimentazione), Refinement (miglioramento delle metodologie, con particolare riguardo a quelle che risparmiano dolore agli animali) e Replacement (sostituire gli esperimenti in vivo sugli animali con l'uso di colture di tessuti o con modelli computerizzati).
La regola delle tre R viene dal passato: l'hanno proposta nel 1959 due studiosi inglesi, Bill Russel e Rex Burch, quale modello teorico che assicurava un approccio più etico alla sperimentazione animale. Di recente il III Congresso internazionale sulle alternative nella sperimentazione animale, tenutosi a Bologna nell'estate 1999, l'ha riproposta come la principale via, teorica e pratica, che coniuga etica e ricerca scientifica con uso degli animali (Vitale, 2000). La ricerca di un consenso su concrete regole procedurali, anche senza aver trovato un accordo sulle questioni filosofiche ed etiche di fondo, esprime efficacemente la vocazione della bioetica contemporanea a dare risposte pragmatiche a problemi che sono e appaiono insolubili se affrontati in linea di principio.
16
Brevettare la vita? Nuovi equilibri mondiali
L'idea di un brevetto posto su organismi viventi suscita immediate reazioni. È molto probabile che un moto di rifiuto istintivo preceda il tentativo stesso di capire quale sia il contenuto scientifico e pratico del brevetto in ambito biologico. Slogan di questo genere, destinati a un uso retorico, hanno segnato il successo di movimenti di piazza come quelli che hanno accompagnato la riunione mondiale di Seattle sul commercio degli organismi geneticamente modificati (OGM) nel 1999 e che si ripropongono puntualmente ogni volta che si riuniscono i vertici dell'establishment mondiale del commercio e del potere economico.
Sull'idea di brevetto in quanto tale non è mai caduta, finora, una condanna sociale a priori. Piuttosto, il brevetto si presenta come una specie di patto implicito tra l'inventore e la società, che si risolve a beneficio comune. Il brevetto non conferisce alcun titolo di proprietà sugli oggetti; è solo una forma di proprietà intellettuale dell'inventore, che permette lo sfruttamento commerciale della sua invenzione in cambio di un monopolio limitato. I profitti che realizza il brevettatore sono accompagnati da vantaggi per la società intera, che partecipa dei benefici della ricerca.
Come mai un meccanismo che ha dato buona prova di sé in tanti ambiti della vita sociale suscita perplessità quando viene applicato alla biologia, in particolare alla ricerca genetica? "Nel complesso, le scienze dell'informazione e le scienze biologiche, cioè computer e geni, domineranno buona parte della vita economica del ventesimo secolo": è la previsione attendibile del futurologo Jeremy Rifkin, che ha esaminato in modo molto documentato il delinearsi dell'era in cui il successo non sarà determinato dal possesso delle cose, ma dalla possibilità di accedere alle informazioni (Rifkin, 2000). Questa frontiera è destinata a modificare i rapporti che l'individuo ha con la realtà materiale del proprio corpo e ― prospettiva non meno preoccupante ― ad aumentare le disuguaglianze sia all'interno dei paesi ricchi, sia tra questi e i paesi poveri.
È eticamente lecito brevettare un farmaco (per esempio un vaccino) sapendo che questo comporta un'esclusiva di produzione da parte di chi acquista il brevetto e un aumento dei costi che può rendere i vaccini inaccessibili, per esempio ai Paesi in via di sviluppo? Non brevettare un vaccino metterebbe tutte le industrie farmaceutiche nelle condizioni di produrlo e la concorrenza farebbe cadere i prezzi, ma il prodotto sarebbe fruibile anche per Paesi poveri. Quando l'etica si scontra con il mercato, come esercita la funzione di legittimazione e gestione?
Un celebre caso clinico e giudiziario ha inaugurato, all'inizio degli anni Novanta, l'epoca dell'espropriazione del diritto di proprietà che ritenevamo più assoluto: quello sul proprio DNA, ovvero sulle cellule che costituiscono il proprio corpo. John Moore era stato in cura presso la clinica universitaria di Los Angeles per una rara forma di tumore. Un ricercatore di quella università aveva scoperto che la milza di Moore produceva una proteina ematica che favoriva la moltiplicazione dei globuli bianchi. Dai tessuti della milza del paziente era stata prodotta una coltura cellulare, brevettata come "invenzione". Quando Moore venne a sapere che parti del suo corpo erano state brevettate senza il suo consenso ― e soprattutto che il valore della coltura era stimato più di tre miliardi di dollari ― fece causa all'università, reclamando un diritto di proprietà sulle proprie cellule. La Corte suprema della California, chiamata a decidere il caso, accettò invece la tesi dell'università di Los Angeles, secondo cui la proprietà intellettuale coperta da brevetto non erano i tessuti del sig. Moore, bensì la coltura cellulare: questa era riconosciuta e tutelata dalla legge. La proprietà delle cellule era indifferente rispetto al brevetto, e quindi il proprietario era escluso da questo e dagli utili economici connessi. Di conseguenza, se il sig. Moore dovesse trovarsi in futuro nella necessità di utilizzare per una terapia medica la coltura cellulare tratta dalla sua milza, dovrebbe pagare l'accesso alla proprietà intellettuale di chi ha brevettato la coltura!
17
La genetica oggi è correntemente utilizzata per creare prodotti farmaceutici e agricoli. Dal punto di vista formale, non si può dire che venga brevettata la vita; è pur vero, però, che i geni dotati di particolare valore commerciale vengono brevettati e, agli occhi della legge, diventano invenzioni. Le componenti di creature viventi (geni, cromosomi, cellule e tessuti) possono essere considerate proprietà intellettuale di chiunque ne isoli per primo le proprietà, ne descriva le funzioni e ne individui le applicazioni commerciali utili.
La protesta di Seattle e il movimento di opposizione agli OGM che ne è nato sono particolarmente allarmati dalle ripercussioni che questa situazione può avere nell'ambito dell'agricoltura. Grazie ai diritti sulla proprietà intellettuale, poche grandi multinazionali saranno presto in grado di controllare l'intero patrimonio di sementi del pianeta. Per la prima volta nella millenaria storia dell'umanità, gli agricoltori non saranno più autorizzati a riservare una parte del raccolto per la semina dell'anno seguente: le aziende del settore, infatti, cedono in affitto per una sola semina le sementi che hanno brevettato. Gli agricoltori dovranno ricomprarle per ogni nuova semina.
Per evitare "furti" da parte degli agricoltori, alcune aziende hanno inserito nelle piante di tabacco ― e presto anche in altre specie di vegetali ― un gene che impedisce alla pianta di essere fertile. Questa tecnologia ― ribattezzata con amara ironia terminator technology ― rende superflua ogni vigilanza poliziesca delle multinazionali sui propri prodotti; ma per "milioni di coltivatori, la cui sopravvivenza è legata ai semi che riescono ad accumulare e a scambiare con i vicini, in un commercio informale e sotterraneo, dover negoziare con le multinazionali delle bioscienze un accesso alle sementi limitato a un unico ciclo produttivo, può significare un passo verso il baratro" (Rifkin, 2000).
Un discorso analogo vale nell'ambito della zootecnia: se un animale è clonato e brevettato, le sue copie sono considerate proprietà del titolare del brevetto; per ogni clone o cucciolo prodotto, bisognerà pagare una royalty al proprietario del brevetto. Questo scenario induce un cambiamento di segno nelle tecnologie rivolte a modificare geneticamente gli organismi. Esse si presentano come una generosa promessa all'umanità di fecondità e abbondanza. Ricorrendo al linguaggio simbolico della Bibbia, è come se la profezia dei tempi messianici si fosse realizzata, con una opulenza inimmaginabile riversata sul popolo che conosceva solo magri prodotti strappati alla terra "con il sudore della fronte". In Isaia, in particolare, la pienezza dei tempi è raffigurata come un lauto convito, preparato per tutti i popoli (Isaia 25,6); vi potranno partecipare tutti quelli che hanno fame, "anche se non hanno denaro" (Isaia 55,9).
La tecnologia applicata agli organismi vegetali e animali sembra la risposta a quelle attese espresse in termini mitici: assicura la fine della scarsità e l'entrata nell'Eldorado di una natura non più matrigna cattiva, ma generosa nutrice dei suoi figli ingegnosi. Il fascino di questo simbolo struttura sotterraneamente anche i racconti evangelici, là dove vengono descritti eventi eccezionali come pochi pani e pochi pesci che sfamano moltitudini (Matteo 14,13-21): nei tempi della "pienezza" la salvezza si presenta come una risposta efficace ai problemi della scarsità e del bisogno.
Chi guarda con un senso di allarme alle biotecnologie teme che, invece della promessa messianica, esse realizzino uno scenario opposto. Per utilizzare ancora il linguaggio evangelico, si può verificare la sentenza posta a commento dalla parabola dei talenti, affidati in misura diversa ai vari servitori: "A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha" (Matteo 25,29). Anche per la biologia si può realizzare quella "nemesi" che Ivan Illich ha denunciato per la medicina: le benedizioni promesse si tramutano in maledizioni (Illich, 1991). La prospettiva dei ricchi che diventano sempre più ricchi e dei poveri che scivolano inesorabilmente verso una più nera povertà ― cioè il triste spettacolo che abbiamo quotidianamente sotto i nostri occhi ― può subire un'accelerazione mediante le biotecnologie.
18
Di chi deve essere il controllo della produzione di prodotti vitali per la salute pubblica? Può essere lasciato al privato o ci deve sempre essere una forma di controllo pubblico? Lo stesso vale per la gestione di servizi (per esempio quelli sanitari e sociali) fondamentali per il benessere di una popolazione. Come sta intervenendo l'etica nel dibattito sulla privatizzazione di questi servizi?
Non è realistico pensare che si possa scavalcare il sistema dei brevetti nell’ambito biotecnologico. Quando la ricerca è condotta con fondi privati, non si può escludere il profitto. E il mercato. Ma il mercato non può essere l’unico motore della ricerca genetica applicata. Lasciata alle regole del mercato, la società premia chi ha e penalizza chi non possiede. Le biotecnologie sono, di fatto, in mano a poche, ricchissime multinazionali. E si spiega: questi interventi sul materiale biologico non si possono improvvisare nei sottoscala, pasticciando con le provette. Si tratta di una ricerca che ha bisogno di grandi investimenti, che solo le imprese più potenti possono permettersi; con la prospettiva di ricavarvi utili adeguati.
Il male non sta nel guadagno, ma nel danno che rischiano di subire i più poveri. Chi non ha... perderà anche quello che ha! Il mercato non è sinonimo di peccato: è uno dei sistemi più efficaci per indurre a produrre e a scambiare beni e servizi. Ma non possiamo lasciare tutto al mercato, perché le sue leggi fanno soccombere i più deboli. Quando si tratta di togliere loro il pane ― in senso letterale, secondo le prospettive che abbiamo considerato probabili per l’agricoltura del futuro ― le ingiustizie del mercato diventano particolarmente odiose. Sono necessarie forme di controllo pubbliche, che concilino gli interessi del mercato con il bene della comunità. Per questo le biotecnologie sono un tema politico, e la politica ― nel suo significato più alto ― non può evitare di monitorarne lo sviluppo e le applicazioni. Per fare giustizia agli svantaggiati. Ovvero ― per ricorrere ancora una volta al linguaggio della Bibbia ― perché la terra è di tutti.
19
Firenze, San Martino dei Buonomini
San Martino divide il proprio mantello con un povero infreddolito
Fra' Antonio Pierozzi, priore del convento di San Marco, nella primavera del 1442 convocò nella sua cella dodici concittadini di diversi ceti sociali ― notai, mercanti, artigiani ― per creare quella congregazione di beneficenza che divenne nota con il nome Buonomini.
La giovane istituzione all'inizio non aveva sede. A partire dal 1478 prese in affitto dai benedettini, per un canone annuo di 12 fiorini, un locale confinante con la chiesa di San Martino del Vescovo, costruita nel 968. Questa sala poco tempo dopo passa ai Buonomini. Fu ristrutturata, trasformata in oratorio e decorata con un ciclo di affreschi.
Il fondatore pose l'istituzione sotto la protezione di San Martino, che aveva diviso il proprio mantello con un povero. San Martino nel medioevo aveva un ruolo importante come santo dei poveri, insieme a San Nicola, venerato dai marinai di Bari, finché la sua fama venne in parte oscurata da quella di San Francesco d'Assisi.
La scena del mantello, simbolo dell'amore per il prossimo, racconta un episodio della vita di Martino, al tempo in cui era un legionario romano. Egli ha pietà di un povero infreddolito che incontra sulla sua strada e divide in due il mantello con la spada per darne la metà al bisognoso. La scena si svolge fuori dalla cinta muraria della città di Amiens. In lontananza si vede in cima a una collina la cattedrale gotica, segno che il gesto di misericordia avviene in nome della cristianità.
Nell'affresco seguente del ciclo è rappresentato il sogno di San Martino, nel quale il Cristo gli si rivela come il povero infreddolito, vestito con la metà del mantello donato. Questo tema costituisce un parallelo iconografico all'episodio di Matteo 25,40: "Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avrete fatta a me".
Christina Riebesell
20
21
capitolo
2
I SISTEMI SOCIALI E SANITARI
"SALUTE PER TUTTI": UTOPIA 0 POLITICA?
La riflessione etica sui sistemi sanitari
Quando nel 1978 venne pubblicata negli Stati Uniti l'Enciclopedia di bioetica, un'opera in quattro volumi che presentava la nuova disciplina, il curatore Warren Reich propose una definizione che sottolineava le diversità nei confronti della tradizionale etica medica. Per bioetica proponeva di intendere lo "studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e delle cure sanitarie, in quanto questa condotta è esaminata alla luce dei valori e dei principi morali". Il passaggio dall'etica medica alla bioetica comportava un allargamento della prospettiva: non si trattava solo di esaminare il comportamento nell'ambito della medicina, ma nel più ampio settore della sanità. La salute, infatti, dipende solo in minima parte da attività mediche; molto di più pesano le decisioni di politica sanitaria e, più in generale, il livello di civiltà di un Paese.
È ormai largamente condivisa l'idea che l'assistenza medica per sé sola ha contribuito in misura comparativamente modesta ai progressi più importanti realizzati nei secoli passati sul terreno dello stato di salute della popolazione. Altrettanto diffusa è la convinzione che l'impegno per la promozione della salute e per la prevenzione delle malattie deve investire anche settori della società diversi dalla medicina, per esempio l'istruzione e i mezzi di informazione. L'assistenza medica è un sottoinsieme dei sistemi di assistenza sanitaria e questi sono dei sottoinsiemi di contesti politici e sociali ancora più vasti.
Hastings Center, Gli scopi della medicina, 1997
L'Enciclopedia di bioetica nella sua prima edizione conteneva solo in nuce quella consapevolezza dei nuovi problemi etici su vasta scala che sarebbero emersi negli anni Ottanta e soprattutto nel decennio successivo. La voce "Razionamento del trattamento medico" (che assume come equivalente il concetto economico di "razionamento" e quello più comune alla letteratura etica di "allocazione" delle risorse) identifica un compito importante per la bioetica: esplicitare, anche nei confronti del pubblico, i criteri utilizzati dai medici nell'assegnazione delle risorse scarse. L'accesso alla dialisi e il trapianto renale erano considerati all'epoca come paradigmi per tutte le altre risorse limitate. Il ruolo individuato per l'etica non è tanto quello di identificare il sistema perfetto; le si assegna piuttosto il compito di esplicitare i criteri ingiusti o ingiustificati, che spesso vengono utilizzati dai medici in modo inconsapevole.
Se il valore della vita è universale, è etico un sistema che nega l'accesso a cure costose per una persona, perché questo drenerebbe le risorse necessarie per garantire cure di base per molti? È più etico lasciare
22
questa scelta, di volta in volta, al singolo medico, o definire delle regole esplicite, da rispettare, e che non consentono di tener conto delle storie individuali?
La scelta tra diversi bisogni sociali e quella relativa alla preferenza da dare alla medicina preventiva o a quella curativa all'epoca della redazione dell'Enciclopedia cominciavano appena a emergere all'orizzonte dei problemi teorici. Anche l'articolo sulla "Giustizia" affronta il tema dell'allocazione delle risorse sanitarie scarse. Come parametro di riferimento vengono utilizzate le esigenze che derivano dalla giustizia distributiva: come devono essere distribuite le risorse sanitarie tra i cittadini di uno stato democratico? Problemi di questo genere devono essere regolati da procedure di libero mercato, da un calcolo utilitaristico, oppure da un diretto riferimento a un principio di giustizia, che proclama un uguale diritto per ogni persona alla cura della salute, indipendentemente dal reddito, dalla posizione geografica o dai servizi resi alla società?
Non manca nel disegno dell'Enciclopedia neppure l'abbozzo di una prospettiva assolutamente innovativa per l'etica: quella degli obblighi nei confronti delle generazioni future e del loro benessere, che pongono dei vincoli al nostro uso delle risorse, all'impatto dello sviluppo sull'ambiente e alla crescita demografica incontrollata (queste considerazioni vengono sviluppate dalle voci "Etica ambientale" e "Obblighi verso le generazioni future"). È questo orizzonte più vasto che differenzia la bioetica rispetto alla riflessione che tradizionalmente si è svolta in margine alla pratica della medicina.
L'etica medica ha aiutato e aiuta ancora a risolvere problemi morali che nascono nell'ambito dell'erogazione delle cure. Ma ci sono problemi strutturali che riguardano i sistemi sanitari stessi, se questi permettono solo ad alcuni di accedere ai servizi ed escludono altre categorie di persone. La bioetica si propone di guardare anche al contesto dell'erogazione delle cure, ponendo questioni che non riguardano il singolo operatore, ma la società nel suo insieme. Ci impedisce così la buona coscienza che ci potrebbe far sentire "morali" ― perché ci ispiriamo ad alti principi e motiviamo correttamente le nostre azioni ― pur operando in contesti oggettivamente "immorali", perché sono a servizio dell'ingiustizia.
Salute a dimensione planetaria
Nella bioetica, che si assume il compito di valutare con criteri etici l'organizzazione dei sistemi sanitari, è confluita una nuova coscienza relativa ai problemi di salute e benessere dell'umanità che si è andata formando nella seconda metà del XX secolo. Le espressioni più alte sono state le dichiarazione programmatiche dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
La fondazione dell'OMS risale al 1946. Gli intenti e il linguaggio sono quelli del dopoguerra, segnato dalle esperienze delle dittature che avevano conculcato i più fondamentali diritti umani e dalle devastazioni di conflitti totali. La volontà di operare sotto il segno contrario, quello della pace, aveva portato nel 1945 a fondare l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU). L’anno seguente le nazioni che uscivano dalla guerra si proponevano, fondando l'OMS, di estendere a tutti il riconoscimento del diritto alla salute. Secondo la programmazione programmatica,
Godere del più alto livello conseguibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di convinzioni politiche, di condizione economica o sociale.
Alla dichiarazione teorica era necessario far seguire programmi concreti e iniziative pratiche. Gli sviluppi degli anni seguenti hanno portato al crollo degli imperi coloniali e all'emergere della dolorosa realtà del sottosviluppo. Anche se la promozione di una coscienza civile per combattere la povertà cooperando allo sviluppo faceva parte degli scopi statutari dell'ONU, per più di trent'anni gli sconvolgimenti sul piano internazionale, accompagnati dalla creazione dei due
23
blocchi ideologico-economici, impedì di tradurre in programmi le dichiarazioni di principio relative al diritto alla salute. Solo nel 1978, in occasione della conferenza internazionale sulla medicina di base fu lanciato il programma "Salute per tutti entro l'anno 2000". Il programma è noto anche come Dichiarazione di Alma Ata, dal luogo dove era stato formulato l'anno prima.
L'aspetto più vistoso della dichiarazione era costituito dall'indicazione temporale: proporsi di realizzare "la salute per tutti" a poco più di 20 anni dalla scadenza del 2000 voleva dire rinunciare a un programma realistico per adottare il linguaggio dell'utopia. O quanto meno puntare sull'effetto slogan per trasmettere un messaggio pubblicitario. Questo intendeva veicolare, più che una scadenza temporale, alcune accentuazioni che costituiscono il significato storico permanente della Dichiarazione. Anzitutto la nozione di salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale:
La salute come stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale dell'uomo e l'accesso a un livello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente importante, d'interesse mondiale, e presuppone la partecipazione di numerosi settori socio-economici, oltre che di quelli sanitari.
Ciò significa che non si può ottenere migliore salute investendo unicamente nel settore sanitario: per la salute è necessario il concorso di altri settori sociali ed economici. La "salute per tutti" è un obiettivo che non si può dissociare dal superamento del sottosviluppo economico e da un nuovo ordine economico del mondo.
Un secondo elemento qualificante della Dichiarazione è la priorità data alla medicina di base. La Dichiarazione la definisce come
la cura indispensabile della salute fondata su metodi pratici, scientificamente solidi e socialmente accettabili, e su una tecnologia resa universalmente accessibile a individui e famiglie della comunità, tramite la loro piena partecipazione e a un costo che la comunità e il Paese possano sostenere a ogni stadio del loro sviluppo con spirito di autogestione e di fiducia in se stessi.
L'indicazione era un forte invito a non guardare nella direzione percorsa dalla medicina di punta, altamente tecnologica, dei paesi ad alto sviluppo. L'idea di cooperazione internazionale che consiste semplicemente nell'importare modelli e strutture sanitarie nelle zone di sottosviluppo andava rimessa profondamente in discussione.
Alcune pratiche di medicina "non tradizionale" si stanno rivelando di efficacia documentata, per esempio l'agopuntura, la chiropratica. Per altre, l'efficacia è ben lungi dall'essere stata dimostrata (fiori di Bach, aromaterapia...). Il dibattito si è svolto prevalentemente sul piano emotivo e scientifico: la scienza chiede che questi trattamenti siano sottoposti a verifiche con studi e sperimentazioni cliniche. Qual è il ruolo della bioetica rispetto a una posizione di rigore (più o meno intransigente) da parte della comunità scientifica e a una realtà che vede un uso sempre più diffuso di queste pratiche? Non solo nei Paesi economicamente sottosviluppati ma anche nel contesto occidentale, dove diventano sempre di più un oggetto di mercato?
Un'applicazione pratica, contenuta nella Dichiarazione di Alma Ata, era l'invito a far affidamento a livello locale sugli addetti alla sanità ― medici, infermieri, levatrici, ausiliari e altri operatori comunitari ― e sulle pratiche tradizionali. La Dichiarazione propone di istruire i terapeuti tradizionali, socialmente e tecnicamente, per lavorare in équipe sanitarie, rispondendo agli specifici bisogni della comunità. Come fa notare un profondo conoscitore dei sistemi terapeutici tradizionali, "chi ha ispirato una direttiva del genere era ovviamente libero dagli stereotipi e dai pregiudizi che ancora attualmente circondano la categoria dei terapeuti tradizionali e, in genere, degli operatori tradizionali del culto con i quali spesso si identificano; inoltre conosceva bene il
24
servizio che, in base a concezioni e conoscenze empiriche recepite dalla tradizione e confermate dall'esperienza e nonostante tutte le inefficienze, possono rendere ai propri simili, altrimenti del tutto abbandonati a se stessi. Nulla di più errato e deleterio di definire con la qualifica di stregone e di stregoneria i praticanti terapeuti tradizionali e l'attività che essi svolgono. I terapeuti tradizionali sono potenzialmente suscettibili di istruzione scientifica e le loro conoscenze empiriche, specialmente quelle sulle erbe medicinali, si prestano a essere scientificamente analizzate e, se nel caso, confermate" (Bernardi, 1998).
Alla vigilia della scadenza enfatica del 2000, e a vent'anni dalla Dichiarazione di Alma Ata, l'OMS ha riproposto il programma "Salute per tutti". Il nuovo testo, che porta la data del 28 aprile 1997, non propone più una scadenza temporale, ma indica il XXI secolo come l'orizzonte entro il quale realizzare la "salute per tutti". L'analisi del quadro generale entro cui si colloca il programma non tralascia nessuno dei punti oscuri della situazione attuale: la povertà crescente dei Paesi del sottosviluppo, la disintegrazione sociale, il degrado ambientale, le incertezze demografiche ed epidemiologiche, le insufficienze delle risposte date finora al problema della salute. Eppure non viene lasciato cadere il progetto di dare una risposta globale al bisogno di salute. Probabilmente in base alla consapevolezza che, finché il mondo nel suo insieme continua a essere un sistema immorale, non ci possono essere isole di moralità da nessuna parte.
Come le scelte della Banca mondiale influenzano la salute
Le politiche rivolte alla prevenzione sono influenzate dal clima culturale generale, dagli slogan e dagli orientamenti che costituiscono lo spirito di un'epoca. Il periodo molto creativo di riflessione sulle condizioni della salute, non disgiunto da forme di critica alla medicina, che si era aperto dopo la Seconda guerra mondiale, si conclude con la fine degli anni Settanta. Una concentrazione di saggi di forte spessore concettuale corona questa fase: Nemesi medica di Ivan Illich (1976); La medicina: mito, miraggio o nemesi? di Thomas McKeown (1978); L'inflazione medica di Archibald Cochrane (1978); L'ordine cannibale. Vita e morte della medicina di Jacques Attali (1979). È il periodo in cui nei Paesi industrializzati dell’Occidente giunge a maturazione la concezione della salute come diritto e si formulano programmi di sanità pubblica come quello che prevede la "Salute per tutti per l'anno 2000" dell'OMS. Ma con gli anni Ottanta il pendolo fa un'oscillazione nella direzione opposta.
Le crisi petrolifere di quegli anni, con i loro effetti negativi sull'economia mondiale, determinarono ovunque una fase di grave recessione. La ricetta adottata fu quella del liberismo, come antitesi alle politiche di welfare state (come punti di riferimento, si ricordi che il 1979 è l'anno della nomina a primo ministro di Margareth Thatcher in Gran Bretagna e nel 1980 Ronald Reagan assume la presidenza degli Stati Uniti). "Il vento liberista spira forte in Occidente e investe tutti i settori della vita della società, non ultimo quello della sanità. La salute è concepita come un bene individuale. In quanto tale, la sua tutela investe la sfera della responsabilità individuale e non collettiva; pertanto non deve pesare sui bilanci pubblici, che tendono ad assottigliarsi parallelamente alla diminuzione della pressione fiscale. Si afferma il principio che il sistema sanitario va considerato al pari di qualsiasi altro settore economico, ordinato (meglio dire "disordinato", visto che la parola d'ordine è deregulation) dai meccanismi del mercato, della produzione e della competizione" (Maciocco, 1994).
La Banca mondiale ― un'organizzazione molto potente a cui sono di fatto affidate le sorti delle economie povere del pianeta attraverso il meccanismo della concessione dei prestiti ― negli anni Ottanta fece propria la linea reaganiana per il "risanamento" delle economie dei Paesi più poveri e indebitati. I Paesi che richiedevano prestiti dovevano impegnarsi ad applicare rigidamente le politiche "suggerite" dalla Banca mondiale. Queste prevedevano drastici tagli nei consumi e nella spesa pubblica, inclusi i servizi sociali come sanità ed educazione; privatizzazioni in tutti i settori; decentramento e bassissimo profilo dello stato centrale.
25
Siena, Santa Maria della Scala: Pellegrinaio
Domenico di Bartolo: La distribuzione delle elemosine
L'ospedale di Santa Maria della Scala aveva, già fin dal 1305, uno statuto che servirà in seguito da modello anche per altri ospedali.
Con riferimento alla nostra scena, negli statuti veniva stabilito che i "Fratres" dovessero distribuire pagnotte intere agli affamati e ai "poveri vergognosi" della città. La distribuzione delle elemosine non aveva luogo necessariamente nell'ospedale stesso: essa poteva avvenire anche sulla strada o in chiesa.
La scena si svolge nella chiesa ospedaliera di Santa Maria della Scala. Sullo sfondo si vede il trittico dell'altare e attraverso il portale della chiesa aperto si intravede il portale principale del duomo, che si trova di fronte, con le sculture delle lunette di Giovanni di Cecco, oggi perdute. Sulla destra del quadro si osserva un confratello, che da un cesto stracolmo distribuisce pagnotte, sulle quali è stato inciso il segno della Scala. Gli si affollano attorno soprattutto bambini, donne con lattanti in braccio, vecchi e pellegrini. In primo piano, a destra, è ritratto uno storpio o ferito con la gamba sinistra fasciata: non è in grado di camminare, per questo deve usare le mano per spostarsi. Per non ferirsi ha legato con cordicelle di cuoio dei pezzi di legno sotto le mani e sotto la gamba sinistra.
La distribuzione delle elemosine non si limita tuttavia alle pagnotte, come mostra la scena al centro della composizione dove un indigente nudo viene coperto con un manto da un religioso. Da sinistra avanzano personalità vestite in modo elegante: sono benefattori dell'ospedale che adesso diventano testimoni delle opere di beneficenza da esso esercitate.
Christina Riebesell
26
Nel documento dedicato alla sanità del 1987 (Financing health services in developing countries. An agenda for reforms) la Banca mondiale teorizzava che la salute è un bene di consumo (in inglese: commodity), a disposizione di chi ha la possibilità e la volontà di pagarsela; affermava inoltre che considerarla un diritto di cittadinanza, tentando di fornire l'assistenza gratuitamente a tutti, "generalmente non funziona". In linea con questi principi, venivano fomite le seguenti indicazioni per ristrutturare i servizi sanitari:
● introdurre presso le strutture sanitarie pubbliche forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;
● promuovere programmi assicurativi;
● favorire la privatizzazione dei servizi sanitari;
● decentralizzare il governo della sanità.
La Banca mondiale è diventata l'organismo con più capacità, competenze e risorse per fare ricerca in salute pubblica: questo rimanda all'amara constatazione che, al di là delle dichiarazioni di principio, la sanità è diventata competenza diretta di un ente finanziario-economico. Peraltro, anche i programmi sanitari hanno come criterio di programmazione e valutazione le risorse economiche dichiarate più o meno disponibile. E non sempre discusse alla luce dei dati forniti dai Ministeri della Sanità.
Il primo elemento ― far pagare le prestazioni sanitarie nel punto di erogazione del servizio; in inglese si usa l'espressione user fees ― è quello fondamentale. Nella logica di liberalizzazione e privatizzazione dei sistemi sanitari, il pagamento delle prestazioni è una condizione previa per l'avvio dei sistemi assicurativi privati: se i pazienti non sono costretti a pagare, non hanno l'incentivo ad assicurarsi contro i rischi di un evento catastrofico.
La privatizzazione dei servizi e il decentramento della programmazione completano la strategia che tende a ridurre al minimo il ruolo dello Stato in sanità, per lasciare il posto a un sistema basato sull’assistenza privata e sulle assicurazioni. È opportuno considerare che "raccomandazioni" di questo genere venivano rivolte a paesi con popolazioni poverissime, con redditi pro capite annui intorno ai 100-200 dollari, con speranza di vita intorno ai 50 anni e tassi di mortalità infantile di gran lunga superiore al 100 per mille.
Con queste politiche la Banca mondiale ha largamente contribuito a determinare il degrado e l'impoverimento dei Paesi meno sviluppati del pianeta. L'ondata ultraliberista, rivolta a fare del mercato il meccanismo primario per distribuire i servizi sanitari, ha accumulato danni non solo nei Paesi più poveri del Terzo mondo, ma anche negli stessi Stati Uniti (l'iniquità del sistema è ben nota e spesso denunciata: circa 38 milioni di cittadini sono privi di qualsiasi forma di assistenza; inoltre il costo della spesa sanitaria è doppio rispetto alla media degli altri Paesi industrializzati).
In una sanità da pianificare, in funzione delle risorse e degli investimenti, i controllori delle risorse (cioè i produttori di servizi e tecnologie da vendere in una differenziazione sempre più sottile tra pubblico e privato) rischiano di non essere più interessati alle persone e ai loro bisogni, che diventano delle variabili, tra le tante, da introdurre e validare in modelli produttivi. È accettabile che i diritti sanitari dei tanti continuino a essere in competizione (dialetticamente? eticamente?) con i diritti economici?
Con un documento del 1993 ― Investing in health ― la Banca mondiale ha rivisto criticamente le proprie posizioni. Non solo il documento ammette i limiti del mercato in campo sanitario e gli effetti devastanti sulla salute della popolazione che hanno avute le misure di risanamento economico proposte, ma propone soluzioni che si rifanno alla Dichiarazione di Alma Ata. Si afferma che la salute è una componente intrinseca dello sviluppo e che è responsabilità dei governi tutelarla.
27
Il messaggio centrale del rapporto è che i governi devono "investire in salute", garantendo a tutti i cittadini un determinato livello di servizi. Nel pacchetto dei servizi clinici essenziali e di interventi di sanità pubblica da erogare a livello distrettuale sono compresi: assistenza prenatale e al parto, trattamento dei bambini malati, della tubercolosi, delle malattie sessualmente trasmesse, delle infezioni minori e dei traumi, la gestione di alcune emergenze, come le fratture e le appendiciti.
La spinta in senso sociale della Banca mondiale non si è esaurita negli anni seguenti (cfr. Maciocco, 1999). Un rapporto del 1997 raccomanda di rafforzare il ruolo dello Stato.
Per rendere lo sviluppo stabile e sostenibile lo Stato deve attuare politiche sociali che assicurino la distribuzione della crescita al fine di ridurre la povertà e le ineguaglianze: ciò è possibile solo se i governi mettono i "fondamenti sociali" in cima alla lista delle priorità. Troppo spesso politiche e programmi distolgono risorse e servizi dai gruppi di popolazione che ne hanno maggiore bisogno.
Nello stesso anno la Banca mondiale ha creato un nuovo settore strategico, chiamato "Salute, nutrizione e demografia". Nel documento programmatico si afferma che l'esperienza dimostra che l'accesso universale ai servizi è il modo più efficace per tutelare i poveri. Riguardo al finanziamento dei sistemi sanitari, si riconosce che in sanità il mercato può fallire e che proprio per questo il sistema assicurativo privato non è un'opzione adatta per i Paesi a basso e medio reddito.
Il rapporto annuale 2000-2001, infine, propone, fin dal titolo, di lanciare un "Attacco alla povertà".
La povertà in mezzo alla ricchezza è un affronto ai valori universali. Ci sono molte dimensioni della povertà, ma noi ci troviamo di fronte a diffusi livelli di vita inaccettabilmente bassi. Il mondo ha i mezzi per attaccare vigorosamente la povertà.
La povertà non è solo una dimensione economica. La Banca mondiale suggerisce che nella lotta contro la povertà vengano presi in considerazione e rafforzati tutti i capitali che sono alla base dello sviluppo di una comunità: il capitale umano (la salute, l'istruzione), il capitale naturale (la protezione e la disponibilità delle risorse naturali: la terra, l'acqua), il capitale fisico (le abitazioni, l'igiene ambientale), il capitale sociale (le relazioni e le aggregazioni sociali, la partecipazione).
L'evoluzione della lettura che la Banca mondiale dà dei fatti globali e delle ricette per porre rimedio ai mali si accompagna all'evoluzione della sua presenza nel settore sanitario. Anche attraverso la sua ottica, non certamente indiziabile di essere troppo incline a umanesimi utopistici, la salute appare come un momento strutturale dell’ordine del mondo.
LA PRESSIONE DELL’ECONOMIA SUI MODELLI SANITARI
Tra economia, politica e sanità si stanno intrecciando delle relazioni conflittuali che sfociano talvolta su scelte drammatiche. Invocando l'etica in una situazione così configurata, rischiamo di farle giocare un ruolo polemico e sgradevole: quello di chi si limita a denunciare le scelte che la società e i sanitari sono costretti a fare, sotto la pressione della stretta economica, richiamandosi ai valori fondamentali della convivenza sociale e agli inalienabili diritti umani.
Dall'etica ci aspettiamo, ovviamente, che sappia dire dei chiari "no" nei confronti di decisioni di politica sanitaria che appaiono in conflitto con ciò che riteniamo moralmente buono; ma non solo questo. Nella difficile situazione in cui ci troviamo, nella quale è sempre più arduo conciliare cura della salute ed economia, l'etica può e deve diventare una risorsa a cui attingere, e non solo un sistema di semafori a luce verde o rossa. È questo ampio spettro di compiti
28
dell'etica ― da quello più negativo di controllo e di eventuale condanna di comportamenti a quello più elevato di animazione ideale ― che costituisce l'apporto della bioetica contemporanea confrontata con i sistemi sociali e sanitari.
Per fissare con un esempio eloquente il tipo di problemi che le società a sviluppo economico avanzato sono costrette ad affrontare, possiamo riferirci a una decisione presa in ambito di programmazione sanitaria. Nella primavera del 1987 la Divisione di "Servizi per adulti e famiglie" dello stato nord-americano dell'Oregon, incaricata di amministrare il programma statale "Medicaid", si trovò costretta a decidere tra diverse opzioni. Per ragioni di tetto di bilancio, nei due anni seguenti "Medicaid" poteva o finanziare l'estensione delle cure mediche di base a 1500 persone che in precedenza non ne beneficiavano, oppure continuare a finanziare un programma di trapianto di organi (midollo, cuore, fegato e pancreas) per un progetto rivolto a 34 persone. La Divisione, obbligata a scegliere tra l'interruzione di un programma di trapianti per pochi e l'investimento in cure mediche di base per molti, optò per la seconda ipotesi. Le persone che avrebbero potuto beneficiare di un trapianto di organo venivano così private di una chance, che praticamente coincideva con un'opportunità di sopravvivenza.
Il caso dell'Oregon ― riportato dal New England Journal of Medicine ― ha un valore esemplare che ci permette di rapportarlo anche a situazioni, come quella italiana, che presuppongono un'organizzazione sanitaria di altro tipo rispetto a quella americana. La decisione presuppone in primo luogo il riconoscimento che le risorse sono limitate: in una programmazione oculata non solo è necessario scegliere tra quanto si investe in sanità e quanto va destinato ad altri settori ― educazione, giustizia, servizi sociali, difesa ecc. ―, ma nella sanità stessa bisogna scegliere tra bisogni in conflitto. Non si può dare tutto a tutti. Per il futuro dobbiamo prevedere con sempre maggior frequenza situazioni di scelte drammatiche, come quella dell'Oregon: di fronte ai costi crescenti della sanità, nessuno Stato, per quanto florida possa essere la sua economia, potrà sottrarsi a decisioni in merito a programmi da privilegiare a scapito di altri, pur di alto valore umanitario.
Se il vero limite fosse quello finanziario, e quindi quello di individuare all'interno di risorse limitate le prestazioni da erogare, non ci sarebbe molto da discutere: le battaglie da condurre dovrebbero essere rivolte a conquistare qualche frazione in più di Prodotto Interno Lordo da assegnare alla sanità. In realtà il problema è più sottile e riguarda le innovazioni tecnologiche e le sempre maggiori promesse della medicina, che prima offriva solo palliazione e conforto, e ora promette di salvare e migliorare le vite.
Le limitazioni del bilancio sono reali e devono essere applicate anche alla sanità. Bisognerà anche decidere se è più auspicabile che il luogo della scelta sia quello pubblico e formale della discussione di un preventivo di bilancio, oppure se si preferisce che il razionamento delle risorse segua altri percorsi, magari clandestini, e la scelta tra i diversi bisogni sanitari venga fatta tacitamente, facendo prevalere interessi settoriali, grazie alle lobby che hanno maggiore capacità di esercitare una pressione. Vogliamo un sistema che, nel distribuire le risorse limitate, consideri le caratteristiche del paziente, o preferiamo un sistema che adotti una specie di lotteria? Vogliamo adottare i canoni del mercato, o preferiamo estendere i criteri di scelta che già nell’etica medica sono utilizzati nel triage?
La decisione di portare il dibattito nel foro pubblico richiede come corollario che si stabilisca chi deve prendere parte attiva al processo deliberativo che porta a suddividere le risorse limitate: se solo i tecnici dell'economia sanitaria e della programmazione, o anche i rappresentanti di associazioni e gruppi di persone interessate; che parte vi devono svolgere i cittadini stessi, malati o potenziali malati, che sono in pratica i più diretti interlocutori di ogni politica di contenimento della spesa sanitaria; e soprattutto il ruolo che spetta ai medici e altri professionisti della sanità in questo tipo di decisioni. Devono essere coinvolti, o è preferibile tenerli fuori del gioco,
29
per garantire loro che possano continuare a svolgere la funzione insostituibile di difensori del malato, nel suo miglior interesse?
Il razionamento dell'assistenza sanitaria non può essere deciso senza il coinvolgimento degli operatori sanitari e dei cittadini: ci dovrebbe essere il massimo della trasparenza, dell'impegno intellettuale e della partecipazione. Questo ha però dei rischi: è difficile che il paziente con ictus concordi su una riduzione degli investimenti e degli interventi per la sua malattia. E, se non controllato, rischia di essere guidato dalle associazioni o dai gruppi più influenti, che farebbero lobby per influenzare i criteri di scelta.
Un'altra lezione che possiamo derivare dalla deliberazione del lontano Oregon è l'esplicitazione del fatto che le scelte di economia sanitaria, tradotte nel concreto, significano opportunità di salute offerte ad alcuni cittadini e sottratte ad altri. Bisogna decidere chi favorire, e a spese di chi, ed eventualmente esplicitare con quali criteri viene fatta la scelta.
Le decisioni relative alle cosiddette "allocazioni delle risorse" sono di diverso tipo, e conseguentemente di diverso impatto emotivo. Quando si tratta di "micro-allocazioni" (per esempio: nel caso in cui più pazienti per la loro sopravvivenza abbiano bisogno di essere ammessi in una Unità di cure intensive, chi deve essere scelto, quando le strutture sono insufficienti per tutti? Analogamente: come procedere in presenza di un numero limitato di incubatrici per numerosi neonati a rischio?), l'emozione connessa con la scelta che compromette la vita di una determinata persona è spontanea e dirompente. Soprattutto se non si è di fronte a un problema teorico, da discutere in una lezione di etica, ma si è coinvolti con malati verso i quali i sanitari sentono gli obblighi connessi con la loro professione, malati con i quali si è già per lo più stabilito un legame personale.
Meno evidente, ma non meno reale, e la drammaticità delle "macro-allocazioni". È pur vero che la distanza dalle persone concrete offre una prospettiva che mette al sicuro dall'assalto delle emozioni. In quella posizione si possono prendere più facilmente decisioni difficili. E anche commettere crimini. Lo spiegava il diabolico Orson Welles nel film di Carol Reed Il terzo uomo a colui che lo inquisiva sui suoi loschi traffici di penicillina avariata, con cui causava la morte di numerosi bambini: è solo questione di prospettiva e di adeguata distanza dall'oggetto. La scena si svolge su una ruota gigantesca che gira sul Prater di Vienna; vedendo gli esseri umani da quell'altezza, è più facile dare alla loro morte la stessa rilevanza morale che allo sterminio di un mucchio di formiche. Tanto più ― si potrebbe aggiungere ― se gli uomini li si vede dalla distanza astronomica fornita dalle tabelle delle statistiche...
Tuttavia anche le macro-allocazioni hanno a che fare con la vita e la morte di esseri umani, benché questa realtà sia più difficile da vedere. Analogamente, si può dire che il bisogno di una medicina acuta è più visibile al pubblico del bisogno di una medicina preventiva. Una persona, con nome e cognome, che sta morendo ora, è più visibile di una persona sana che morirà in futuro se non si adottano le misure profilattiche adeguate.
La scarsità di risorse per la sanità a livello sociale, con i conflitti connessi, è diversa da quella che si incontra nelle micro-allocazioni. Non si tratta dell'inadeguata presenza di qualche bene, rispetto al bisogno e alla domanda. Questa è la situazione che si crea quando, per esempio, c'è un solo organo da trapiantare, mentre due pazienti sono in lista d'attesa. Se il sig. Rossi riceve l'organo, non Io riceverà il sig. Neri; per quanto drammatica sia la scelta, ciò non riguarda la sig.ra Bianchi, che è in trattamento in un altro reparto dell'ospedale per un carcinoma. Ma se ci spostiamo a un livello di considerazione globale della distribuzione di risorse nella società, troviamo che l’interferenza tra questi due processi terapeutici è reale, anche senza essere direttamente visibile. È la situazione per la quale l'esperta di bioetica americana Haavi Morrein ha coniato il termine "scarsità fiscale" (Morrein, 1985).
30
In regime di scarsità fiscale, la decisione di usare un antiblastico costoso riguarda non solo altri pazienti che potrebbero aver bisogno di quel farmaco, ma tutti i pazienti nella loro globalità, costretti ad attingere al fondo limitato delle risorse disponibili per la sanità. Un milione speso per un paziente che ne ha bisogno, è un milione non più disponibile per qualcun altro. Poiché ogni decisione sanitaria ha un impatto economico identificabile, deve essere sottoposta a un esame che non riguarda solo l'indicazione clinica, ma anche altri parametri di valutazione. Bisognerà così considerare anche se la decisione è saggia dal punto di vista economico e se rispetta un criterio di giustizia relativamente ad altri bisogni in conflitto.
In questo orizzonte appare tutta la rilevanza morale della decisione se privilegiare i trattamenti d'avanguardia per pochi o l'accesso di un più gran numero di persone alle cure di base, come nel caso dell'Oregon. Se accettiamo il concetto di scarsità fiscale, la necessità di scelte tra interessi in conflitto si ripercuote, al di là delle grandi decisioni di programmazione, anche sui più banali dettagli dell'assistenza clinica quotidiana. Di ogni radiografia, di ogni test di laboratorio bisognerà considerare l'impatto economico in un sistema di risorse limitate; anche queste singole decisioni cliniche, quindi, andrebbero valutate confrontandole con le esigenze della giustizia, che costituiscono lo scheletro etico del sistema sanitario.
Il contenimento dei costi non pone solo un problema circoscritto della pratica medica nelle società ad alto sviluppo, ma è destinato a far esplodere un equilibrio precario tra grandi sistemi, quali sono appunto la sanità, l'economia e l'etica. "La medicina, la morale e il denaro ― ha affermato lo storico della medicina Albert Jonsen introducendo un volume dedicato al costo della salute ― sono vissuti per secoli in una coabitazione imbarazzante. Nella istituzione sociale della cura dei malati ognuno ha bisogno dell'altro, eppure ognuno è a disagio nell'ammettere la presenza dell'altro. La morale, in particolare, è in imbarazzo, quando le si chiede di spiegare perché il denaro e la medicina non sono nemici" (Jonsen, 1986).
Un'analisi storica dettagliata potrebbe ricostruire le diverse strategie messe in atto per alleviare le tensioni tra pratica medica ed economia. I medici più generosi, per esempio, erano soliti farsi pagare dai pazienti ricchi, ma dedicavano parte del tempo e delle cure gratuitamente ai poveri; le amministrazioni statali provvedevano in vari modi alla cura degli indigenti; il sistema delle mutue e delle assicurazioni distribuiva su più numerose unità il peso economico della malattia per gli individui. Questi accomodamenti del passato non resistono più agli accresciuti disagi della coabitazione odierna tra medicina, denaro ed etica. "La medicina e la cura della salute ― per riprendere ancora la formulazione del problema fatta da Jonsen ― sono ora esplicite imprese finanziarie. L'etica della medicina subisce al giorno d'oggi chiaramente la pressione di diverse costrizioni economiche. I medici, gli economisti e i filosofi devono imparare a capirsi meglio gli uni gli altri, e a sostituire la coabitazione imbarazzante con qualcosa che si avvicini a una chiarezza contrattuale".
In realtà, la nuova situazione ha prodotto, come prima reazione, la tendenza delle professioni sanitarie a dissociarsi dai problemi che l'economia sanitaria pone al bilancio dello Stato e a non lasciarsi rimettere in discussione. Per una specie di riflesso condizionato, i medici si sono messi in posizione di difesa, in nome dei valori che tradizionalmente sottendono la pratica della medicina.
Qual è il ruolo delle professioni sanitarie? Ogni singolo è coinvolto nella distribuzione delle risorse (il medico, il caposervizio, l'infermiere che deve decidere a chi allocare il suo tempo nel turno) e deve assumersene la responsabilità. È importante trovare un consenso sulle regole della condotta professionale e definire che esiste una relazione tra responsabilità nei confronti del singolo paziente ma anche degli altri pazienti. Si deve inoltre arrivare a creare protocolli di comportamento. Lavorare in sanità coincide con il partecipare a un processo di formulazione e gestione dei valori oltre che di conoscenze e risorse?
31
Preoccupata di difendere i canoni fondamentali del comportamento professionale, la medicina ha trovato un'alleata nell'etica, determinata anch'essa a lasciare il denaro fuori della porta. Si è venuto a creare così uno spontaneo consenso sul fatto che i medici devono tenersi lontani dagli aspetti economici della sanità, perché l'introduzione di questo punto di vista nel comportamento quotidiano costituirebbe la più grave minaccia all'etica medica tradizionale.
Questa gravita essenzialmente attorno al "principio di beneficità". In parole semplici, ciò significa che, nel rapporto individuale medico-paziente, il sanitario orienta la sua azione tenendo in considerazione esclusivamente il maggior beneficio del paziente che ha in cura. Il principio di beneficità richiede che il medico faccia tutto il possibile per il paziente, senza tener conto dei costi. Secondo il punto di vista tradizionale, è un'eresia affermare che il medico possa suggerire o eseguire un'azione che sia qualcosa di meno di quanto, nelle concrete circostanze, è considerato "il meglio" per il singolo malato. I medici rivendicano l'autorità morale di essere esentati dalla considerazione dei costi nella loro azione rivolta alla cura della salute.
La preoccupazione per gli aspetti economici è riservata ad altri, amministratori e politici. Decidere sulla distribuzione delle risorse è compito della società, non del medico. È la società che, attraverso gli organi istituzionali e i meccanismi appropriati, deve stabilire quanto investire nei vari servizi: cura delle malattie acute, prevenzione e ricerca; trattamento delle malattie comuni o di quelle rare; priorità agli anziani o ai giovani; dedicare risorse a coloro che sono socialmente produttivi o a coloro che non lo sono. Se i medici si occupassero di queste decisioni, snaturerebbero il carattere della loro professione.
Un secondo pilastro della moralità medica tradizionale è il riferimento alla sacralità della vita e il rispetto assoluto di essa. Negare o sottrarre un trattamento terapeutico, anche se marginalmente benefico, sulla base della considerazione dei costi della cura o anche di una valutazione razionale del rapporto costi-benefici, è considerato una violazione del principio assoluto della sacralità della vita che deve ispirare l'azione del medico. Vita umana e denaro sono due grandezze non equiparabili, che l'etica medica rifiuta di mettere su due piatti della stessa bilancia.
Gli operatori sanitari si trovano di fronte alla scelta di essere funzionari (più o meno ben pagati) per applicare regole che derivano da un'analisi dei "costi compatibili" o esercitare la responsabilità di fare delle scelte che mantengano l'attenzione ai bisogni inevasi dei pazienti. Le due posizioni non sono sempre compatibili e generano indicatori profondamente diversi su cui basare le valutazioni e le scelte. Quali i criteri della scelta di comportamento? Quanto e come, in quanto responsabili di una competenza professionale, se ne deve far rispettare la valenza di "servizio"?
Oltre a questi motivi di opposizione in linea di principio a ogni progetto che voglia fare dei sanitari uno strumento attivo di una politica sanitaria rivolta al contenimento della spesa, ne possiamo individuare altri di profilo meno elevato, che non attingono argomentazioni dagli orientamenti più consolidati dell'etica medica. Sono quelli che derivano dall'autocomprensione della medicina quale professione liberale. Anche in una società come la nostra, che ha ampiamente socializzato le cure della salute, i medici continuano a opporre una profonda resistenza a una integrazione della società, quale terzo pagante, nel rapporto tra medico e paziente. "Ogni volta che tratto un malato ― soleva dire un illustre clinico, medico personale del cancelliere tedesco Bismarck ― io sono solo con lui su un'isola deserta". Idealmente, i medici amano rappresentarsi su quell'isola, anche se marcano il cartellino dell'ospedale e ricevono lo stipendio dalla Asl.
I riflessi condizionati che spiegano la resistenza dei medici e dell'etica elaborata dalla loro professione a lasciarsi coinvolgere nella preoccupazione di ridurre i costi della sanità sono comprendibili
32
e ampiamente condivisibili. Tuttavia questo atteggiamento di disimpegno rischia di rivelarsi estremamente controproducente, dal punto di vista della stessa etica medica. Le decisioni sulle inevitabili restrizioni del bilancio saranno prese in assenza degli interlocutori qualificati e parti in causa, quali sono appunto i rappresentanti delle professioni sanitarie e della riflessione etica. Magari da puri "tecnici" dell'economia sanitaria, che rischiano di introdurre surrettiziamente dei valori nelle loro scelte, senza averne consapevolezza: ma valori puramente economici, a danno dei valori umani che l'etica professionale vuol tutelare.
Fa parte della responsabilità degli operatori sanitari fornire i dati epidemiologici in base ai quali far fare le scelte e rendere visibili le storie dei pazienti che rischiano di scomparire nei grandi numeri delle tabelle o delle macro-analisi. Questo consente di attivare una dialettica tra il problema e la risposta al singolo paziente e il ruolo nel dibattito politico sulle filosofie delle scelte di politica sanitaria. Lavorare in sanità coincide anche con l'affermare la competenza a identificare gli indicatori di accessibilità o meno ai diritti alla salute?
Rifiutando un positivo ripensamento della triade medicina-denaro-etica, si perde un'opportunità unica di accedere a nuove prospettive che riguardano l'esercizio della professione medica, la concezione della salute, il ruolo della giustizia nella convivenza sociale. È soprattutto questo orizzonte positivo di crescita nella consapevolezza e di elaborazione di migliori risposte alla complessa situazione che stimola l'etica, in un serrato dialogo con la riflessione prodotta da coloro che esercitano le professioni sanitarie, a confrontarsi con la sfida che i problemi economici pongono oggi alla sanità.
Definire questo nuovo orizzonte è il compito della bioetica. Sia nei suoi contenuti che nel suo metodo, la bioetica si differenzia dalla tradizionale etica medica. Per l'approccio dei problemi connessi con le scelte relative al prezzo della salute abbiamo bisogno dell'apporto di diverse discipline e pratiche professionali (e, conseguentemente, anche di diverse etiche professionali), nonché di un confronto che si ispira più all'etica civile (intesa a esprimere quel consenso sui valori e sui mezzi pratici per promuoverli che si crea nella società pluralistica e secolare) che all'etica dipendente da sistemi dottrinali. A servizio di queste esigenze si pone, appunto, la bioetica.
L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANITARIO IN ITALIA
Nel breve periodo di appena mezzo secolo l'Italia ha modificato più volte il proprio sistema sanitario. Ogni nuovo disegno ha strutturato in modo diverso il rapporto tra i cittadini e le istituzioni erogatrici dei servizi, ma anche l'atteggiamento degli operatori sanitari nei confronti delle strutture e del sistema. Ogni realizzazione del sistema sanitario ha comportato sia opportunità che rischi ed è stata veicolo sia di valori che di disvalori in senso etico.
L'era delle mutue
Dopo la Seconda guerra mondiale troviamo che la domanda sanitaria è organizzata dagli enti mutualistici. Il principio che regola il sistema è quello assicurativo, con interventi dello Stato. Esistono molti enti di categoria, con una grande diversità di copertura dei rischi. Ciò significa che alcuni cittadini hanno la fortuna di possedere, per sé e la propria famiglia, una mutua "buona", mentre altri hanno una copertura peggiore. Non tutti, inoltre, sono mutuati. Coloro che non hanno alcuna assistenza mutualistica devono ricorrere all'assistenza caritativa, erogata da enti ecclesiastici o comunali.
33
Firenze, San Martino dei Buonomini
Visitare gli infermi
Il ciclo dei dieci affreschi nell'Oratorio è suddiviso nel modo seguente: oltre alle due storie della vita di San Martino, patrono dell'istituzione, sono rappresentate, così come era tradizione delle istituzioni benefiche, le sette opere di misericordia, ma con modifiche che riflettono lo spirito e il modo di agire dei Buonomini. Dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati sono riuniti in una sola scena, per lasciare lo spazio a due temi che non appartengono al ciclo delle sette opere di misericordia: lo sposalizio dei trovatelli e una scena inusuale, ma particolarmente caratteristica per Firenze: l'inventario di un lascito.
Anche la scena del ciclo relativa al Visitare gli infermi ha subito una modifica iconografica rispetto all'uso rinascimentale di raffigurare malati maschili. In essa vi è infatti rappresentata una puerpera e i Buonomini le portano fasce per il bambino, un cappone e un fiasco di vino. L'assistenza ai malati in senso proprio non faceva parte dei compiti dei Buonomini, né essi gestivano alcun ospedale.
Proprio questo distacco dallo schema iconografico rivela un'altra caratteristica del ciclo di affreschi di San Martino. Colpisce che i bisognosi anche in altre scene ― come Dar da mangiare agli affamati e Vestire gli ignudi ― siano costituiti esclusivamente da donne e bambini, o al più da vecchi. Si è evitato di rappresentare lo stato di bisogno di uomini in età attiva. Una spiegazione di questo è data dall'autoidentificazione dei Buonomini con coloro che ricevevano la loro carità. Inoltre gli uomini venivano considerati responsabili per il proprio destino; evidentemente al contrario di donne e bambini.
Christina Riebesell
34
L'epoca della medicina mutualistica, con le sue poche luci e le tante ombre, ha lasciato una traccia tenace nella memoria degli italiani attraverso il romanzo di Giuseppe D'Agata Il medico della mutua (1964), rafforzato dal successo del film dallo stesso titolo diretto da Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi (1968).
Una pagina del romanzo ci presenta, con gli occhi del dott. Tersilli, che aspira a formarsi un "patrimonio di mutuati", il rapporto esistente tra medici e gli assistiti:
Ho deciso di vedere da vicino i mutuati. Perciò vado all'uscita delle fabbriche, degli uffici, e li osservo, sia pure di sfuggita, perché hanno tutti fretta di allontanarsi, col tram, con i motorini e le biciclette.
È difficile spiegarsi come quegli uomini e quelle donne, che hanno l'apparenza di gente in salute, possano trasformarsi in mutuati attivi; come sappiano, con tutta la fretta che muove i loro passi, adattarsi a fare lunghissime anticamere negli ambulatori. Deve essere più che mai forte il potere del medico. A fare un confronto col passato, con ciò che sappiamo dei medici di una volta, pare che la potenza del medico si sia accresciuta, grazie alla mutualità. La figura del medico ha perso forse un certo tipo di suggestione esteriore, ma si è senz'altro arricchita di un piglio amministrativo-assistenziale che è capace di trasformare i lavoratori in mutuati [...].
All'apparenza i mutuati sembrano persone normali, con facce, atteggiamenti e modi di vestire del tutto normali. Quello che li distingue, che li rende mutuati, è un carattere interno, non tanto una specifica malattia, quanto una qualità particolare che gli viene dall'avere in tasca o nella borsa il libretto, in regola, della mutua.
Questo libretto rappresenta il punto di incontro tra mutuato e medico: e non è una questione di visita, di malattia, di cura; il mutuato vuole la ricetta e il medico vuole segnare la visita: questo significa il libretto della mutua.
"Anche se gli dici che non ha niente, scrivigli sempre una medicina. Se non lo fai, perdi quel mutuato".
Il mutuato sa che il libretto della mutua è qualcosa di molto preciso per il medico, e quando la sua fame di medicine si fa inestinguibile è capace anche di usarlo come strumento di ricatto: lo sventola allora di fronte alle mani di medici, centinaia di mani tese ad afferrarlo. Per regolamento il libretto deve rimanere nelle mani del mutuato, ma il sogno di ogni medico è di avere in una cassaforte, al sicuro, pile e pile di libretti, migliaia di libretti di grossi nuclei familiari composti di vecchi, donne e bambini.
Il sistema delle mutue era un passo avanti rispetto all'organizzazione liberale dei servizi sanitari, che prevedeva fondamentalmente due scenari: uno di pagamento all'atto per i benestanti e l'altro di assistenza caritatevole per chi non si poteva permettere le prestazioni libero-professionali. Era tuttavia un sistema molto difettoso (e molto costoso, come dimostravano i debiti ingenti accumulati dalle mutue e ripianati dallo Stato). Alcuni proponevano di tornare indietro. Tra questi spiccavano i rappresentanti più affermati della professione, che usavano come argomento l'etica medica: questa avrebbe impedito che i medici facessero mancare l'assistenza ai più poveri. In una pagina del romanzo II medico della mutua troviamo questa argomentazione in bocca a un primario che arringa i colleghi medici durante un'assemblea:
"Colleghi! La causa dei mali che affliggono la nostra benemerita classe è la mutua. Dobbiamo abolire la mutua, se vogliamo salvarci. Vade retro, Satana!
Se ci richiamiamo al nostro aureo principio, di agire secondo scienza e coscienza, non c'è bisogno dell'esistenza della mutua. Non saremo certo noi a rifiutare le nostre cure ai poveri, agli indigenti, agli umili: si affidi sereno il lavoratore alla nostra sensibilità di medici e di umanisti; collabori con noi ad abbattere la mutua, il diaframma che lo separa da noi. La missione del medico è universale, eterna, insostituibile".
Invece di un passo indietro, l'Italia decise di fare un passo avanti, creando un Servizio sanitario nazionale.
35
Il Servizio sanitario nazionale
Nel 1978 la legge 833 istituiva il Servizio sanitario nazionale. Il 1° articolo della legge ne definisce i contorni e le funzioni:
Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti del servizio.
Il principio fondamentale era quello universalistico: il SSN appariva come un grande ombrello che copriva la popolazione nella sua interezza (mentre i sistemi che funzionano su base assicurativa, come le mutue, garantiscono solo alcuni). Liquidate le mutue, la sanità viene governata dal governo centrale, il quale determina i prezzi dei farmaci, stabilisce i contratti collettivi, determina i fondi per gli investimenti.
L'universalismo riguardava ― almeno nelle intenzioni ― anche le prestazioni: a ognuno sarebbe stata fornita tutta l'assistenza di cui aveva bisogno. Da ognuno lo Stato avrebbe prelevato risorse economiche secondo le sue possibilità, per ridistribuirle a ognuno secondo le sue necessità: questo era uno degli slogan con cui veniva presentato alla popolazione il SSN. In Inghilterra ― dove il National Health Service era stato introdotto nel 1948 ― un altro slogan semplificatore era costituito dalla promessa che, d'ora in poi, "dalla culla alla tomba" ai bisogni di salute dei cittadini ci avrebbe pensato lo Stato.
La previsione che l'universalismo delle prestazioni avrebbe migliorato la salute dei cittadini, e quindi diminuito la domanda di prestazioni, si rivelò ben presto una generosa illusione. Politiche dei tagli e dei ticket cercarono di porre un freno alla crescita della spesa sanitaria. Invano: gli aumenti sembravano inarrestabili.
I motivi della crescita fuori controllo della spesa sanitaria durante gli anni Ottanta sono di diversa natura:
● aumento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti (estensione dei servizi prestati e del materiale scientifico utilizzato, con l'utilizzo di apparecchiature tecnologicamente sempre più avanzate: laser, tac, risonanze magnetiche...);
● andamento demografico, con l'innalzamento dell'età media della popolazione;
● cause legate ai meccanismi di domanda-offerta (la crescita dell'offerta fa crescere la domanda, e viceversa; gli utenti non conoscono i costi dei servizi che vengono prestati; i sanitari e gli amministratori non hanno vincoli di bilancio);
● spreco di risorse nell'attività di produzione dei servizi (cattiva distribuzione sul piano territoriale, scoordinamento dei servizi).
Per realizzare l'equilibrio economico e finanziario delle Unità sanitarie locali si dovette procedere a una "riforma della riforma sanitaria" mediante un riordino radicale del SSN.
Nasce la sanità aziendalizzata
Le leggi di riordino prima e di razionalizzazione poi del SSN sono state elaborate negli anni Novanta (rispettivamente, per il riordino Dlgs 502/1992 e 517/1993, per la razionalizzazione Dlgs 229/1999). L'intento di queste leggi è stato quello di ribaltare le regole del gioco rispetto all'organizzazione precedente, a cominciare dall'aspetto economico-finanziario. I fini del SSN, così come descritti dal primo articolo della legge 833/1978, vengono mantenuti; ma devono essere realizzati ― come prescrive il primo articolo del Dlgs 502 ― "in coerenza con l’entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale". In altre parole, il servizio sanitario deve essere
36
offerto ai cittadini tenendo presente che il tetto della spesa, fissato in precedenza, non deve essere superato.
Il Piano sanitario nazionale 1994-1996 ha descritto in questi termini il nuovo scenario creato dalla "riforma della riforma", presentando gli obiettivi che si deve proporre il SSN:
nuovi scenari sociali in cui si collocano la difesa e la promozione della salute obbligano a ripensare l'orientamento di fondo della politica sanitaria. La prima caratteristica di una prospettiva contemporanea è quella di presentarsi come un orizzonte di risorse limitate. Non esiste più il sogno utopistico di uno Stato che si propone di rispondere a tutti i bisogni di salute dei cittadini; in sanità sarà sempre più pesante la divaricazione tra domanda e offerta, perché la società invecchia ed è sempre più affetta da malattie degenerative. Questi cambiamenti di scenario impongono la dura necessità di fare delle scelte sia a livello macro sia a livello micro-economico, al fine di riuscire a massimizzare i benefici ottenibili dalle risorse disponibili.
Il cambiamento disegnato dai provvedimenti legislativi degli anni Novanta è spesso riassunto nel termine "aziendalizzazione" della sanità. Per parlare di azienda riferita alla sanità senza equivoci, dobbiamo chiarire che non si tratta di trasporre nelle istituzioni che si occupano di salute ― da recuperare, da promuovere, da tutelare ― la filosofia delle aziende nate per produrre e commercializzare beni e servizi, obbedendo a una logica di profitto. Le parole-chiave da associare all'azienda di cui si parla in sanità sono piuttosto:
● L'orientamento alla soddisfazione dell'utente dei servizi. Introdurre lo "stile azienda" in sanità significa assumere l'atteggiamento di coloro che producono beni e servizi nei confronti dei loro clienti. La centralità del paziente, considerato come "cliente" dei servizi sanitari, implica un diverso modo di lavorare. Quando si parlava finora di mettere il paziente al centro delle cure si intendeva rivolgere agli operatori sanitari una esortazione morale a comportarsi bene ― cioè con sensibilità, empatia, umanità ― con il malato. In epoca di aziendalizzazione la centralità dell'utente significa invece l'adozione di una nuova strategia di organizzazione dei servizi, che richiede una specifica capacità manageriale.
● Il coinvolgimento degli operatori nelle logiche organizzative. Sottoposta alla sfida della qualità, la vecchia mentalità aziendalistica ha dovuto adottare nuove filosofie di organizzazione e di produzione. La dichiarazione di un manager giapponese a dei colleghi inglesi, presentando loro l'orientamento vincente alla "qualità totale", illustra il diverso rapporto con la creatività degli operatori:
Per voi l'essenza dal management consiste nel tirar fuori le idee dalla testa del dirigente per metterle nelle mani degli operatori (uffici e reparti). Per noi l'essenza del management è precisamente l'arte di mobilitare le risorse intellettuali di tutto il personale a servizio dell’azienda. Dato che noi abbiamo valutato meglio di voi le sfide economiche e tecnologiche, sappiamo che l'intelligenza di un gruppo di dirigenti, per quanto brillanti e capaci essi siano, non è più sufficiente per garantire il successo.
Galgano, 1990.
Questa filosofia è risultata vincente nella produzione di automobili e televisori; tanto più può esserlo quando si tratta di un servizio personalizzato come le cure sanitarie. Ma richiede la rinuncia all'organizzazione gerarchica e piramidale, così caratteristica delle strutture sanitarie.
● Il senso di appartenenza. La condivisione degli obiettivi comuni dell'azienda (mission) permette di allineare le forze di tutti gli operatori in un piano strategico comune. Ciò presuppone una cultura dell'organizzazione, che fa riferimento al modo in cui avvengono i processi di integrazione informale tra i membri dell'organizzazione e il tipo di valori sociali, conoscenze
37
e credenze condivise che si affermano tra di essi (si dice che la cultura di una organizzazione si può rilevare utilizzando come indicatore il tipo di battute e barzellette che si è soliti fare sui capi...).
● La soddisfazione degli operatori. Secondo la filosofia della "qualità totale", non si può fornire un prodotto eccellente se coloro che lo producono non sono attivamente coinvolti: non come piccole ruote di un ingranaggio, ma come protagonisti attivi che pensano le soluzioni e le propongono, fanno progetti e li realizzano, ottengono piccoli miglioramenti costanti (il miglioramento continuo della qualità è come una linea che si muove a spirale, in un movimento ascendente). II cliente soddisfatto produce, a sua volta, un fornitore di servizi soddisfatto. Con persone frustrate e demotivate non si può fare un'azienda che abbia l"'eccellenza" come obiettivo.
LA VALUTAZIONE ETICA DEI SISTEMI SANITARI
Per decidere se un sistema sanitario merita o no la qualifica di "etico", dobbiamo riferirci a modelli generali che rispondono alle domande relative al posto che gli individui occupano nella società e agli obblighi di questa nei confronti dei cittadini, in particolare di quelli che si trovano in stato di bisogno. Quante risorse dobbiamo destinare alla cura delle persone fragili? Con quali criteri dobbiamo ripartirle? Due fondamentali modelli rispondono a queste domande, collocandosi su due versanti opposti: uno privilegia l'individuo e la sua responsabilità, l'altro la società e la solidarietà.
Tradizione liberale, giustizia e medicina
Il movimento liberale, che crebbe in Europa nel XVIII e XIX secolo, ebbe una profonda ripercussione anche sull'organizzazione delle cure sanitarie. Il pilastro centrale del liberalismo è una concezione antropologica che privilegia l'individuo quale artefice del proprio destino; l'accento è posto sulle libertà politiche e culturali, con una diffidenza marcata verso lo Stato e il suo ruolo intrusivo, quand'anche i suoi interventi fossero pensati a beneficio dei più deboli. Nella tradizione liberale lo strumento più efficace per la distribuzione dei beni è considerato il sistema economico del libero scambio, o mercato.
La posizione liberale è classicamente rappresentata dalla raccomandazione che Adam Smith fa all'uomo, che ha "costantemente bisogno dell'aiuto dei suoi fratelli": non attenda l'aiuto dalla benevolenza degli altri uomini, ma dal loro interesse: "Egli avrà maggiori possibilità di ottenerlo e riuscirà a volgere a proprio favore la cura che quelli hanno del proprio interesse e a dimostrare che toma a loro vantaggio fare ciò di cui li richiede. Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio e del fornaio che noi aspettiamo il pranzo, ma dalla considerazione che essi fanno del proprio interesse. Noi ci rivolgiamo non alla loro umanità ma al loro interesse e non parliamo mai delle nostre necessità, bensì dei loro vantaggi" (Smith, 1965, ed. orig. 1776). La celebre immagine della "mano invisibile" e provvidenziale, che dallo scontro degli interessi privati fa scaturire l'armonia dell’insieme, viene a identificarsi praticamente con il mercato.
La teoria liberale dei diritti individuali rivendica solo il diritto negativo alla salute (in altre parole: lo Stato deve impedire che qualcuno attenti alla mia integrità fisica), non il diritto positivo all'assistenza sanitaria. Per la tradizione liberale ― e per il neoliberalismo economico del nostro tempo ― il diritto all'assistenza sanitaria non esiste, almeno come un capitolo della giustizia (dove finisce la giustizia si apre il terreno di altre virtù: per quanto la giustizia affermi che non siamo obbligati a contribuire al benessere degli altri, la carità ci ordina di aiutare coloro che non possono rivendicare il diritto al nostro aiuto).
La filosofia liberale ha avuto una ripercussione importante nell'organizzazione delle cure sanitarie. Secondo la concezione della "medicina liberale", il mercato sanitario si sarebbe dovuto
38
reggere secondo le leggi del libero scambio, senza intervento di terzi; l'intervento dello Stato nei rapporti tra medico e paziente è considerato come un'ingerenza indebita. Per i poveri, che non potevano accedere al sistema di prestazioni sanitarie basato sul mercato di domanda e offerta, era previsto il ricorso alla "beneficenza": carità individuale o di istituzioni religiose, grandi ospizi o istituti per pauperes infirmi ("Tra i due si realizzava uno scambio reciproco di significati, facendo dell'uno e dell'altro, alternativamente, un attributo e un sostantivo: l'infermo povero e il povero infermo. Essi esprimevano una categoria composita, senza troppa distinzione tra indigenza economica ed emergenza sanitaria: la folla ― in una parola ― dei malati inguaribili"; Cosmacini, 1998). Ma anche la risorsa della beneficenza fu avversata in nome del liberalismo. È così che l'economia politica si guadagnò, nell'ambito linguistico inglese, l'appellativo di dismal science ― scienza spietata.
Secondo l'interpretazione più radicale del liberalismo, fornita da Robert Malthus, la beneficenza è non solo un'attività "antieconomica" (dato che i malati non pagano le prestazioni ricevute), ma anche "nociva". La miseria, infatti, è una conseguenza "assolutamente necessaria" delle leggi di natura e da essa derivano la malattia e la morte prematura di gran parte della popolazione. Le istituzioni benefiche, anche se attivate con i propositi più caritatevoli, alla lunga riusciranno solo a procrastinare le sofferenze degli esseri condannati dalla natura stessa allo sterminio. Malthus attacca in modo particolare le poor laws inglesi, che a suo avviso tendono a peggiorare la situazione generale dei poveri: "Si può dire che, in una certa misura, queste legge creano i poveri che poi manterranno. E dato che le provviste del paese, in conseguenza dell'aumento della popolazione, devono essere distribuite in parti minori per ognuno, appare evidente che il lavoro di chi non gode della pubblica assistenza avrà un potere d'acquisto inferiore, e quindi crescerà il numero delle persone obbligate a ricorrere all'assistenza" (Malthus, 1977, ed. orig. 1798). Lungi dall'essere un'azione virtuosa, l'assistenza offerta alle frange più fragili della società risulta dannosa.
Sottostante alle concezioni liberaliste più rigide emerge un moralismo che attribuisce ai "fragili" la volontà di trarre profitto dalla loro situazione. Sempre secondo Malthus, se si concedono "confortevoli ritiri dove rifugiarsi nei periodi più duri", i soggetti verso i quali si esercita un'assistenza sociale o sanitaria saranno indotti ad accomodarvisi, rifuggendo alle loro responsabilità. Troviamo un'eco satirica di questa concezione liberista estrema nel celebre romanzo utopico di Samuel Butler Erewhon. Nel mondo capovolto che immagina, il malato deve essere indotto a sentirsi colpevole della sua malattia. Commentando il processo che si conclude con la severa condanna di un ammalato per il "grave delitto di tubercolosi polmonare", Butler esplicita la logica che sottende la paradossale condanna: "Il giudice era fermamente convinto che la punizione inflitta al debole e all'ammalato fosse il solo modo di prevenire il diffondersi del decadimento fisico e delle malattie e che, alla resa dei conti, l'apparente severità della sentenza avrebbe risparmiato alla società una sofferenza dieci volte maggiore di quella subita dall'accusato" (Butler, 1975). II paradosso del malato colpevolizzato è stato realizzato dalla nostra società dal diffondersi dell'atteggiamento etichettato come victim blaming. Si stanno studiando diversi modelli che vanno dal taglio del salario in caso di malattia "per colpa" (per esempio, un incidente stradale in stato di ubriachezza), ai malati "parziali" (ci si deve recare al lavoro con una gamba rotta, perché la frattura è stata provocata sciando).
Un manager che ha un infarto (legato allo stress) o un fumatore con un cancro del polmone, secondo la logica della "colpa", non dovrebbero essere assistiti perché consapevoli dei rischi della propria attività? Il diritto alla salute e all'assistenza è un diritto "parziale"?
La posizione liberista è riapparsa con vivacità nell'orizzonte culturale contemporaneo con il neoliberismo economico. Non si tratta solo di un dibattito culturale: stagioni intere di politica
39
economica e sociale ne sono state influenzate, come l'epoca di Reagan negli Stati Uniti e quella della Thatcher in Gran Bretagna. Anche sul riordino del nostro Servizio sanitario nazionale, avviato negli anni Novanta, spira un vento neoliberista, in particolare per il ruolo attribuito al mercato nel produrre l'efficienza dei servizi.
La bioetica ha sentito l'influenza del pensiero liberale, soprattutto con riferimento al dibattito sull'assicurazione sanitaria obbligatoria. Il pensiero contrattualista, influenzato dalle posizioni filosofiche di John Rawls e Robert Nozick sulla giustizia, ha portato alcuni studiosi a negare il diritto all'assistenza sanitaria. "Un diritto umano fondamentale ― afferma Tristam Engelhardt ― a fornire l'assistenza sanitaria, anche se limitata a un minimo decente di assistenza sanitaria, non esiste." A suo avviso, ogni tentativo di giustificazione di una prestazione sanitaria deve fondarsi sul principio di beneficità, non su quello di giustizia (la necessità dell'assistenza ― in altre parole ― si può giustificare solo con il dovere di fare del bene, non con la rivendicazione di diritti economici, sociali e culturali).
Un paragrafo molto eloquente di Engelhardt è dedicato alla necessità di "convivere con le diseguaglianze e la tragedia": "Arti e scienze sanitarie sono attività di uomini e donne finiti, in possesso di risorse finite, che vivono ed esercitano le loro professioni rispettando limiti morali, che non consentono loro di tentare tutto ciò che vorrebbero per conseguire il bene. Tutte le attività umane sono caratterizzate da limiti. Ciò è particolarmente doloroso nel caso della medicina, che deve convivere con le sofferenze di individui indifesi e innocenti e tentare di confortarli, assisterli e, quando è possibile, guarirli. La lotteria naturale e quella sociale, l'esistenza di diritti di proprietà privati, e le conseguenze delle libere scelte, sia individuali, sia pubbliche, destinano gli individui a vivere vite diverse, quanto a opportunità e a soddisfazione. Fino a un certo punto,sarà opportuno tentare di eliminare queste diseguaglianze. Ci saranno dei limiti ai tentativi moralmente ammissibili. Questi limiti stabiliranno quando le diseguaglianze e i risultati sfortunati non saranno iniqui" (Engelhardt, 1991).
Una versione più mite del liberalismo, ma non priva di conseguenze nel sistema delle cure rivolte ai più fragili, è quella che propone il passaggio dalla copertura universalistica all'assegnazione di un "bonus" ai cittadini, affidando a loro la responsabilità delle scelte assicurative. È noto che la proposta di un "bonus" è stata originariamente avanzata nel 1955 dall'economista Milton Friedman, in un'ottica neoliberale, per dare efficienza al sistema scolastico: i cittadini,dotati di un voucher, o buono di acquisto a destinazione vincolata, avrebbero deciso di spenderlo nelle strutture scolastiche, pubbliche o private, che avessero trovato più adeguate. Questo sistema è finalizzato a innescare una competizione tra i fornitori di servizi, che condurrebbe a un miglioramento della qualità dei servizi erogati.
L'estensione di tale idea all'ambito sanitario è stata sostenuta dall'Institute of Economie Affairs di Londra. Questa versione moderna della vecchia ricetta liberista, che preferisce la distribuzione in denaro alla distribuzione in natura dei servizi, è vista come sinonimo di libertà di scelta per tutti i cittadini e vuol coniugare mercato, concorrenza e solidarietà. Ma non sono irrilevanti le preoccupazioni di chi teme che anche in questa forma moderata di medicina liberale i più fragili avrebbero una condizione svantaggiata e si dovrebbe riscoprire per loro qualcosa che assomiglia da vicino alla pubblica beneficenza.
Le popolazioni fragili sono anche quelle con maggiori bisogni sanitari. È eticamente accettabile mettere un tetto sull'offerta dei servizi, proprio per coloro che ne hanno maggiore bisogno?
Fragilità e welfare community
Sul versante opposto del modello liberale si colloca chi ritiene che il modo migliore di far fronte alle malattie e alle diverse forme di fragilità è quello che le affida all'intervento attivo della pubblica
40
amministrazione. Il contesto è in questo caso quello dello "stato sociale". Dobbiamo anzitutto renderci conto della relativa novità dell'organizzazione che affida allo Stato la risposta ai bisogni dei più fragili. Un volume dedicato alla riforma della pubblica amministrazione sottolinea in apertura i cambiamenti costanti nei confronti di ciò che affidiamo allo Stato e ciò che attribuiamo ad altre forme di solidarietà allargata: "Un tempo erano le armerie dello Stato a fabbricare le armi e nessuno avrebbe mai pensato di lasciare una cosa così importante alle industrie private. Oggi, nessuno si sognerebbe mai di affidarla allo Stato. Un tempo nessuno si aspettava che lo Stato si facesse carico degli indigenti, il 'welfare state' non esisteva prima che Bismarck ne creasse uno nel 1870. Oggi, non solo la maggior parte delle amministrazioni dei Paesi sviluppati si fa carico degli indigenti, ma addirittura stanzia fondi per garantire l'assistenza sanitaria e pensionistica a tutti i cittadini. Un tempo, nessuno si aspettava che spegnere gli incendi fosse compito della pubblica amministrazione. Oggi non potrebbe esistere un'amministrazione nel cui contesto non sia previsto un dipartimento dei vigili del fuoco" (Osbome, Gaebler, 1995).
Una progressiva estensione dei compiti dello Stato ha portato alla prevalenza del modello universalistico di tutela della salute. Un pregiudizio favorevole cade sui più fragili, quando si accetta il principio ― politico e morale insieme ― che nessuno deve essere escluso dalla rete della solidarietà allargata che gli fornisce le cure di cui ha bisogno: se tutti sono uguali, il debole è "più uguale degli altri"!
L'orientamento universalistico, per quanto nobile, ha dovuto confrontarsi con una realtà sociale ed economica avara nei confronti dei progetti più generosi di assistenza misurata sui bisogni. Così è avvenuto, come abbiamo visto, per la sanità italiana estesa a tutti, secondo il Servizio sanitario nazionale del 1978.
La necessità di fare delle scelte ― una condizione che, sul finire di un secolo che ha visto l'ampliamento progressivo della copertura sanitaria a tutti i cittadini, si impone a tutti i sistemi sanitari dell'area dello sviluppo ― fa emergere in medicina problemi etici che non hanno riscontro in nessun'altra epoca. Non solo quelli, ormai ben identificati, che si è soliti catalogare come questioni di bioetica (in pratica, questioni relative alla necessità di porre dei limiti a quello che siamo in grado di fare con la potentissima medicina tecnologica che è la nostra). Oltre ai problemi di bioetica, si fanno oggi urgenti i dilemmi sociali circa l'estensione delle cure, nella prospettiva delle risorse limitate.
Nei sistemi in cui convivono il welfare state e un sistema privatistico si crea la dicotomia tra chi ha accesso a un'assistenza, comunque limitata, e chi invece può acquistare beni e servizi "migliori" rispetto ai bisogni (normale corsia di ospedale vs stanza singola; possibilità di scegliere il medico vs farsi visitare da chi è di turno; lunghe liste di attesa vs risposta immediata). È una discriminazione accettabile per un diritto quale quello alla salute?
All’inizio del secolo i problemi etici delle scelte in sanità si ponevano ― quando si ponevano ― in una prospettiva individuale. Una rappresentazione letteraria è quella offerta da Bernard Shaw nella pièce Il dilemma del dottore (1906). Il dilemma si presenta come una questione di priorità, legata a un potere di vita o di morte: quando le risorse sono scarse e non bastano per curare tutti, è compito del medico decidere quale vita meriti di essere salvata?
Il "dilemma" del dottore ― che si trova a scegliere tra la vita di un giovane pittore geniale e quella di persone senza rilievo sociale ― offre materia caustica a Shaw, quanto mai scettico circa la capacità della professione medica di risolvere i suoi problemi secondo coscienza e determinato a mettere in guardia i possibili pazienti dall'affidarsi a essa. A quasi un secolo dalla prima messa in scena della commedia, ci sentiamo autorizzati a vedervi un'anticipazione di dilemmi di ben altro spessore che si pongono oggi alle società industriali avanzate. Ci stiamo affacciando su scelte
41
drammatiche che non riguardano più solo le "micro-allocazioni" (scegliere tra diversi candidati che hanno bisogno di un trattamento disponibile in misura limitata, e quindi entrano in conflitto tra di loro), bensì le "macro-allocazioni": quante e quali risorse la nostra società è disposta a destinare alle cure sanitarie? In che maniera garantire l'accesso ai servizi sanitari che la società decide di fornire a tutti i cittadini, indipendentemente delle loro capacità economiche? In questo più ampio scenario i dilemmi non sono più solo quelli del singolo dottore, ma della società intera.
Il modello di Stato sociale che nella maggior parte dei Paesi è stato creato nella seconda metà del XX secolo sta perdendo terreno ovunque: la società civile non è più capace di prevenire e riassorbire le situazioni di emarginazione sociale. Le ripercussioni più gravi della restrizione dello Stato sociale si registrano nella sanità. Se il patto di civiltà che ha dato origine allo Stato sociale si rescinde, vedremo inevitabilmente divaricarsi le opportunità dei cittadini di accedere alle cure sanitarie: i ceti economicamente più forti si scrolleranno dalle spalle il peso costituito dalle categorie più fragili e si costruiranno una sanità a propria misura. Le famiglie, che già ora sono in prima linea nel fornire cure e assistenza nelle situazioni di cronicità, saranno sempre più gravate dalle richieste di supplire alle carenze di uno Stato sociale in ritirata.
Pur riconoscendo la necessità di rivedere quegli aspetti dello Stato sociale che sono all’origine di comportamenti consumistici e di diseconomie, procedendo a un coraggioso riassetto istituzionale e organizzativo dell'esistente, lo Stato sociale in quanto tale va difeso come una irrinunciabile conquista di civiltà. Le turbolenze che accompagnano la nostra navigazione, mentre cerchiamo di traghettare lo Stato sociale verso un'organizzazione della sanità più efficiente e più equa, sono molto serie; ma non tanto drammatiche, comunque, da farci ritenere che la nave andrebbe a fondo se non ci decidessimo a scaricare in acqua alcuni passeggeri. Un "dilemma del dottore" di questa entità neppure Bernard Shaw lo poteva immaginare. La humanitas ci induce a impegnarci con tutte le forze della ragione e della volontà perché una vergogna di questo genere ci sia risparmiata.
La riflessione filosofica, politica, etica ed economica degli ultimi anni si è dedicata attivamente al problema di un'allocazione delle risorse che cerchi di conciliare l'universalismo della loro destinazione con le esigenze di una gestione economica. La stagione delle scelte allocative è stata inaugurata dal modello, che ha ormai assunto un valore emblematico, elaborato dallo stato americano dell'Oregon. La commissione incaricata di elaborare i criteri per guidare le scelte ha stabilito delle correlazioni di diagnosi e di trattamenti con un ordine di priorità, privilegiando i trattamenti efficaci che assicuravano un alto quoziente di QUALY, cioè di anni di vita attesa di buona qualità (cfr. Bucci, 1996). La distinzione tra le patologie per le quali tutti ― compresi i poveri, con il ricorso alle risorse dei sistemi assicurativi pubblici ― avevano diritto a ricevere un trattamento, da quelle lasciate alla disponibilità economica degli individui veniva fatta tracciando una linea che divideva in due parti la lista delle prestazioni. Il modello Oregon è tanto discutibile che la Corte suprema degli Stati Uniti lo ha respinto, in quanto incompatibile con i diritti dell'individuo. In ogni caso ha però un valore storico, quale primo tentativo, metodologicamente grossolano, di fare ciò che, secondo il presidente del Senato delI'Oregon, dovrà essere un compito di tutte le società avanzate: stabilire una lista delle priorità.
Due altri modelli, elaborati da altrettante commissioni nazionali, meritano un'attenta considerazione: quello olandese (Le scelte in sanità, 1991) e quello svedese (Priorità nell'assistenza sanitaria, 1997). Alla domanda fondamentale ― qual è l'assistenza che vogliamo garantire a tutti i cittadini (il basic package), indipendentemente dalla loro capacità economica, in forza del principio di solidarietà che sta alla base dello stato sociale? ― la Commissione olandese risponde indicando dei criteri procedurali per giungere a fare scelte socialmente ed eticamente accettabili. I criteri sono rappresentabili come quattro successivi filtri o setacci: entrerà nel pacchetto base da offrire a tutti i cittadini soltanto quella domanda di salute che riuscirà a passare attraverso tutt'e quattro i setacci.
42
Il primo filtro proposto è quello di presentarsi come "cura necessaria". La Commissione propone come criterio di necessità il fatto di garantire l'assistenza del cittadino come membro della comunità. Se questo è il criterio che mette in moto la solidarietà, il demente, per esempio, o il malato in coma vegetativo permanente hanno diritto alle cure necessarie perché possano essere cittadini. Qualunque sia il costo, la cura necessaria supera il primo filtro. I più fragili ricevono una tutela sicura da questo meccanismo procedurale. L'efficacia, l'efficienza e la responsabilità individuale sono gli altri tre criteri che filtrano la domanda.
Offrire assistenza illimitata ad alcuni potrebbe arrecare danno ad altri. Quando, anche nel quotidiano, si pone il problema della limitatezza di risorse, la risposta eticamente più corretta è quella di risolvere i problemi più semplici o quelli più complessi che richiedono cure specialistiche? Risolvere completamente i problemi di pochi (per esempio garantire assistenza a domicilio 24 ore su 24 a un paziente con Alzheimer) o parzialmente quelli di un maggior numero di persone (2 ore di assistenza al giorno a 12 pazienti)?
Anche il lavoro della Commissione svedese parte dal presupposto che, se si vuole mantenere la fiducia del cittadino nella sanità, devono essere formulate apertamente e discusse le motivazioni fondamentali che stanno alla base delle misure adottate e delle priorità scelte. È necessario attivare un processo che porti a una più chiara definizione della sanità nei confronti della società e a una più netta delimitazione delle varie responsabilità. Come criterio per la scelta della priorità in campo sanitario la Commissione ha indicato una "piattaforma etica" costituita da tre principi: il principio della dignità umana (ogni essere umano ha una uguale dignità e gli stessi diritti, indipendentemente dalle caratteristiche individuali e dalle funzioni svolte nella comunità), il principio del bisogno e della solidarietà (le risorse devono essere dedicate a quei settori che presentano i maggiori bisogni) e il principio del costo-efficienza (nello scegliere fra differenti settori di attività o diverse misure terapeutiche, si deve mirare a un rapporto ragionevole fra costo ed effetti ottenuti, misurati in termini di miglioramento della salute e della qualità di vita. Il principio del costo-efficienza deve essere applicato solo per confrontare metodi di trattamento della stessa patologia).
"L'ordine assegnato a questi tre principi vede il principio della dignità umana prevalere su quello di bisogno e solidarietà, mentre quest’ultimo precede il principio di costo-efficienza. Poiché il principio di bisogno e solidarietà predomina su quello di costo-efficienza, le malattie gravi e le gravi compromissioni della qualità della vita devono avere la precedenza su malattie e compromissioni di minor entità, anche se l'assistenza alle patologie più gravi è di gran lunga più costosa. Il principio costo-efficienza non può pertanto giustificare l'astensione dalle (o una riduzione della qualità delle) cure dedicate ai morenti, ai malati gravi o cronici, agli anziani, ai dementi, ai ritardati mentali, ai gravi handicappati, o altre persone la cui cura non abbia un ritorno economico per la società" (Commissione del Parlamento svedese: Priorità nell’assistenza sanitaria, 1997).
43
capitolo
3
LA MEDICINA
A CHE COSA SERVE LA MEDICINA?
La medicina accompagna, fin dall'inizio, lo sviluppo di qualsiasi civiltà dell'uomo. Potremmo quindi presumere, considerando la sua antichità, che abbia rapporti solo marginali con quel movimento, a cui abbiamo dato il nome di "bioetica", che si è sviluppato in Occidente negli ultimi tre decenni del XX secolo. Dobbiamo invece riconoscere che proprio la bioetica è destinata a cambiare il volto della pratica medica. Almeno di una parte della medicina. Perché di fatto noi utilizziamo la medicina per diversi scopi: alcuni di essi sono modificati dal nuovo clima culturale della bioetica, mentre altri rimangono sostanzialmente inalterati.
Le nostre domande tradizionali
Possiamo ricondurre le numerose domande che siamo soliti rivolgere alla medicina a uno schema che considera tre principali modelli. Il primo è quello che alla medicina richiede il ritorno allo stato di salute compromesso dalla malattia. Gli antichi lo chiamavano restitutio ad integrum, vale a dire recupero della condizione precedente. L'intervento della medicina ci riporta alla situazione prima della malattia, chiudendo la parentesi aperta da quest'ultima. È quello che ogni malato ardentemente desidera. Pensiamo al felice momento in cui il dottore ci dice, dopo un periodo di forzata degenza: "Oggi si può alzare: è guarito!".
Aneliamo a tornare a essere "come prima", benché sappiamo che questo non è possibile in senso letterale: anche quando non vi fosse più alcuna traccia visibile della patologia ― come una leggera zoppia dopo una frattura del piede ― il corpo conserva una memoria del fatto patologico. Basti pensare alla immunizzazione che si acquisisce nei confronti dei batteri che causano le malattie infettive. E ancor più conserva memoria della patologia subita la nostra psiche. Ma il vissuto della restitutio ad integrum è esattamente questo: la senzione di tornare a poggiare i piedi sulla terraferma della salute, dopo essere stato sballottato tra i flutti della malattia.
Quando la volontà ― consciamente o meno ― non interferisce con questo processo, facendo desiderare una permanenza nello stato patologico, è la natura stessa che ci spinge verso la guarigione. In epoca greco-romana la tendenza della natura al recupero della salute era talmente valorizzata che alla medicina veniva attribuita la mera funzione di fornire un aiuto alla natura, favorendo la forza sanante insita in essa (vix sanitrix naturae). Dobbiamo concedere che, fino agli strepitosi progressi terapeutici realizzati a partire dalla metà del XX secolo, questo era, in definitiva, il ruolo della medicina: fornire un appoggio o una lieve accelerazione al processo della guarigione predisposto dalla natura.
44
Il secondo modello di cura era chiamato dai classici dell'antichità, sia medici che filosofi, "la guarigione sufficiente". Si tratta della misura di guarigione necessaria per continuare a vivere, pur non potendo ottenere la guarigione come restitutio ad integrum. Quello che per la medicina del passato era un’evenienza rara, quasi eccezionale ― prevalevano le malattie acute, a predominante tipologia infettiva, dalle quali o si guariva, o si moriva ― ai nostri giorni è diventato l'esito più frequente del processo di cura.
Il primo modello di cura si realizza ormai solo nel 20% delle nostre malattie, cioè in una minoranza delle situazioni patologiche. Nell'altro 80% di casi avviene che la medicina non riesce a dare la guarigione, intesa come restituzione all'integrità e alla salute piena, ma offre la guarigione che consiste nella capacità di continuare a vivere malgrado la malattia e con la malattia. La stragrande maggioranza delle malattie che ci portano a bussare alla porta del medico sono di questo tipo. Andando dal medico dobbiamo abbandonare il sogno ingenuo che usciremo prima o poi, fosse anche per un percorso lungo e contorto, dal tunnel della malattia per tornare alla salute.
La ricerca internazionale promossa dallo Hastings Center Gli scopi della medicina: nuove priorità (1997) ha descritto accuratamente il fenomeno del cambiamento dello scenario di cura e le ripercussioni nell'attività del medico: "Nei confronti dei malati cronici che devono imparare ad adattarsi a un sé nuovo e alterato, il lavoro del personale medico dovrà concentrarsi non già sulla terapia, ma sulla gestione della malattia, dove per gestione si intende l'assistenza psicologica empatica e continua a una persona che in un modo o nell'altro deve accettare la realtà della malattia e conviverci. Qualcuno ha osservato che la medicina, a volte, deve aiutare il malato cronico a forgiarsi una nuova identità" (Hastings Center, 1997).
In questo contesto il significato di cura è, dunque, diverso. Ciò implica che per un numero crescente di persone la medicina non dà risposte risolutive: offre solo, se si riesce a coglierla, la capacità di continuare a vivere con il nostro diabete, con il nostro asma, con la nostra insufficienza cardiaca, con le due (o tre, quattro, cinque) malattie croniche che si avvolgono le une sulle altre dopo una certa età.
Questo cambiamento di scenario modifica anche i contenuti degli interventi sanitari? L'intervento sanitario consiste non solo nel curare, ma anche nel creare autonomia che consente, almeno in parte, il controllo sulle situazioni. Creare autonomia significa non solo combattere la malattia e risolvere il problema, ma anche insegnare abilità e aumentare le conoscenze. Il patient empowerment si ottiene anche con l'informazione e il sostegno e amplia la gamma degli interventi in sanità. Il senso di un intervento sanitario è determinato dall'autonomia del paziente: libertà dal dolore, da un'infezione, maggiore capacità di controllo sulla malattia. Può questa prospettiva offrire un terreno comune per confrontare alternative e può aiutare nelle scelte?
Accanto a queste due domande che vengono abitualmente rivolte alla medicina, ne possiamo identificare una terza: la richiesta di essere accompagnati verso la conquista della "Grande Salute". Con questa espressione ― che prendiamo in prestito dal filosofo Friedrich Nietzsche, il quale per altro l'ha utilizzata in un senso leggermente diverso ― intendiamo quello stato che non presuppone né l'assenza di malattie, né la convivenza con esse, bensì la realizzazione del nostro progetto di uomini e di donne che, attraverso le vicende del corpo, danno forma a un destino che dipende da loro e che trascende il piano corporeo.
Possiamo descrivere la nostra storia di uomini e di donne dicendo che attraverso la nostra "patologia" ― cioè il pathos che noi viviamo ― scriviamo la nostra autobiografia; o ancora che la nostra autobiografia non è altro che la nostra "patografia", cioè una serie di sofferenze, dolori, prove legate alla nostra esistenza corporea. Elementi centrali di questa "autobiografia scritta attraverso
45
il pathos" sono le malattie; ma non solo queste. La salute non è solo la condizione registrata dal nostro libretto sanitario, ma è l'equivalente della nostra vita. La "Grande Salute" non è altro che la storia del nostro corpo attraverso momenti patologici o fisiologici che noi possiamo registrare come la storia della nostra autorealizzazione. Da questo punto di vista ― per fare un esempio ― aver avuto o no dei figli, averli avuti in buona salute o con problemi, o averli persi drammaticamente fa parte della nostra "patografia" nella stessa misura delle malattie che ci hanno colpito.
Molti sistemi medici, diversi dalla medicina scientifica o occidentale, intendono offrire un aiuto a realizzare la "Grande Salute", non meno di quanto vogliono favorire il recupero della salute compromessa dalla malattia. Offrono, infatti, significati e spiegazioni, indicano come ci si deve comportare, fanno da ponte con tutti gli altri aspetti della vita del gruppo culturale in cui si è inseriti. Nella nostra tradizione queste funzioni sono state attribuite più alla filosofia e alla religione che alla medicina; tuttavia la medicina, specialmente in passato, le ha svolte con ruolo di supplenza.
Probabilmente i medici del passato avevano un orecchio disposto ad accogliere delle domande che vanno inserite nel registro della "Grande Salute". Non solo perché l'arsenale terapeutico di cui potevano disporre era molto modesto e la scienza medica non era stata enfatizzata come risposta a tutti i mali. La pratica clinica, che ruotava fondamentalmente intorno all'ascolto del malato, aveva insegnato ai più sensibili tra i medici che una buona parte dei mali per i quali si chiede l'intervento della medicina ha radici molto più profonde della patologia organica e richiede perciò risposte che la scienza medica non può dare.
Un'illustrazione eloquente di questo atteggiamento è offerta dal racconto di Anton Cechov, Un caso di pratica medica (pubblicato in originale nel 1898: rispecchia, quindi, una medicina molto antecedente a quella che avrebbe preso il sopravvento nella seconda metà del XX secolo). Il protagonista è un medico di Mosca che viene chiamato a visitare, a parecchie ore di strada dalla capitale, la figlia della proprietaria di una fabbrica. La giovane donna sta male, anche se per la medicina "non ha niente". Vive praticamente reclusa con la madre vedova e una governante, accanto alla fabbrica di loro proprietà; la bruttezza fisica ne fa una naturale candidata a uno sterile celibato, mentre l'intelligenza non può che aumentare la sua infelicità.
Nelle ore che il dottor Korelëv è costretto a trascorrere accanto alla malata, in attesa di riprendere il treno il giorno dopo, si rende conto che tutta la situazione è malata: gli operai sfruttati e abbruttiti, i proprietari vittime dell'ingiustizia di cui sono gli artefici. Nel cuore della notte, passata quasi insonne, il dottore fa ancora una visita alla malata. La giovane donna gli dichiara di sentirsi incoraggiata a parlare di tutto:
"Voglio dirvi cosa penso. Credo di non essere malata; ma mi tormento e ho paura, perché deve essere così e non può essere altrimenti. Una persona qualunque, anche la più sana, non può non inquietarsi se sotto la sua finestra vive un brigante. Sono continuamente curata. Certo, ne sono riconoscente, non contesto l'utilità della medicina, però vorrei parlare non con un medico, ma con qualcuno che fosse vicino al mio spirito: un amico che mi comprendesse e saprebbe dire se ho ragione o torto."
"Non avete amici?"
"Sono sola, ho una madre e l'amo; tuttavia sono sola. La mia vita è andata così..." [...]
Sorrise nuovamente e alzò gli occhi verso il dottore. Il suo sguardo era pieno di malinconia, d'intelligenza. Parve a Korelëv che avesse fiducia in lui e volesse parlargli sinceramente; che avesse dei pensieri simili ai suoi. Ma ella taceva e forse attendeva che fosse lui a parlare.
Egli sapeva che cosa avrebbe potuto dirle. Era chiaro che bisognava ch'ella abbandonasse al più presto quei cinque fabbricati e il milione, se lo possedeva, e che lasciasse là il diavolo che di notte l'agguantava. Era ugualmente chiaro, per Korelëv, che ella pensava lo stesso, e che aspettava che qualcuno, di cui avesse fiducia, glielo dicesse.
Disse ciò che voleva, non con un discorso filato, ma in maniera tortuosa.
46
"Siete scontenta della vostra situazione di proprietaria di una fabbrica e di ricca ereditiera, non credete ai vostri diritti e non dormite. Questo è sicuramente meglio che se voi foste soddisfatta, e dormiste pensando che va tutto bene. La vostra insonnia è rispettabile e, checché ne sia, è certo un buon segno."
Invece di limitarsi a guarire togliendo il sintomo, il dottor Korelëv esercita quella che Jung avrebbe chiamato la funzione "pastorale" (Seelsorge) della medicina. È vero che, a suo avviso, chi si deve occupare dei fatti spirituali, connessi con la ricerca del significato, non dovrebbe essere il medico, ma il curatore d'anime; se il medico se ne occupa, è a causa della scarsa credibilità dei pastori.
Resta il fatto che, secondo la medicina più tradizionale, la restitutio ad integrum non è l’unico modo con cui l’arte medica opera la guarigione. Il concetto di "guarigione sufficiente", e ancor più la "Grande Salute", rimandano necessariamente all’individuo e alla società in cui è inserito, all’utopia della guarigione totale e al mondo dei valori che la persona fa propri.
La cura: modi e gradi
I tre modelli di domanda rivolta alla medicina ― la cura come restituzione della salute nella sua integrità, la cura come aiuto per vivere con le nostre malattie e infine la cura intesa come l’appoggio di cui abbiamo bisogno per diventare uomini e donne realizzati attraverso quello che la vita, dalla nascita alla morte, ci fornisce ― richiedono diversi ruoli dei curanti e presuppongono un diverso grado di consapevolezza da parte del paziente per partecipare al processo terapeutico. In maniera schematica, i modi e i gradi della cura possono essere così rappresentati:
|
|
La restituito ad integrum |
La "guarigione sufficiente"
|
La "Grande Salute" |
|
La descrizione del processo terapeutico |
Togliere il sintomo o la condizione patologica |
Rendere possibile la continuazione del progetto esistenziale
|
Giungere, attraverso la patologia, a una più piena autorealizzazione della persona
|
|
Il ruolo del terapeuta |
Professionista/ tecnico: propone la cura efficace (to cure)
|
Educatore: favorisce l’empowerment del malato |
Counselor (testimone partecipe): si prende cura (to care) |
|
La partecipazione consapevole del paziente
|
Auspicabile |
Necessaria |
Indispensabile |
Quando ci orientiamo al modello sottinteso alla restitutio ad integrum ― e quindi ci aspettiamo che l’intervento medico elimini la condizione patologica, ristabilendo lo stato di salute precedente, o quanto meno elimini il sintomo ― richiediamo da parte del sanitario che ci sia soprattutto la competenza clinica e che il processo di cura sia condotto secondo gli standard della scienza medica attuale. Il ruolo del terapeuta è massimamente attivo, in quanto deve intervenire con la cura efficace.
47
Nei casi di emergenza, o quando il paziente non è in grado di esprimere la sua volontà, il terapeuta si può lecitamente sostituire al paziente nel prendere le decisioni. La partecipazione consapevole del paziente al processo clinico è auspicabile, secondo la moderna cultura dei diritti che richiede il "consenso informato" del soggetto alle decisioni che lo riguardano; tuttavia quasi sempre in passato, e ancora oggi in molti casi, l'affidamento del paziente nelle mani del terapeuta equivale a una delega implicita a fare tutto ciò che è necessario per il recupero della salute.
Se invece lo scenario è il secondo, la situazione diventa più complessa. Il rapporto che si instaura quando lo scenario è quello della salute sufficiente, o necessaria a convivere con una patologia ineliminabile, è diverso da quello che predomina nelle malattie acute. È diverso anche il ruolo terapeutico: mentre nella medicina acuta il medico si occupa dell'emergenza e il paziente è passivo, nella medicina cronica il medico ha l'obiettivo di portare il paziente a contare su se stesso. Nella medicina acuta il rapporto è spesso genitore-figlio: il medico prende un ruolo di genitore e guida con autorevolezza; invece nella medicina cronica la relazione si modella piuttosto sul rapporto adulto-adulto.
I due modelli non sono necessariamente antitetici. Il primo modello, sostitutivo, si realizza anche nel secondo caso, quando le informazioni vengono impartite e non partecipate e condivise. L'insegnamento della tecnica senza far capire il come e il perché equivale alla somministrazione di un farmaco. Certo, il paziente deve voler continuare a eseguirla. Il dialogo può essere funzionale per continuare a mantenere un rapporto di potere dell'operatore sanitario e di dipendenza del paziente.
In generale, la medicina per i malati che non vanno verso la guarigione ma si trovano in una situazione di stabile cronicità domanda un numero maggiore di aspetti educativi. Educazione non sta per indottrinamento. Spesso si intende per educazione sanitaria l'insegnare al paziente ad assumere determinati comportamenti (non fumare, non assumere sostanze dannose, non mangiare dolci se si è diabetici...). L'educazione di cui parliamo qui non si limita a insegnare determinate regole. Come avviene nell'educazione degli adulti, vuol dire sostanzialmente cercare insieme obiettivi, negoziarli, verificarli, per poi ridefinirli da capo. È un rapporto adulto-adulto, fondato sul rispetto e la stima; il ruolo decisivo lo gioca non un'autorità che il terapeuta può esercitare dall'alto, ma il rapporto che si stabilisce nel tempo.
È possibile realizzare questo tipo di rapporto con tutti? Il rapporto tra adulti, fondato su stima e rispetto, prevede il superamento dei limiti definiti dal dovere professionale e il mettersi in gioco come persona. Non è sempre possibile realizzare con tutti una relazione. Questo mina i contenuti e l'efficacia dell'intervento sanitario?
La modalità della cura che risponde alla ricerca della "Grande Salute" non è esclusiva dei professionisti sanitari. Per essere curati in questo più ampio significato ― in maniera tale che attraverso le vicende del nostro corpo: quelle felici e quelle tristi, la generazione di altri viventi che perpetuano la catena dell'essere, la crescita, la decadenza e la morte, noi possiamo realizzarci ― più che un sapere tecnico è necessaria la capacità di essere presenti per l'altro e di esercitare un ascolto attivo: "l'ascolto che guarisce", come è stato chiamato (AA.VV., 1989). Possiamo chiamare questo rapporto counseling, intendendolo ― in senso molto inclusivo ― come una capacità di presenza per l’altra persona.
La misura della consapevolezza necessaria per entrare nel processo della "Grande Salute" è massima: nessuno ci può far crescere, se non lo vogliamo. Non è detto che le vicende del corpo ― nascita, crescita, resistenza alle aggressioni patologiche, decadenza, morte ― producano di per sé degli esseri consapevoli, cioè quegli "uomini" che sarebbero dovuti diventare, mettendo completamente
48
a frutto le proprie potenzialità. La fine della nostra vita come pienezza non è scontata, è un processo molto aleatorio. L'esperienza quotidiana ce lo conferma: ci sono delle persone che attraverso le dure vicende del corpo diventano migliori, maturano verso una maggiore umanità; ce ne sono altre che attraverso le vicende analoghe si chiudono, diventando ostili a tutto e a tutti, ancora meno apprezzabili dal punto di vista dell'autorealizzazione umana. Se i risultati della medicina non sono garantiti quanto alla restitutio ad integrum, ancor meno lo sono nei confronti della guarigione sufficiente e soprattutto della "Grande Salute".
CAMBIAMENTI DI SCENARIO: LA MEDICINA PREDITTIVA
Decodificare il destino
Non molto tempo fa, Karen Belz prese un appuntamento per vedermi nel mio studio. La conoscevo da anni, come amico di famiglia. Sempre franca e diretta, si aspettava che gli altri si comportassero allo stesso modo. Ora mi stava dicendo che voleva sottoporsi a un test per i cosiddetti geni del cancro della mammella, BRCA 1 e BRCA 2. "Non posso continuare a vivere in questo limbo", mi disse; "Devo sapere". Non ne fui sorpreso, dal momento che non era il primo membro della famiglia Belz a entrare nel mio studio. La madre di Karen, Eva, dopo una lunga lotta era morta di cancro alla mammella tre anni prima. Ruth, la sorella di Karen, di due anni più grande di lei, aveva sviluppato la stessa malattia sei mesi prima, all'età di trentasei anni. Dopo che il tumore era stato diagnosticato, Ruth aveva fatto il test per sapere se era portatrice della mutazione BRCA connessa con il cancro del seno ed era risultata positiva; aveva fatto pressione su Karen perché anche lei si sottoponesse al test.
Il test per il BRCA è uno dei primi frutti del progetto per il genoma umano. BRCA 1 e 2 sono due tra i circa 100.000 geni contenuti nei nostri 46 cromosomi. Le donne che ereditano una copia difettosa di uno dei due geni corrono un rischio significativamente maggiore di contrarre un cancro della mammella o dell'ovaio nel corso della loro vita. Questa incidenza è particolarmente alta tra gli ebrei Ashkenazi, come la famiglia Belz. La presenza combinata delle mutazioni di BRCA 1 e 2 tra gli ebrei Ashkenazi è maggiore del 2 per cento: un numero molto alto nella genetica di popolazione.
Lo stile di Karen era di andare diritto al nocciolo delle cose, ma io credevo che corresse troppo veloce. Non era possibile neppure dire che era destinata ad avere il cancro, per non parlare di che cosa bisognava fare. Mi sentivo sbalestrato, senza il sostegno di una base solida di dati clinici inoppugnabili. È un momento di inadeguatezza di cui ogni medico ha paura, in quanto si rende conto che, nonostante i gravi limiti delle conoscenze di cui disponiamo, bisogna decidere qualcosa ― qualcosa che in futuro potrebbe risultare fatalmente sbagliato.
Ero tentato di nascondermi dietro la popolare nozione dell’empowerment per il quale solo i pazienti possono scegliere la loro terapia, e dirle che solo a lei spettava la decisione. Ma non sarebbe stato un gesto codardo, una comoda scappatoia? La decisione era sua; ma ciò non significava che doveva decidere da sola.
"Deve farsi togliere le mammelle o le ovaie?". La domanda restò sospesa tra di noi per un lungo momento. "Perché la mia risposta le sia d'aiuto, dovrei sedermi al posto suo, invece che da questa parte della scrivania, essere una donna di trentaquattro anni, con due bambine e un solido matrimonio. Ma se io avessi una mutazione genetica analoga alla sua, con il 90 per cento di rischio ― per dire ― di cancro ai testicoli e 20 per cento di cancro alla prostata, e mio padre ne fosse morto e mio fratello ora ce l'avesse, nonostante un'accurata sorveglianza medica ― regolari indagini fisiche e radiologiche, biopsie ed esami del sangue ― e fosse sottoposto a trattamenti intensivi di chemio e radioterapia per le metastasi, con tutta la loro tossicità e incertezza dell'esito della cura, che cosa farei?". Con il mio discorso desideravo accendere l’intuizione, la sua e la mia. "Avrei davanti due scelte insoddisfacenti: una conservativa ― aspettare sotto sorveglianza ― e una radicale ― sottopormi a un'asportazione chirurgica preventiva ― senza una vera scelta intermedia."
"Non c'è nessun'altra possibilità?", mi interruppe Karen. "Accetto che non ci sia una soluzione semplice. Ma ti senti disperato quando ti dicono che c'è solo quello. Vorresti fare qualcosa per te stesso, e non limitarti a vivere sotto sorveglianza. Mi sembra come aspettare passivamente nel ghetto di essere selezionati."
49
[...] Come Karen, tutti noi siamo di fronte alla scelta di sapere le nostre probabilità di malattia. Oltre al BRCA 1 e 2, sono state identificate le mutazioni genetiche che predispongono al morbo di Alzheimer, al cancro del colon, al morbo di Huntington, ai tumori endocrini e al melanoma. La lista è destinata a crescere, fino a comprendere tutte le nostre potenziali patologie. Possiamo infischiarcene di questa conoscenza, sfuggirla; ma nei momenti di calma durante il giorno o quando ci svegliamo nel cuore della notte, saremo costretti ad accettarla come un nostro compagno permanente.
[...] Per una settimana ho aspettato ansiosamente che Karen venisse al nuovo appuntamento. Nella facoltà di medicina e durante gli anni di specializzazione non ero stato formato a trattare i problemi che dovevo affrontare. Non avevo avuto istruzioni da parte di un medico più anziano su come parlare e ascoltare, come decidere quali domande erano appropriate e quali da evitare, o come esporre gli argomenti in favore della migliore scelta.
Karen arrivò puntuale all'appuntamento di mezzogiorno. Parlò per prima, con serenità ed energia: "Mi farò asportare i seni e le ovaie". [...] Considerando le incertezze che pazienti come Karen devono affrontare, penso che abbiano a che fare meno con la scienza e la società del futuro, ma piuttosto con la saggezza che viene dal passato [...]. La speranza che ci sostiene viene dalla fede che il nostro futuro deve ancora essere creato, ed è creato in parte da noi.
Groopman, 2000
La storia che abbiamo letto ― riportata con le parole stesse del medico che ne è stato protagonista ― ci introduce in un aspetto nuovo della medicina: la sua capacità di prevedere i fatti morbosi. Non è più necessario che questi si presentino attraverso il dolore o i danni inferii all'organismo; anche la stessa diagnosi precoce, che individua la presenza di una malattia in una fase iniziale e quindi più facilmente curabile, è scavalcata dalle possibilità che offrono le conoscenze del genoma umano. Karen, la paziente del dott. Groopman, non ha il cancro: ha solo ereditato un gene che la espone, con una probabilità più alta di altre donne, a contrarlo un giorno.
Possiamo immaginare situazioni analoghe: come il caso di un giovane uomo nella cui famiglia ci siano casi di corea di Huntington (una grave malattia neurologica, che si manifesta per lo più dopo i 40 anni e che porta alla demenza). Non è malato; non sa neppure se si ammalerà. Potrebbe affidarsi al destino. Ma possiamo immaginare che, come Karen si ribella all'attesa passiva, che le ricorda la situazione del ghetto, da cui alcuni venivano prelevati a caso per essere spediti nei campi di sterminio, così il nostro uomo voglia acquisire le informazioni, attraverso il test genetico, per sapere se è portatore del gene che lo espone alla malattia. Alcune importanti decisioni della sua vita ― sposarsi, mettere al mondo dei figli, accendere un'assicurazione ― potrebbero dipendere da quelle informazioni. Questi sono alcuni degli scenari tipici della medicina predittiva.
Come si fa a promuovere autonomia (e quindi ad avere un 'consenso informato' dal paziente) quando si deve parlare di rischi? Il rischio include due concetti: quello di esito non voluto e quello di probabilità. In molte situazioni i rischi reali non sono noti; e a volte non si sa se una situazione sia un rischio o un beneficio. Ad esempio una chemioterapia può prolungare la vita, e questo può essere un esito positivo per alcuni ma un rischio per altri se la qualità di vita non è buona. Si può parlare di comunicazione e aiuto nelle scelte quando non si possono dare informazioni? su quale base può decidere il paziente?
La situazione che si crea quando si dispone di informazioni di natura probabilistica e si è costretti a prendere delle decisioni in condizioni di incertezza comporta degli aggravi particolari rispetto alla condizione che conosce ogni malato. Lo storico della medicina Diego Gracia ha osservato che il passaggio dall'etica medica alla bioetica è accompagnato da una profonda trasformazione che riguarda il sapere medico, nella sua dimensione scientifica e logica: "A una logica deterministica e casualistica sta subentrandone un’altra, statistica e probabilistica [...]. La medicina deve prendere continuamente delle decisioni in conformità con quella che viene
50
definita 'teoria della decisione razionale', che ci insegna a decidere in situazioni di 'incertezza', senza poter arrivare alla certezza. Queste decisioni si basano sempre sul calcolo delle probabilità. La decisione razionale è ovviamente la più probabile. Ma non si può esigere niente di più da nessuno" (Gracia, 1993).
Ciò vuol dire che al posto della prognosi sicura ("dire la verità") e al posto della diagnosi certa subentra un ventaglio di probabilità diagnostiche, di prognosi e di terapie riferite al singolo caso. Questo è l'orizzonte in cui si muove, in particolare, la "medicina predittiva". È fuorviarne immaginare che la "predittività" vada intesa come previsione di un evento clinico certo: ci muoviamo sempre nell'ambito delle probabilità. L'incertezza rimane l'orizzonte connaturale alla decisione clinica, anche quando vi introduciamo le conoscenze rese disponibili dalla genetica medica e dal counseling genetico. La dimensione etica che la caratterizza è sostanzialmente riconducibile all'ippocratico "giudizio difficile" ("La vita è breve, l'arte lunga, l'occasione fuggevole, l'esperienza fallace, il giudizio difficile": è il primo degli Aforismi attribuiti a Ippocrate). La difficoltà del giudizio deriva dall'incertezza del sapere su cui le decisioni devono essere prese.
Una donna di 40 anni, senza fattori di rischio, che ha paura di un cancro della mammella, si sottopone a una mammografia. La probabilità di avere diagnosticato un cancro è bassa ed è più elevato il rischio di un referto falso positivo, con lo stress che deriva dal fatto di doversi sottoporre a controlli, interventi non necessari... Quali rischi vanno discussi con il paziente: tutti i possibili rischi? i più comuni? i più importanti?
La medicina predittiva ci costringe a confrontarci con questioni etiche che erano implicite anche nella decisione clinica del passato, ma che ora non possono più essere disattese. Il processo di decision making acquista una maggiore complessità e risulta "difficile" in una misura impensabile in una prospettiva ippocratica tradizionale. Non si tratta solo di prendere delle decisioni in quella particolare forma di sapere che è la probabilità statistica (quale guida all'azione si ricava dal fatto di sapere che il feto ha il 50 o il 75 per cento di probabilità di contrarre la malformazione indesiderata? La mente umana, a differenza dei computer e dei "sistemi esperti", è molto povera quando si tratta di lavorare con una serie di probabilità); la medicina predittiva apre la porta a una quantità di fattori umani che intervengono nella decisione, rendendo l'esito imprevedibile.
La decisione non deriva, per un processo lineare, dalla diagnosi o dalla prognosi, ma si modella sulle convinzioni sociali e morali dei protagonisti. Non è un'entità astratta e neutra ― "la medicina" ― che determina le decisioni, ma sono piuttosto le convinzione sull'uomo, sulla vita, sul mondo, sulla felicità e sulla "buona vita", sul futuro. Sono decisive le scelte filosofiche incarnate nei nostri credi personali e nelle nostre ideologie collettive. Proprio la medicina predittiva ci costringe a renderci conto di quanta normatività implicita sia presente nelle cosiddette "indicazioni mediche", che pretendono di rivestire con l'autorità della medicina decisioni che non dipendono dalla sola medicina.
Questa prospettiva ha costretto la clinica tradizionale ad ampliare l'orizzonte di riferimento entro cui si era soliti prendere le decisioni. L'ampliamento è consistito nell'introdurre la considerazione della "qualità della vita" come criterio per le decisioni cliniche. Nella bioetica contemporanea questa prospettiva si è imposta con forza nelle decisioni che riguardano i trattamenti che prolungano la vita. Un gruppo di lavoro dell'autorevole Hastings Center ha elaborato, già alcuni anni fa, delle linee-guida per scelte cliniche centrate sulla valorizzazione del criterio della qualità della vita. Il documento prodotto afferma, tra l'altro:
La qualità della vita è un concetto etico essenziale, che prende in considerazione il bene dell'individuo, il genere di vita possibile, considerate le condizioni della persona, e se tale condizione permette all'individuo
51
di avere la vita che egli considera degna di essere vissuta [...]. Permettendo al paziente e a chi rappresenta di fare scelte che considerano la "qualità della vita", diminuiamo il rischio di imporre vite di dolore, indegnità o pesi insostenibili a coloro che sono incapaci di difendersi.
Guidelines on the termination of life, 1987
Il dibattito sulla "qualità della vita" evoca uno scenario che ribalta il significato che siamo soliti attribuire all'azione medica, facendo apparire una medicina che si presenta come costrizione violenta, invece che come beneficio; un apparato ostile e insensibile al vissuto soggettivo, invece che simpatetico aiuto nelle situazioni più drammatiche; una struttura autoritaria con cui si deve lottare per avere il diritto di uscirne, piuttosto che rivendicare il privilegio di entrarvi. Anche se il criterio della "qualità della vita" è stato inizialmente utilizzato con riferimento alle scelte che si pongono sul versante del prolungamento ("artificiale") della vita, la sua applicazione si è generalizzata a contesti sempre più ampi e a momenti sempre più precoci dell'esistenza. Anche nell'ambito della medicina predittiva la considerazione della "qualità della vita" è il perno attorno a cui ruotano le decisioni, di natura clinica e inscindibilmente anche etica.
Far prendere decisioni nel contesto di qualità di vita del paziente significa aiutare il paziente a tradurre i dati medi in dati rilevanti per la sua situazione. Ridurre i valori di colesterolo riduce il numero degli infarti nella popolazione generale: il singolo paziente può avere l'impressione di sostenere costi molto alti (farmaci, alimenti particolari) e pagare un prezzo elevato in termini di qualità di vita per una probabilità molto piccola di ottener un beneficio individuale. È compatibile questo tipo di comunicazione con i tempi di contatto con i pazienti e con i ritmi di lavoro? Non garantirla significa non dare autonomia e quindi venire meno ai fini della medicina?
Il riferimento "alla qualità della vita" obbliga a riconsiderare in profondità concezioni tradizionalmente acquisite, ma non più appropriate alla situazione attuale, circa gli scopi stessi della medicina. La lotta contro la malattia e la morte deve integrare anche il controllo del dolore e mirare a prevenire le indegnità della condizione patologica; il prolungamento della vita garantita dalla medicina deve far posto alla capacità di adattarla alle esigenze soggettive di fruibilità.
La preoccupazione tradizionale di far coincidere il fine della medicina con la volontà di procurare al paziente il bene della salute ― identificato in ciò che la scienza, di cui il sanitario è portatore, sa e può fornire ― deve commisurarsi con il diritto del paziente stesso a determinare (o per lo meno a co-determinare, all'interno dell'alleanza terapeutica che struttura il rapporto fondamentale) il proprio bene. Il "principio di autonomia" completa e controbilancia il tradizionale "principio di beneficità". Più che contrapposti, i due principi vanno integrati. Senza il correttivo che l'uno apporta all'altro, ambedue possono guidare l'azione verso scelte estreme, alle quali la maggior parte delle persone ragionevoli negherebbe il proprio consenso morale.
VERSO UNA MEDICINA DELLA PERSONA
La richiesta di "umanizzazione" della medicina
La bioetica come movimento culturale, prima, e come disciplina specifica, poi, si è sviluppata su un terreno preparato da una diffusa accusa di "disumanizzazione" rivolta alla medicina e di una parallela richiesta di "umanizzazione". Sia l'una che l'altra hanno diversi significati. Quello più corrente ha a che fare con la sensazione che, parallelamente all'accrescersi delle potenzialità terapeutiche della medicina, si è andata atrofizzando la capacità degli operatori sanitari di essere presenti, in quanto persone umane dotate di sensibilità ed emozioni, alla persona del malato. In breve, si rimprovera ai professionisti della sanità di saper "curare", ma di non saper "prendersi cura".
52
53
Roma, Archivio di Stato, O.S.S. 3193
Liber Regulae Sancti Spiritus
Capitolo 35: La ricerca degli infermi
Le 54 scene figurative delle iniziali del Liber Regulae raffigurano sia la vita conventuale dei confratelli, sia le loro opere di carità, quali la cura degli infermi, l'assistenza agli anziani e bisognosi, l'accoglienza delle donne in difficoltà, dei pellegrini e dei frati degli ordini mendicanti. Compiti del tutto particolari erano l'accoglienza dei nobili bisognosi e la ricerca dei malati abbandonati nelle piazze e nelle strade della città. L'incapacità di molti infermi di raggiungere l'ospedale con le proprie forze viene esplicitamente espressa nella Regola. Il capitolo 35 recita: "In un giorno della settimana, per le vie e per le piazze, si cerchino i poveri infermi per condurli alla Casa di Santo Spirito, dove saranno curati con grande diligenza". La miniatura corrispondente rappresenta un malato che viene adagiato su un carro da un confratello e da una consorella per essere trasportato all'ospedale di Santo Spirito. Un terzo confratello si china su di lui a mani giunte, offrendo conforto spirituale. Sia gli abiti che il carro mostrano l'insegna dell'ordine: la doppia croce che il capitolo 53 della Regola obbligava a portare sulla parte sinistra del mantello.
Nella metà superiore dell'immagine si vede un uomo in attesa davanti a un edificio a due piani, che rappresenta l'ospedale. Si tratta probabilmente del precettore che accoglie il nuovo venuto. Il capitolo 8 della Regola prevedeva che il malato, prima di essere messo a letto, si confessasse e ricevesse la comunione.
Christina Riebesell
54
Prendersi cura vuol dire "prendere in carico" la persona con i suoi problemi, non solo quelli sanitari. Un anziano viene ricoverato per una polmonite, contratta perché non ha il riscaldamento in casa. La presa in carico prevederebbe a cercare di risolvere i problemi: raccogliere una corretta anamnesi, segnalare il caso all'assistente sociale, non dimetterlo perché altrimenti il problema si ripresenterebbe... Si può chiedere tutto questo a un operatore sanitario?
Questo discorso sulla disumanizzazione/umanizzazione della medicina si svolge sul piano della "morale". Nel linguaggio comune con questo termine non si intende la disciplina filosofica che considera il comportamento umano alla luce dei valori (bene/male, giusto/ingiusto, utile/dannoso) bensì, in senso più riduttivo, si giudica il comportamento altrui in base a delle attese. Accusando medici e personale sanitario di disumanizzazione, in pratica "si fa loro la morale". Si rimprovera ai medici e agli infermieri di non ispirarsi agli ideali sanitari e filantropici tradizionalmente connessi con le professioni terapeutiche. Anche l'esaltazione della professione del medico e dell'infermiere come "missione" conduce allo stesso risultato: il sanitario, confrontato con un modello troppo idealizzato ― qualcuno si spinge fino a considerare le professioni sanitarie come una specie di sacerdozio della salute, e quindi si aspetta da chi le esercita la stessa dedizione altruistica propria dei sacerdoti ― tende a ripiegare sulla rassegnazione o sul cinismo.
Simili campagne di moralizzazione, che accompagnano oggi come un controcanto l'enfatizzazione delle notizie di "malasanità", non danno i risultati attesi da chi le conduce. Rischiano invece di essere controproducenti: i sanitari, sentendosi sotto accusa, si chiudono in se stessi corporativisticamente, oppure rispondono alle critiche, percepite come aggressioni ostili, con altrettanta ostilità. Sulla base di tale reciproca incomprensione non si può costruire nessun progetto per innalzare la qualità della pratica medica. Si scava, piuttosto, un fossato sempre più ampio di diffidenza, proprio in un ambito in cui la fiducia è il valore principale.
Per una questione di giustizia, e non per una tattica di captatio benevolentiae, a coloro che lavorano nell'ambito della sanità bisogna anzitutto tributare il riconoscimento che non svolgono un lavoro come gli altri: per la particolare situazione del malato ― talvolta in lotta drammatica per la vita e la salute, in stato di particolare tensione emotiva sempre ― i sanitari sono coinvolti e sollecitati a una partecipazione umana che supera quella di qualsiasi altro lavoro. Quando i discorsi suH'umanizzazione della medicina pigiano esclusivamente il pedale dei sentimenti, accusando al tempo stesso i sanitari di non mettere abbastanza cuore in quello che fanno, la morale, da terreno saldo di consenso sulla base della condivisione degli stessi valori, rischia di tramutarsi in sabbie mobili.
L'ambivalenza della richiesta di umanizzazione sta nel fatto che spesso si chiede ai singoli di adottare comportamenti diversi rispetto a quelli previsti dal sistema. Un conto è la richiesta, legittima, di sensibilità, buona educazione e buon senso, fatta al singolo medico o infermiere nel rapporto individuale col paziente. Diverso è pensare di poter trovare spazi di dialogo per tutti in un contesto con poco personale e ritmi di lavoro concitati; di poter spendere un'ora per spiegare a un paziente i rischi di un intervento quando l'ambulatorio ospedaliero fissa gli appuntamenti a intervalli di mezz'ora; o prolungare un ricovero per problemi "sociali" quando i DRG fissano dei limiti.
Una particolare insidia è insita nelle argomentazioni moraleggianti di tipo religioso. Quando, per esempio, si presenta unilateralmente il lavoro sanitario sotto la metafora del Buon samaritano e a medici e infermieri viene richiesto un comportamento tutto modulato sull'oblatività, l'abnegazione e l'amore per il prossimo, si incrementa inevitabilmente il senso di inadeguatezza. Di qui è poi facile scivolare in cronici sensi di colpa. Ciò che ne consegue è per lo più una brusca interruzione di contatto con la proposta di un ideale così manifestamente lontano dal poter essere tradotto in atto. Da questo punto di vista, gli operatori che non vogliono più sentir parlare
55
di "umanizzazione" esprimono piuttosto un giustificato rifiuto delle "prediche", nel senso angustiante e oppressivo del termine.
Un altro portale d'ingresso alla richiesta di "umanizzazione" della medicina è costituito dalle accuse di distanza dai bisogni emotivi del malato a causa della crescente tecnicizzazione degli interventi diagnostico-terapeutici. È diventato un luogo comune contrapporre la medicina altamente tecnologica (high tech) a quella con contenuti molto umani e coinvolgenti (high touch). Il tema è presente, da più di un decennio, soprattutto nelle pubblicazioni infermieristiche.
È corretto separare la funzione di cura (tecnica) da quella di assistenza (relazionale)? Un eccessivo coinvolgimento emotivo non consente di tenere il giusto distacco necessario per fare alcune scelte o interventi terapeutici; una presenza basata solo sul sostegno relazionale è sostituibile con la presenza parentale. Peraltro, quando si esegue un intervento tecnico è fondamentale concentrarsi su quello che si i sta facendo e dimenticare la persona (per esempio il chirurgo che opera; o l'endoscopista che esegue una broncoscopia).
La risposta alle nuove tecnologie biomediche, con il loro pericolo intrinseco di freddo distacco, viene individuata in una vicinanza che ha funzione di compensazione. Il ruolo di "contatto" è affidato per lo più alla professione infermieristica, con il risultato globale di una maggiore concentrazione del medico sulle dimensioni tecniche della cura. La pratica medica, tutta rivolta all'efficacia della prestazione, si sente autorizzata in tal modo a essere sempre più fredda, in quanto la calda presenza dell'infermiere compensa le sue carenze. Tra curare e prendersi cura viene così a instaurarsi una dicotomia, che giunge a immaginare un "curare" (come impresa eroica, hard) dispensato dal "prendersi cura" (attività lasciata a professioni più soft, dedite alla dimensione relazionale). Anche l'umanizzazione della medicina che accettasse la separazione sistematica tra l'high tech e l'high touch, puntando solo su quest'ultimo per rispondere al senso di estraneità crescente dei pazienti, finirebbe per costituire un tradimento della causa.
Il recupero antropologico del soggetto
La richiesta di "umanizzazione della medicina" può essere intesa, in una seconda accezione, come la richiesta di un punto di vista sull'uomo, sano o malato, diversa da quella propria delle scienze naturali, che la medicina ha assunto da quando si è andata strutturando come scienza, a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Il ripensamento della medicina è legato al superamento del positivismo come modello più alto del sapere.
Il positivismo è una teoria filosofica elaborata nel XIX secolo, ma che ha influenzato anche il secolo successivo. Inteso come rispetto dei fatti osservati, il positivismo costituisce una delle acquisizioni della filosofia della scienza a cui non si può rinunciare. Ma l'uomo di scienza, legandosi al positivismo, aveva creato situazioni parziali e tendenziose, illudendosi sulla professata obiettività impersonale dei fatti. Ciò si verifica soprattutto quando oggetto della scienza è l'uomo.
Lo spirito del positivismo è reso letterariamente dalla dichiarazione di fede che Charles Dickens nel romanzo Tempi difficili mette in bocca a un personaggio, Thomas Gradgrind, un direttore di scuola che si compiace di essere un uomo "eminentemente pratico". Il romanziere immagina che, rivolgendosi a un gruppo di signore presenti in una scuola, il personaggio, campione del positivismo, rivolga loro questo discorsetto:
"Ora quello che voglio sono Fatti. Insegnate a questi ragazzi e a queste ragazze Fatti e niente altro. Solo di Fatti abbiamo bisogno nella vita. Non piantate altro e sradicate tutto il resto. Solo coi Fatti si può plasmare
56
la mente degli animali che ragionano: il resto non servirà mai loro assolutamente nulla. Questo è il principio su cui ho allevato i miei figli, e questo è il principio su cui ho allevato questi fanciulli. Tenetevi ai Fatti, signore!".
Applicato alla medicina, il positivismo tendeva a concepirla come scienza pura, fondata su fatti, su nudi fatti. La medicina si proponeva di essere neutra o indifferente rispetto alle questioni collegate ai valori; la scienza medica, nella sua purezza, si riteneva collocata al di là del bene e del male.
Assumendo il modo di conoscere proprio delle scienze naturali, la medicina ha cercato di adeguarsi a quella forma particolare di conoscenza che è fondata sulla razionalità e si acquisisce con l'osservazione e l'esperimento, secondo una particolare metodologia "critica". In quanto scienza naturale, la medicina procede empiricamente. La sua base è costituita da fisiologia e patologia; disfunzione e malattia sono considerate come conseguenze di disturbi di processi materiali-organici. In questa prospettiva, la malattia non è più qualcosa che capita all'uomo nel suo insieme, ma qualcosa che succede ai suoi organi. Lo studio delle cause della malattia si restringe alla ricerca di mutamenti locali nei tessuti, nelle strutture cellulari e nella stessa costituzione delle molecole biochimiche fondamentali. Il fatto morboso si ritiene compreso quando si può spiegare stabilendo il rapporto causa-effetto, sulla base delle leggi che regolano i fatti fisico-chimici.
La razionalizzazione di tipo naturalistico porta a spogliare il fatto morboso di ogni carattere storico e personale. Esso è significativo per la medicina solo in quanto è un caso "tipico". La stessa organizzazione della clinica riposa sul modello organicistico: le malattie vengono suddivise per reparti, come le merci di un supermercato; e i medici, passando di letto in letto come tecnici a una catena di montaggio, si dedicano a scoprire le cause del guasto, per riparare l'organo malato. Questa medicina è la medicina dei pezzi; e, con la specializzazione crescente, di pezzi sempre più piccoli.
Questo aspetto è però anche positivo perché ha portato alla crescente specializzazione della medicina e delle sue risposte. La perfetta conoscenza dei polmoni consente di intervenire meglio sulle malattie respiratorie. La specializzazione in chirurgia della mano permette al chirurgo di riattaccare un dito. La biologia molecolare ha frantumato ulteriormente il concetto di organi o loro sezioni. Si tratta di un passaggio indispensabile o di esasperazione e frantumazione, fino a snaturamento, delle conoscenze?
Da quando la medicina si è organizzata come scienza della natura, è cominciato per l'arte di guarire un periodo di splendore, sotto l'egida dell'efficacia e di realizzazioni mai raggiunte in precedenza. I progressi della chirurgia, della batteriologia, della farmacologia non sarebbero stati ottenuti, se la medicina non si fosse allineata tra le scienze della natura. Proprio questi successi, fungendo da rinforzo positivo, portano a consolidare la convinzione che la strada imboccata fosse quella giusta, impedendo di rendersi conto dei pericoli insiti in essa. Senza misconoscere i momenti positivi della concezione natural-scientifica (in particolare il principio della ricerca empirica esatta e il significato fondamentale del lavoro di indagine di tipo fisiologico e biochimico), si deve però convenire che, quando l'uomo è considerato semplicemente come un pezzo di natura tra gli altri, si opera una violenta mutilazione antropologica.
La crisi nella medicina non sarà superata finché non avremo rifiutato di considerare come esclusivo il punto di vista delle scienze della natura. L'"umanizzazione" da introdurre nella pratica dell'arte sanitaria è più radicale del semplice recupero degli aspetti filantropici o umanitari ― nel senso che abbiamo analizzato sopra ― da includere, oltre alla competenza professionale, nel rapporto con il malato. La disposizione interiore dell'oblatività e le virtù personali sono ovviamente
57
necessarie per l'esercizio dell'arte sanitaria: vir bonus, sanandi peritus, definiva il medico la tradizione ippocratica (dove "bonus" indica una costellazione di qualità che si aggiungono alla perizia professionale). Le stesse esigenze valgono per chiunque ― infermiere, tecnico, ausiliare ― avvicini il malato. Ma la "bontà" dell'operatore non basta, da sola, a umanizzare la medicina, se questa non recupera la prospettiva della totalità dell'essere umano.
Ciò vuol dire, in pratica, che il sapere mutuato dalle scienze della natura deve essere abbinato a quello che è specifico delle cosiddette "scienze umane": la storia, la sociologia, la psicologia, l'antropologia culturale, il diritto, la filosofia, la teologia, solo per menzionare le più importanti. Esse meritano il nome di "umane" perché considerano nell'uomo la formalità che lo specifica, ciò per cui l'uomo si differenzia dagli altri esseri animati: la sua storicità, interiorità, individualità, spiritualità. In una parola, l'uomo come soggetto. Mentre invece è procedimento tipico delle scienze della natura evacuare il soggetto, per considerare l'uomo come un pezzo di natura tra gli altri.
È innegabile che esiste una relazione tra storia personale, ambiente in cui si cresce, cultura e stato di salute. Mettendo insieme in un modello troppe variabili, non si rischia di renderlo difficilmente intellegibile? In fondo, i progressi sino a ora ci sono stati perché la frammentazione dell'uomo in organi ha consentito di studiarli, comprenderli, creare dei modelli di funzionamento. Tenere conto dell'influenza reciproca di numerose variabili (cliniche, fisiologiche, ambientali, psicologiche, culturali) renderebbe oltremodo complessa la costruzione di modelli. Quindi, pur riconoscendo una certa relazione, tenere separato il biologico, dallo psicologico, dal sociale è forse una necessità.
Questo è un esito particolarmente infausto in medicina, dove si fa più evidente che l'uomo considerato in questo modo diventa una caricatura. Nel suo linguaggio codificato, il malato scompare; la sua presenza è puramente oggettuale. Com'è stato detto efficacemente, per essere più scienza, la medicina perde il malato. Con altra formula a effetto, qualcuno ha denunciato che la medicina rischia di morire di obesità scientifica...
Finché l'uomo malato non sarà considerato anche secondo il punto di vista delle scienze della natura, sarà sempre "mal-trattato", anche se, per ipotesi, il trattamento fosse irreprensibile dal punto di vista di ciò che prescrive la scienza medica. La congiuntura culturale sembra oggi favorevole a una medicina che voglia ricucire lo strappo creatosi tra scienza della natura e scienze umane, le quali non mostrano più di nutrire quel complesso di inferiorità che le ha tradizionalmente caratterizzate nei riguardi delle prime.
Un secondo elemento congiunturale è la crisi in atto nelle scienze naturali: crisi non di disgregazione, ma di crescita. Secondo l'analisi di Thomas Kuhn, si sta registrando nelle scienze un tipico periodo di transizione dalla "scienza normale" al caos che precede il cambiamento di paradigma. La filosofia della scienza ― o epistemologia ― contemporanea ci ha reso consapevoli che le scienze non procedono per accumulo lineare di conoscenze, ma per rivoluzioni, nel corso delle quali ha luogo un cambiamento di paradigma. Si pensi al passaggio dalla fisica di Aristotele a quella di Newton, e da questa alla fisica di Einstein; al passaggio dal sistema geocentrico di Tolomeo all'astronomia di Copernico e di Galileo; alla transizione dalla teoria del flogisto alla chimica di Lavoisier: sono tutti esempi di una ristrutturazione del sapere sulla base di un "nuovo paradigma" che emerge dal caos. Lo stesso clima si può cogliere oggi nelle scienze biomediche.
È legittimo attendersi che nel nuovo paradigma emerga un'antropologia diversa da quella implicita nella medicina scientifica finora invalsa. Ciò comporta una rottura con il naturalismo, che considera l'uomo come un essere vivente in tutto e per tutto simile agli altri esseri viventi, e si attiene a una metodologia che esclude sistematicamente gli aspetti psichici, spirituali,
58
storico-biografici e sociali dell'esistenza umana (o quanto meno non li ritiene rilevanti per il processo patologico e per quello terapeutico).
Il paziente lavoro di ricostruzione dell'immagine dell'uomo malato, compito delle scienze dell'uomo abbinate a quelle della natura, si completa con la riconquista del soggetto, che è il vero regista dei sintomi e il protagonista del processo di guarigione. Possiamo evocare il processo facendo ricorso a una felice figura, uscita dalla fervida immaginazione del romanziere Salman Rushdie: l'immagine del lenzuolo bucato. Il romanzo I figli della mezzanotte (1984) ricostruisce la biografia del personaggio principale presentandoci suo nonno, che era medico in India all'inizio del XX secolo. Aziz è un giovane intraprendente, che ha studiato in Inghilterra e conosce bene l'arte medica. Viene chiamato da un possidente locale per effettuare una visita medica a sua figlia:
"Dottor sahib, mia figlia, ovviamente, è una ragazza per bene. Non mostra il proprio corpo agli estranei. Lei capirà quindi che io non posso permetterle di vederla, per nessuna ragione."
"Ma Ghani sahib, vuoi dirmi come faccio a visitarla senza guardarla?", obietta il dottore.
L'espediente per visitare la ragazza è trovato ricorrendo a un lenzuolo, al cui centro era stato praticato un buco, un cerchio rudimentale di circa diciotto centimetri:
"Lei sarà così gentile da specificare quale parte di mia figlia le è necessario ispezionare. Dopo di che io impartirò l'ordine di porre il segmento richiesto in corrispondenza di quel buco che lei vede. In questo modo la cosa sarà perfettamente possibile."
Nel corso di tre anni Naseen Ghani, la figlia del proprietario terriero, contrasse un numero veramente straordinario di piccole malattie. Le visite del medico divennero eventi quasi settimanali:
Ogni volta gli si concedeva di contemplare fugacemente attraverso il lenzuolo mutilato, un diverso cerchio di diciotto centimetri del corpo della ragazza [...]. Così a poco a poco il dottor Aziz si costruì mentalmente un'immagine di Naseen, un collage mal combinato delle sue parti separatamente ispezionate. Questo fantasma di donna ripartita cominciò a ossessionarlo, e non soltanto nei suoi sogni.
A questo punto è fin troppo chiaro che le malattie erano un pretesto dietro cui si nascondeva un soggetto desiderante, e il lenzuolo perforato un espediente per far sorgere un desiderio corrispettivo nel medico. Paradossalmente, la medicina dei nostri giorni assomiglia in modo inquietante a quella praticata in un contesto culturale arcaico, quale quello della provincia indiana di un secolo fa. Ma la nostra, malgrado la sua sofisticatezza tecnologica, è ancora più grossolana quando ignora la presenza nascosta di un soggetto desiderante che si nasconde dietro la patologia. La medicina dei pezzi che noi mettiamo in pratica non è un astuto espediente poetico per far indovinare la presenza nascosta del soggetto, ma solo una visione impoverita della realtà umana.
La terza rivoluzione biomedica
Il cammino verso la medicina della persona non passa attraverso il rifiuto della scienza, ma piuttosto attraverso il superamento di visioni dell'uomo prodotte da una scienza parziale. In questo senso sono esemplari le prospettive che ci apre la ricerca genetica più recente. Gli osservatori più attenti dello scenario scientifico descrivono i progressi ai quali stiamo assistendo come "la terza rivoluzione biomedica". Così titola un articolo, a firma dello storico della medicina Mirko Grmek, apparso nel supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore. L'importanza dell'articolo è duplice: per il nome dello studioso ― uno dei più importanti storici del pensiero medico e delle scienze biologiche ― e per la data. L'articolo è apparso infatti alla vigilia della morte dello storico, morte favorita dalla rinuncia volontaria al supporto respiratorio di cui aveva bisogno per la
59
grave malattia che stava consumando la sua vita. Lo scritto ha perciò il valore di un lucido testamento spirituale.
Ricostruendo le fasi attraverso le quali è passato il pensiero scientifico occidentale, Grmek individua tre rivoluzioni che hanno portato alla scienza biomedica dei nostri giorni. La prima, che gli storici sono soliti chiamare la "rivoluzione scientifica" per antonomasia, si colloca nel XVII secolo, il secolo di Galileo. La seconda è avvenuta nella seconda metà del XIX secolo: un insieme di idee nuove (pensiamo alla "medicina sperimentale" di Claude Bernard), di scoperte convergenti e di tecniche molto più efficaci di quelle del passato modificano profondamente il sapere e il saper fare sia delle scienze della natura non vivente, sia di quelle della vita. La terza rivoluzione, quella che abbiamo sotto i nostri occhi e che è destinata a portare frutti soprattutto in futuro, è legata alla scoperta delle basi informazionali dell'organizzazione biologica.
Nei processi biologici c'è qualcosa di non riducibile alle leggi della materia e dell'energia. Questa entità ― che in mancanza di meglio chiamiamo "informazione" ― è un processo di cui l'intera natura, e non soltanto la natura vivente, è intrisa. Il concetto di informazione codificata dà una spiegazione unitaria di fenomeni biologici diversi: "Nel collegare la biochimica delle macromolecole alla genetica e alla teoria dell'informazione, la biologia ha trovato un nuovo paradigma e conquistato un campo di applicazione particolarmente vasto e fecondo [...]. Questa padronanza inedita della creazione, del destino e della morte dell'individuo solleva delicati problemi etici e impone una riflessione su concetti metafisici fondamentali. In una situazione in cui a gravi rischi di deriva si accompagnano insperate promesse, la medicina predittiva, l'ingegneria genetica, i trapianti di organi e l'uso di protesi sofisticate aprono prospettive talmente nuove, così esaltanti e inquietanti allo stesso momento, che l'aggettivo rivoluzionario non sembra esagerato" (Grmek, 2000).
Un passo decisivo nella direzione indicata da Grmek è costituito dal concetto di "malattia molecolare", che fa dipendere la patogenesi delle malattie da anomalie di molecole informazionali. "Con l'avvento della genetica molecolare il gene ha cercato di sostituire il microbo come supporto della concezione ontologica della malattia. Secondo la medicina predittiva basata sulla genetica molecolare, infatti, nel nostro patrimonio genetico risiede la causa ultima delle nostre malattie, e con il sequenziamento del DNA umano si spera di poter dare una base di certezza alla diagnosi precoce e di stabilire strategie di prevenzione e trattamento delle malattie" (Corbellini, 2000).
Questa nuova rivoluzione non rischia forse di aumentare l'onnipotenza della medicina? Mentre prima la medicina si limitava a riparare un organo ammalato, adesso interviene addirittura su informazioni codificate prima della nascita e che segnano il destino di salute, malattia e sviluppo della persona. Questo non rischia di confermare sempre di più quella separatezza tra corpo e psiche che si stava faticosamente cercando di ricongiungere?
È assolutamente prematuro ogni tentativo di immaginare il volto che assumerà la medicina dopo che la "rivoluzione dell'informazione" si sarà completamente realizzata. Possiamo solo prevedere che solamente allora la causa di una medicina della persona sarà vinta. L'orizzonte di una medicina della persona in senso pieno include sia la prospettiva dell'"umanizzazione" (nel duplice significato di una pratica medica che faccia appello a quella disposizione interiore dell'operatore sanitario appropriata alla fragilità di chi a lui fa ricorso e di una medicina che sappia fare ricorso alle scienze umane, oltre che alle conoscenze biologiche), sia quella del recupero della soggettività del malato, adottando un approccio olistico e non parcellizzato o centrato sugli organi bisognosi di un intervento terapeutico. Tuttavia la meta sarà raggiunta solo quando saremo in grado di considerare quella assoluta unicità della persona che può essere colta non con una credenza metafisica, bensì con la conoscenza del tessuto informativo che organizza a livello molecolare l'individuo.
60
IL GIOCO DELLE LIBERTÀ IN MEDICINA
Sotto lo slogan: "Libertà di scelta"
Uno dei cambiamenti più innovativi intervenuti nell’orizzonte della medicina è l'irruzione del concetto di libertà. "Libertà di cura", "libertà di scelta": è ricordo recente come, all'insegna di slogan di questo genere, si sia sviluppato un movimento di opinione molto aggressivo, per rivendicare l'accesso dei cittadini a un trattamento del cancro che, contrariamente a quanto riteneva la medicina ufficiale, veniva presentato come efficace. Il clamore sollevato dalla presunta "terapia Di Bella" è tramontato e le polemiche rifluite; ma in medicina con la richiesta della libertà di cura si è aperto un capitolo inedito.
Non si tratta solo dell'attenzione che l'una o l'altra terapia fasulla periodicamente attirano su di sé, prima di scomparire di scena dopo il breve periodo di notorietà. L'opinione pubblica non si è trovata solo di fronte all'ennesimo episodio di millantato credito da parte di un trattamento o dello straripare di una moda in medicina. Le folle in piazza che reclamano un farmaco in nome della libertà di cura possono essere viste come la spia di una transizione in atto nella medicina come pratica sociale.
Un fenomeno meno effimero della cosiddetta multiterapia Di Bella è il ricorso di molte persone alle "medicine alternative". Con questo nome si intendono sistemi medici che sono cresciuti nell'alveo della tradizione dell'occidente, ma discostandosi dalle interpretazioni della malattia fornite dal sapere medico ufficiale e dai rimedi riconosciuti. La medicina omeopatica è il più noto di tali sistemi. Oppure modalità di cura sviluppatesi al di fuori della cultura occidentale, come l'agopuntura cinese, la medicina tibetana o quella ayurvedica dell'india. Il ricorso alla variegata schiera di "altre" medicine, in alternativa o in modo complementare alla medicina scientifica ufficiale, è molto frequente. Anche in questo caso si pone il problema della libertà di cura: siamo liberi di scegliere il sistema medico che preferiamo? Possiamo richiedere che i sistemi solidaristici ― in particolare, la sanità pubblica, finanziata con i soldi di tutti ― si facciano carico delle nostre scelte preferenziali?
Il sistema di finanziamento pubblico della sanità deve fare in modo di ottenere i massimi benefici rispetto alle risorse disponibili. Questo limita, inevitabilmente, le scelte del paziente (e non solo). Si devono finanziare solo i trattamenti di documentata efficacia, e ignorare trattamenti molto utilizzati (molte forme di medicine complementari) che pesano in termini economici sui pazienti? Dato che l'appartenenza al SSN non è una scelta libera, né necessariamente condivisa, l'utente non dovrebbe poter pretendere di avere i trattamenti che preferisce?
La novità di questi interrogativi risalta nel confronto con l'esercizio della medicina che ha dominato fino al più recente passato, quella in cui il rapporto tra professionisti sanitari e pazienti era iscritto entro il perimetro del paternalismo. Ciò vuol dire, concretamente, che era il medico a decidere che cosa andava fatto per il bene del malato: prescriveva la terapia ― una decisione che prendeva da solo, "in scienza e coscienza", si era soliti precisare ― e il malato la eseguiva. Il dovere del malato era di sottomettersi all'autorità medica, diventando "osservante" (compliant; in inglese). "Obbedire al medico è cominciare a guarire", sentenziava l'illustre medico spagnolo Gregorio Marañon, fornendo un'istantanea che fotografa il modello ideale della medicina di ieri. Rispetto a quel modello dobbiamo riconoscere che anche in medicina, come in tanti altri ambienti della vita sociale, l'obbedienza non è più una virtù.
Nell'immaginario degli operatori sanitari (degli infermieri in particolare) il paziente impopolare è un paziente che disubbidisce (rifiuta le cure) o il cui comportamento non risponde al quadro patologico (una patologia non grave con un paziente accasciato a letto, che si lamenta...). Anche questa è una forma di disubbidienza (o non rispondenza) rispetto alle attese. Per molti operatori sanitari l'ubbidienza è ancora una caratteristica positiva.
61
La "disobbedienza civile" dei cittadini non si esercita solo nei confronti di cure ancora parzialmente o sostanzialmente inefficaci ― come nel caso dell'oncologia ― ma tende a invadere progressivamente la pratica dell'intera medicina. Se fino a ieri il "malato inosservante" (Iandolo, 1985) poteva essere individuato come problema per il singolo medico, carente di autorevolezza e delle capacità pedagogiche necessarie per ottenere l'adeguamento del paziente alle sue prescrizioni, oggi la rivendicazione da parte dei cittadini di poter dire la loro sulle terapie appropriate sconvolge il quadro stesso di riferimento entro il quale la medicina è stata tradizionalmente praticata.
Potremmo sintetizzare il cambiamento come un passaggio dalla "liberazione" alla "libertà". Le due parole, malgrado l'identica radice etimologica, evocano scenari completamente diversi quando sono applicate alla pratica medica. Tradizionalmente questa è stata intesa come un'azione di "liberazione dal male'' ― che si presenta sotto forma di aggressione all'integrità fisica, alla salute, al benessere ― intrapresa congiuntamente, in una concertazione esplicita, da tutti i protagonisti: professionisti sanitari, malati, politici sanitari e amministratori. Nell'orizzonte della liberazione si presume che gli interessi di tutti coincidano e si immagina che le azioni dei vari protagonisti siano rivolte a un fine comune, che massimizza il beneficio di tutti.
La prospettiva della "libertà", invece, fa riferimento a una pluralità di interessi, che minaccia di tramutarsi in un esplicito conflitto. La rivendicazione di una capacità di scelta da parte dei pazienti, con un conseguente diritto a far valere le proprie preferenze ("libertà di cura"), sconvolge il quadro di riferimento in medicina, secondo il quale è il medico che sceglie, a beneficio del paziente. La presenza dello Stato, che attraverso il SSN assicura la copertura delle cure ― anche le più costose, indipendentemente dalla capacità dei cittadini di pagarsele ― viene a complicare ulteriormente lo scenario delle scelte sanitarie. Anche la società entra, attraverso i meccanismi della welfare community, nel gioco delle libertà incrociate, insieme alla professionalità dei sanitari, che sono tenuti a offrire le cure che hanno passato il vaglio della più rigorosa scienza medica, e al diritto dei cittadini di partecipare alle scelte terapeutiche.
Fino a che punto è possibile (o lecito) praticare una libera scelta quando questa crea conflitti? L'efficacia di alcune vaccinazioni richiede una politica di vaccinazione di massa. In base a una valutazione di rischio-beneficio, il singolo può decidere di non vaccinarsi. Come anche un paziente con un'infezione virale, e che vuole assumere antibiotici, può non essere pronto a riconoscere i pericoli per la popolazione, legati a un uso scorretto degli antibiotici.
Le diverse libertà possono entrare in rotta di collisione; per questo è necessario trovare qualche elemento regolatore. A ciò fa riferimento il concetto di "gioco delle libertà". Non è insolito che al "gioco" sia attribuita una funzione esplicativa dei comportamenti umani più ampia del significato quotidiano della parola. Già Eric Berne ― fondatore della scuola di psicologia nota come "Analisi transazionale" ― spiegava nel suo libro più noto, A che gioco giochiamo, che non è forzatura applicare la parola, come lui fa, a certi tragici tipi di comportamento, come il suicidio, l'alcolismo, la tossicomania o la criminalità: chiamarli "giochi" non significa essere irresponsabili o fare dello spirito di pessima lega. A suo avviso, "l'aspetto essenziale del gioco umano non è il carattere spurio delle emozioni, ma il fatto che le emozioni obbediscono a determinate regole. Lo dimostra la condanna che passa su certe manifestazioni emotive illegittime. Il gioco può essere crudelmente, addirittura fatalmente serio, ma la condanna sociale diventa grave solo quando si viene meno alle regole" (Berne, 1967). Adottando questa categoria, possiamo dire che la nostra società sta riscrivendo le regole che governano il gioco delle libertà in medicina.
La stagione dei diritti in medicina
Possiamo sintetizzare questo cambiamento di scenario dicendo che la medicina è entrata nell'epoca moderna. La modernizzazione della medicina a cui facciamo riferimento non va intesa
62
in quel senso ampio, che fa del moderno un sinonimo di ciò che è più recente o più aggiornato. La "modernità" è una categoria storiografica, con cui indichiamo quella particolare concezione dell'uomo e dei rapporti sociali che caratterizza l'epoca iniziata con l'illuminismo. I suoi tratti più evidenti sono la fine dell'assolutismo e l'inizio della democrazia in politica, il liberalismo economico e il razionalismo nella vita culturale.
Il riferimento a Kant è d'obbligo. Dello spirito che anima l'epoca moderna egli ha dato le descrizioni più incisive. Nel definire l'illuminismo, Kant lo ha contrapposto alla minorità, intesa come incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro: "L'Illuminismo è l'uscita degli uomini dallo stato di minorità a loro dovuto. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. A loro stessi è dovuta questa minorità, se la causa di essa non è un difetto dell'intelletto ma la mancanza di decisione e del coraggio di servirsene come guida" (Kant, 1975, ed. orig. 1791).
L'invito di Kant ― Sapere aude: abbi il coraggio di servirti della ragione! ― si è progressivamente esteso a tutti gli ambiti della vita sociale. Solo la medicina ha costituito, per lungo tempo, una specie di riserva retta ancora dalle leggi dell'assolutismo, in veste di benevolo paternalismo. Nello stato di malattia l'individuo sembra riprecipitare in una condizione di "minorità" non giustificata dall'età. La maggiore età è una condizione labile agli occhi del paternalismo medico. Quando un individuo è malato, il diritto a usare il proprio intelletto appare sospeso: è il medico che decide quali informazioni dare al malato, il trattamento più indicato, i percorsi da fargli seguire nell'accidentato cammino verso la salute (e ancor più in quello verso la morte).
Oltre che per questa concezione dell'autonomia dell'individuo, Kant è un punto di riferimento anche per la riformulazione dell'etica in termini razionalisti. Sono numerose le versioni dell'ideale morale ricondotto nell'ambito della ragione pura; ci limitiamo a segnalare quella più frequentemente citata: "Considera l'essere umano non come un mezzo, ma anche come un fine dell'azione". È un orizzonte condiviso anche da diverse formulazione dell'etica che si ispirano al personalismo.
Il diritto alla libertà, nella sua versione di diritto all'autodeterminazione e di fare scelte in armonia con i valori autonomi della persona, è apparso sullo scenario della sanità come un diritto di seconda generazione, rispetto ai diritti fondamentali che costituiscono il tessuto delle società democratiche. L'impatto della prospettiva dei diritti sul modello tradizionalmente vigente in sanità, centrato sull'ideale umanitario e sul dovere del medico di orientare la sua azione al bene del malato, è stato particolarmente dirompente negli Stati Uniti. Il progressivo affermarsi del principio di autonomia nella giurisprudenza è andato parallelamente modificando la pratica della medicina.
Una delle prime formulazioni del diritto del paziente alla propria autonomia anche nella cura della salute è quella che risale al giudice americano Benjamin Cardozo, in una sentenza del 1914: "Ogni essere umano adulto e capace di intendere e di volere ha il diritto di decidere che cosa viene fatto al suo corpo". Come l'albero nel seme, in questa frase è contenuto tutto lo sviluppo, avvenuto negli ultimi tre decenni del XX secolo, verso la regolamentazione del consenso informato nella terapia e nella ricerca, e la tutela sempre più minuziosa del diritto del paziente a essere coinvolto nelle decisioni cliniche che lo riguardano.
Medici e infermieri dopo anni di studio acquisiscono conoscenze e tecniche che li mettono nelle condizioni di fare delle scelte, che si traducono in proposte di trattamenti. Alcune persone, dopo aver avuto una malattia ed essere stati pazienti, acquisiscono conoscenze ed esperienza anche notevoli, e sono in grado i di fare scelte consapevoli e informate (sono una minoranza). Se a una persona è stato diagnosticato un cancro, e vengono prospettate due diverse opzioni di terapia, in base a quali criteri può fare una scelta? In molti casi mancano le nozioni più elementari per poter comprendere le informazioni che vengono date.
Il paziente ha diritto a essere informato; ma quanto può essere giustificato, o pericoloso, lasciare il diritto di scelta? L'esempio della terapia Di Bella illustra chiaramente quanto le opinioni e le scelte dei pazienti possano essere influenzate. E non sempre a ragione.
63
Quale punto di arrivo finale dell'intera parabola dell'autodeterminazione in sanità possiamo indicare l'entrata in vigore negli Stati Uniti, il 10 dicembre 1991, del Self-determination Act (McLoskey, 1991). La legge dell'autodeterminazione è uno strumento giuridico rivolto a tutelare concretamente il libero intervento dei malati nelle decisioni cliniche che li riguardano, in particolare in quelle finalizzate al prolungamento della vita.
La legge dispone che ogni istituzione sanitaria che riceve paziente assistiti dai due programmi federali Medicare e Medicaid è tenuta a fornire ai pazienti in modo sistematico, al momento della loro ammissione in ospedale, informazioni riguardo alle leggi dello Stato relative alle advance directives (cioè le disposizioni previe circa il trattamento che la persona è autorizzata a impartire in previsione del caso in cui non sia più in grado di intendere e di volere: a queste i sanitari devono attenersi, in mancanza di una volontà attuale del paziente) e sollecitare l'autodeterminazione del paziente. La stessa legge obbliga gli ospedali e le case di riposo per anziani a istituire dei meccanismi per rendere edotti i pazienti dei loro diritti legali, che prevedono la facoltà di accettare o rifiutare il trattamento medico, e di predisporre in modo chiaro chi è autorizzato a parlare in nome del paziente e a prendere le decisioni al posto suo.
Negli stessi Stati Uniti non tutti sono d'accordo sull'adeguatezza della legge dell'autodeterminazione a conseguire il fine che si prefigge, cioè il rispetto della volontà delle persone circa i trattamenti sanitari a cui sono sottoposte. Tuttavia è incontestabile che questa normativa americana costituisce il tentativo più coerente di portare fino alle estreme conseguenze il principio dell'informazione al paziente, per favorire la sua autodeterminazione. Se si considera che in tedesco l'informazione data al paziente si chiama Aufklärung ― lo stesso termine che designa l'Illuminismo ― ci rendiamo conto che con il diritto all'autodeterminazione e al consenso informato, riconosciuto per legge, lo spirito dell'illuminismo sembra aver conquistato l'ultima provincia che si era sottratta al suo dominio.
Malgrado l'aperta o sotterranea resistenza dei medici formati nell'alveo della tradizione ippocratica, il movimento che tende a smantellare l'assolutismo del medico e a promuovere l'autonomia del paziente ha raggiunto anche l'Europa. Con l'affermarsi della concezione moderna del rapporto medico-paziente, viene sospesa per i medici l'autorizzazione a procedere a qualsiasi misura terapeutica essi ritengano andare a beneficio del malato, sulla base di un criterio medico. La pratica dell'informazione del paziente circa diagnosi e prognosi e dell'acquisizione del consenso per gli interventi terapeutici sarà sempre meno un optional riservato a medici di orientamento umanistico: essa diventerà un criterio per valutare la qualità della pratica della medicina. Di conseguenza, diventerà in misura crescente un obbligo deontologico e, in alcuni casi, anche legale.
Questi sviluppi dell'autonomia del paziente e del suo diritto all'informazione potrebbero procedere anche verso uno scenario infausto. È possibile immaginare che lo spostamento d'accento sull'autonomia del paziente avvenga in un clima avvelenato dalla diffidenza e dal risentimento dei sanitari per il potere perduto. Il triste risultato di tale evoluzione sarebbe che il diritto alla libertà decisionale si tramuti nella sua caricatura: vale a dire, nel "diritto" a essere lasciato solo, proprio nel momento in cui il malato ha maggiormente bisogno della presenza benevola ed efficace di un sanitario che lo assista, non solo con la scienza ma anche con la sua completa umanità.
Lo sviluppo della richiesta di un consenso informato ― magari redatto su un modulo apposito, per fini burocratici! ― potrebbe risultare così come un espediente per rifilare al malato la responsabilità di decisioni che andrebbero invece condivise, lasciando prevalere la preoccupazione esclusiva di tutelare il medico da possibili rivendicazioni del malato in sede giudiziaria. Per questo è opportuna una continua vigilanza da parte della riflessione bioetica. Non è vero che ogni innovazione nel tessuto dei rapporti di natura terapeutica, e nella conseguente
64
ridistribuzione di diritti e doveri, va necessariamente nel senso di una medicina più umana. Le innovazioni vanno vagliate e soppesate, confrontandole con i valori sui quali esiste un consenso sociale.
L'analisi di molti moduli di consenso informato ― con termini tecnici, caratteri piccoli, lunghi più pagine, consegnati e non discussi (e soprattutto, ridiscussi) ― con il paziente fa vedere come quello dell'informazione si sia trasformato, in molti casi, da un diritto a un adempimento burocratico.
Diritti di "terza generazione"
Una delle formulazioni più note dei diritti umani è la Dichiarazione di indipendenza degli Stati americani redatta da Thomas Jefferson nel 1776. Tra le verità che "non hanno bisogno di essere dimostrate", viene citato il fatto che tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti e che sono dotati di certi diritti innati, dei quali non possono essere privati a nessun patto, come "il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità" (the pursuit of happiness).
Nei confronti di quest'ultimo diritto noi europei siamo stati sempre piuttosto scettici. La "ricerca della felicità" l'abbiamo lasciata all'iniziativa individuale del cittadino, chiedendo allo Stato di occuparsi solo dei primi due diritti: la protezione della vita e la tutela della libertà. La ricerca della felicità non l'abbiamo scritta tra i diritti costituzionali, e tanto meno abbiamo considerato un possibile legame tra essa e la pratica della medicina. Eppure niente sembra più attuale di questa nuova frontiera di diritti, che potremmo chiamare diritti di "terza generazione". Essi emergono insieme a una nuova richiesta di salute, non più limitata alla lotta contro la malattia, ma identificata con il pieno benessere: fisico, psichico, sociale e spirituale.
Quella che si profila è una fisionomia globale diversa della medicina, per la quale è stata coniata l'espressione "medicina del desiderio". Il modellamento del corpo sul desiderio diventa l’elemento trainante della ricerca di salute nelle società ad alto sviluppo economico. Il ventaglio degli interventi richiesti a questo tipo di medicina è molto ampio. Comprende (tanto per nominarne alcuni) i trattamenti antistress ed estetici delle beauty-farms; la regolazione della fertilità oltre ― e talvolta contro ― i limiti della natura (fecondazione in vitro, programmazione del sesso del nascituro, modifiche dell'eredità genetica); la determinazione da parte del soggetto della quantità e qualità delle cure che determinano la lunghezza della vita giunta al termine.
Le nuove emergenze (per esempio AIDS, la "sindrome della mucca pazza", l'inguaribilità dell'Alzheimer) ci riportano a riflettere su alcuni limiti dei progressi della medicina e sul fatto che molte frontiere siano ancora da abbattere. L'evoluzione verso la "medicina del desiderio" non è forse attesa? Sono stati affrontati i principali problemi di base, sono state debellate la maggioranza delle malattie infettive: perché le richieste delle persone dovrebbero limitarsi alla risposta ai bisogni di base e non spingersi a chiedere di abbattere nuove barriere? Molte cose che sembravano non solo impossibili, ma addirittura impensabili, sono oggi realizzabili. È una conseguenza diretta dell'immagine che la medicina si è costruita intorno: la scienza dell'impossibile. E stanno diventando impossibili e ingestibili anche molte delle richieste che le vengono fatte.
Tra i casi che si contendono il primato nel rendere evidente quanto la dimensione soggettiva del desiderio possa confinare con l'arbitrio, possiamo citare due situazioni che si riferiscono, rispettivamente, all'inizio e alla fine della vita. La gravidanza indotta in donne che hanno superato l'età fertile si colloca sul primo segmento. Non solo i primi anni dopo la menopausa, ma anche quelli che potrebbero essere considerati di vecchiaia incipiente non sono più considerati tabù per i tecnici della procreatica. Il traguardo dei 60 anni è stato già superato.
Il desiderio soggettivo di un figlio, abbinato alla fattibilità tecnica della fecondazione, sono i due presupposti di questo scenario di biologia colonizzata dal desiderio. Altre variazioni sono
65
costituite dalla richiesta di fecondazione artificiale da parte di donna nubile, che non vuole un legame matrimoniale (spesso per motivi di preferenza sessuale, in quanto lesbica); oppure la richiesta di utilizzo del liquido seminale congelato del marito defunto; oppure le gravidanze per conto di terzi (allocazioni dell'utero). I tentativi di circoscrivere il dilagare di queste pratiche mediante normative a carattere legislativo o deontologico hanno dovuto affrontare tutte queste varietà di medicina riproduttiva a servizio del desiderio.
All'altro estremo, quello della fine della vita, possiamo menzionare le procedure finalizzate a tenere la morte nell'ambito degli avvenimenti sui quali si può esercitare il proprio controllo volontario. I "testamenti biologici" (living will) ne sono una delle espressioni più note. In questo modo si intende prevenire la situazione in cui il soggetto non sia in grado di controllare il corso degli interventi clinici finalizzati a prolungare la vita: per l'evenienza di stato di coma o di incapacità di intendere e di volere, si lasciano per iscritto le disposizioni alle quali ci si aspetta che il medico si attenga.
Il nodo etico di questi casi si stringe intorno all'espropriazione della decisione morale che tradizionalmente era competenza del medico. In una medicina di questo profilo, al sanitario sembra sottratta qualsiasi facoltà di intervenire con un proprio giudizio etico sull'azione appropriata: quello che ci si attende da lui è solo una prestazione d'opera, finalizzata a obiettivi determinati dal "cliente".
In linea di principio è inevitabile che la libertà di scelta del paziente metta in discussione il potere del medico o dell'infermiere. Ma fino a che punto il medico ha il diritto di rifiutare una scelta "informata" del paziente? Un conto è se i costi della scelta ricadono sul Sistema sanitario nazionale: allora la scelta dipende dai limiti imposti dalle regole del sistema; diverso può essere se i costi dell'intervento vengono sostenuti dal paziente. Gli esempi (riportati sui rotocalchi) di interventi di chirurgia plastica estrema di alcune rockstar (e non solo) dimostrano quanto gli spazi per la "medicina del desiderio" non dipendano dalla ragionevolezza o meno di valori e richieste, ma da problemi di budget.
L'opposizione da parte del medico per ragioni di coscienza rimane una estrema barriera contro l'avanzata del desiderio in medicina, che minaccia di travolgere il modello tradizionale di rapporto medico-paziente. Questa possibilità ha avuto un esplicito riconoscimento nel caso dell'interruzione volontaria della gravidanza. È forse opportuno prendere in considerazione che possa essere invocata anche in altre circostanze, per garantire al sanitario il pieno rispetto dell'autonomia della sua decisione etica, che gli spetta come soggetto.
Un altro approccio di quest'ordine di problemi, dei quali abbiamo considerato il profilo etico, è quello economico. Una delle preoccupazioni crescenti delle società che, come la nostra, hanno identificato nella risposta socializzata alla domanda di salute un obiettivo di civiltà, oltre che di giustizia, riguarda l'estensione di tale risposta alle richieste: deve comprendere anche, per esempio, tutte le domande di interventi sanitari futili, ma ritenuti soggettivamente auspicabili? Mentre la spesa sanitaria, presa nella spirale dei costi crescenti, sembra sfuggire a ogni ragionevole programmazione, possiamo in quanto Stato sociale permetterci una "medicina del desiderio"?
Gli interrogativi ci sono riproposti in maniera brutale dalla constatazione della crescente iniquità che caratterizza l'allocazione delle risorse sanitarie: accanto alle somme considerevoli spese per ottenere un concepimento tramite le tecniche di procreazione artificiale, dobbiamo registrare la mancanza di fondi per un’efficace campagna di prevenzione della sterilità; accanto ai costosissimi trapianti di organi, l'inerzia nel combattere mediante la prevenzione, con spese minori e maggiori benefici, il diffondersi delle patologie degenerative.
A fronte di una richiesta crescente di consumo di prodotti correlati con la salute, la limitatezza delle risorse costringe a riconoscere che neppure la più ricca delle società è in grado di rispondere
66
alla domanda, nella misura dei desideri. È necessario non solo elaborare procedure per filtrare la domanda con criteri di equità, ma intervenire sulla domanda stessa. Una proposta diffusa è quella di distinguere tra bisogni autentici di salute e desideri soggettivi, assicurando una risposta sociale ai primi e lasciando i secondi al gioco del libero mercato, che si regola secondo la domanda e l'offerta.
Questa proposta di economia sanitaria ha implicazioni filosofiche e politiche rilevanti. L'affermazione che esista una realtà qualificabile come "bisogni umani di base" divide coloro che si orientano in senso libertario da coloro che sono più orientati in senso pro-sociale. I libertari ritengono che ogni distinzione tra bisogni e desideri sia arbitraria; di conseguenza, rifiutano una politica che intenda provvedere a supposti bisogni sanitari della popolazione. Altri invece difendono come intuitiva la differenza, per esempio, tra la somministrazione di un farmaco che stronca un'infezione o l’effettuazione di una vaccinazione, e un intervento di chirurgia estetica per modificare il profilo del naso.
Il concetto di salute come benessere rende sempre più sottili queste differenze. Il desiderio di maternità può essere talmente forte da portare a squilibri psichici o depressione, se non viene realizzato. L'insoddisfazione per il proprio corpo può creare problemi psicologici importanti, se non si interviene con una plastica. Il SSN deve farsi carico dei costi della procreazione assistita e dell'intervento di chirurgia plastica; o del supporto psicologico o psichiatrico necessario a queste persone; o di nessuno dei due? E rispetto a quali valori o criteri un'infezione deve essere curata e un disagio psichico (non identificabile come "pazzia") no?
Alla base di queste divergenze non intravediamo solo una maggiore o minore fiducia nel valore regolativo delle leggi del mercato per la convivenza umana, ma concezioni filosofiche diverse. Il timore di cadere in forme ingiustificabili di paternalismo ha finora, per lo più, fatto ritenere come una via non praticabile la distinzione tra bisogni e desideri di salute. Le misure amministrative che, per contenere i costi della sanità, fanno cadere inesorabilmente la scure su alcune prestazioni (per esempio, sottraendo dalla copertura del SSN alcuni importanti interventi odontoiatrici), non osano cercare una giustificazione ideologica nella distinzione tra bisogni e desideri.
Senza la pretesa di fornire qui una formula che regoli questo importante conflitto, ci limitiamo a richiamare che il "desiderio", interpretato in senso antropologico qualificato, non è necessariamente la formula della bancarotta in sanità. L'ascolto del desiderio, ovvero il rispetto dei diritti del paziente intesi come richiesta di qualità nei servizi sanitari, non ci incammina necessariamente verso la spirale incontenibile di domande sempre crescenti. Paradossalmente, le richieste di rinnovamento della pratica medica attuale più caratterizzate in termini umanistici ― dalla medicina palliativa alle cure domiciliari ― sono relativamente a minor costo economico e a più alta gratificazione del malato. L'attenzione alla qualità delle cure, correlata all'interesse per la qualità della vita, si rivela pagante non solo in termini umanitari, ma anche economici.
Se ci sottraiamo alla rappresentazione semplicistica che fa corrispondere "il più" al meglio, possiamo scoprire che "il meno" non corrisponde necessariamente al peggio. Molti pazienti, invece, riceveranno benefici se la pressione esercitata dal contenimento dei costi limiterà gli interventi non necessari, ridurrà i danni iatrogeni e punterà più sulla qualità della vita, che è ottenibile spesso a un prezzo minore. "La professione medica ― ha scritto Haavi Morrein ― ha messo molto impegno nel cercare quali nuove cose i medici dovevano fare ai propri pazienti. Ora chiediamo solo che comincino a cercare, con lo stesso impegno, quali cose non hanno bisogno di fare" (Morrein, 1985).
Il medico non ha bisogno di promettere al paziente di fare qualsiasi cosa, per promettere di
67
fare il suo meglio, purché la scelta del giusto mezzo, tra il troppo e il troppo poco, sia il risultato di una ricerca comune. L'individuazione di quel "meno" che con tiene anche il "più", e coincide quindi con il "meglio", si può ottenere solo mediante una migliore transazione con il paziente, entro il paradigma fondamentale di una medicina del dialogo.
Medicina e pluralismo delle culture
La presenza simultanea di diverse culture, da quando siamo diventati terra di immigrazione, è una novità per la nostra società. E per i servizi sanitari. Medici e infermieri sono costretti a far i conti con la diversità: da quella relativamente poco problematica di pazienti che, per prescrizioni religiose, escludono certi cibi dalla loro dieta, al rifiuto di pazienti donne di farsi visitare da medici maschi o accudire da infermieri, per ragioni di separatezza culturale dei sessi, fino alle questioni più intriganti delle mutilazioni genitali femminili, ritenute da alcune tradizioni parte integrante della preparazione del corpo femminile all'incontro con quello maschile.
L'incontro con le diverse etnie non crea necessariamente nuovi problemi ma acutizza problemi già presenti nell'incontro con persone, valori e abitudini diverse. Sarebbe riduttivo pensare che il nursing transculturale consista nell'insegnamento delle pratiche e abitudini legate alla religione e all'etnia. È principalmente l'acquisizione (difficile) dell'atteggiamento all'apertura e al confronto e di metodi per imparare a comunicare. Alla base ― come peraltro alla base del lavoro dell'infermiere e degli operatori sanitari ― deve esserci un atteggiamento di profondo rispetto e accettazione dell'altro.
Il pluralismo culturale costituisce una sfida per l'organizzazione della nostra società in generale e un problema specifico nell'ambito sanitario. La medicina, infatti, sembra meno preparata di altri settori della vita sociale a confrontarsi con le diversità culturali. La medicina si sente più incline a privilegiare la natura che unisce gli uomini, piuttosto che la cultura che li differenzia. È come se le aggressioni della malattia inducessero ad arretrare sul terreno solido della biologia, comune a tutti gli uomini, e a mettere in ombra le diverse modalità che ogni cultura ha sviluppato per tradurre in pratica la soddisfazione dei bisogni legati alla comune natura umana. A ciò si aggiunge il preteso universalismo dell'etica medica ― che per l'Occidente è stata formulata dalla medicina ippocratica e non ha sostanzialmente mutato la sua struttura per 25 secoli ― che ha fatto ritenere irrilevanti le differenze riconducibili alla cultura: una medicina, una etica medica per tutti gli uomini, dunque.
La convivenza di culture diverse, che accettano di trasformare il pluralismo culturale in un'opportunità e in una risorsa, comincia appena ad affermarsi nel nostro paese. L'interculturalità è un nuovo modo di organizzare la vita sociale, considerando la pluralità delle culture come una sfida che merita di essere accettata. Tra le iniziative pionieristiche in questo ambito si segnala l'attivazione di un corso di laurea in "Scienze e tecniche dell'interculturalità" presso l'Università di Trieste, con il conferimento di un "dottorato in interculturalità".
Anche per la sanità italiana si è aperta l'era dell'interculturalità. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 menziona esplicitamente, tra le "azioni" per la tutela dei soggetti deboli, "la formazione degli operatori sanitari finalizzata ad approcci interculturali nella tutela della salute". Non si tratta di introdurre la medicina delle migrazioni come una nuova branca della medicina, e tanto meno come una nuova specializzazione. La medicina che si sviluppa prendendo sul serio l'interculturalità è fondamentalmente la medicina delle relazioni: reagendo alla tendenza a spostare il piano diagnostico verso l'oggettivazione strumentale, come predilige l'organicismo, la medicina deve imparare a integrare gli scenari e i contesti socio-culturali, nonché le risorse individuali e collettive del paziente. Il gruppo di appartenenza, con la sua cultura, diventa la principale risorsa di cui si avvale il terapeuta nel processo di cura.
68
Se le abitudini e la cultura di un'etnia portano la persona a compiere atti contrari alle evidenze scientifiche o alle nostre convinzioni, quale deve essere l'atteggiamento da tenere? Di rispetto fino all'estremo o di pragmatismo ("abbiamo delle regole, e chi vive qui deve seguirle")? La "via di mezzo" non è sempre praticabile in istituzioni con vincoli organizzativi.
La migliore introduzione al tema dell'interculturalità è offerta, più che da considerazioni teoriche, dall'esperienza concreta di chi eroga i servizi sanitari in contesti caratterizzati dalla presenza simultanea di diverse culture. Una ricerca molto istruttiva, diretta dall'antropologo culturale Vincenzo Padiglione, è stata svolta a Roma, tra 11 strutture del territorio, comprendenti centri di ascolto, di orientamento e prima accoglienza, servizi di assistenza sanitaria e di consulenza specialistica (Padiglione et al., 1999). Obiettivo della ricerca era quello di individuare i modelli di comprensione delle situazioni problematiche e delle fenomenologie sociali legate all'avvento della società multietnica. In particolare, si voleva verificare se le esperienze professionali legate a tali fenomenologie influiscono sulla costruzione di una competenza interculturale negli operatori socio-sanitari coinvolti in questo tipo di esperienze.
La ricerca ha portato all'individuazione di tre modelli caratteristici che contraddistinguono l'atteggiamento degli operatori, denominati rispettivamente differenzialista, universalista e di dialogo interculturale. Il modello differenzialista presuppone che il fenomeno dell'immigrazione possa essere affrontato come se esistessero problemi "etnospecifici" per "specifiche etnopersone", quasi che le differenze d'origine fossero stabilmente "iscritte nella pelle" degli immigrati. Esaltare la specificità delle esigenze culturali si traduce praticamente in una maggiore attenzione agli elementi immediatamente tangibili che marcano l'appartenenza culturale, primo fra tutti la lingua.
La seconda prospettiva da cui si può guardare l'intercultura è quella del fronte universalista. Essa parte dall'idea che sia possibile cogliere nelle persone immigrate, a prescindere dalla loro provenienza, delle caratteristiche invarianti, come se fossero tratti di personalità comuni a tutti i popoli. In questa prospettiva si ritiene inutile ricercare prodotti mentali a latitudini differenti, in quanto le emozioni, i comportamenti e gli affetti sono ritenuti fondamentalmente simili, almeno nei processi di base caratterizzanti. In questa direzione va letta una certa tendenza a credere che un modello di intervento possa risultare "universalmente efficace".
La terza prospettiva per leggere i fenomeni e i problemi legati all'intercultura è denominata dalla ricerca in questione dialogo interculturale. Questa posizione considera il tema dell’incontro tra culture ponendo attenzione alla conoscenza interculturale reciproca che si viene a creare nell'incontro stesso tra l'utente immigrato e l'operatore a cui si rivolge, partendo da un rapporto che rispetta le differenze culturali e accetta le diversità dei linguaggi in cui i due partecipanti alla relazione sono portatori, le osserva e le negozia nello svolgersi della relazione. L'attenzione privilegiata alla relazione tra l'utente e il contesto di inserimento consente agli operatori di svincolarsi da un tipo di intervento che cerca di dare semplicemente una risposta a un bisogno concreto, stimolando invece un atteggiamento attivo negli utenti per affrontare i loro problemi.
Qual è la differenza tra questo tipo di approccio e l'assistenza, secondo i modelli del nursing, in cui si parte da una valutazione della situazione e un'analisi dei bisogni e si cerca di stimolare la self care nei pazienti, a partire dalle loro risorse?
Una lettura diversa delle esperienze maturate da operatori sanitari di prima linea, che si confrontano quotidianamente con il pluralismo culturale, è offerta da Marco Mazzetti (medico psichiatra, esperto in antropologia culturale). Mazzetti non individua tre "stili" nell’impostazione di
69
un servizio sanitario interculturale; piuttosto, sulla base di numerose osservazioni maturate soprattutto nell'ambito dei servizi agli immigrati gestiti dalla Caritas, mette in evidenza tre "fasi", che attraverserebbero i servizi nel corso del tempo. Le tre fasi sono chiamate, dell'"esotismo", dello "scetticismo" e del "criticismo sanitario" (Mazzetti, 1999). A fronte degli atteggiamenti che mutano negli operatori, si registrano anche trasformazioni nel modo in cui gli immigrati si avvicinano ai servizi. Una tabella, proposta da Mazzetti, illustra sinotticamente i cambiamenti negli operatori e in coloro che ricevono i servizi:
|
|
Medico
|
Paziente |
|
1a Fase: esotismo
|
"Sindrome di Salgari" |
"Sindrome da General Hospital |
|
2a Fase: scetticismo
|
"Questo non ha niente" "Mi fa solo perdere tempo" |
"Questo medico non vale molto" "Mi curano male perché sono straniero" |
|
3a Fase: criticismo |
― Superare i pregiudizi ― Considerare la diade medico-paziente |
― Accettare i limiti del medico e della medicina ― Comprendere cosa è realisticamente possibile
|
Il confronto tra le due tipologie ― da una parte i tre modelli differenzialista, universalista e dialogo interculturale proposti da Padiglione, dall'altro le tre fasi dell’esotismo, dello scetticismo e del criticismo sanitario suggerite da Mazzetti ― lascia aperto un interessante ambito di ulteriore ricerca. Si tratta di verificare se gli atteggiamenti degli operatori esposti sul fronte dell'intercultura si modificano col tempo (cambiamenti diacronici), oppure se sono sincronicamente presenti, a seconda del modello dominante nel singolo servizio.
Da questa rilettura delle esperienze possiamo trarre un'indicazione preziosa per caratterizzare la medicina interculturale: essa non ha a che fare un paziente "straniero", pietrificato nella sua diversità; né con un paziente "omologato", da trattare come isoculturale. La medicina interculturale mette in relazione delle persone in cammino, in atto di riformulare continuamente la propria identità. Non è soltanto l'immigrato, infatti, a rischio di perdere la propria identità e sottoposto allo stress di riformularne una nuova: anche l'identità professionale del medico e dell'infermiere, con il suo bagaglio di certezze, è sottoposta a un'analoga spinta al cambiamento.
Le risposte concrete al pluralismo culturale ― come i progetti, avviati da alcuni ospedali e aziende sanitarie locali, di assicurare un servizio di "mediazione culturale" ― sono solo un primo passo. Fornire a operatori sanitari e cittadini stranieri la possibilità di capirsi tramite l'intervento di traduttori; aiutare gli operatori a conoscere le abitudini, i comportamenti e le condizioni di vita del Paese di origine di popolazioni con radici etniche e culturali diverse dalle nostre; preparare campagne di informazione e prevenzione; tradurre per i pazienti stranieri informazioni, documenti, prescrizioni terapeutiche, indicazioni di esami e modalità di cura, accompagnandoli, se necessario, presso altri presidi sanitari: sono solo alcuni dei progetti possibili per dare una risposta positiva alla multiculturalità. Ma l'obiettivo ultimo non è solo quello di presentare un volto amico della sanità anche in una società multietnica: la pratica dell'interculturalità offre un'occasione a tutti gli operatori sanitari per reimparare a muoversi nell'ambito delle relazioni, del rapporto interpersonale, della capacità di un lavoro in rete, del confronto interdisciplinare.
70
71
Pistoia, Ospedale del Ceppo
Assistere gli infermi
L'Ospedale del Ceppo fu fondato nel XIII secolo e amministrato per lungo tempo dai Confrati Agostiniani della Compagnia del Ceppo. Nel 1501, con un decreto della Repubblica di Firenze, la direzione venne affidata all'Arcispedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Nel 1522 lo "spedalingo" fiorentino Leonardo Bonafede commissionò il fregio smaltato policromo in terracotta della loggia a Santi Buglioni.
Nei riquadri al di sopra degli archi vennero raffigurate le Sette opere di misericordia. Sei di esse ― vale a dire: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, ospitare i pellegrini, vestire gli ignudi, visitare i carcerati egli ammalati ― sono menzionate nel Nuovo Testamento, nel discorso sul Giudizio Universale (Matteo 25,31-46).
La scena Assistere gli infermi ha un fascino particolare, che le deriva dall'essere in rapporto diretto con l'istituzione per la quale è stata pensata. Come attraverso una finestra aperta, lo sguardo entra liberamente nell'interno. Fuori, sulla piazza, l'osservatore e potenziale paziente viene a conoscere cosa l'aspetta dentro le mura. Oltre a questo rispecchiamento delle vicende interne sulla facciata esterna ― cioè a un aspetto educativo ― si esprime qui con intento propagandistico il senso di superiorità di una società ― quella fiorentina ― il cui intervento va percepito come un atto caritatevole.
Su uno sfondo bianco, lo sguardo dell'osservatore si apre sulla sala di degenza per gli uomini. La disponibilità di letti per gli uomini era di molto superiore a quella per le donne.
Lungo le pareti sono allineati i letti, sul cui capezzale è appeso un cartello con i rispettivi numeri, in cifre arabe e latine. Nel cartiglio con il numero risalta il ceppo, che fa riferimento alla leggenda della fondazione: a seguito di un sogno, la coppia dei fondatori avrebbe creato un ospedale nel posto preciso in cui aveva trovato un ceppo secco, che gettava nuove foglie. Su ogni letto appare il simbolo che ricorda la storia miracolosa della fondazione. Subito sotto si vedono gli oggetti personali conservati presso il capezzale, segno del realismo fedele con cui la narrazione artistica riproduce i dettagli.
Il malato del letto XX, all'estremità sinistra della scena, un uomo anziano con la barba, sta seduto sul letto sotto una coperta, avvolto in un bianco lenzuolo, la testa coperta piegata dolorosamente in avanti. Un medico, vestito con mantello nero e berretto, sta prendendo il polso. Dall'espressione assorta del suo viso sembra di poter leggere l'ascolto attento del battito. Ai piedi del letto un infermiere tiene alzata un'ampolla con l'urina, il cui contenuto il medico si accinge a esaminare. È un uomo anziano, dalla corporatura massiccia, forse un assistente onorario, che con la sinistra si deve sostenere a una stampella. Il personale assistente è esclusivamente maschile ed è contraddistinto da un copricapo e da un grembiule bianco. Anche le fonti scritte confermano che gli uomini venivano assistiti da uomini e le donne da donne.
Christina Riebesell
72
In una prospettiva più immediata, l'accesso di cittadini di altre culture ai servizi sanitari comuni richiede agli operatori una "educazione etnica", che è l'unica terapia per quel malessere della cultura che è l'etnocentrismo:
L'etnocentrismo patologico è una malattia sottile, tanto più subdola perché si innesta su una condizione di sana legittimità, qual è appunto l'etnocentrismo positivo. Ma quando esplode fa paura. I segni della patologia li troviamo nei segni lugubri dei nostri giorni: la dottrina della "pulizia etnica" dei serbi, l'intolleranza per le minoranze, il rifiuto degli immigrati, la paura degli extracomunitari, le orde dei naziskin ― una lista che potrebbe allungarsi...
L'etnocentrismo patologico è difficilmente curabile, ma può essere prevenuto, deve essere prevenuto. L'unica prevenzione possibile è un'adeguata educazione etnica, volta proprio a sviluppare una corretta percezione dell'etnocentrismo nei suoi contrastanti aspetti, positivo e patologico.
Bernardi, 1993.
Questa educazione etnica, che appartiene al genere dell'educazione permanente, renderà gli operatori sanitari più sensibili a tutte le diversità: quella etnica è solo più vistosa, senza tuttavia esaurire il vasto ventaglio di diversità connesso con il pluralismo culturale che attraversa oggi tutte le società.
PAROLE NUOVE PER COMPORTAMENTI NUOVI
Il difficile non è avere idee nuove,
ma sfuggire alle idee vecchie,
le quali si ramificano
in ogni angolo della mente.
John Maynard Keynes
Quale segno che la medicina, entrata nell'epoca della bioetica, sta attraversando un profondo cambiamento, possiamo assumere un fatto linguistico: l'invasione di parole nuove per indicare i comportamenti nuovi. Alcune di esse circolano direttamente in inglese, perché sono intraducibili. Questa estraneità linguistica sta a indicare che il cambiamento non è frutto di un'evoluzione intervenuta spontaneamente nella secolare tradizione della pratica della medicina, ma è stato piuttosto indotto da fermenti venuti da altre aree culturali. Inoltre alcune parole che indicano la nuova medicina sono state tradotte in italiano, ma tradotte male: con forzature linguistiche o travisando in pratica il loro significato. Quel che è più grave, in alcuni casi le parole nuove non indicano un cambiamento, ma sono utilizzate per comportamenti non più appropriati. Lasciandoci guidare dalle parole nuove, facciamo un inventario essenziale dei tratti caratteristici della medicina che si è lasciata modificare dal movimento culturale promosso dalla bioetica.
Consenso informato
Il consenso informato è un nome al singolare che si riferisce, in realtà, a tre diverse situazioni. Bisogna considerarle separatamente, per comprendere che cosa ognuna di esse richiede al sanitario che vi si trova impegnato. La prima accezione è quella che tutela la volontarietà nella partecipazione alla ricerca biomedica. Questo è anche il primo significato che si è venuto formando, dal punto di vista storico, di "consenso". All'indomani della Seconda guerra mondiale l'opinione pubblica è venuta a conoscenza delle ricerche condotte da scienziati medici tedeschi su prigionieri e deportati nei lager. Dopo il processo che ha condannato i principali responsabili, è stato elaborato il Codice di Norimberga (1946), che ha stabilito le condizioni necessarie per giustificare moralmente un esperimento che utilizza esseri umani. Il Codice prevede
73
esplicitamente, oltre all’utilità e all'innocuità dell'esperimento, anche il consenso volontario del soggetto sperimentale.
Negli anni successivi altre dichiarazioni internazionali e linee guida hanno ulteriormente precisato quali elementi devono costituire questo consenso. La volontarietà prevede che il soggetto partecipi liberamente. Si vuol prevenire l'arruolamento dei soggetti in ricerche cliniche e sperimentazioni mediante la costrizione, l'inganno, le intimidazioni o le incentivazioni che utilizzano la debolezza di persone che si trovano in posizione di vulnerabilità. Progressivamente, è diventato sempre più chiaro che la libertà del consenso dipende dalla qualità dell'informazione che lo precede.
Lo scienziato e il soggetto sperimentale non si trovano su due posizioni equiparabili, quanto a conoscenze e a potere decisionale. È facile estorcere un consenso, sottraendo o manipolando le informazioni. L'autonomia dell'individuo è rispettata solo se, prima di acconsentire all'arruolamento nella ricerca, la persona coinvolta ha ricevuto le informazioni necessarie, le ha comprese e ha valutato tutta la portata della propria partecipazione. Tutte queste condizioni sono evocate dalla dizione abbreviata di "consenso informato".
Attualmente le regole relative alla ricerca biomedica sono state stabilite, per quanto riguarda i Paesi della CEE, da documenti noti come Good Clinical Practice (nelle successive redazioni del 1990 e del 1997), che l'Italia ha recepito con decreti ministeriali. Queste regole prevedono che il consenso a partecipare allo studio clinico sia dato per iscritto dopo che sono state fomite le informazioni relative agli obiettivi dello studio, i potenziali benefici, rischi e inconvenienti, nonché i diritti e le responsabilità del soggetto. Normalmente le procedure sono sottoposte a un comitato etico, che vigila per la tutela dell'integrità fisica e dei diritti delle persone coinvolte nella ricerca. Secondo questa prima accezione, dunque, la preoccupazione dei sanitari deve essere quella di spiegare ai soggetti che stanno partecipando ― liberamente ― a una sperimentazione, e che non viene loro fornito un trattamento standard.
Paradossalmente, al di là dei problemi che continuano a esistere, i pazienti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche sono quelli più protetti, ricevono, con livelli diversi di comprensibilità e chiarezza, spiegazioni sui trattamenti a cui sono sottoposti. Nel quotidiano dell'assistenza vengono eseguiti numerosi trattamenti (non sempre di routine) senza che il paziente venga informato dei rischi o gli venga data la possibilità di poter scegliere. Per esempio, il paziente non può scegliere se farsi fare un prelievo da un infermiere che sta imparando a farli; o se rifiutare la profilassi antibiotica che in qual reparto viene fatta di routine anche per gli interventi non raccomandati.
Il secondo contesto nel quale parliamo di consenso informato è nell'ambito di procedure diagnostiche e trattamenti a carattere non sperimentale ― quindi in una situazione diagnostico-terapeutica routinaria ― ma che comportano un certo grado di pericolosità e di effetti collaterali negativi. Pensiamo, tipicamente, a una trasfusione di sangue: pur essendo un intervento standardizzato in medicina, non è esente da rischi di contrarre infezioni. Lo stesso vale per il vaccino antitetanico. Ora, ci rendiamo sempre più conto che, pur avendo il medico la delega sociale a fare per il paziente ciò che secondo lo stato dell'arte medica risulta più appropriato, e magari anche in presenza di una richiesta esplicita da parte del paziente di fare tutto il possibile in vista del risultato terapeutico, non sarebbe corretto nei confronti del paziente nascondergli i rischi.
Di quali rischi deve essere informato il paziente? Di tutti i possibili rischi? dei più comuni? dei principali?
E qual è il margine di scelta se l'esame (o la trasfusione) è indispensabile, per esempio per la diagnosi? Se il paziente non ha possibilità di scelta, va comunque informato? In questo caso, l'informazione è una forma di rispetto dei diritti del paziente o un mero adempimento burocratico?
74
Per alcune procedure esiste un vero e proprio obbligo formale codificato di informare il paziente e di chiedergli il consenso (per la trasfusione di sangue è prevista anche una modulistica redatta dal Ministero della Sanità). Per tutte le procedure a rischio possiamo parlare di obbligo morale. Il Codice deontologico dei medici (1998) prevede anche un obbligo deontologico.
Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta in tutti i casi in cui per la pericolosità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente.
Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possono comportare grave rischio per l'incolumità del paziente devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
Codice di deontologia medica, 1998, art. 31
Il terzo significato che acquista il consenso informato è quello relativo al nuovo rapporto che, secondo la cultura moderna e la riflessione bioetica che l'accompagna, tende a stabilirsi tra sanitari e cittadini. Il secondo scenario era focalizzato sulle situazioni cliniche in cui gli interventi diagnostici e terapeutici comportano dei rischi, oppure esistono alternative terapeutiche con diversa ricaduta sulla quantità e sulla qualità di vita del paziente. Ma la bioetica richiede qualcosa di più: la partecipazione attiva della persona a cui le cure sanitarie sono rivolte, in modo che possa essere un soggetto responsabile e coinvolto nelle scelte che lo riguardano (cfr. Comitato nazionale per la bioetica, Informazione e consenso all'atto medico, 1992).
Il nuovo rapporto si applica a tutta la medicina nel suo esercizio quotidiano. La partecipazione attiva del paziente è indispensabile dal punto di vista non di una medicina difensiva, ma di una medicina rispettosa dei valori personali dell'individuo. Se si vuole assicurare la partecipazione del paziente, in quanto protagonista delle scelte che lo riguardano, il baricentro si sposta dal consenso all'informazione.
Non tutti i pazienti vogliono (o possono, per problemi di comprensione o mancanza di basi culturali) avere un ruolo attivo nel proprio trattamento. Il problema non si pone se è il paziente a scegliere di affidarsi al medico o all'infermiere; ma in base a quali criteri medici e infermieri decidono quando sostituirsi al paziente?
Mentre il consenso a un trattamento non è difficile da ottenere ― specialmente se il medico sa fare un uso accorto delle emozioni del paziente ― dare le informazioni utili e necessarie perché il paziente possa essere il regista delle decisioni che lo riguardano, è molto arduo. Richiede tempo e competenza. Soprattutto domanda che l’empowerment del paziente sia considerato come un obiettivo importante, che merita ogni sforzo per essere perseguito.
Empowerment
In medicina la "modernizzazione" introdotta dalla bioetica sta portando a una modifica di fondo dei rapporti tra coloro che erogano le cure e i cittadini che le ricevono. Con una parola che sintetizza tutto il processo, ci si riferisce al fenomeno nel suo insieme come a un empowerment del paziente. La parola inglese contiene la nozione di "potere" (power). L'aspetto più visibile è proprio quello di uno spostamento di potere tra le persone coinvolte nella relazione. Il potere a cui ci si riferisce non è quello di natura politica o, nei rapporti interpersonali, ciò che autorizza qualcuno a dare ordini, aspettandosi che altri obbediscano. Tutte le relazioni di cura e assistenza prevedono un potere, utilizzato in modo benefico a vantaggio di un altro: pensiamo al rapporto tra genitori e bambini, insegnanti e allievi, medici e malati, appunto.
75
Il concetto di empowerment sostituisce quello di operatore sanitario come avvocato (o alleato) del paziente. Il primo in particolare riproponeva il rapporto di dipendenza: il paziente ha bisogno di qualcuno che lo difenda. Empowerment invece sottolinea il concetto di autonomia.
L'analisi di questo tipo di transazioni raggruppa rapporti di natura molto diversa nella categoria di "relazioni complementari": queste si basano sulla differenza tra le posizioni coinvolte. Funzionano bene quando ognuno si attiene al suo ruolo e non pretende di fare la parte dell'altro. Dal punto di vista grafico, il modello che le rappresenta prevede due posizioni: una sovrastante (one up) e una di sottomissione (one down):
| One up |
| One down |
Diverse invece sono le "relazioni simmetriche", nelle quali i protagonisti hanno uguale potere e non si comportano secondo ruoli fissi. Ce li possiamo immaginare l'uno di fronte all'altro, faccia a faccia, senza poter dire chi comanda e chi obbedisce (Watzlawick, 1971).
Il senso del processo di empowerment del paziente non è quello di mettere quest'ultimo in posizione one up e il medico in posizione one down, invertendo i rapporti di potere che siamo soliti associare con l'esercizio della medicina (dove il medico è considerato tanto più bravo quanto più esercita un'autorità indiscutibile e induce il paziente a essere "osservante" o compliant). Non sarebbe un progresso se il medico diventasse l'esecutore nelle decisioni del paziente; anzi ciò costituirebbe una minaccia per la salute, perché al paziente verrebbe a mancare il bagaglio di conoscenze proprie del sapere professionale del medico. L'empowerment è invece un cambiamento di rapporti complesso, che ha luogo su diversi piani. Lo schema grafico proposto da Gianfranco Domenighetti prevede tre elementi costitutivi dell'empowerment:
|
Autogestione della salute |
● Promozione della salute (fattori di rischio, di protezione ecc.) ● Prevenzione ● Automedicazione semplice
|
|
Accesso più consapevole alle prestazioni |
● Informazione su: "meccanismi" e conflitti d'interesse, efficacia e incertezza della medicina e della pratica medica ● Promozione del "secondo parere" medico ● Diffusione pubblica dei risultati di studi sulla qualità e l'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi ● Creazione dei centri informatori
|
|
Atteggiamento adulto verso i professionisti della salute
|
● Diritti dei pazienti ● Promozione della consapevolezza che la totalità della "fattura" sanitaria è pagata direttamente e/o indirettamente dai consumatori Empowerment dei consumatori" (da Domenighetti, 1996)
|
76
Il primo fattore dell'empowerment è la capacità di mantenere, per ampi settori della vita, il controllo sulla propria salute e la capacità di porre rimedio ai fatti patologici senza ricorrere ai professionisti ("automedicazione semplice"). L'autogestione della salute è, quindi, l'antidoto al fenomeno, già clamorosamente denunciato dal sociologo Ivan Illich con il volume Nemesi medica (1977 e 1991), dell'"espropriazione della salute" attuata dall'impresa medica contemporanea. È la dimensione dell'empowerment che possiamo definire culturale.
La dimensione culturale dell'empowerment, cioè quella di una riappropriazione della propria salute, equivale a trasmettere maggiori conoscenze sul corpo e il suo funzionamento, su cosa è normale (gravidanza e parto, i processi fisiologici dell'invecchiamento) e cosa patologico. Possono essere gli operatori sanitari gli artifici di questo processo? Devono essere gli operatori sanitari a trasmettere queste conoscenze? Il rischio è che si riproponga un modello di salute delegata.
L'accesso più consapevole alle prestazioni sanitarie comprende inoltre tutte le conoscenze che il cittadino, in qualità di consumatore dei servizi, può e deve acquisire prima di giungere a una decisione clinica. Si tratta di tutto il processo di informazione che deve venire dal medico stesso, affinché il consenso che dà il paziente possa essere qualificato come "informato". Il paziente inoltre può acquisire altre informazioni da altri operatori ("secondo parere"), perché l'opinione di un sanitario può non costituire una base sufficiente per decidere. L'empowerment presuppone perciò un elemento intellettuale o cognitivo.
L'empowerment comprende, infine, una dimensione psicologica, ovvero l'atteggiamento "adulto" verso medici, infermieri e altri professionisti sanitari. Il movimento dei diritti del paziente ― e strutture volte a renderli operativi, come i tribunali per i diritti dei malati e iniziative analoghe ― ha contribuito in modo determinante a modificare l'atteggiamento psicologico di sudditanza che i malati in passato tendevano ad assumere.
Qualità
Nei documenti ufficiali che descrivono dal punto di vista normativo la nuova sanità, la qualità ha un profilo dominante. Il Piano sanitario nazionale 1994-1996 riassume nel passaggio da una crescita quantitativa a una qualitativa la fisionomia tipica del riordino del SSN avviato negli anni Novanta:
La necessità di ripensare a fondo il profilo stesso di un programma sanitario per il Paese si presenta come una straordinaria opportunità per ridefinire il progetto di civiltà, che è l'obiettivo di una politica per la salute. Per anni si è pensato che la promozione della salute richiedesse solo nuovi investimenti in tecnologie, strutture e personale sanitario, nella fiducia di ottenere solo da tale impegno un migliore livello di salute. L'inversione di rotta cui il momento attuale costringe punta a un miglioramento che si sviluppa sotto il segno della qualità, più che della quantità. La pressione della scarsità delle risorse orienta a immaginare un servizio alla salute che accetti in senso positivo la sfida dell'autolimitazione.
Piano sanitario nazionale 1994-1996, 2.A
Per prevenire che il cambiamento di filosofia sia inteso semplicemente come una strategia di risparmio in epoca di risorse scarse, lo stesso documento specifica che si tratta di un "cambiamento di paradigma" di cui tutti i sistemi sanitari moderni hanno bisogno:
"Il più" ― nel senso di interventismo terapeutico, di innovazione tecnologica e di investimento economico ― non coincide sempre con "il meglio". Anzi, i problemi più acuti dei nostri giorni sembrano provenire più dall'eccesso che dalla carenza (si vedano le situazioni etichettate come "accanimento terapeutico" e le richieste di limiti all’interventismo medico, in nome della volontà oggettiva di conservare la dignità umana anche nella fase terminale della vita). Se "il più" non equivale al meglio, analogamente,
77
"il meno" non corrisponde necessariamente al peggio: molti pazienti riceveranno benefici se la pressione esercitata dal contenimento dei costi limiterà gli interventi non necessari, ridurrà i danni iatrogeni e punterà più sulla qualità della cura, che equivale spesso a un prezzo minore.
La qualità ha dunque una molteplicità di significati:
● Pratica manageriale. Prima di essere introdotta in medicina, è stata individuata come la strategia che assicura il successo delle imprese che producono beni e servizi. Le aziende dell'Occidente hanno individuato nella sfida della qualità la via per uscire dalla crisi (Deming, 1986). La Verifica e Revisione della Qualità (VRQ; in inglese Quality Assurance) abbraccia tutte le attività intraprese per predire e prevenire la scarsa qualità. Secondo la definizione del British Standard Institute, è un "sistema di gestione finalizzato a dare la massima garanzia che un dato livello accettabile della qualità del servizio venga raggiunto con un minimo di spesa complessiva".
L'autenticazione e la certificazione della qualità sino ad ora hanno testimoniato la sua assenza. È importante distinguere, quando si parla di qualità, quello che ha a che fare con il riconoscimento del dovuto ― cioè informazione al paziente, liste di attesa con tempi accettabili, gentilezza, orari compatibili con i normali ritmi di vita ― da quello che invece viene dato in più. Finora la qualità ha coinciso con la restituzione al paziente di quello che avrebbe dovuto normalmente avere.
● Una scelta etica e deontologica. Comporta per i professionisti della sanità la disponibilità ad accettare la valutazione come metodo per migliorare la pratica. La domanda chiave ― "Ciò che viene fatto è la cosa migliore? Ci sono modi migliori per farlo?" ― presuppone la consapevolezza che "non possiamo più vivere con i livelli che vengono comunemente accettati di ritardi, errori, materiali difettosi ed esecuzioni carenti" (Deming, 1986).
Adottando la verifica della propria qualità professionale, si accetta di controllare sistematicamente se il servizio soddisfa i bisogni così come vengono definiti dai professionisti che forniscono le cure; se vengono eseguite correttamente le tecniche e le procedure che sono necessarie per soddisfare i bisogni del cliente (Ovretveit, 1996). Un passo fondamentale verso la qualità consiste nell'accettazione della verifica professionale (audit: valutazione retrospettiva delle prestazioni attraverso la revisione della documentazione, come le cartelle cliniche).
● Una politica sanitaria. Secondo i decreti legislativi che hanno trasformato le Usi in aziende sanitarie, al controllo di qualità va attribuito un ruolo strategico:
Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità delle prestazioni, nonché del loro costo [...].
Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN [il Ministero della Sanità] definisce con proprio decreto i contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché all'andamento delle attività di prevenzione delle malattie.
Dlgs 502/1992, artt.10 e 14.
Evidence based medicine (EBM)
Abbinata alla sigla complementare ― Evidence based health care ― costituisce la parole d'ordine della medicina e della sanità degli anni Novanta. Più che per ognuna delle altre parole nuove che caratterizzano la situazione della medicina modificata dalla bioetica, si pone il problema
78
della traduzione. La formula inglese ci invita a ripensare la pratica medica (medicine) e l'assistenza sanitaria (health care), fondandole sulla evidence. Ma che cosa si intende con questa parola? La scelta peggiore che si può fare è tradurre la parola con la corrispondente latina: "evidenza". Non si tratta di promuovere una medicina "basata sull'evidenza", come si sente dire ripetutamente: evidence, in inglese, ed "evidenza", in italiano, sono solo apparentemente la stessa cosa (gli esperti di inglese sono soliti parlare, in questo come in casi analoghi, di termini che si presentano, nelle due lingue, come "falsi amici"...). Evidence significa per lo più "prova", mentre chi proclama una cosa "evidente" non si sente obbligato a portare delle prove. Il cambiamento che la EBM vuol introdurre nella pratica medica consiste fondamentalmente in una mentalità nuova, che induce a cercare le prove dell'efficacia dei trattamenti.
Già fin dagli anni Settanta alcuni epidemiologi hanno cominciato ad attirare l'attenzione sulla variabilità delle pratiche mediche: di fronte a patologie simili, medici diversi tendono a fare cose diverse. Secondo l'accusa dell'epidemiologo Archibald Cochrane, non c'è stata da parte del corpo professionale medico una cura sistematica per distinguere tra trattamenti sicuri ed efficaci e quelli che non lo sono:
È certamente una grave responsabilità etica e sociale, prima ancora che professionale, della classe medica non aver saputo creare meccanismi permanenti per la valutazione critica, la verifica e l'aggiornamento delle informazioni sull'efficacia degli interventi sanitari man mano che esse vengono prodotte.
La EBM è rivolta a escludere dalle prestazioni offerte ai malati quelle che non rispondono all'esigenza fondamentale della qualità: l'efficacia dimostrata.
Il movimento della EBMedicine (e Nursing) non è nuovo, essendo in qualche modo già insito nel concetto di medicina come scienza sperimentale. Ha creato però un vento di novità in medicina e nell'assistenza dove si tende(va) a utilizzare le conoscenze di fisiopatologia per giustificare i vantaggi di un farmaco o di un trattamento. I criteri per valutare gli interventi si rifanno a binomi difficilmente contestabili: funziona-non funziona; è utile-non lo è.
La congiuntura attuale di contrazione delle risorse economiche ha sicuramente contribuito a portare in primo piano, a partire dagli anni Novanta, la questione dell'efficacia dei trattamenti: efficacia non creduta dagli operatori (e dagli utenti), ma "provata". Proprio perché non possiamo più permetterci di pagare cose inutili, dobbiamo focalizzare maggiormente i nostri sforzi nel discemere ciò che serve veramente al bene del paziente da ciò che va eliminato perché inefficace o futile.
La distinzione è diventata, con il Dlgs 229/1999 che razionalizza il SSN, il criterio per distinguere le prestazioni fornite dal SSN ― livello essenziale di assistenza ― e quelle che il cittadino che le desidera può eventualmente procurarsi a spese proprie o con sistemi integrativi:
Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo benessere in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del SSN le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che [...] non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate.
Dlgs 229/1999, n. 7.
Le prove di efficacia, ottenute attraverso metodologie specifiche (soprattutto la metanalisi: rassegna sistematica di studi, per lo più controllati randomizzati, per giungere a delle conclusioni confrontando i risultati dei singoli studi), sono la base per costruire le linee guida professionali.
79
È importante che L'EBM-N non si trasformi in un boomerang. Non sono disponibili prove di efficacia per pratiche magari utili, perché fino a ora non sono state oggetto di ricerca. La documentazione di efficacia non corrisponde (la medicina e l'assistenza non sono scienze esatte) a certezza. Il fatto di lavorare in base alle prove di efficacia non deve dare (false) sicurezze.
La metodologia innovativa promossa dalla EBM non riguarda solo i medici: ha ampi campi di applicazione anche nella pratica professionale dell'infermiere. Si tratta di passare dalla routine ("Nel nostro reparto si è sempre fatto così"; "Le piaghe di decubito ho imparato a trattarle in questo modo"...) a un nursing basato sulle prove di efficacia (Cavana, 1996).
Accountability
Descrivendo l'evoluzione che ha subito nel giro di pochi anni la sanità americana, A.S. Relman ha distinto tre epoche. Nella prima si è avuta, a partire dagli anni Quaranta del XX secolo, un'espansione sempre maggiore dei servizi sanitari; nella seconda ― che per gli Stati Uniti corrisponde agli inizi degli anni Settanta per l'Italia agli anni Novanta ― la preoccupazione maggiore è stata quella di contenere i costi, introducendo sistemi diversi di remunerazione nelle prestazioni; la terza èra ― che secondo Relman costituisce una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare l'assistenza sanitaria ― è iniziata verso la fine degli anni Ottanta. Relman la chiama l'epoca della valutazione (assessment) e dell'accountability (Relman, 1988). La traduzione di questo secondo termine è molto ardua. Anzi, come afferma con ironia pungente Indro Montanelli, l'accountability è "parola chiave della democrazia anglosassone. In Italia non è stata ancora tradotta" (Corriere della Sera, 12 aprile 1999).
Stando all'Enciclopedia della gestione di qualità in sanità ― che riporta il giudizio di Montanelli ― l'accountability indica il dovere di documentare, di rendicontare ciò che si è fatto a chi ci ha dato l'incarico e ci paga lo stipendio o ci ha messo a disposizione altre risorse (quindi, per i dirigenti pubblici, anche ai cittadini in quanto contribuenti). Non è quindi sovrapponibile alla responsabilità, che rimanda ai doveri verso i destinatari degli interventi (Morosini, Perraro, 1999). In altri termini, accountability fa riferimento a quella dimensione dell'etica pubblica che richiede il rispetto di regole e priorità implicitamente accettate con il contratto sociale. Il contrario dell'accountability è l'autoreferenzialità, ovvero il non dover rendere conto che a se stessi, o al gruppo dei propri pari 1.
In medicina il principale ostacolo al prevalere dell'atteggiamento di accountability è il persistere del rimando alla "scienza e coscienza", quali istanze supreme con le quali si deve misurare l'operato del medico. La coscienza è, per definizione, non verificabile dall'esterno (quando chiediamo a qualcuno di "mettersi una mano sulla coscienza" ci rendiamo conto che stiamo facendo appello alla dimensione più segreta e irraggiungibile di un'altra persona). La scienza, poi, non è controllabile se non da chi abbia la stessa formazione del medico, quindi sfugge al "laico".
Soprattutto lo scenario del contenimento delle spese sanitarie, abbinato alla responsabilità che ha un servizio sanitario pubblico nell'uso delle risorse dei cittadini destinate alla salute, rende
80
urgente che i comportamenti di tutti i professionisti che operano in medicina siano ispirati dall’accountability. Né la libertà prescrittiva del medico, né la subordinazione gerarchica dell'infermiere sono più una giustificazione accettabile per rifiutare di sottoporsi a un confronto pubblico sulle scelte fatte, le risorse utilizzate, i risultati di salute ottenuti.
Privacy
La privacy è un'altra realtà così lontana dalla nostra esperienza culturale che manchiamo anche di un termine italiano per designarla 2. È invece un pilastro della pratica sociale e giuridica anglosassone, che ha formulato in modo incisivo il diritto di privacy come il diritto a "essere lasciato solo" (the right to let be alone), vale a dire a non subire interferenze sulla propria persona e nella propria vita privata. Una legge ― "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", L. 675 del 31 dicembre 1996 ― ha introdotto anche in Italia delle norme che vietano di far circolare dati personali senza il consenso degli interessati.
Per comprendere lo spirito della legge ― e di conseguenza per tradurla in pratica in modo corretto ― è necessario distinguere tre tipi di informazioni che ci riguardano, e che sono tutelate in modo diverso:
1 informazioni per cui è libera la raccolta (per esempio, notizie usate a fini di ricerca: senza queste informazioni non si potrebbero fare ricerche epidemiologiche, né programmazione sanitaria);
2 informazioni per le quali occorre il permesso dell'interessato (per esempio, dati raccolti nello svolgimento di promozioni commerciali; chiunque possiede il mio indirizzo ― come la banca o una rivista a cui mi sono abbonato ― deve chiedermi l’autorizzazione se vuole trasmetterlo ad altri;
3 informazioni sensibili, definite dalla legge come "dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": in altre parole, sono dati sensibili quelli che potrebbero esporre la persona a qualche forma di discriminazione; per diffondere queste informazioni non basta il consenso della persona interessata, ma è necessaria anche l'autorizzazione del Garante per la privacy.
La tutela della privacy apre un nuovo fronte di obblighi per i sanitari. Non si possono limitare a fare il loro meglio per curare la malattia e promuovere la salute dei cittadini, ma devono farlo in modo da evitare che le informazioni relative ai dati sensibili possano giungere a persone o istituzioni (per esempio assicurazioni) non autorizzate. L’utente che si rivolge al medico, all'ospedale o all'ambulatorio consegna una serie di dati di varia importanza, che richiedono un trattamento diversificato: per esempio, risultati di precedenti esami, cartelle cliniche di altri ricoveri, pareri medici antecedenti, consulti. Questi dati non possono essere trattati alla stregua di informazioni quali dati anagrafici, residenza e professione.
81
La tutela della privacy ha esteso i confini e verniciato di nuovo il concetto di segreto professionale. Il paziente viene protetto dalla divulgazione delle informazioni anche a se stesso. In molti reparti, paradossalmente, tutti gli operatori sanitari possono leggere la cartella clinica, ma non il paziente. Spesso l'interpretazione della legge sulla privacy è andata al di là del buon senso: per esempio il non dire se una persona è ricoverata a chi chiede informazioni; o il non dare informazioni telefoniche sulle condizioni di salute.
Analoga considerazione va fatta per la conservazione dei dati: quelli sensibili godono di maggior tutela e devono essere conservati in modo che non siano accessibili a tutti. A tutela dei dati trattati devono essere adottate cautele e precauzioni di carattere organizzativo e di tipo procedurale che coinvolgono tutto il personale.
La mancata tutela della privacy ha ricadute molto concrete nella vita delle persone. Pensiamo a due situazioni ― che si verificano purtroppo con una certa frequenza ― in cui viene meno la protezione dei dati personali e dei dati "sensibili". Una signora si reca in ospedale per partorire. Il bambino nasce, ma sopravvive solo per pochi giorni. Per anni, tuttavia, la famiglia continua a ricevere posta promozionale di prodotti per l'infanzia, che rinnova ogni volta lo stesso strazio della perdita. In questo caso i dati personali anagrafici, non protetti dalla struttura ospedaliera, sono finiti in mano a chi li usa a fini commerciali: per la famiglia in questione una prova ben più dolorosa del fastidio che subiamo quando il nostro indirizzo è assediato da pubblicità non gradita. Tra i nuovi obblighi degli operatori sanitari è incluso perciò quello di informare il soggetto, cui i dati si riferiscono, sulla finalità e modalità del trattamento dei dati stessi e richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.
Una violazione dei dati sensibili si ha invece quando una certificazione ― per esempio un referto diagnostico ― cade nelle mani sbagliate, informando di una prognosi infausta o anche di una semplice gravidanza, quando la persona a cui è rivolta ha interesse a tener riservata l'informazione. Per questo il personale sanitario dovrà mettere tutta la cura nel proteggere questo tipo di dati. Le certificazioni (come le cartelle cliniche) rilasciate dagli organismi sanitari non possono essere ritirate da persone diverse dagli interessati, se non sulla base di una delega scritta e con inclusione dei documenti in busta chiusa.
82
83
seconda parte
LA TRAMA DELLE NORME
84
85
capitolo
4
LE LEGGI
I doveri che l’infermiere, in quanto professionista, deve osservare sono non solo numerosi ma anche di diversa natura. Per capirne la varietà e l'intreccio, consideriamo le frasi seguenti:
● "L'infermiere responsabile (caposala) deve tenere l'elenco aggiornato di farmaci stupefacenti, segnando l'ingresso e l'uscita di ogni confezione dall'apposito armadio".
● "L'infermiere deve qualificare e aggiornare la sua formazione in rapporto allo sviluppo tecnico-scientifico".
● "L'infermiere deve considerare il malato al quale presta assistenza non come un mezzo, ma come un fine".
● "L'infermiere deve occuparsi del malato con gli stessi sentimenti altruistici con cui il Buon Samaritano si è preso cura del viandante assalito dai ladroni".
Nessuno si lascerà fuorviare dal fatto che le quattro frasi contengono tutte il verbo "dovere": è evidente che gli obblighi ai quali fanno riferimento non sono gli stessi. La riprova è costituita dal fatto che la sanzione per chi non li osserva cambia nei diversi casi. Mentre l'infermiere che non rispetta le norme relative agli stupefacenti può andare incontro a una denuncia, nessuna sanzione civile o penale minaccia chi non nutre sentimenti evangelici verso il bisognoso. Nel primo caso, inoltre, siamo di fronte a un obbligo che vale per chiunque abbia quella specifica responsabilità, mentre l'obbligo di amare il prossimo come se stessi vincola solo il credente che accetta la rivelazione biblica e aderisce liberamente alla religione che vi si ispira.
Di diversa natura sono anche i doveri connessi con il buon funzionamento di una professione (come, nell'esempio che abbiamo fatto, l'obbligo dell'aggiornamento professionale) e quelli che derivano da una risposta razionale e argomentata agli interrogativi che ci poniamo sull'uomo, la sua natura, i suoi comportamenti (per riferirci ancora ai nostri esempi, in terzo luogo abbiamo riportato la formulazione dell'etica che risale al filosofo Immanuel Kant). Le quattro proposizioni rimandano a quattro diversi sistemi di norme, che ci dicono come dobbiamo comportarci. Le possiamo distinguere chiamandole, rispettivamente, la legge, la deontologia, l'etica e la morale.
La situazione è più complicata di come la stiamo presentando per il fatto che non tutti adottano la stessa terminologia. In particolare, l'etica e la morale tendono a confondersi: la prima deriva dal greco, la seconda dal latino; gli antichi usavano indifferentemente l'una per l'altra e lo stesso fa l'uso comune anche oggi (salvo che l'etica è meno screditata della morale, che evoca per lo più un contesto di norme oppressive e di pregiudizi, di natura religiosa o sociale). Anche tra coloro che si occupano professionalmente di etica non è infrequente l'uso linguistico dei due
86
termini come sinonimi. Così per esempio Fernando Savater ― che ha divulgato l'etica con il fortunato volume Etica per un figlio ― spiega la terminologia adottata:
Io utilizzerò le parole "morale" ed "etica" come equivalenti, però da un punto di vista tecnico non hanno lo stesso significato. "Morale" è l'insieme di comportamenti e norme che tu, io e alcuni di coloro che ci circondano consideriamo in genere come validi; "etica" è la riflessione sul perché li consideriamo validi e il paragone con altre "morali" di altre persone. Io però continuerò a usare una parola o l'altra indifferentemente come arte di vivere.
Savater, 2000.
Un motivo più intrinseco di confusione è il linguaggio che usano i diversi sistemi di norme. Tutti ricorrono, infatti, al verbo "dovere" e termini equivalenti. Si rischia così di confondere la natura specifica dei diversi obblighi. Per amore di chiarezza, li considereremo separatamente, anche se nella vita quotidiana le norme che vincolano i nostri comportamenti sono simultaneamente presenti, costituendo un fitto intreccio.
È ADATTA LA LEGGE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA SANITARIO E PAZIENTE?
Le norme legali ci prescrivono in che modo dobbiamo comportarci in quanto cittadini, all'interno di una condizione condivisa con altri cittadini e sanzionata dallo Stato. Di queste norme si occupano il diritto, in quanto disciplina, e gli organismi legislativi che le varano, le modificano e le revocano, nonché i tribunali che fanno riferimento ai codici ― civile e penale ― per sanzionare i comportamenti dei trasgressori.
In generale l'attività medica viene vista come un'area in cui le normative giuridiche sono inappropriate, in quanto la medicina sa regolare i rapporti tra terapeuti e pazienti in modo autonomo, senza il bisogno di leggi. L'esperienza diretta ― come sanitari, o come pazienti, talvolta in tutti e due i ruoli ― ci aiuta a capire perché sentiamo la norma giuridica estranea alla particolare situazione che si crea tra chi eroga e chi riceve cure sanitarie. La legge, che adotta il linguaggio dei diritti e dei doveri reciproci, è particolarmente appropriata a regolare le procedure tra avversari, o quanto meno tra estranei. In questa prospettiva la norma tende a prescrivere doveri minimi e a considerare la persona come portatrice di diritti, come per esempio il diritto a non essere danneggiato, a essere trattato con una misura di giustizia o di equità. L'insieme dei diritti e dei doveri che regolano i rapporti tra estranei tende a demarcare i confini che separano le persone.
Ma non è questo il genere di relazione che vogliamo quando i rapporti diventano intimi. Si può immaginare un rapporto di amicizia che cominci con la dichiarazione dei diritti negativi di libertà? Da un amico vogliamo essere trattati con giustizia, certo, ma vogliamo soprattutto essere considerati nella nostra unicità, come esseri speciali. Ed è anche quanto vogliamo dal medico, dall'infermiere e da tutti i professionisti ai quali ci rivolgiamo per essere curati. Desideriamo che ci curino e che si prendano cura di noi, che ci considerino con empatia ― cioè mettendosi nei nostri panni ―; in una parola, che stabiliscano con noi un rapporto retto dalle regole che valgono tra gli intimi, non tra gli estranei.
Medico e infermiere sono persone, estranee al paziente, che per professione devono prendersi carico di un problema di salute. Le norme giuridiche regolano i comportamenti dei cittadini e anche degli operatori sanitari, che sono cittadini che svolgono una funzione particolare. Le norme sono necessarie per esplicitare i diritti del paziente e quello che deve attendersi? Per proteggere il paziente da operatori incompetenti o in malafede? In qualunque relazione tra "estranei"? Quali professioni sono regolate da norme giuridiche?
87
Le norme giuridiche promuovono un atteggiamento minimalista: il dovere è compiuto quando si è rispettato il livello più basso di ciò che è prescritto. Nel rapporto di cura, invece, fare quanto più possibile non dipende dalla bontà personale del medico o dell'infermiere, ma è la condizione abituale per poter dire che si sta facendo buona medicina. La legge non ci prescrive mai di "fare tutto il possibile", mentre è quanto richiede quotidianamente la pratica dei rapporti di cura.
Pensiamo alle situazioni cliniche nelle quali bisogna decidere se ricorrere o no a terapie che incidono sulla durata e sulla qualità della vita del paziente. In questi casi è necessario un tipo di ragionamento dove non si tratta semplicemente di applicare delle regole, ma di capire un contesto, il posto che l'individuo vi occupa, i legami familiari che lo qualificano, e ovviamente la volontà e le preferenze dell'individuo circa la sua vita. Questo è il tipo di medico che vorremmo come medico personale. Temeremmo invece che le sorti della nostra vita e della nostra salute fossero affidate a un sanitario unicamente preoccupato di osservare le prescrizioni legali che gli evitano guai con la giustizia.
Per lungo tempo la pratica della medicina si è svolta senza il bisogno di avere delle norme legali che prescrivessero ai medici che cosa fare. Guardando alla situazione italiana, possiamo dire che fino agli anni Novanta leggi specifiche in ambito biomedico sono state molto rare, e solamente circoscritte ad alcune pratiche che creano particolari perplessità etiche e giuridiche.
Possiamo ricordare:
― leggi relative alla pratica della donazione di organi (legge 458/1967: prelievo e trapianto di rene da vivente; legge 644/1975: espianto di organi da cadavere per il trapianto. Dopo quasi cinque lustri di dibattiti, le norme sui trapianti di organi sono state riformate dalla legge 91/1999);
― legge sul transessualismo (legge 194/1978, che permette la modificazione del sesso fenotipico per una nuova attribuzione);
― legge sulla sterilizzazione volontaria (risultata, in pratica, legalizzata dall'abolizione, da parte della legge 194/1978, degli articoli del codice penale che la proibivano come un "delitto contro l’integrità e la sanità della stirpe'');
― legge sull'interruzione della gravidanza (legge 194/1978).
Se a queste specifiche leggi ad hoc aggiungiamo le norme relative all'assistenza psichiatrica, quelle che regolano l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla lotta contro l'AIDS, abbiamo il quadro completo delle leggi relative alla pratica della medicina. In tutte le altre situazioni ― vale a dire, nella stragrande maggioranza ― il trattamento medico-chirurgico si è svolto nel silenzio della legge.
Al di là di queste situazioni, nell'insieme piuttosto eccezionali, non si è sentito il bisogno di leggi che regolassero i comportamenti dei professionisti in sanità. Il moltiplicarsi di nuove e più invasive possibilità di intervento e soprattutto il mutato rapporto di fondo tra sanitari e cittadini hanno promosso, parallelamente, il dibattito bioetico e la richiesta di un "biodiritto". Il diffondersi di pratiche come la procreazione medicalmente assistita, e soprattutto l'enfasi giornalistica e lo scandalismo con cui sono pubblicizzati alcuni casi-limite, hanno fatto diventare un luogo comune la denuncia del far west procreatico e la richiesta di una legge. Analoghe invocazioni di interventi legislativi hanno avuto luogo dopo la notizia di procedere alla clonazione di organismi o, periodicamente, di fronte a fatti di cronaca riferiti a episodi di eutanasia.
Le leggi vengono promulgate quando una professione non si "autoregola", oppure normare con leggi è l'evoluzione naturale di rapporti e situazioni ad alta complessità e dove le possibilità di fare danno all'individuo sono elevate?
88
La spinta verso il biodiritto non ha avuto luogo solo in rapporto a queste singole pratiche. Con il tempo è andato cambiando il rapporto stesso che teneva insieme sanitari e cittadini. Dobbiamo renderci conto che l'esercizio della medicina nella nostra società avviene in condizioni giuridiche abbastanza paradossali, che comportano la massima copertura etica e la minima copertura giuridica dell'atto medico. Intervenire sul corpo di un'altra persona, ai fini della salute, è un'azione connotata da valori altamente positivi (agire "per il bene del malato", l'esercizio dell'arte terapeutica come "missione" o come "servizio" ecc.). Eppure i sanitari hanno l'impressione di camminare su una corda, con il rischio permanente di cadere in un vuoto normativo che non riconosce all'atto medico una fisionomia giuridica specifica.
Forse il caso più emblematico è costituito dalla prima, clamorosa condanna di un chirurgo per aver eseguito un intervento ignorando il diritto del paziente a essere informato e a dare il suo consenso. Si tratta del celebre "caso Massimo". Nel 1990, la Corte di Assise di primo grado di Firenze condannava il chirurgo Carlo Massimo per il reato di lesione personale volontaria (art. 582 del codice penale) con riferimento a un intervento chirurgico conclusosi con la morte della paziente. L'addebito non gli veniva sollevato per uno dei classici motivi di ricorso penale, in quanto cioè il chirurgo avrebbe agito con imperizia, imprudenza o negligenza. La motivazione della condanna introduce invece dei temi nuovi rispetto alla pratica giuridica e medico-legale del passato.
I fatti sono noti: un'anziana signora era stata ricoverata in ospedale per un intervento di asportazione transanale di un adenoma villoso, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un'amputazione del retto. Durante l'esecuzione dell'intervento, invece, il chirurgo aveva proceduto in questa seconda maniera. La paziente aveva risentito profondamente dell'intervento avvenuto contro la sua volontà, ed era deceduta poche settimane dopo in condizioni fisiche e psichiche deplorevoli.
Il chirurgo è stato riconosciuto colpevole ― leggiamo nella sentenza di primo grado ― per un intervento demolitivo "in completa assenza di necessità e urgenza terapeutiche che giustificassero un tale tipo di intervento e soprattutto senza preventivamente notiziare la paziente o i suoi familiari, che non erano stati interpellati in proposito né minimamente informati dell'entità e dei concreti rischi del più grave atto operatorio che veniva eseguito, e non avendo comunque ricevuto alcuna forma di consenso a intraprendere un trattamento chirurgico di portata così devastante".
La difesa dell'operato del chirurgo, impostata sulla necessità di un intervento finalizzato nelle intenzioni a salvare la vita della malata, è stata esplicitamente rifiutata dal tribunale. La corte, considerando l'espressa volontà della paziente, che aveva consentito solo a un intervento per via transanale, riconosceva a quest'ultima "il diritto di rifiutare le cure mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze". Questo atteggiamento non implica il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece ― sempre secondo la corte ― "la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal volere, o peggio dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita e che, pertanto, lui e lui solo può legittimamente fare".
Può la legge, in caso di conflitto di valori (il chirurgo dare priorità alla vita della paziente; la paziente alla sua qualità di vita e al diritto di essere rispettata come persona, e pertanto informata), definire una priorità di valori? Il diritto all'autodeterminazione è più importante del diritto alla vita?
L'orizzonte di argomentazioni e di valori in cui si muove il tribunale fiorentino ― la cui sentenza, peraltro, sarà successivamente convalidata da tutte le istanze superiori di giustizia ― diverge notevolmente da quello che ha tradizionalmente regolato la pratica della medicina. Sono
89
intervenuti nella nostra cultura cambiamenti importanti, che hanno spostato sensibilmente l'asse dei diritti e dei doveri.
Finora una tacita "alleanza terapeutica" tra medico e paziente e una benevola interpretazione giuridica dell'atto medico, che dava la priorità all'intenzione che lo animava, hanno assicurato un funzionamento relativamente tranquillo e senza eccessive litigiosità giudiziarie. Le denunce per malpractice sono state rare ed eccezionali nella società italiana. Tuttavia la situazione anche in Italia è cambiata: il periodo in cui la deontologia professionale era sufficiente per normare il comportamento del sanitario e per garantirgli un ambito di intervento protetto, a giudizio insindacabile di una sua valutazione clinica, è passato.
Era la deontologia professionale nel passato a costituire una guida sufficiente a normare il comportamento del sanitario o c'erano piuttosto meno attese e consapevolezza di diritti da parte dei cittadini, che accettavano comportamenti scorretti da parte dei medici, e avevano meno informazioni per poter valutare i casi di malpratica? Le norme, richieste dai cittadini dove erano più eclatanti i casi di contenzioso o di malpratica, hanno se non altro definito il minimo al di sotto del quale non si può andare, e affermato la preminenza di alcuni valori.
Probabilmente non si può pensare a una legislazione che preveda in anticipo le condizioni di legittimità a cui il sanitario debba attenersi per non incorrere nei rigori della legge. Ma quanto meno sarà necessario proteggere sia il sanitario che il cittadino in quelle pratiche che non possono più basarsi sulla implicita "alleanza terapeutica".
Circa l'opportunità dell’intervento della legge nelle singole procedure diagnostiche e terapeutiche di cui si dibatte in bioetica si registrano opinioni divergenti. In quali ambiti è opportuno legiferare e in quali invece è meglio lasciare alle regolamentazioni deontologiche e all'unico criterio dell'etica, affidando ai cittadini la scelta di ricorrervi o no? Fino a che punto deve estendersi un'eventuale legislazione bioetica: deve determinare analiticamente tutta la fattispecie, oppure è preferibile una normativa "leggera", che si limiti a una legge-quadro?
L'AGENDA DEL LEGISLATORE ITALIANO
Il principale problema con cui sono attualmente confrontati i corpi legislativi dello Stato è quello della regolamentazione del variegato arsenale di interventi che afferiscono alla procreazione medicalmente assistita. Non è un fatto nuovo che il diritto si interessi della generazione umana. La regolazione sociale si serve abitualmente delle norme giuridiche per mettere ordine nella genealogia, rispetto al caos della realtà fattuale. Il diritto è Io strumento privilegiato per rendere istituzione la vita, il soggetto, la persona. Un'articolazione particolare del diritto applicato alla generazione è quella delle risposte legali all'infertilità involontaria. Ma la legge può costituire un aiuto per quelle persone che vogliono così ardentemente un bambino da far ricorso alle numerose risposte che la procreatica sa dare all'infertilità?
Il diritto ha sempre definito i confini tra i desideri e le possibilità (desiderio di cure e interventi sanitari e diritti individuali e della collettività). La legge interviene anche su sfere molto private, per esempio il desiderio del paziente di sospendere le cure. La legge norma settori per i quali non esiste un'informazione capillare (e quindi mancano i presupposti per una scelta consapevole del paziente) e interviene a protezione della persona. Ma quando una persona, consapevole dei rischi e dei problemi, decide di sottoporsi a pratiche di fecondazione assistita, possiamo dire che la norma costituisca un'indebita ingerenza nella sfera privata?
Il dibattito tra l'opportunità di astenersi dal legiferare in ambito di procreazione artificiale (rimandando, eventualmente, a norme extragiuridiche il compito di regolazione) e la necessità di
90
un intervento legislativo ha fatto per lo più pendere la bilancia a favore della seconda opzione. Pesano in questo senso motivi sociali di grande portata, quali la protezione dei "clienti" che si sottomettono a pratiche riproduttive e il controllo della diffusione caotica delle tecniche. Il dibattito bioetico mostra una propensione marcata a promuovere la nascita di un "biodiritto". La bioetica ha infatti innata una vocazione regolatrice: sia nel mantenere un equilibrio tra spinte ed esigenze diverse (tra le aspirazioni umane al progresso e i sacrifici che questo esige; tra i benefici e i costi, non solo economici, della ricerca; tra i desideri personali e le esigenze sociali), sia nel trovare regole per la vita sociale condivisibili, malgrado il pluralismo filosofico-religioso ed etico che caratterizza il mondo occidentale.
Il passaggio alle prescrizioni normative costituisce tuttavia per il diritto una notevole sfida. Intanto per le condizioni contingenti in cui avviene la progettazione di tale regolazione giuridica: l'arte del diritto ha bisogno di una lenta riflessione, mentre in questo ambito è sottoposta alle spinte di un progresso tecnologico quanto mai accelerato, grazie alla sinergia tra interessi scientifici, bisogno di legittimazione attraverso i risultati e "cultura del narcisismo". In secondo luogo, il diritto è messo in crisi dalle ripercussioni che le tecnologie riproduttive hanno sulle concezioni antropologiche condivise.
Si può affermare, senza esagerazione, che nella riproduzione artificiale sia implicita una mutazione antropologica di vasta portata. Vengono rimessi in discussione, infatti, l'alleanza tra i sessi necessaria per la generazione di un figlio, il ruolo del tempo nella genesi della vita (con la crioconservazione degli embrioni, l'ordine delle generazioni viene sconvolto), le strutture giuridiche di maternità e paternità.
Quest'ultimo aspetto è particolarmente problematico per il diritto, il quale nella sua funzione normativa si fonda sulle strutture parentali come categorie antropologiche. Se il diritto, pur essendo aperto a tutti i fatti, non deve solo subirli, ma è chiamato a regolarli, è tenuto ad assumere la difesa delle strutture antropologiche essenziali nell'alleanza tra uomo e donna, nella bilinearità paterna e materna e nella differenziazione senza discriminare tra paternità e maternità, quanto ai criteri determinanti della filiazione.
Perché il diritto possa svolgere la sua funzione istituzionale, deve trovare una posizione di equilibrio tra la sottomissione e il rifiuto totale della procreazione medicalizzata: la prima porterebbe a legittimare ogni pratica, il secondo a negare la realtà. Per questo la costituzione dell'ordine giuridico non può prescindere da una valutazione dei fatti, che comporta un giudizio su di essi. Valutare se le strutture naturali di parentela vengono rispettate o compromesse ― per permettere al bambino di costruire la propria identità non basta assicurargli amore: bisogna anche garantirgli un posto nell'ordine genealogico ― è uno dei criteri con cui dovrà essere valutata una legge, un criterio migliore delle affermazioni di principio a cui vengono attribuiti valori di dogmi (come per esempio: "Ogni persona ha diritto a un figlio"; oppure: "Ogni bambino ha diritto di conoscere le proprie origini"; oppure ancora: "Ogni embrione è persona"...).
Questo modo di impostare il dibattito previo a una legiferazione è diverso dallo spirito di crociata o di contrapposizione frontale che impedisce o ritarda una legge ragionevole. Le contrapposizioni in questo ambito non sono tra chi è "per la vita" e chi è contro, tra chi difende la libertà degli individui e chi ha in mente uno Stato assolutista che decide al posto dei cittadini anche nelle questioni più intime relative al se e come generare un figlio. È un atto di violenza ideologica rivendicare alla propria posizione l'esclusività di certi valori, se con questo si vuol insinuare che chi dissente della propria posizione sia ― poniamo ― contro la vita o contro la libertà.
Il ruolo della legge nell'ambito della bioetica, e della procreazione medicalmente assistita in particolare, è molto delicato. La legge è una grande risorsa nel regolare i rapporti sociali, purché non entri in modo troppo intrusivo nelle relazioni di intimità che legano le persone. Per fare un esempio diverso dalla procreazione, è sicuramente dovere morale di un figlio prendersi cura
91
dei genitori anziani e malati, bisognosi di assistenza; ma che cosa succederebbe se questo dovere di pietas filiale fosse prescritto per legge? Avremmo un rapporto tra le generazioni più solidale e una protezione più sicura per gli anziani? Possiamo legittimamente dubitarne. Se invocata fuori posto, la legge può fare danni maggiori dei guasti ai quali intende porre rimedio. Non si vive bene in un Paese nel quale ciò che è illegale si sovrappone a ciò che è immorale.
UN QUADRO EUROPEO PER LA BIOETICA Regole comuni per l'Europa
L'Europa, che si va faticosamente costruendo come realtà culturale e politica omogenea, si orienta anche a darsi una normativa comune in materia di bioetica. Il cammino per portare l'Europa ad adottare nell'ambito della biologia e della medicina norme vincolanti per tutti i Paesi che la costituiscono è lungo e travagliato. Ancor prima che i più recenti progressi nella biologia e nella medicina richiamassero l'attenzione sulle possibilità di abusi e di azioni contrarie alla dignità umana, l'Europa ha dovuto confrontarsi con scandalose violazioni del "minimo morale", avvenute sotto il segno delle politiche eugenetiche e delle sperimentazioni con esseri umani di marca nazista. Una delle barriere innalzate per prevenire quelle ricadute nella barbarie è stata la "Convenzione europea sui diritti dell'uomo", approvata nel 1950 dai 23 stati membri del Consiglio d'Europa.
La Convenzione vuol essere una garanzia collettiva sul piano europeo di alcuni dei princìpi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, rafforzata da un controllo internazionale giudiziario, le cui decisioni devono essere rispettate da tutti gli Stati. Gli organi di controllo sono la Commissione europea dei diritti dell'uomo e il Tribunale europeo dei diritti dell'uomo, che hanno la loro sede a Strasburgo.
Tuttavia, le nuove pratiche biomediche rischiano di infrangere tali diritti, pur senza superare il livello di guardia costituito dalla Convenzione. Il Tribunale europeo dei diritti dell'uomo è stato chiamato a intervenire su questioni che esulano completamente dal quadro problematico per il quale è stato istituito e per le quali i suoi strumenti giuridici appaiono quantomeno inadeguati. Per esemplificare: una signora danese nel 1983 è ricorsa al Tribunale dichiarando di essere stata sottoposta a "tortura" perché l'uso di un nuovo strumento, in una operazione volontaria di sterilizzazione che non aveva avuto successo, aveva costituito un esperimento senza il suo consenso.
Un altro caso riguarda il ricorso al Tribunale contro la condanna da parte del governo francese delle organizzazioni che aiutano le coppie a cercare madri "gestazionali" (in termini colloquiali si parla di "uteri in affitto"). Il Tribunale è stato chiamato anche a deliberare circa i diritti di un olandese donatore di seme, il quale chiedeva che gli fosse concesso il diritto di visita nei confronti di un bambino nato dalla sua donazione.
Dalla metà degli anni Ottanta si è incominciato a sentire in maniera acuta in Europa la carenza di una riflessione adeguata nell'ambito bioetico come supporto per normative omogenee. Nel 1985 i ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa si dichiaravano per un fronte comune, affermando che le leggi nazionali sarebbero state inefficaci se non ci fosse stato un allineamento dei Paesi vicini. Basti pensare al "turismo abortivo", in uso in Italia verso Londra prima che la legge rendesse possibile anche in Italia, in circostanze specifiche, l'interruzione volontaria della gravidanza. Più di recente, però, ha avuto luogo un'inversione di flusso: donne inglesi vengono in Italia per pratiche di procreazione medicalmente assistita, che qui hanno luogo in assenza di una legge apposita, mentre sono proibite in Inghilterra.
Qual è la differenza tra un paziente italiano che decide di andare in Francia per sottoporsi a trattamenti oncologici non disponibili in Italia, e una paziente inglese che decide di venire in Italia per sottoporsi a pratiche di fecondazione assistita non disponibili nella sua nazione? Normare su questi aspetti implica anche
92
che garantire uguali standard di trattamenti in Europa? È un problema di diritti o scelte, oppure solo un problema economico? Si deve intervenire con norme giuridiche quando sono i pazienti ad affrontare le spese dei trattamenti?
Il diffondersi delle nuove pratiche scuote la società nelle sue convinzioni più profonde. Chi non è turbato dalle questioni metafisiche o dai dubbi etici non può non vedere almeno la dimensione economica dei problemi. In Europa ci stiamo avvicinando a passi inesorabili al "grande mercato", che fa seguito al progressivo smantellamento delle barriere nazionali. Poiché la pratiche biomediche hanno una ricaduta economica di enorme importanza, quando gli investimenti privati hanno la possibilità di circolare liberamente si rischia di vederli risucchiati da Paesi con una legislazione più tollerante, a danno di quelli che pongono ai propri ricercatori limitazioni più severe in nome della sicurezza e dell'etica. È una prospettiva che diventa inquietante quando si prende in considerazione la commercializzazione del corpo umano.
Le iniziative per creare una legislazione comune in materia di bioetica hanno dovuto affrontare il dibattito se, il linea di principio, tale unificazione sia possibile o auspicabile. Coloro che sono contrari a una legiferazione in questo ambito adducono come argomento l'insufficiente consenso che esiste attualmente su alcune questioni antropologiche cruciali, come l'inizio e la fine della vita, lo status giuridico dell'embrione, l'impatto delle tecnologie riproduttive e della genetica. L'impegno comune, per esempio, a rispettare la vita umana ha poco senso quando gli Stati divergono radicalmente in questioni come l'aborto o l’uso di embrioni nella ricerca.
In un sistema globale per evitare i problemi delle "migrazioni sanitarie" ogni Stato deve legiferare autonomamente o deve cercare di trovare un accordo comune; ma non solo. Una legge "imperfetta" italiana sulla procreazione assistita può costituire una violazione del diritto di scelta del cittadino italiano? Gli esempi non mancano anche in altri settori, per esempio l'estradizione in caso di reati, il segreto bancario...
Coloro, peraltro, che invece sollecitano misure di regolazione giuridica considerano i benefici di una legislazione a diversi livelli. La legge da sola non rende morale i cittadini; tuttavia, essa influenza il comportamento morale. Non avere nessuna legge equivale all'anarchia. Tra una legge inefficace e un'abdicazione alla responsabilità da parte dello Stato è meglio correre il rischio di un'eventuale inefficacia. Una legislazione anche imperfetta, inoltre, può avere effetti contagiosi positivi su altri Paesi, che potrebbero ispirarvisi e migliorarla.
La Convenzione europea di bioetica
In un mondo che va facendosi sempre più piccolo e transitabile in tutte le direzioni; in un'Europa che punta ormai a una completa integrazione culturale, oltre che economica e politica, non è accettabile che in tema di bioetica si possa continuare a procedere in ordine sparso. Da questa convinzione è nato il progetto di una "convenzione" europea in tema di biomedicina, che orienti lo sviluppo futuro del diritto sanitario, oltre che della deontologia. Dopo quasi cinque anni di lavoro e animati dibattiti ― avvenuti, per la verità, più all'estero che in Italia ― il Comitato direttivo per la bioetica del Consiglio d'Europa (CDBI) ha proposto un testo di convenzione che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1996 e successivamente sottoposto alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa. Si tratta dei 38 articoli della "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina", più semplicemente indicata come "Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina".
Una metà circa dei 40 paesi dell'Unione europea ha sottoscritto la Convenzione. Successivamente il documento dovrà essere ratificato dai parlamenti degli Stati firmatari. Rispetto, infatti, alle "Raccomandazioni" del Consiglio d'Europa e ai "Trattati", che si limitano alla enunciazione
93
di principi, lo strumento della "Convenzione" trae la propria forza dal fatto che diviene vincolante per gli Stati che la ratificano, obbligandoli all'applicazione delle sue norme all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Il significato della Convenzione non è, dunque, "esortativo" per gli Stati che la sottoscrivono, bensì normativo. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel marzo 2001.
L'analisi del contenuto della Convenzione ci permette di rilevare la grande importanza attribuita a due temi che determinano il nuovo rapporto tra sanitari e cittadini nell'ambito sanitario: il consenso agli atti diagnostici e terapeutici e vita privata e diritto all'informazione. Il primo capitolo "Disposizioni generali" ha carattere introduttivo. In modo molto equilibrato, presta attenzione sia alla dimensione individuale dell'etica (art. 2: Primato dell'essere umano), sia a quella sociale (art. 3: Accesso equo alle cure sanitarie). Gli Stati che sottoscrivono la Convenzione si impegnano a non far prevalere una visione massificata della società ("L'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza"); allo stesso tempo, però, sono obbligati ad assicurare "un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata''. La Convenzione, in altri termini, non giustifica un liberismo estremo, attento solo a tutelare i diritti dell'individuo, ma prevede un impegno parallelo da parte dello Stato a garantire i più deboli.
Il secondo e terzo capitolo (dedicati rispettivamente al consenso e alla privacy e diritto all'informazione) registrano la piena accettazione dell'orientamento fondamentale della modernità a riconoscere l'autonomia per il paziente nel rapporto con i professionisti sanitari. Nessun intervento può, in linea di principio, essere imposto a una persona senza il suo consenso (art. 5: "Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato"). L'individuo deve comunque poter liberamente dare o rifiutare il proprio consenso a qualsiasi "intervento", inteso nell'accezione più ampia: ogni atto medico con finalità di prevenzione, di terapia, di educazione sanitaria o di ricerca. Una cura particolare dedica la Convenzione alla protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso (art. 6) e delle persone che soffrono di un disturbo mentale (art. 7).
L'informazione è un diritto del paziente (art. 10); tuttavia la sua eventuale volontà di non essere informato deve essere rispettata. Sul ruolo attribuito all'informazione da dare al paziente e sulla sua partecipazione attiva al processo clinico la Convenzione è esplicita. Il consenso su questo nucleo essenziale della nuova medicina è stato raggiunto con relativa facilità, a differenza di altri temi controversi come il trapianto di organi, la protezione di embrioni e feti umani, la genetica. La Convenzione non prende posizione su questi argomenti, che saranno oggetto di "protocolli addizionali" in via di elaborazione.
Il valore di fondo difeso dal cap. IV, dedicato al genoma umano, è quello della non discriminazione (art. 11: "Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione al suo patrimonio genetico è vietata"). Per questo i test genetici predittivi devono limitarsi a fini terapeutici o di ricerca medica e le tecniche di fecondazione medicalmente assistita non devono essere utilizzate per selezionare il sesso del nascituro.
Le disposizioni relative alla ricerca scientifica (cap. IV), al prelievo di organi e tessuti da donatori viventi a fini di trapianto (cap. VI) e all'utilizzazione di parti del corpo umano per il profitto (cap. VII) hanno bisogno di ulteriori precisazioni, come i protocolli aggiuntivi non mancheranno di fare. Il disegno fondamentale, tuttavia, che sottostà all'intera Convenzione è molto chiaro: non si vuol permettere che le applicazioni del progresso della biologia e della medicina violino i diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano; allo stesso tempo si richiede agli Stati un ruolo attivo ― e non di semplici spettatori ― per promuovere la giustizia e l'equità.
94
Pistoia, Ospedale del Ceppo
Santi Buglioni: Alloggiare i pellegrini
Gli ospedali medievali avevano originariamente finalità caritative e sociali di ogni genere; soprattutto servivano per accogliere i pellegrini, i trovatelli e gli orfani, e per nutrire i poveri. La funzione di ospedale, in senso moderno era del tutto secondaria a quella di ospizio per i pellegrini, qui rappresentata.
La scena Alloggiare i pellegrini è quella che nel fregio di Buglioni riflette forse meglio il suo intento artistico: interpretare la loggia dell'ospedale come palcoscenico e attribuire alla piazza la funzione di teatro popolare. Sono infatti presenti figure tipiche del folklore o del presepio, con tutte le caratteristiche tipiche del pellegrino: un cappello dalla larga falda con la conchiglia di San Giacomo, il bastone da pellegrino, il mantello per la pioggia con la pellegrina ecc.
Al centro hanno fatto il loro ingresso due pellegrini eminenti, la cui aureola li qualifica come santi. Non sono chiaramente identificabili. Quello di sinistra, dal gesto benedicente, potrebbe essere Cristo pellegrino che mette alla prova i misericordiosi, oppure San Jacopo, protettore di Pistoia. In questo caso il secondo santo si potrebbe individuare in San Giovanni Battista, patrono di Firenze, la città committente. I capelli lunghi, il viso barbuto e il caratteristico vestito di pelli che lo ricopre sembrano confortare questa ipotesi. Il committente gli è particolarmente devoto, tanto da lavare personalmente i piedi dello straniero.
Tutte le ripartizioni del fregio mostrano un ritratto del committente fiorentino, ma solo qui lo spedalingo non è collocato al centro della composizione e inginocchiandosi diventa più basso dei personaggi presenti. Sull'evento si concentra lo sguardo di quattro paia di occhi: lo sguardo umile dello spedalingo, il capo abbassato dello straniero e gli sguardi dei due aiutanti, che offrono assistenza con la brocca e l'asciugamani.
La lavanda dei piedi è un antico costume orientale: agli stranieri, così come agli ospiti, dopo il loro ingresso e prima del pasto, venivano lavati i piedi. Anche Cristo ha lavato i piedi ai discepoli prima dell'ultima cena (Giov. 13,4 ss.). Il rito è stato conservato nella Chiesa cattolica come simbolo di umiltà. Nella scena rappresentata da Buglioni il gesto di umiltà viene sottolineato dal fatto che la personalità di più alto rango dell'ospedale, lo spedalingo Leonardo Buonafede, esegue personalmente la lavanda dei piedi. Il significato spirituale dell'atto viene ulteriormente sottolineato dal fatto di rivolgersi a un santo.
Christina Riebesell
95
5
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
SIGNIFICATO E FUNZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
Quando agiamo entro l'ambito tracciato dalla legge, il nostro comportamento è legale. Ma non tutto ciò che è legale è legittimo. È possibile immaginare situazioni in cui un certo intervento (diagnostico, terapeutico o di ricerca) sia in accordo con le leggi esistenti, ma contrasti con il giudizio morale del professionista sanitario: e che quindi questi lo giudichi legale, ma non legittimo.
Un esempio molto chiaro della dissociazione tra legalità (= conformità alla legge) e legittimità (= accettabile dal punto di vista della professione o della propria coscienza morale) è offerto dal conflitto in cui si sono trovati molti medici e infermieri durante il periodo in cui è stata in vigore in Germania, sotto il regime nazista, la legge che imponeva l'eutanasia per i cosiddetti "pesi morti" della nazione (lungodegenti negli ospedali psichiatrici, schizofrenici, epilettici, alcolizzati, malati in fase terminale e neonati con malformazioni genetiche).
Dalla ricostruzione di tutta la triste vicenda ― che si calcola sia costata la vita a 70.000 persone, la metà dei lungodegenti negli ospedali psichiatrici ― risulta che le uniche forme di resistenza all'esecuzione del programma di eutanasia, voluto personalmente da Hitler, furono quelle di istituzioni psichiatriche gestite dalla Chiesa, sia evangelica che cattolica. Il numero dei medici che si oppose attivamente al programma non fu elevato, così come furono relativamente pochi i convinti sostenitori del programma. La grande massa, sia dei medici sia della popolazione che ne venne a conoscenza, si lasciò guidare con inerzia.
Può il valore dell'obbedienza a una legge essere prioritario rispetto a quello del rispetto alla vita? Questo è stato il conflitto in cui si sono trovati molti infermieri e medici (oltre alla paura per le conseguenze personali della disubbidienza). Alla fine del corso, gli infermieri giuravano fedeltà e ubbidienza a Hitler e veniva insegnato loro a non mettere in discussione gli ordini delle autorità.
Nel libro di Alice Ricciardi von Platen dedicato all'esecuzione del programma di eutanasia troviamo la seguente testimonianza di un medico:
"Ero chiaramente in conflitto. In linea di principio condividevo l’eutanasia, ma quando mi resi conto che sarei stato l'organo esecutivo del programma e quindi, in ultima analisi, che la mia attività era di uccidere, mi sentii sopraffatto. Cominciai a pensare a come uscire da quel sistema. Ritenevo impossibile rifiutare l'incarico."
Ricciardi, 2000.
96
Mettersi contro la legge comporta sanzioni; in situazioni estreme ― come quelle create dalle disposizioni normative che imponevano di eseguire l'eutanasia nei confronti dei "pesi sociali" ― seguire la propria coscienza può richiedere un alto prezzo, che non tutti sono disposti a pagare. Nella stessa opera troviamo la testimonianza, depositata durante il processo svoltosi nel 1947, di un altro medico, che aveva eseguito l'eutanasia su una ragazza proveniente da un istituto di rieducazione e giudicata irrecuperabile:
"Non fu facile per me, ma cosa potevo fare? Avevo ricevuto un ordine, cosa dovevo fare? Dovevo eseguirlo. Oggi mi rendo conto che non è giusto uccidere una ragazza così, che il concetto stesso di 'antisociale' è estremamente vago, ma a quel tempo non la pensavo così e mi sono limitato a inviare la mia relazione. Mi è sempre stato detto: la responsabilità è tutta dei professori di Berlino. Che cosa dovevo fare? Non mi avrebbero certo spedito al fronte ma in un campo di concentramento."
Ricciardi, 2000.
Certo, muoversi al di fuori della legge o contro di essa è un comportamento che espone a sanzioni; ma la legge non è l'unico, né il più alto dei punti di riferimento. Al di là della legge si apre lo spazio della coscienza. In alcuni ordinamenti viene esplicitamente presa in considerazione la possibilità che la coscienza entri in conflitto con la legge: vedi, per esempio, la regolamentazione dell'obiezione di coscienza rispetto alle norme della legge 194/1978, che disciplina l'interruzione volontaria della gravidanza in Italia. Altre volte il contrasto tra la coscienza individuale e la legge non è né previsto, né regolato. Spetta allora a ciascuno decidere da quale parte stare: se con la legge contro la propria coscienza, o con ciò che in coscienza si ritiene giusto, mettendosi contro la legge e pagandone il prezzo.
L'infermiere è responsabile nei confronti dell'istituzione e deve seguirne le regole. L'assistenza infermieristica viene pianificata all'interno di un quadro definito dalla diagnosi medica e l'infermiere è legalmente responsabile dell'esecuzione degli ordini medici. A livello legale pesa di più il potere delle decisioni istituzionali e del medico. L'infermiere è anche responsabile nei confronti del paziente. Cosa si deve fare quando il medico prende una decisione non condivisibile e chiede all'infermiere di eseguirla? Si deve iniziare l'alimentazione per gastrostomia a un paziente in situazione non reversibile che non è in grado di dare il consenso e le cui condizioni continuano a peggiorare?
Prima di rivolgerci all'etica, vogliamo considerare un'altra fonte di norme per le pratiche biomediche: le regole deontologiche. In linea di principio, queste sono indipendenti sia dall'etica che dalla legge. Sono formulate dai professionisti, al fine di garantire il buon funzionamento sociale della professione. La sanzione delle infrazioni alla deontologia non è né di natura morale (colpa), né giuridica (crimine); ha piuttosto carattere disciplinare (a seconda dei diversi gradi di gravità dell'infrazione, si prevede l'ammonizione, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione o addirittura la radiazione dall'albo professionale, con la conseguenza di non poter più praticare la professione nel contesto sociale che l'autorizza).
Nell'ambito delle professioni sanitarie sono stati i medici i primi a dotarsi di un codice di deontologia. Il primo codice medico ufficiale è, in ordine cronologico, quello emanato dall'American MedicaL Association nel 1847. I medici italiani dovettero attendere la metà del XX secolo per il loro codice di deontologia: il primo ― il cosiddetto "codice Frugoni" ― fu elaborato nel 1954; poi fu rinnovato con una frequenza crescente: nel 1978, nel 1989, nel 1995 e il più recente nel 1998.
La preoccupazione principale che traspare nel corpo delle norme di deontologia medica, in quanto modelli di comportamento faticosamente consolidati nel tempo mediante la ripetitività e autorevolmente proposti dagli organismi più rappresentativi della professione, è quella di costruire una relazione di fiducia con il paziente. La deontologia tende a correggere l'intrinseca
97
asimmetria del rapporto medico-paziente, esplicitando le norme di comportamento a cui i sanitari, in quanto professionisti, si impegnano ad attenersi. Non si limita, perciò, a difendere gli interessi della categoria, concepita come una corporazione, ma tutela anche i pazienti da eventuali comportamenti illeciti da parte dei membri della professione.
Un codice deontologico esplicita i criteri di comportamento degli operatori sanitari, e pertanto quello che il cittadino deve attendersi dal professionista. Va esplicitato il comportamento minimo considerato corretto o il comportamento ottimale? Rispondere ai bisogni dell'utente, cioè assistere, non è un comportamento particolarmente meritevole. È parte intrinseca di una professione scelta proprio per rispondere ai bisogni di chi sta male. Tenere le proprie conoscenze aggiornate e fare ricerca non è un "di più", ma il minimo dovuto nei confronti delle persone per le quali si lavora. Ribadire che queste sono le scelte di una professione significa riaffermare il dovuto. Sottolinearlo eccessivamente significa, come lettura estrema, portare un determinato comportamento nell'area, più o meno precaria, della benevolenza di una professione.
Le regole deontologiche sono, perciò, più che un semplice regolamento interno alla professione. Le si potrebbe chiamare uno "spirito" con cui si esercita la professione, che deriva da una percezione collettiva dell'attività svolta, del senso di questa attività e del suo articolarsi con l'organizzazione sociale, che autorizza l'esercizio dell'arte terapeutica. Se i cittadini avessero l'impressione che le regole deontologiche tutelano solo gli interessi dei professionisti, sarebbe compromessa la relazione fiduciale, che per la medicina è indispensabile.
RAPPORTO TRA LEGGE, DEONTOLOGIA, ETICA
Etica, deontologia, legge: diversi sono i modi di correlare queste tre istanze normative, di dare loro rilevanza sociale. Si può immaginare tra loro un'azione sinergica. Per esemplificare, possiamo riferirci alla regolamentazione dell'interruzione della gravidanza in vigore in Italia dal 1978. La deontologia professionale del medico si situa a cerniera tra le istanze normative della legge e quelle della coscienza morale individuale. Il codice deontologico proclama la non disponibilità del medico per le interruzioni volontarie della gravidanza al di fuori dei casi previsti dalle legge, mentre lo lascia libero di seguire la coscienza negli altri casi (cfr. codice di deontologia del 1978, nn. 46-47).
La deontologia viene così a collocarsi su un piano diverso dalla legge e non in rotta di collisione con essa. La legge, a sua volta, prevedendo la clausola dell'obiezione di coscienza per l’operatore sanitario, lascia sia all'etica che agli orientamenti deontologici il loro libero gioco. In particolare, la deontologia attuale concede al medico la facoltà di collaborare a un'interruzione volontaria della gravidanza, senza per questo dover rinunciare a comprendere la sua opera professionale come orientata verso la salute.
Una regolamentazione di questo genere, che riconosca la specificità irriducibile delle tre istanze regolative ― coscienza, deontologia, legge ―, sembra più adatta a contenere i mali dell'aborto di quanto possa esserlo una legislazione modellata in modo unitario sui principi morali (che nella nostra società non sono condivisi da tutti). Meglio delle costruzioni rigide, quelle articolate permettono un libero gioco tra le parti in conflitto e suddividono le spinte distruttive in atto in una società pluralista.
Gli infermieri si trovano nella posizione ambigua, e allo stesso tempo ricca di potenzialità, di arrivare a un compromesso, cioè a una scelta collaborativa, anche se non necessariamente condivisa, nel cui processo (dove devono essere soprattutto rispettati gli orientamenti deontologici) tutti ― ma soprattutto il paziente ― si sono potuti esprimere. Il libero gioco sta nel confronto e nel dialogo o nella decisione finale a cui si arriva?
98
Questa impostazione, che tende a prevalere nella nostra società, attribuisce un ruolo autonomo alla deontologia professionale rispetto alle norme morali e alle prescrizioni della legge. Una resistenza a concepire così il ruolo della deontologia viene da coloro che la subordinano alla difesa dei valori, così come sono proposti dalle concezioni religiose o da sistemi etici. Un esempio particolarmente chiaro di questa tendenza è stato offerto dai medici polacchi, dopo la caduta del comunismo nel loro Paese. Per contrastare una legislazione molto permissiva in tema di aborto volontario, hanno riallineato la deontologia professionale sulle posizioni tradizionali, che chiedevano al medico di non collaborare mai con l'aborto volontario, per non inquinare l'immagine di una professione che si vuole totalmente al servizio della vita, senza alcuna deroga. In questo caso la deontologia, ispirata da una concezione etica particolare, viene usata contro la legge, per boicottarla.
Al contrario, chi difende la specificità della deontologia non vuole né farla diventare legge, né modellarla su una determinata etica. Non per opportunismo o per mancanza di convinzioni morali (che possono e devono trovare il loro spazio di espressione), ma perché la deontologia è subordinata alle decisioni morali concrete, a quel "caso per caso" che rispecchia l’infinita varietà delle situazioni umane e non può essere rispecchiato da nessun sistema etico. Nell'esercizio concreto della sua professione il professionista sanitario si sente spesso sfidato a tenere insieme cose difficilmente conciliabili, come difendere la vita e tutelare la libertà delle scelte, ispirare la sua azione ad alti principi ― quale quello dell'inviolabilità della vita umana ― e rispettare come soggetto etico anche chi chiede un aborto volontario, perché sente di non avere altra scelta. La deontologia appare più adatta della legge a guidare nelle zone grigie della vita e più capace dell'etica di rispondere alla fallibilità dell'umano, specialmente nell'ambito delle scelte tragiche.
Paziente con cancro del fegato. Sa di avere i mesi contati. È disponibile a sottoporsi a qualunque terapia pur di tentare di sopravvivere fino alla nascita del nipotino. Il personale sanitario è consapevole che non c'è nulla che possa prolungargli la vita e qualunque intervento sarebbe una forma di accanimento terapeutico. Rispettare l'autonomia di scelta del paziente, anche se questo non si traduce in beneficio? Far prevalere la scelta razionale del clinico: non effettuare interventi inutili e che non rechino danno al paziente? Qual è il "gioco" delle parti in queste situazioni?
Da questo punto di vista, una deontologia più muscolosa sarebbe solo illusoriamente più forte. In realtà, rendendola una legge o una morale, le si toglierebbe la capacità di essere un plastico strumento a servizio di un'azione che domanda di conciliare spinte contrastanti. Misurare la deontologia con il metro dell’etica è altrettanto inappropriato quanto chiedere alla legge di esaurire le esigenze della morale. Debole e disarmata rispetto ai confini netti del diritto e alle certezze dell'etica, più compromessa con le contraddizioni della libertà umana, la deontologia appare tuttavia più adatta ad alimentare la speranza.
La deontologia professionale può essere utilizzata bene o male. Un buon uso della deontologia può sgombrare il terreno da pratiche indebite e rendere meno incombente la presenza della legge. Si può immaginare, per esempio, quale contributo verrebbe dall'introduzione di severe norme deontologiche nell'ambito delle tecnologie applicate alla riproduzione. Se i professionisti che vi lavorano fossero capaci di delinearle con chiarezza e di farle applicare, sarebbero delegittimati tutti coloro che non vi si attengono. Molte pratiche stravaganti o non corrispondenti a uno standard medico esigente sarebbero così escluse; ricadrebbero forse nella clandestinità o nella pratica "selvaggia", ma potrebbero così essere più facilmente identificate e perseguite dalla legge.
L'area dell'etica è quella dove la legge non è ancora giunta, o possibile, dove le ipotesi non si sono ancora configurate in dottrine e dove le scelte delle persone devono essere giocate senza privilegi dell'una o dell'altra
99
parte. La deontologia pone dei vincoli e orienta il comportamento delle persone. La sanzione dell'etica è morale, quelle della deontologia e della legge sono "legali". In questo senso legge e deontologia si sovrappongono?
Se invece le norme deontologiche mancano ― o, ancor peggio, esistono, ma gli ordini professionali non hanno il potere di sanzionare i comportamenti dei professionisti che si discostano, perché non le condividono ― si sarà costretti a rendere più dettagliate e intensive le regolamentazioni legali.
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INFERMIERI
La deontologia, formalizzata nei codici deontologici, caratterizza le professioni (in particolare quelle che mettono i professionisti in contatto diretto con gli utenti), fanno circolare informazioni e richiedono fiducia. Le professioni sanitarie fanno parte di questo gruppo. Tra di esse, tuttavia, in passato alcune avevano più peso delle altre. Al medico, in particolare, veniva riconosciuto più potere decisionale e più responsabilità che all'infermiere. Il fatto stesso che per quest'ultimo esistesse un "mansionario" ― cioè un elenco tassativo delle attività che gli infermieri potevano svolgere, per lo più in presenza del medico e solo in ambiente ospedaliero ― limitava notevolmente la loro operatività. Senza dire che, se qualcuno si deve confrontare con mansioni e compiti preassegnati a partire da ciò che è autorizzato a fare e non con obiettivi da conseguire, non potrà essere confrontato con i risultati, e quindi sviluppare un vero senso di responsabilità. In altre parole, senza la libertà di azione nella scelta di mezzi adeguati per raggiungere gli obiettivi, non ci può essere una vera professione. Mancava quindi la condizione fondamentale perché esistesse un codice deontologico ― come corpo di regole che i professionisti si autoimpongono ― nel senso rigoroso del termine.
Gli infermieri hanno messo un impegno culturale e politico molto determinato per superare la condizione che li voleva esecutori di ordini, piuttosto che professionisti in senso pieno. Non senza ambivalenze, in verità. Perché il mansionario, se da un lato limita le possibilità di azione, dall'altro protegge da rischi e responsabilità. La divisione del lavoro e l'organizzazione burocratica della società esercitano anche una forte attrazione. Pensiamo alla formula liberatoria: "Non mi compete", che spesso incontriamo nell'amministrazione pubblica; se l'irresponsabilità burocratica provoca la nostra indignazione quando ci accade di esserne vittime, ci tenta invece quando promette di garantirci una immunità per i nostri comportamenti conformi alla divisione dei compiti.
Il Dpr 225/1974, che aveva istituito il mansionario per gli infermieri italiani, è stato finalmente abrogato dalla legge 42/1999. Si chiudeva così un'epoca di "responsabilità protetta" e gli infermieri venivano riconosciuti come professionisti dell'assistenza, e non più come semplici esecutori. Parallelamente veniva riconosciuto che l'ambito proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere viene determinato da tre elementi: il profilo professionale (stabilito con decreto del ministro della Sanità 739/1994), la formazione ricevuta e le norme contenute nel codice deontologico. Il nuovo codice ― giunto a compimento nel 1999 ― costituisce dunque la struttura portante della professionalità dell'infermiere.
Anche precedentemente a tale data gli infermieri italiani avevano un codice deontologico, di cui andavano fieri: veniva consegnato agli allievi con una certa solennità e citato con reverenza. Datato 1966, rispecchiava una concezione del ruolo dell'infermiere alta sotto il profilo etico, ma depressa dal punto di vista dell'identità professionale. Le stesse formulazioni del ruolo dell'infermiere sfumavano verso una "missionarietà" che eccede quanto si può richiede a un professionista. Valga come semplificazione il primo articolo, che esplicita la dimensione umana dell'infermiere:
100
L'infermiere è a servizio della vita dell'uomo; lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare la sofferenza e ad affrontare l'idea della morte.
La formulazione enfatica (immaginiamo facilmente le maiuscole: la Vita, l'Uomo...) si addice piuttosto a una funzione sacerdotale o quanto meno genitoriale-materna. Gli alti ideali proposti mascheravano la realtà: in ambito sanitario l'infermiere era il più delle volte considerato un servente, stretto in un ordine gerarchico che lo subordinava rigidamente al medico.
Il codice deontologico della Federazione nazionale collegi IPASVI, in vigore fino al 1999, per quanto limitato nel riconoscimento della professionalità dell'infermiere, era sicuramente anni-luce lontano dai regolamenti in uso un secolo prima. L'elenco dei Doveri dell'infermiera che riportiamo ― di fonte sconosciuta, ma identificabile come proveniente dagli Stati Uniti ― ci permette di capire il cammino sociale che hanno dovuto compiere gli infermieri per giungere a essere riconosciuti come professionisti in senso pieno.
|
Doveri dell'infermiera nel 1887 Oltre ad assistere 50 pazienti, l'infermiera deve osservare le seguenti regole: 1 Spazzare quotidianamente i pavimenti dell'infermeria, spolverare il comodino del paziente e il davanzale della finestra. 2 Mantenere una temperatura adeguata nell'infermeria, portando ogni giorno un secchio di carbone. 3 La luce è importante per osservare il paziente. Perciò ogni giorno bisogna riempire le lampade di kerosene e lavare le finestre una volta la settimana. 4 Le note infermieristiche sono importanti per aiutare i medici. Scrivere le note con cura. 5 Ogni infermiera inizierà il turno alle 7 di mattina e tornerà a casa alle 8 di sera, tranne il sabato, giorno in cui sarà consentita una pausa da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio. 6 Le infermiere diplomate che godono della considerazione del direttore del personale avranno una sera libera alla settimana per uscire con il fidanzato o due sere la settimana per partecipare ad attività religiose. 7 Ogni infermiera deve risparmiare una parte del salario quotidiano per affrontare la vecchiaia. Se l'infermiera guadagna 30 dollari al mese, dovrà risparmiarne almeno 15. 8 L'infermiera che fuma, beve liquori, va a farsi acconciare i capelli in un salone di bellezza o frequenta le sale da ballo darà al direttore del personale buoni motivi di sospettare delle sue intenzioni e della sua integrità morale. 9 L'infermiera che svolge i propri compiti e assiste senza errori i pazienti per 5 anni riceverà un aumento di 5 centesimi di dollaro al giorno, purché non abbia debiti con l'amministrazione dell'ospedale.
|
Con l'acquisizione di un vero statuto professionale, gli infermieri italiani hanno potuto formulare un codice deontologico vero e proprio. Il nuovo codice, nell'esplicitare i valori condivisi dalla comunità infermieristica, rinuncia a ogni formulazione sovrapponibile al linguaggio religioso. Assume perciò una posizione di rispetto nei confronti di ogni visione filosofica, ideologica e religiosa, senza per questo rinunciare a esplicitare i principi etici irrinunciabili che, secondo la riflessione bioetica, devono ispirare l'esercizio della medicina.
La modernità ― nel senso di sintonia con i valori che caratterizzano la stagione dell'etica in medicina che si colloca sotto il segno della rivoluzione liberale ― del codice deontologico degli infermieri italiani si annuncia già dal testo posto a introduzione del documento stesso. Il codice
101
è preceduto, infatti, dal "Patto infermiere-cittadino", elaborato già nel 1996. Il significato del Patto risulta con maggiore chiarezza se lo si confronta con il giuramento, anteposto alle più recenti revisioni del codice deontologico dei medici italiani (1995 e 1998). Il giuramento, anche se lascia cadere ogni riferimento alla divinità, è pur sempre un'espressione sacrale. Nella sua forma laica, non può che fondarsi sulla coscienza di colui che giura, e quindi è essenzialmente autoreferenziale. Il patto, invece, mette in rapporto i due contraenti. Rivela una vocazione democratica, tanto quanto il giuramento è aristocratico. Mentre il giuramento esprime un impegno assoluto e unilaterale, il patto esige una distribuzione di potere equa tra i contraenti. È quanto dire che un codice deontologico che ha un patto come cornice di riferimento, è più attrezzato a raccogliere nelle sue vele il vento della bioetica.
Quale ruolo il patto attribuisca all'altro ― come soggetto e non solo come oggetto di cure ― emerge dall’articolo del codice che considera l'ipotesi di un dissenso sulle questioni etiche che può sorgere nella pratica:
Nel caso di conflitto determinato da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all'obiezione di coscienza (2.5).
Gli infermieri si collocano d’emblée sulla frontiera dei nuovi diritti-doveri tra curanti e cittadini tracciata dalla bioetica formulando in questi termini il rapporto con la persona assistita:
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte (4.7).
La semplicità con cui viene indicato il fatto che l'ascolto è il punto di partenza per l'intero processo che conduce al consenso informato è più che una formulazione felice: è la spia che nel nuovo codice deontologico degli infermieri si esprime una percezione dei bisogni diversa da quella che vediamo rispecchiata dalla pratica medica abituale.
Il bambino ha la febbre e il medico fa diagnosi di polmonite. La madre crede nella medicina complementare e non fa somministrare all'infermiera l'antibiotico prescritto. La scelta non è condivisibile, perché al bambino viene negato un intervento di documentata efficacia. Un trattamento impositivo e autoritario (informare il medico, colpevolizzare la madre) forse avrebbe l'effetto di far somministrare il farmaco, ma non crea le condizioni per un buon rapporto con la madre né garantisce la compliance. Cercare di capire i motivi della scelta della madre, senza adottare un atteggiamento colpevolizzante, spiegare le possibili conseguenze, parlare della terapia, dire cosa controllare e osservare nel bambino e quando preoccuparsi, non porta necessariamente all'adozione della terapia prescritta. Quando l'ascolto non porta alla soluzione, che tipo di patto si crea tra infermiere e paziente? La volontà di quale delle parti prevale?
Il patto, infine, si colloca all'interno della comunità. Ha luogo tra l'infermiere e il malato, ma in quanto cittadino. Ciò rimanda, oltre che ai suoi diritti, anche ai diritti delle altre persone che condividono la stessa condizione. Ne consegue un'attenzione ai problemi della giustizia e dell'equità nell'uso delle risorse:
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse.
In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale (2.7).
102
103
capitolo
6
L'ETICA VISSUTA E L'ETICA COME DISCIPLINA
Dobbiamo anzitutto distinguere la bioetica in quanto movimento e sensibilità diffusa nella nostra società nei confronti dei problemi che suscita il progresso biomedico dalla disciplina filosofica che giustifica i giudizi morali. L'esistenza di una disciplina nasce dalla necessità di trovare un fondamento di ragione ai giudizi morali, a differenza delle preferenze culinarie (cibi che si amano e altri che si aborriscono...) e da quelle estetiche (qualcuno preferisce la musica sinfonica e qualcun altro il jazz...). È precisamente la possibilità di riferirsi a una filosofia che impedisce di "andare a naso" nelle questioni morali. Non ci sono prove dell'esistenza di un "fiuto etico"; esistono invece molte ragioni a favore dell'importanza di sviluppare argomentazioni razionali per giustificare le nostre scelte.
L'etica è un'attività della ragione alla ricerca del bene morale. Non è, perciò, un sistema di credenze collegate a una fede, né si riduce all'insieme di comportamenti condivisi da quelli che appartengono alla stessa cultura. Si realizza, in concreto, grazie alla capacità argomentativa che rende capaci di presentare in modo convincente le ragioni che sostengono l'una o l'altra opzione. Presentarle agli altri, ma prima ancora a se stessi.
Tra l'etica vissuta e l’etica come disciplina c'è un passaggio forzato, nel quale abbiamo l'impressione che vada perduto qualche elemento importante di ciò che rende l'orientamento ai valori parte della nostra vita, una spinta interiore intima e calda che ci guida ad agire. L'estraneità comincia con il fatto che, quando cominciamo a spiegare perché e come comportarci moralmente, dobbiamo servirci delle parole. Questa traduzione verbale, come ogni traduzione, è anche un tradimento ("traduttore traditore" è un gioco di parole italiano che è diventato universalmente familiare a chiunque si occupa di traduzioni).
L'espressione di "etica vissuta" sta forse a indicare la differenza tra le reazioni intuitive e spontanee alle situazioni e ai dilemmi del quotidiano e quelle che invece prendono orientamento da teorie e principi e producono comportamenti o riflessioni logiche e coerenti. Nell'"etica vissuta" contesti diversi possono originare diverse, sinanche contraddittorie, intuizioni etiche.
Un'illustrazione divertente del processo di travisamento linguistico a cui è soggetta l'etica vissuta è quella presentata dallo scrittore Luigi Meneghello in Libera nos a malo. Nel libro l'autore toma ripetutamente sulla diversa percezione del mondo, della vita sociale e della moralità mediata del dialetto ― in questo caso quello della sua infanzia, trascorsa a Malo, un paesino dell'alto vicentino ― e quella che trasmette la lingua italiana. La divaricazione riguarda anche l'etica:
104
Il divario tra il codice di condotta postulato dalla cultura ufficiale scritta, e il costume reale del paese, era grande.
Trovo sul rovescio della copertina di un vecchio quaderno di scuola usato un anno prima che nascessi io, un Decalogo Civile che comincia così:
1. Ama i compagni di scuola, che saranno i tuoi compagni di lavoro di tutta la vita.
2 Ama lo studio... [...]
Ho preso in questo Decalogo il primo esempio che mi è capitato sottomano, per richiamarmi concretamente a uno dei tanti "codici" espliciti di condotta, o prevalentemente di origine civile e laica, come questo, o ispirati direttamente agli insegnamenti morali della religione, che da questo punto di vista era il settore più importante della cultura ufficiale.
Tutti sono ugualmente lontani dal codice reale di condotta che seguiva la gente, pur non trovandolo scritto in alcun luogo. Non dico che questo fosse l'opposto di quelli, che la gente vivesse in modo apertamente immorale e incivile: dico solo che la nostra condotta non si ispirava ai modelli che ci erano proposti.
Le virtù principali vigevano nella cerchia del mondo familiare, ed erano connesse colle necessità della vita, e col lavoro. La parola "dovere" in senso morale è sconosciuta al dialetto; c'è invece l’espressione "bisogna" nel senso in cui si dice che morire bisogna. Anche lavorare bisogna, per sé, per la "dona", per "el me òmo", per i figli, per i vecchi che non possono più lavorare [...].
Un decalogo realistico in lingua sarebbe dovuto cominciare così:
Ricordati che bisogna lavorare perla tua famiglia, e che la tua famiglia viene prima di tutto.
Meneghello, 2000.
Innumerevoli sono i sistemi etici che la lunga storia della filosofia morale ha sviluppato nel corso dei secoli. La bioetica non è un sistema alternativo; attinge piuttosto al vasto patrimonio creato dai pensatori che si sono proposti di rispondere alle questioni del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto nell'ambito dei comportamenti umani. Sottostanti ai diversi sistemi di pensiero, possiamo individuare degli orientamenti di fondo. Talvolta sono usati anche nelle argomentazioni per scegliere tra i vari comportamenti, ma per lo più rimangono impliciti. Li passiamo brevemente in rassegna, per esplicitarli.
GRANDI ORIENTAMENTI DI FONDO
Orientamento religioso/laico
Le religioni, con le loro prescrizioni morali volte a guidare il comportamento dei credenti, sono vivacemente presenti anche nella nuova ricerca di norme e regole nell'ambito della bioetica. Proprio l'attualità dirompente dei problemi connessi con la vita e il suo mantenimento ha dato alle religioni tradizionali una nuova visibilità. La stretta in cui si trova la vita sulla terra sembra fornire alle religioni un'opportunità insperata di essere presenti sulla scena del mondo. Il loro patrimonio di saggezza è ascoltato con una serietà che nel mondo moderno era data per definitivamente scomparsa. E non sono soltanto i credenti a prestare ascolto a questi insegnamenti: il magistero morale delle religioni nell'ambito delle questioni collegate con l'etica della vita ha acquistato una risonanza che eccede ampiamente la cerchia dei fedeli.
Tuttavia le religioni corrono il pericolo di entrare nel dibattito sulla bioetica portandosi dietro un lungo passato di intolleranza per chi pensa e agisce diversamente da come prescrive l'ortodossia. Restringendo la nostra visuale ai paesi latini, sviluppatisi con l'eredità del cristianesimo, dobbiamo riconoscere che nella nostra tradizione la tolleranza non era compresa nella lista delle virtù. Anzi, era piuttosto sospettata come un vizio, mentre la vera virtù era considerata l'intolleranza, identificata con la difesa a oltranza della verità (o piuttosto della Verità; in quanto rivelata, la religione le attribuisce un carattere assoluto).
105
La tolleranza come virtù civile è stata scoperta dagli anglosassoni nel XVII secolo. A essa dobbiamo il rispetto della diversità e il pluralismo come alternativa al fanatismo. Il fanatismo afferma che i valori sono assoluti e oggettivi, e devono essere imposti anche a chi non li condivide; la tolleranza, invece, sottolinea l'autonomia morale e la libertà di tutti gli esseri umani e la ricerca di un accordo mediante il consenso.
A contenere le tentazioni di straripamento e di prevaricazione delle coscienze a cui inclina l'orientamento religioso dell'etica, si profila l'etica a orientamento laico. Il laicismo è presente nella riflessione bioetica con due diversi significati: uno debole e uno forte. In senso debole si intende per laicismo un atteggiamento critico e antidogmatico, che si ispira ai valori del pluralismo, della libertà e della tolleranza. Questa forma di laicismo non si identifica con una particolare filosofia o teoria, ma è piuttosto un metodo che rende possibile la coesistenza di tutte le filosofie e teorie possibili. Secondo l'accezione debole di laicismo, quando si parla di "Stato laico" si intende un tipo di ordinamento che, prendendo atto della varietà delle opinioni e delle credenze, ritiene che lo Stato debba praticare una rigorosa neutralità in materia di ideologia, di fede e di morale.
In senso forte, invece, il laicismo indica la dottrina di coloro che non si limitano a una generica adesione ai valori dello spirito critico e della tolleranza, ma ragionano indipendentemente dall'ipotesi di Dio. In questo senso si parla correntemente di "cultura laica" e di "bioetica laica", in quanto assumono un atteggiamento dottrinale non religioso (che in Italia equivale per lo più a un non cattolico). Anche in questa accezione l'orientamento laico ha una sua giustificazione, e non deve essere confuso con le forme rozze di anticlericalismo, che spesso sono una reazione a un invadente clericalismo.
Orientamento alla natura o alla tecnica
Ci si può orientare nei confronti della natura e dei limiti che essa pone ai nostri progetti ― con le patologie varie, il decadimento, la morte ― o adattandosi a essi, oppure cercando di trascenderli. Possiamo chiamare il primo atteggiamento "naturalismo". Esso riconosce una intrinseca saggezza e utilità (per la specie, se non per l'individuo) in ciò che la natura fa subire agli organismi viventi. Il secondo atteggiamento fa propria la logica della tecnica, per la quale ogni limite è fatto per essere superato (cfr. Galimberti, 1999).
L’antica filosofia greca può essere assunta come modello di naturalismo. A differenza della cultura moderna, che ci ha insegnato a contrapporre l'aspetto morale a quello fisico, il regno della libertà e quello della necessità, per i greci è buono ciò che occupa il suo posto nel kósmos, quale insieme ordinato di cose. In questo orientamento la saggezza richiede la capacità di discernere tra ciò che rispetta le leggi della natura e ciò che le viola. Anche la medicina era soggetta a questo regime. La vera forza sanante era considerata quella della natura (i latini parlavano di vis sanatrix naturae). Il medico possiede solo una potenza che gli viene prestata, per breve tempo, per porsi al servizio della natura stessa; ed è un medico tanto più bravo quanto meglio sa distinguere tra le malattie che per natura sono destinate alla guarigione e quelle invece che vanno verso un esito infausto inevitabile.
Ritroviamo la stessa concezione naturalistica nel cristianesimo medievale: l'uomo deve adattarsi all'ordine della natura, che in ultima analisi è un ordine divino, in quanto Dio è creatore della natura e delle sue leggi. Ma l'orientamento alla "legge naturale", come partecipazione alla "legge eterna", non è più un criterio di orientamento per l'uomo dell'epoca moderna, che si lascia guidare dalla tecnica. Caratteristica della tecnica moderna, a differenza di quella dell'antichità e del medioevo, è di "produrre artificialmente degli esseri naturali". Non produce solo degli "artefatti", contrapposti alle realtà naturali, ma interviene in zone sempre più ampie dell'essere vivente, producendo le stesse cose della natura e dotate della stessa attività naturale.
Tradotta nel linguaggio del senso comune, la logica della tecnica suona: "se siamo in grado
106
di farlo, perché non farlo?". Un rafforzamento di questo orientamento viene dal ruolo che la cultura contemporanea attribuisce al desiderio. Sia la tecnica che il desiderio tendono a porre la soggettività al di sopra di ogni norma etica; anzi, la bontà morale dell'azione viene correntemente commisurata sulla rispondenza al desiderio: è bene quello che porta al soddisfacimento di ciò che è sentito soggettivamente come desiderabile. Non si accetta un principio regolatore del desiderio, come se questo non avesse altra regola che se stesso. Così la logica della tecnica induce a perseguire ogni fine realizzabile, spingendo il progetto di dominio della natura fino alla completa disposizione del proprio corpo.
L'orientamento di tipo naturalistico non è inconciliabile con la cultura del nostro tempo. Naturalmente esso resta vivo nella bioetica di ispirazione religiosa (in questo senso, il riferimento a un "ordine naturale" e a "leggi naturali" è presente nella dottrina cattolica come argomento per condannare interventi nell'ambito della procreazione umana). Ma non solo. Vanno nella direzione di una certa forma di naturalismo anche le riflessioni di filosofi contemporanei che si dedicano alla bioetica, come Daniel Callahan e gli studiosi che hanno redatto il rapporto Gli scopi della medicina: nuove priorità (Hastings Center, 1997). Callahan ha collocato tutta la sua lunga riflessione sull’etica della medicina e della biologia sotto il segno dei "limiti" da porre necessariamente allo sviluppo tecnicamente possibile (Callahan, 2000). Siamo invitati a considerare la vita umana come limitata. La vita si sviluppa "naturalmente" entro un arco temporale che comprende un inizio, una crescita, una decadenza e una fine, con la morte come suo correlato naturale. Pensarla altrimenti ― cioè come una frontiera mobile, che si può allargare a condizione di investirvi più ricerca e più denaro ― porta a una peggiore qualità della vita, oltre che a un baratro senza fondo nei conti della sanità.
Orientamento al dovere o all'utilità
Due fondamentali orientamenti tendono ad aggregare i sistemi morali ― in quanto corpi di teorie, principi e regole più o meno sistematicamente collegate ― che sono state elaborati nel corso della storia della filosofia: i sistemi a orientamento teleologico e quelli a orientamento deontologico.
1 Teorie a orientamento deontologico (da non confondere con la deontologia professionale!): identificano gli standard morali indipendentemente dai fini buoni o utili che l'azione si propone. Un atto è normalmente giusto in quanto soddisfa le esigenze di un dovere (che in greco si dice deon; di qui l'aggettivo "deontologico" che caratterizza questo orientamento). L'etica di Immanuel Kant può essere identificata come una delle teorizzazioni più compatte e conseguenti dell'indirizzo deontologico. Per chi si orienta in senso deontologico, un'azione moralmente cattiva ― per esempio, mentire ― non va fatta, qualunque sia il bene che ne possa derivare.
2 Teorie a orientamento teleologico: sono quelle che fanno derivare il carattere morale dell'azione dal fine (telos, in greco) che questa persegue e dal bene che produce. Un sistema a chiaro carattere teleologico è l'utilitarismo di John Stuart Mill. La moralità viene fatta coincidere con la promozione del benessere umano, minimizzando i danni e massimizzando i benefici. Di conseguenza, le azioni sono giuste in proporzione a quanto tendono a promuovere la felicità ― diminuendo il dolore e aumentando il piacere ― e ingiuste quelle con tendenze contrarie.
Semplificando al massimo, si può dire che i sistemi etici a orientamento deontologico cercano il bene morale a monte, nel dovere che sovrasta l'uomo; i sistemi a orientamento teleologico, invece, lo cercano a valle, in ciò che l'azione produce. Una diversa versione di questa visione dicotomica delle teorie etiche è quella proposta da Max Weber, come etica della convinzione ed etica della responsabilità.
Chi si ispira all'etica della convinzione, secondo Weber, seguirà il dovere in quanto dovere,
107
indipendentemente da ciò che la sua azione produce: dirà, per esempio, la verità perché la verità va detta e la menzogna evitata, per principio. Chi invece aderisce a un'etica della responsabilità valuterà il proprio dovere morale sulla base delle conseguenze della sua azione: l'assunzione responsabile dei risultati della sua azione può imporgli, per esempio, di non dire la verità se questa nuoce ingiustamente a qualcuno (Weber, 1948).
La formulazione di Max Weber ci aiuta a renderci conto che i due orientamenti, presi separatamente, possono ispirare sia la più alta moralità, sia la peggiore immoralità. L'orientamento alle convinzioni può produrre le azioni più coerenti e di più alta tensione morale, ma può nutrire anche i fanatismi più intransigenti. Parallelamente, possiamo trovare l'attenta considerazione del risultato delle proprie azioni tanto nel più cinico opportunista ("Parigi val bene una messa''...), quanto nella persona più sensibile nel rispettare i diritti altrui e nel promuovere il bene comune.
Quanto diciamo per l'etica della convinzione e per l'etica della responsabilità vale anche per le teorie a orientamento deontologico e teleologico. Non sono esse, di per sé, che fanno le persone buone o cattive, o che determinano il carattere morale di un'azione. La pratica quotidiana della bioetica favorisce il confronto tra soggetti morali, sollecitandoli a misurarsi non con la qualità dei sistemi morali ai quali aderiscono, ma con le decisioni concrete. Ciò è vero soprattutto nell'ambito della bioetica clinica.
Una riproposta molto innovativa dell'"etica della responsabilità" è sorta dall'ambito culturale identificabile come pensiero femminista, o piuttosto riconducibile alla differenza di genere (gender). Carol Gilligan ha denunciato il sessismo nascosto nelle teorizzazioni relative allo sviluppo morale: la loro apparente neutralità ha impedito di vedere la modalità femminile di concepire i conflitti e le scelte morali.
Per secoli abbiamo ascoltato la voce degli uomini e le teorie dello sviluppo ispirate alla loro esperienza; oggi abbiamo cominciato ad accorgerci non solo del silenzio delle donne, ma anche della difficoltà di udirle, quand'anche parlino.
Gilligan, 1987.
La struttura etica che emerge dal pensiero delle donne è stata considerata come una deviazione dal modello ideale, una specie di fallimento evolutivo. In breve: rispetto al comportamento maschile, considerato come "norma", è come se nelle donne, rispetto alla capacità di giungere a un giudizio morale, ci fosse qualcosa che non va...
Analizzando il modo femminile di definire un conflitto morale e di prendere le decisioni ― buona parte della ricerca empirica della studiosa americana è stata condotta su donne che affrontavano la decisione di abortire ― Carol Gilligan ha messo in evidenza un modo alternativo di concepire la maturità morale, che ha qualificato come "etica della responsabilità". Questa riflette il sapere cumulativo dell'umanità sui rapporti umani, più che un'idea universale di giustizia; concepisce i conflitti come una rottura della rete di relazioni, più che come un contrasto tra valori gerarchicamente ordinati; articola la maturità etica intorno all'intuizione centrale dell’interdipendenza tra sé e l'altro. Tale visione dell'etica è coerente con il posto che occupa la donna nel ciclo della vita umana, all'interno del quale il suo compito è quello di assicurare i legami affettivi. Il prendersi cura degli altri è tipico della modalità femminile di essere al mondo, e ciò informa il comportamento etico nella sua struttura più intima.
La forte rivendicazione di un altro atteggiamento morale, che non sia da considerare semplicemente come uno stadio inferiore di uno sviluppo lineare della moralità destinato a concludersi con quella "matura" o "normale" (leggi: maschile), è il contributo del pensiero femminista, che ha analizzato la differenza di genere anche nel modo di concepire l’etica. Non dovrebbe però essere interpretata come la proposta di sostituire l’etica al maschile con l’etica al femminile, ovvero
108
di sostituire una unilateralità con un’altra unilateralità. La combinazione dell'etica dei principi con l'etica della responsabilità spinge piuttosto a guardare verso un orizzonte di integrazione possibile tra due diversi ideali di rapporto interpersonale: quello che prevede che gli esseri umani saranno trattati con equità nonostante le differenze di potere, e quello in cui si prefigura che nessuno verrà lasciato solo e fatto soffrire.
Se i valori sono universali, può esistere un'etica al maschile e una al femminile? Il fatto che tutti gli esseri umani saranno trattati con equità nonostante le differenze di potere implica anche risparmiare sofferenze all'altro (cioè non far soffrire). Questa apparente diversità è dovuta più a prospettive diverse che non all'ispirazione a diversi valori. La professione infermieristica (il cui compito è prendersi cura, e che è esercitata al 905 da donne) deve ispirarsi a un'etica al femminile? Qual è il ruolo dell'"etica al femminile" nella medicina, il cui compito è di curare, ma anche di accompagnare e assistere?
Orientamento alla sacralità o alla qualità della vita
Il concetto di "qualità della vita" ha una carriera che corre parallela agli sviluppi della bioetica. La considerazione della qualità della vita assicurata dal progresso medico ha messo in evidenza che delle negatività accompagnano, come un'ombra, quello che possiamo ottenere con la biomedicina. In particolare, le capacità acquisite di prolungare la vita, in condizioni che in passato avrebbero condotto celermente alla morte, hanno mostrato la loro ambivalenza: possono anche fornire l'occasione per "condanne a vita", percepite soggettivamente dalle parti in causa come più oppressive di una condanna a morte. La qualità della vita si invoca in relazione a uno scenario che ribalta il significato che siamo soliti attribuire all'azione medica: una costrizione violenta, invece che un beneficio; un apparato burocratico e ostile, invece che una partecipazione simpatetica ai drammi che colpiscono le persone; una struttura in cui si deve lottare per uscirne, piuttosto che per entrarvi.
Il concetto di qualità di vita (per definizione, identificabile e misurabile solo dalla persona) ha ulteriormente polarizzato la posizione del medico rispetto a quella del paziente-utente. È più importante la vita o la sua qualità? E questo significa che il paziente può rifiutare la vita se questa, a suo giudizio, non ha una qualità sufficiente? Un sistema sanitario nazionale deve cercare di dare vita o qualità di vita?
L'orientamento a difendere la qualità della vita mira, dunque, alla difesa dell'individuo dalle prevaricazioni che può subire proprio da parte della medicina. Tuttavia il ricorso al criterio della qualità della vita come guida per le scelte morali in ambito bioetico è avversato da coloro che tendono a orientarsi verso il polo opposto: quello della "sacralità della vita". Anzitutto perché l'espressione è ambigua. Che cosa si deve intendere per qualità umana della vita? Per qualcuno coincide con il funzionamento normale dell'organismo; per altri con la felicità soggettività correlata alla possibilità di modellare l'esistenza secondo i propri obiettivi e preferenze. La qualità della vita appare, dunque, come una frontiera mobile, a seconda dei significati che vengono attribuiti all'espressione.
L'orientamento alla qualità della vita, inoltre, veicola implicitamente un presupposto: che mantenere in vita un organismo non deve essere considerato in tutti i casi un dovere morale. Quando il peso dèi trattamento è maggiore del beneficio, o quando la vita è così deteriorata che l'intervento medico non ha più senso, la bilancia pende verso l'arresto e la sottrazione delle cure. Lo schema teoretico che regge questo tipo di considerazione è l'orientamento teleologico. Esso è perciò rifiutato da chi nella giustificazione etica argomenta in senso deontologico.
L'orientamento alla qualità della vita è avversato da chi lo ritiene una minaccia per le vite umane che vengono a collocarsi sotto quello che è ritenuto il livello minimo della "qualità" umana. Il criterio della "sacralità della vita" viene considerato come maggiormente adatto a proteggere le vite umane più minacciate, in quanto si trovano al di sotto degli standard di qualità. L'argomentazione
109
è più esplicita nella riflessione che si situa nel contesto religioso. Per numerosi credenti ― in particolare per le cosiddette "religioni del Libro": ebrei, cristiani e musulmani ― la qualità della vita umana consiste nel suo carattere sacro, in quanto dono di Dio, ed è quindi sottratta alla decisione dell'uomo. Solo Dio può disporre della vita; indipendentemente dai suoi livelli di qualità, la vita umana è un bene e non è disponibile, neppure per colui stesso che ne beneficia.
L'orientamento a considerare la qualità e quello alla sacralità della vita in genere vengono percepiti come contrapposti e presentati come espressioni tipiche di un orientamento religioso dell’etica, da una parte, e di un orientamento laico, dall'altra. Sotto alcuni punti di vista la contrapposizione è giustificata. In un orizzonte religioso, per esempio, non si può ammettere una signoria sulla vita che sia diversa da quella di Dio: il concetto moderno di autonomia, che svincola l'individuo da ogni autorità che non sia quella dell'intelletto, e lo rende entro questi limiti padrone della sua vita, non è conciliabile con le tradizioni religiose cui facciamo riferimento. Ma la contrapposizione non va spinta fino a fare dei due orientamenti delle ipotesi etiche insostenibili, addirittura quasi caricaturali.
Può essere difficile opporsi al desiderio di un paziente, che sta soffrendo e ha una cattiva qualità di vita, di morire più velocemente e in modo più umano. O non concordare che è compassionevole aiutarlo a morire. Questo allevierebbe anche la sofferenza dei familiari, il carico di lavoro per gli infermieri oltre che i costi per il SSN. Medici e infermieri devono alleviare la sofferenza, ma se questo non è possibile (la sofferenza non è solo il dolore fisico) si deve rispettare l'autonomia di scelta del paziente o sostenerne la vita?
I due orientamenti hanno bisogno di guardarsi dai rispettivi estremismi. Ambedue possono guidare l’azione verso scelte estreme, a cui la maggior parte delle persone ragionevoli negherebbe il proprio consenso morale. La difesa a oltranza della vita in nome della sua sacralità può indurre a impiegare enormi sforzi e risorse terapeutiche per preservare forme di vita che mancano dei requisiti umani. Proprio questa idolatria della vita nella sua dimensione biologica è contraria al significato religioso della sacralità della vita; ne costituisce una versione caricaturale, che la scredita tanto agli occhi dei non credenti quanto a quelli dei credenti stessi.
Per converso, una considerazione puramente "qualitativa" della vita umana, che la considerasse legittima solo al di sopra di un determinato livello di utilità e fruibilità, toglierebbe ogni tutela ai più svantaggiati. La tendenza a respingere ai margini della società chi non corrisponde allo standard dominante di normalità verrebbe molto rinforzata. Si può capire e condividere le resistenze del mondo dei professionisti della sanità, che hanno tradizionalmente compreso il proprio ruolo come tutela della vita più debole e minacciata, ad adottare un riferimento esclusivo alla qualità della vita come guida per le decisioni cliniche.
I due orientamenti sono rivolti a proteggere due diversi punti di vista sulla vita. Se contrapposti, esprimono una falsa alternativa: la qualità della vita che tuteliamo rinforza, infatti, il nostro interesse per la sacralità della vita; e la nostra difesa della vita come sacra ne rivela la qualità umana.
STAGIONI DELL'ETICA IN MEDICINA
Sulla soglia del XXI secolo, noi cerchiamo una "buona" medicina per rispondere ai nostri problemi di salute, non meno di quanto abbiano fatto i nostri antenati o i nostri padri in passato. Ma la nostra idea di ciò che corrisponde a buona o cattiva medicina è cambiata, così come sono cambiate le nostre attese nei confronti di un ospedale o del servizio sanitario pubblico. Più precisamente, possiamo dire che le nostre attese sono il risultato di un processo storico che ha visto
110
il susseguirsi di almeno tre grandi modelli di buona medicina, ognuno dei quali prospetta in modo coerente come si devono comportare i diversi protagonisti del sistema delle cure: i medici, i malati, gli infermieri e gli altri professionisti sanitari, la società del suo insieme. Ogni modello che si sussegue nel tempo ci obbliga a ripensare ogni volta la medicina intera sotto una diversa luce di qualità. In modo sintetico, possiamo dire che i tre modelli rappresentano tre diverse stagioni dell'etica in medicina.
Per illustrare i cambiamenti di tutto ciò che associamo all'idea di "buona" medicina, ci serviremo di uno schema (vedi Tabella 2.1). Come ogni schema, introduce una certa semplificazione nella realtà delle cose, ma ha il vantaggio di concentrare l'attenzione sui punti nevralgici del cambiamento.
Tabella 2.1 - STAGIONI DELL'ETICA IN MEDICINA
|
|
Epoca premoderna etica medica
|
Epoca Moderna bioetica |
Epoca Postmoderna etica dell'organizzazione
|
|
La buona medicina |
Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente? |
Quale trattamento rispetta il malato nei suoi valori e nell’autonomia delle sue scelte? |
Quale trattamento ottimizza l’uso delle risorse e produce un paziente/cliente soddisfatto?
|
|
L’ideale medico
|
Paternalismo benevolo
|
Autorità democraticamente condivisa |
Leadership morale, scientifica, organizzativa
|
|
Il buon paziente
|
Obbediente (compliance) |
Partecipante (consenso informato) |
Cliente giustamente soddisfatto e consolidato |
|
Il buon rapporto |
Alleanza terapeutica (il dottore con il suo paziente)
|
Contratto di prestazione d'opera (partnership professionista-utente) |
Stewardship (fornitore di servizi-cliente) all'interno del patto sociale per la salute
|
|
Il buon infermiere
|
"paramedico" esecutore delle decisioni mediche supporto emotivo del paziente
|
Facilitatore della comunicazione, a beneficio di un paziente autonomo |
Manager responsabile della qualità dei servizi forniti |
|
Chi prende le decisioni
|
Il medico, in "scienza e coscienza |
Il medico e il malato insieme (decisione consensuale) |
La direzione aziendale insieme ai dirigenti delle unità operative (negoziazione)
|
|
Principio- guida
|
Beneficità |
Autonomia |
Giustizia |
111
L'etica medica come etica dei medici
Il primo modello presentato dallo schema può essere chiamato pre-moderno. Ha caratteristiche di grande antichità e di forte tenuta nel tempo. La sua antichità è indiscussa, in quanto in Occidente risale almeno a Ippocrate. Ha anche una capacità intrinseca di proporsi in modo convincente, dal momento che non esiste in tutta la tradizione occidentale un modello culturale che abbia resistito tanto a lungo. L'Occidente ha cambiato una quantità di cose nell'organizzazione sociale ― l'economia, la famiglia, la religione, il diritto, la politica ― dall'antichità greco-romana a oggi. La medicina stessa si è profondamente modificata nel corso del tempo, sia nei modelli teorici che nel modo di fornire aiuto ai malati. Tra il medico seguace di Galeno ― che interpreta le malattie secondo la teoria degli umori ― il medico scienziato dell'ottocento ― che ricorre al metodo della scienza sperimentale per spiegare come funziona l'organismo sano o malato ― e il medico della nostra epoca ― che è capace di ricondurre le malattie a un difetto del corredo genetico ed è in grado di prevederne l'insorgenza con anni di anticipo ― le differenze sono enormi. La stessa cosa si può dire riguardo al ricorso di salassi, ai vaccini e all'ingegneria genetica, se ci spostiamo sul versante delle risorse terapeutiche con cui far fronte alla patologia.
Per l'etica, invece, non è avvenuto così. Le convinzioni su ciò che è bene o male fare in medicina, sui comportamenti giusti o ingiusti nei confronti del malato sono rimaste relativamente stabili per secoli. Praticamente si tratta di una tradizione ininterrotta che in Occidente è durata più di 25 secoli, dall'epoca di Ippocrate (V secolo a.C.) fino ai nostri giorni: in tutto questo tempo non abbiamo mai sentito il bisogno di modificare il concetto, condiviso dai medici e dai pazienti, di quelle pratiche di cura della salute a cui attribuire un valore morale positivo.
Ci possiamo riferire a quest'epoca come alla stagione premoderna dell'etica in medicina. Sinteticamente la denominiamo etica medica. L'aggettivo è giustificato. L'etica a cui ci riferiamo, infatti, è sostanzialmente l'etica "del medico". È il medico che la determina e la professione medica che se ne fa garante. In questa etica sono prescritti comportamenti per i malati, per i familiari, per le professioni che collaborano con il medico; tutti svolgono, tuttavia, funzioni subordinate e sono chiamati a modellarsi sulle richieste che provengono dai medici, i quali hanno un ruolo decisivo nello stabilire che cosa sia "buona" medicina. La qualifica di "paramedici" data a coloro che esercitano professioni sanitarie non mediche rispecchia bene questa situazione di centralità del medico. Anche l'etica dei non medici in questa stagione è un'etica "paramedica".
La domanda fondamentale a cui risponde la medicina di qualità dell'epoca pre-modema è: "Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente?". Troviamo questa preoccupazione già nel giuramento di Ippocrate, nella cosiddetta clausola terapeutica:
Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa.
Per decenni si è sempre pensato alle professioni sanitarie come a una famiglia, dove c'è il medico-padre, l'infermiera-madre e il paziente-figlio. Ma abbiamo ormai abbandonato l'illusione di avere saggezza e protezioni totali dal padre; il desiderio di avere comfort e protezione per tutto dalla madre non è raggiungibile; e il paziente è cresciuto. Svanita l'idea della famiglia, tra queste tre figure si deve creare un nuovo tipo di alleanza. I cambiamenti di relazioni nel SSN sono naturalmente dettati da cambiamenti di ben più ampia portata. Aumenta il potere delle donne in molti settori e ci sono sempre più donne medico rispetto a dieci anni fa, anche all'interno delle gerarchie. E il loro numero è destinato ad aumentare. Si creano nuovi scenari per diversi tipi di relazione e collaborazione professionale e l'equazione donna uguale status inferiore diventa sempre più debole.
Salvage J. Smith R., Doctors and nurses: doing il differently.
BMJ 2000; 320: 1019-20.
112
Tutto questo si traduce anche in un'etica diversa? i principali contenuti dei codici etici sono orientati al rapporto tra professionista e paziente e tra professionisti della stessa professione. La crescita di altre professioni (per esempio l'infermiere come "avvocato" del paziente) o l'empowerment del paziente, modificando i rapporti, modificano anche il modo di coniugare i principi etici?
Tutta l'azione del medico è diretta a procurare il bene del paziente, identificato con la soluzione positiva la problema creato dalla patologia. Le risorse che il medico utilizzerà sono ovviamente quelle che la scienza del tempo gli mette a disposizione: per il medico dell’antichità era la "dieta" (cioè il regime terapeutico che tendeva a ristabilire nella vita del malato l'equilibrio turbato); per il medico dei nostri giorni i trattamenti appropriati potranno essere gli antibiotici o i trapianti di organo. Qualunque sia la scienza di riferimento, il modello rimane tuttavia Io stesso: il medico si impegna a fare il bene del paziente.
Questo modello presuppone un ruolo del medico fondamentalmente paternalista. "Paternalismo" in questo contesto non equivale a un giudizio di valore: vuol essere solo la descrizione di una modalità di rapporto. Vuol dire che tra chi cura e colui che riceve le cure c'è lo stesso rapporto asimmetrico che esiste tra un buon padre e una buona madre e i figli del cui bene sono responsabili. Il medico è colui che sa qual è il bene del paziente e vuole realizzarlo, mettendovi tutto il suo impegno e tutta la dedizione. È la scienza in continuo progresso che lo guida nel percorso della terapia, mentre la coscienza gli impedisce di trarre profitto dalla debolezza del paziente (per esempio, strumentalizzandolo ai fini di ingiusto lucro o di fama). Nel linguaggio della bioetica americana che si orienta ai principi, si parla a questo proposito di una medicina ispirata al principio della benejicence, ovvero di "beneficità".
Spesso in medicina e nell'assistenza i confini tra ricerca di conoscenza, coercizione e condivisione sono labili. Gli operatori sanitari sono comunque in una posizione di potere (culturale, per il ruolo che esercitano, per la situazione in cui si trovano) nei confronti dell'utente; anche inconsapevolmente, ne orientano le scelte. Il paternalismo è spesso inevitabile, soprattutto quando l'altro non è in grado culturalmente di capire. Il principio della beneficità giustifica il paternalismo, che presuppone uno scarso rispetto della completa autonomia decisionale? La completa autonomia decisionale di una persona in stato di bisogno è realisticamente perseguibile?
Il malato contribuisce alla buona medicina impegnandosi a essere docile e osservante delle prescrizioni, in un rapporto di affidamento fiduciale. Egli non ha, di per sé, nulla da dire in merito all'atto terapeutico, che rimane affidato a quanto il medico stabilisce per il suo bene. Tutto quello che il malato ha da fare, è di diventare "paziente", in tutti i significati del termine. Il buon paziente è il paziente "osservante"; a lui si richiede di entrare nel trattamento mediante la compliance.
In questo modello il buon rapporto è l'alleanza terapeutica tra colui che si dedica all'opera della guarigione e chi riceve questo servizio. Il termine "alleanza" fa parte della tradizione religiosa. Il rapporto medico-paziente ha, di fatto, una connotazione fortemente religiosa in senso ampio, in quanto, allo stesso modo dell'alleanza che è il pilastro centrale della religione ebraico-cristiana, mette in relazione due fondamentali diseguaglianze. Nell'alleanza religiosa si tratta del legame che si instaura tra la potenza della divinità, in quanto fonte di forza e di salvezza, e la situazione di necessità propria del popolo di Israele. L'unione dei due mediante l'alleanza produce la salvezza. Analogamente, la guarigione in medicina, nel modello tradizionale, si ottiene mediante l'unione tra la scienza-coscienza del medico (che include il suo sapere, la filantropia, la volontà di fare il bene del paziente) e la volontà del paziente di mantenersi dentro questo rapporto di alleanza.
113
Seguire la prescrizione medica è la condizione essenziale perché l'alleanza possa esplicare i suoi effetti benefici, e quindi procurare la guarigione. Il contraente dell'alleanza, che è il malato, si deve affidare e accettare le condizioni che gli vengono poste per la guarigione; il medico, che concede l'alleanza, lo guida verso il suo proprio bene. Dai collaboratori del medico ― in primo luogo gli infermieri ―, in quanto "paramedici" ci si attende che collaborino anche a indurre i malati a essere "osservanti".
Può esistere alleanza terapeutica quando il paziente rifiuta il trattamento? L'alleanza terapeutica si verifica anche nella relazione infermiere-paziente: è giustificabile un'alleanza terapeutica dell'infermiere-paziente contro il medico? Per esempio, quando l'infermiere sostiene il paziente che non vuole continuare una chemio o radioterapia prescritte perché, a suo avviso, non prolungano la sopravvivenza ma incidono negativamente sulla qualità di vita?
Questo modello riconduce la qualità etica di un atto medico a un unico parametro: quello costituito da un vettore che visualizza la maggiore o minore rispondenza di ciò che si fa al paziente a ciò che gli porta un beneficio, in quanto è clinicamente indicato. Graficamente lo possiamo rappresentare in questo modo:
Modello pre-moderno

I valori sono scalari per alludere al fatto che il bene procurato al paziente può essere maggiore o minore (e anche, nei casi estremi, nullo o addirittura costituire un fatto nocivo; per questo l'etica medica ippocratica ha messo come guardiano di tutto l'edificio costituito dai doveri del medico l'imperativo fondamentale: Primum non nocere, vale a dire che il primo dovere del medico è di evitare che il malato riceva un danno). Questo modello continua ancora a strutturare i nostri comportamenti sociali, sia dei professionisti che lavorano in sanità sia dei pazienti. Soltanto quando diventiamo "moderni" il modello entra in crisi.
La stagione della bioetica
Quando comincia l'epoca moderna? I manuali di filosofia e di storia generalmente fanno iniziare la modernità con l'illuminismo, nel XVIII secolo. Ci dicono che nella storia è avvenuto un cambiamento profondo, una di quelle fratture che hanno ripercussioni generalizzate su tutta la struttura dell'esistenza. L'Illuminismo ha modificato l'insieme della vita politica e sociale; solo in un ambito non è entrato: in medicina. Nei rapporti sociali che si stringono attorno a chi somministra e a chi riceve le cure sanitarie, l’epoca moderna non è incominciata che pochissimo tempo fa. Soltanto da una ventina di anni sono diventati visibili i segni di una frattura che indica che la medicina è entrata nell'epoca moderna. Di conseguenza, cambiano tutti i parametri che costituiscono il modello di "buona medicina" proprio dell'epoca pre-moderna.
114
Seguendo lo schema, possiamo riscontrare come per tutti i protagonisti il comportamento richiesto sia diverso da quello del modello dell'etica medica. Il fine generale della medicina non è più soltanto quello di portare il maggior beneficio al paziente: perché un trattamento medico abbia un carattere di qualità, ci dobbiamo anche domandare se rispetta il malato nei suoi valori e nell'autonomia delle sue scelte. Nell'epoca moderna, infatti, il malato va fondamentalmente considerato come una persona autonoma, capace di autodeterminare le proprie scelte.
Il malato dell'epoca moderna è quello che ha la capacità e il coraggio di non farsi trattare come una persona eterodeterminata, ma assume il peso e la responsabilità delle decisioni che lo riguardano. Ciò mette in crisi il modello secondo cui nella medicina tradizionale il malato è per definizione uno che non può audeterminarsi. Riconosciamo l'influenza di concezioni antiche, come quelle espresse da Aristotele quando afferma che il malato, proprio per la sua condizione, non è capace di dare giudizi razionali, in quanto è turbato dalle passioni, come per esempio la paura per la propria vita; nello stato di malattia deve quindi subentrare la struttura paternalistica di contenimento: qualcun altro prende le decisioni per il bene del malato, dal momento che questi non lo può fare. Dire che la medicina entra nell'epoca moderna significa prima di tutto rimettere in discussione questo paradigma profondo, che presuppone una fondamentale diseguaglianza tra le persone autonome e quelle che non lo sono (le scelte di queste ultime essendo determinate dalle prime).
La comunicazione con il paziente non si traduce solo con la figura del paziente informato, in grado e ansioso di partecipare e decidere, ma genera tre diversi tipi di figure: quella più tradizionale del malato che rifiuta la realtà e che si pone nelle mani del medico; il paziente informato, che chiede di conoscere il proprio destino, vuole gestire le terapie e anche la propria morte; il paziente confuso, che soffre della peggiore qualità di vita.
Il non detto, le contraddizioni involontarie del medico e degli operatori sanitari sulla diagnosi, la mancanza di informazioni finiscono per rendere caotica la sua relazione con il mondo. Il paziente diventa sospettoso, chiede pareri a tutti, rischia di prendere decisioni non corrette, e non sempre è facile o possibile arrivare alla chiarezza. Come va impostato il rapporto? Chi decide quanta autonomia lasciare al paziente? E a quale paziente?
Nell'epoca moderna i valori del malato, intesi come un quadro di riferimento autonomo, che può essere diverso da quello del sanitario e che guida il malato nelle sue scelte, diventano un momento fondamentale del fare "buona" medicina. La potente ed efficace medicina che la scienza, abbinata alla tecnologia, ci mette oggi a disposizione si apre su scenari diversi. L'arsenale medico è potente e vario, e presenta alternative create dai valori soggettivi. A seconda del concetto soggettivo di buona vita, ovvero di ciò che vogliamo perseguire nella nostra vita, un intervento medico può essere appropriato o no. In parole semplici, non tutti considerano un bene auspicabile ciò che la medicina è in grado di offrire.
Perché si abbia buona medicina non ci si può limitare a rispondere alla domanda: "Questo intervento porta oggettivamente un beneficio al paziente?". Non basta stabilire ― per esempio ― che l'atto medico ha di fatto prolungato la vita del paziente. Se quanto il medico intraprende va contro i suoi valori e le sue decisioni, non possiamo parlare di buona medicina. L'autodeterminazione del paziente, in quanto articolazione fondamentale dei suoi diritti (per capire la differenza del paradigma, basti pensare che nel modello tradizionale si parla solo di doveri del medico e non di diritti del paziente) diventa un criterio di qualità. L'intervento sanitario non può più essere deciso unilateralmente dal medico che si basa sul sapere della sua professione, ma deve essere individuato insieme al paziente, spesso con un faticoso processo di contrattazione.
Superato il paternalismo benevolo, l'ideale medico in questo modello diventa un'autorità democraticamente condivisa; il buon paziente è un paziente partecipante alla decisione. Il cardine di questa strutturazione concettuale è il consenso informato. L’idea di qualità dell'atto medico si arricchisce di una nuova componente: è buono l'intervento sanitario che ha anche una correttezza
115
formale, vale a dire il rispetto delle procedure volte a far partecipare il paziente alle scelte diagnostiche e terapeutiche che lo riguardano.
È un diritto del paziente anche quello di non voler partecipare alle scelte terapeutiche? Chi delega le scelte nelle mani degli operatori sanitari non è un buon paziente? Se il criterio di una buona medicina e assistenza è quello della partecipazione, un intervento in cui non si riesce a realizzare è un cattivo intervento? Fino a che punto gli operatori sanitari devono "forzare" il paziente a partecipare?
In questa prospettiva il paziente non ha più solo diritti, ma anche doveri. La sua posizione non è esclusivamente di privilegio, ma anche di scomoda responsabilità, in quanto deve partecipare al processo decisionale. Non possiamo escludere che talvolta il paziente potrebbe preferire piuttosto di delegare la decisione, affidandola interamente al medico ("Faccia quello che è necessario: il dottore è lei, non io!").
Il paziente partecipante nelle scelte ha il compito di diventare un buon paziente, non basta che si limiti a non far storie, a non porre troppe domande, a essere docile e seguire le prescrizioni mediche; il buon paziente ha anche un compito etico: deve realizzare tutto quello che è necessario per essere un buon paziente. II buon rapporto è una partnership, che si instaura tra professionista e utente.
Il termine "utente" può suscitare delle associazioni che sembrano fuori luogo in sanità. Per ricondurlo entro l'ambito appropriato, basta pensare al senso etimologico della parola. L’utente è colui che "utilizza" la competenza del medico; in quanto utente, ha il dovere di usarla bene, responsabilmente, per fare insieme al professionista le scelte appropriate. Mentre l'etica medica era tutta centrata sul medico, la bioetica implica uno spostamento dell'accento: la qualità di ciò che si fa per il malato non è più determinata in maniera unica ed esclusiva dal sapere e dal potere del medico, ma viene stabilita in modo dialogico, insieme al paziente, il quale deve partecipare alle decisioni con i suoi valori, nell'ambito del consenso sociale. Quindi nella bioetica entrano la società, l'etica civile, l'accordo ottenuto trasversalmente alle diverse comunità morali di appartenenza, includendo anche gli "stranieri morali".
In questo quadro cambia anche ciò che ci attendiamo dal buon infermiere. Nell'orizzonte della bioetica diventa un professionista più qualificato. L'infermiere ha una funzione importante nella medicina del dialogo, in quanto facilitatore della comunicazione a beneficio di un paziente autonomo. Infatti l'autonomia della persona non è un punto di partenza, ma di arrivo; favorire l'autonomia del paziente diventa un obiettivo da raggiungere. Poiché quello che affermava Aristotele corrisponde a verità: quando siamo malati, soprattutto in modo grave, precipitiamo in una condizione di non autonomia, in quanto siamo sopraffatti dalle passioni. Facilitare la comunicazione è una funzione importante in questo modello di qualità, tanto da mobilitare tutta la professionalità dell'infermiere e degli altri operatori sanitari che hanno un rapporto diretto con il paziente.
Cercare di capire e di coinvolgere l'altro, prima di arrivare a delle scelte che possono avere delle implicazioni importanti per la vita del paziente, è il modo più corretto e democratico di impostare una relazione assistenziale. Se però il contesto generale non è orientato al dialogo (mancanza di cultura dell'informazione in reparto, clima con prese di decisioni autoritarie) il singolo infermiere si trova in una situazione obiettivamente difficile. A volte è il paziente a rifiutarlo o a non renderlo possibile (perché prevenuto, o non in grado di comprendere alcuni contenuti, per problemi di cultura, di lingua, di capacità intellettive). La consapevolezza dei diritti (da parte sia dei pazienti che degli operatori) è un processo culturale anche sociale. Si può chiedere agli infermieri di fare gli eroi, di essere gli unici a coinvolgere il paziente in un contesto che nega il coinvolgimento? Quali sono le responsabilità individuali in queste situazioni?
Questo modello di qualità nella nostra cultura si diffonde con estrema difficoltà. Lo contrasta una profonda resistenza, sia da parte del mondo medico, sia da parte dei cittadini. Si avverte che è necessario accrescere le conoscenze e mobilitare tutte le energie concettuali e morali, al
116
fine di entrare in questo modello. Tanto i professionisti della sanità quanto i pazienti sono obbligati a cambiare modelli di riferimento che hanno una lunghissima tradizione. È un passaggio epocale, che sposta l'accento della qualità da un modello a un altro, inaugurando un’altra epoca della qualità e dell'etica nella medicina.
Per evitare facili equivoci e smantellare almeno alcune riserve ― quelle che nascono dal timore che si intenda abbandonare l'etica medica tradizionale ― è necessario sottolineare che i due modelli non sono diacronici, ma sincronici. In altre parole, non si susseguono nel tempo, sostituendo con il modello moderno i valori tradizionali, ma sono chiamati a convivere. Le scelte in medicina si collocano su un piano a due dimensioni: la contrattazione tra l'indicazione clinica e le preferenze del paziente.
Piano della contrattazione beneficio-preferenze

Etica dell'organizzazione sociale dei servizi sanitari
Il terzo modello di etica in medicina fa riferimento ai valori sottostanti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi sanitari. In passato esistevano criteri etici diversi. Per esempio, era considerato giustificato che potessero accedere alle cure mediche i ricchi e benestanti sulla base di una prestazione professionale, e quindi a pagamento; per i poveri, invece, erano previsti dei servizi di tipo caritativo o di beneficenza. La nostra organizzazione sociale dei servizi sociali e sanitari è andata modellandosi sempre più sul criterio universalistico: tutti i cittadini hanno diritto alle cure sanitarie, indipendentemente dal loro reddito. In Italia questo modello è diventato legge nel 1978, con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche sopravvenute negli anni Novanta ― decreti di riordino e razionalizzazione del SSN ― non hanno mutato questo impianto generale; tuttavia, introducendo le modifiche che si sintetizzano nel concetto globale di "aziendalizzazione", hanno cambiato i parametri di riferimento con cui valutiamo la quantità etica dei servizi sanitari erogati.
L'aziendalizzazione ha reso meno visibili, ma non ha eliminato le categorie degli "esclusi" dalla sanità: i pazienti cronici sono diventati meno appetibili; la riduzione delle degenze e della loro lunghezza ha reso più a rischio alcune categorie di pazienti fragili. La quantità etica dei servizi erogati andrebbe valutata anche in base alla capacità di risposta ai bisogni. È etico un sistema die, pur erogando un servizio in base a un criterio universalistico, lascia inevase fasce di bisogno (per esempio i pazienti dementi, anziani, cronici...)?
Il malato non deve essere solo informato e responsabilizzato per partecipare in modo autonomo alle decisioni terapeutiche, ma deve anche essere considerato come un "cliente" al quale vengono rivolti dei servizi. Non ha solo dei bisogni di salute ai quali vuole una risposta efficace; né basta considerarlo un cittadino con dei diritti da rivendicare: come "cliente", vuole anche essere soddisfatto.
Soddisfare i pazienti diventa un'esigenza strategica per la sopravvivenza dell'azienda sanitaria territoriale. Il paziente, infatti, spostandosi da una struttura all'altra, porta dietro la propria capacità di spesa, rappresentata dalla propria quota capitaria. Quindi è importante una gestione oculata dell'azienda:
117
se perde i pazienti, perché questi preferiscono un'altra struttura, l'azienda esce dal mercato. Se i sanitari non trattano bene i pazienti per motivi ideali (carità cristiana o filantropia) oppure per la ragione che è loro diritto in quanto cittadini avere una buona assistenza, devono farlo almeno per interesse dell'azienda; e quindi per il proprio interesse, in quanto partecipi dell'azienda.
Che cosa cambia nell'essenza di una professione, quando il comportamento ("trattare bene il paziente") si ispira non a convinzioni morali o al riconoscimento di diritti, ma a un fine funzionale: ottenere cioè che il paziente rimanga soddisfatto e continui a rivolgersi all'azienda in cui si lavora?
Il modello di qualità post-moderno comporta delle variazioni anche in tutte le altre articolazioni fondamentali del sistema di rapporti entro cui si svolge l'azione sanitaria. Innanzi tutto l'interrogativo fondamentale che dovrà porsi chiunque abbia delle responsabilità nelle scelte ruoterà intorno a elementi della qualità di carattere gestionale: quale trattamento ottimizzerà l'uso delle risorse e produrrà un paziente-cliente soddisfatto? La fisionomia stessa dell'interrogativo etico viene modificata.
Nell'etica medica il registro per valutare la qualità è quello della bontà (l'azione è buona in quanto porta il beneficio della guarigione); la bioetica si colloca entro la tradizione etica coltivata nel mondo anglosassone, che valuta se l'azione sia giusta o ingiusta, in rapporto ai diritti e nel rispetto delle procedure; la nuova stagione che si è aperta ci obbliga a interrogarci se l'azione sia appropriata rispetto ai fini da conseguire, che comportano sia una più acuta sensibilità per il bene comune e l'equità sociale, sia l'attenzione agli interessi dell'azienda.
La qualità, ovvero il valore etico di un intervento sanitario, oggi è molto più complessa. I criteri più recenti non devono sostituire quelli precedenti, ma integrarsi con essi. La "buona" medicina deve sempre mirare a guarire in maniera rapida, efficace e duratura; per questo deve fornire le cose giuste. Ma ciò non basta: deve anche preoccuparsi di fornirle nel modo giusto, rispettando i diritti del malato e promuovendo la sua autonomia. A queste esigenze si aggiungono ora anche quelle relative a ciò che si dimostra appropriato nell'orizzonte della giustizia in considerazione dell'accesso ai servizi e dell'equa distribuzione delle risorse: la buona medicina deve fornire le cose giuste, nel modo giusto, a tutti coloro che ne hanno diritto e bisogno.
L'ideale medico dell'epoca post-moderna è una leadership morale. Il modello paternalista non funziona più là dove si assume lo stile dell'azienda post-moderna: è necessario dotarlo di autorevolezza. Non ci possiamo più basare su una divisione dei compiti di tipo burocratico. Soltanto chi ha quella che la cultura del management chiama vision, cioè la visione strategica degli obiettivi e dei mezzi, sviluppa una forza morale capace di trascinare gli altri membri dell'équipe.
Il buon paziente è il cliente soddisfatto e consolidato; ma bisogna subito aggiungere che il nostro obiettivo non è il cliente in qualsiasi modo soddisfatto e consolidato, bensì il cliente "giustamente" soddisfatto (in medicina non si potrà mai applicare Io slogan secondo cui "il cliente ha sempre ragione"!). Il buon rapporto è la stewardship, che implica un atteggiamento non centrato sul professionista, ma sugli standard di qualità del servizio.
Per quanto riguarda l'infermiere, in questo quadro lo possiamo considerare come il manager responsabile della qualità dei servizi offerti. È un compito nuovo, che affida all'infermiere non soltanto le funzioni puramente esecutive del primo modello e quelle umanistiche-interpersonali del secondo, ma anche un compito veramente promozionale della qualità. La qualità percepita dal paziente può essere monitorata molto meglio da un caposala che da un medico (il quale, oltretutto, è vincolato dal rapporto particolare che si crea con il paziente).
La buona medicina, quella dotata di qualità, è quella che nasce dall'integrazione delle esigenze che nascono dall'etica medica, da quelle della bioetica, e delle esigenze infine di quella nuova stagione dell'etica in medicina che sentiamo incombere, sotto la spinta delle nuove condizioni sociali e della pressione dell'economia, e che possiamo chiamare etica dell'organizzazione. Per la precisione, da tutt'e tre contemporaneamente. Le stagioni dell'etica in medicina, con le rispettive esigenze riguardo a ciò che è giusto e appropriato nell'assistenza sanitaria, non vanno viste come
118
modelli conclusi che si succedono nel tempo, ma come esigenze contemporanee e contestuali. Lo schema seguente, ideato graficamente da Patrizio Pasqualetti, pone le scelte in uno spazio tridimensionale, permettendoci di visualizzare la complessità della situazione attuale:
Spazio della contrattazione beneficio-preferenze-appropriatezza

Finché la qualità dell'intervento sanitario sul paziente si misurava esclusivamente con il metro del beneficio del paziente (epoca pre-moderna), maggiore era il beneficio ― nello schema viene indicato simbolicamente con una retta numerata da 0 a 15 ― che il malato riceveva da quello che si poteva fare per lui, maggiore era la qualità, anche etica, dell'atto medico. La modernità, con l'introduzione dell’autonomia del paziente, ha introdotto un altro parametro, indicato nello schema come asse delle preferenze. La buona scelta medica dovrà tener conto temporaneamente di due fattori: il beneficio da procurare al paziente e il suo consenso a ciò che il malato ha individuato e scelto come proprio bene. La scelta si realizza sul piano orizzontale di una contrattazione, che spesso produce un compromesso (non è detto, infatti, che ciò che costituisce dal punto di vista clinico il maggior beneficio per il paziente corrisponda alle sue preferenze, o inversamente: ciò che il paziente informato vuole per sé può non coincidere con quanto la medicina sarebbe in grado di fare per lui).
A queste due dimensioni oggi dobbiamo aggiungerne una terza, così che la decisone clinica ci appare collocata in uno spazio tridimensionale. Dobbiamo considerare, infatti, anche l'appropriatezza sociale degli interventi sanitari, in una prospettiva di uso ottimale di risorse limitate, solidarietà con i più fragili ed equità. Quello che possiamo fare per un malato, anche se valutabile con un punteggio alto sul parametro dell'appropriatezza clinica e su quello delle preferenze personali, potrebbe collocarsi molto in basso rispetto al criterio del buon uso delle risorse.
La buona medicina ci appare così come il frutto di una "contrattazione" molteplice, che deve tener conto di tre diversi parametri: l'indicazione clinica (il "bene" del paziente), le preferenze e i valori soggettivi del paziente (il "consenso informato") e infine l'appropriatezza sociale. L'assistenza sanitaria, dovendo conciliare nelle sue scelte esigenze diverse e talvolta contrastanti, senza minimamente rinunciare alle esigenze della scienza, ci appare più che mai un’arte.
119
capitolo
7
LA RICERCA DI UN METODO PER LA BIOETICA CLINICA
Quando si parla di bioetica si ha in mente, oltre a determinati contenuti, anche un modo abbastanza stereotipato di trattarli. In genere all'origine di una discussione di bioetica c'è "il caso": un fatto concreto, che i mass media prowedono a enfatizzare adeguatamente. Può essere una nascita che segna un nuovo traguardo nell'ambito della procreazione artificiale, un intervento spettacolare di terapia genica, un sofisticato trapianto di organi, un caso di eutanasia o di suicidio assistito, il dibattito su aborto o non aborto per le donne violentate, la clonazione di un organismo animale o umano... Quasi ogni giorno possiamo aspettarci che la stampa ci fornisca, a grandi titoli, "il caso".
A questo punto subentrano gli esperti. Opportunamente sollecitati, esprimono il loro parere. "Il caso" lo conoscono solo nella veste in cui è stato confezionato per l'informazione. Le esigenze mediologiche, inoltre, richiedono che il loro parere sia espresso in forma sintetica, efficace, con preferenza per gli schieramenti netti: sì o no, permesso o proibito, lecito o illecito. Gli adattamenti redazionali provvedono a fare gli opportuni raffronti tra le opinioni degli esperti, in modo da mettere in evidenza le contrapposizioni.
Gli americani hanno un’espressione molto evocativa per questo tipo di interventi. Lo chiamano to shoot from the hips. È il gesto del pistolero, che spara velocemente senza estrarre l'arma dalla fondina. I "casi" che arrivano all'attenzione del pubblico sembrano bersagli ideali per queste raffiche di giudizi etici, da parte di un gruppo ristretto di esperti che si definiscono "bioeticisti".
Non possiamo che rallegrarci per la popolarità che sta assumendo il dibattito sulle scelte connesse con i trattamenti sanitari e la ricerca biomedica. Vediamo crescere una sensibilità per i dilemmi posti dal trattamento responsabile della vita. E tuttavia il diffondersi del modello di bioetica qui evocato ― con tratti ironici, ma non caricaturali ― suscita parecchie perplessità. Possiamo riassumere le principali sotto tre termini: "rilevanza", "competenza" e "metodo".
Per "rilevanza" intendiamo la scelta di che cosa è ritenuto importante o degno di attenzione, e che cosa invece no. Ebbene, nella bioetica da mass media la riflessione etica viene messa in correlazione solo con i casi clamorosi ed estremi, quasi che quelli ordinari fossero irrilevanti. Semmai è vero il contrario: è soprattutto la pratica quotidiana delle cure sanitarie e dell'assistenza agli infermi che è carica di perplessità e obbliga a scelte in cui si giocano importanti valori morali. Non è solo il dilemma se staccare o no la spina del respiratore in un malato in coma irreversibile che presenta un problema etico, ma le mille piccole scelte connesse con il trattamento di una malattia grave o a prognosi infausta. Se e come dare l'informazione, il consenso del paziente
120
ai trattamenti che lo riguardano, la ripercussione delle scelte terapeutiche non solo sulle possibilità di guarigione ma anche sulla qualità della vita: sono solo alcuni degli aspetti che fanno della cura quotidiana della salute un fatto non solo tecnico ma relazionale. Di rilevante importanza per l'etica, quindi, anche quando non si presenta sotto l'aspetto di un caso clamoroso.
È importante non confondere un problema etico con un problema di malpratica. Dimettere un paziente senza le informazioni necessarie per gestire la sua malattia è malpratica; lavorare in un sistema che non consente di tenere ricoverato il paziente finché non acquisisce le tecniche essenziali per gestirsi diventa un problema etico. Il quotidiano dell'assistenza ci pone di fronte a scelte che non portano necessariamente a decisioni drammatiche, ma che dovrebbero far riflettere per le implicazioni che provocano sull'altro. Se si danno informazioni sugli stili di vita da tenere per evitare ricadute o peggioramenti di una malattia, lo si può fare scherzando o seriamente; si può spaventare il paziente e farlo sentire colpevole o a disagio per le sue abitudini. Ogni scelta si basa su principi e comporta conseguenze e implicazioni diverse (anche di ordine etico). È più facile identificare (e riflettere su) la situazione eccezionale che non sulle scelte quotidiane, sulle implicazioni organizzative, sul modo di lavorare, che mettono però egualmente in discussione | il concetto di rispetto, diritto e libertà dell'altro.
Parlando di "competenza", ci riferiamo invece ai soggetti autorizzati a svolgere tale riflessione etica. Ben vengano gli esperti di bioetica: purché, però, ciò non porti all'espropriazione dei veri titolari dell'etica. Vale a dire, di tutte le persone ragionevoli e responsabili. Una delle ragioni di non minor peso a favore del ricorso al termine bioetica, a preferenza del più tradizionale "etica medica", è proprio il fatto che esso sposta l'accento dalla pretesa competenza esclusiva di un gruppo di professionisti ― etica "medica", intesa come etica propria "dei medici", determinata dal loro sapere specifico ― al coinvolgimento di tutti nelle decisioni che riguardano la vita e la sua cura. Sarebbe una beffa se la bioetica, invece di promuovere il dialogo e la partecipazione attiva di tutti nelle scelte di natura terapeutica e nell'applicazione del sapere biomedico, favorisse l'emergere di nuovi mandarini del sapere etico.
Il terzo motivo di perplessità nei confronti della bioetica quale viene messa in atto nei dibattiti pubblici è riferibile al metodo. Si ha l'impressione che il confronto sui principi e gli schieramenti ideologici abbia la precedenza. I diversi "casi" clamorosi, dei quali amano occuparsi la stampa e la televisione, vengono usati in quanto portano materiale argomentativo per consolidare tesi precostituite.
Il disagio maggiore verso una bioetica di questo tipo lo esprimono quei sanitari che sono più sensibili e più impegnati sul fronte dell'etica clinica. Sentono una certa estraneità da quel procedere argomentativo che è proprio della bioetica ― interessato ai principi più che ai fatti clinici nella loro concretezza e singolarità, e teso a produrre una sorta di sapere normativo, che pretende di guidare in modo del tutto esterno e per così dire "automatico" l'azione di chi opera nel contesto sanitario ― rispetto al punto di partenza di ogni processo decisionale che è proprio della buona medicina: la diagnosi, la prognosi e la considerazione comparativa dei rischi e dei benefici. I clinici hanno sempre saputo che le decisioni che si prendono al letto del malato non sono illustrazioni astratte di teoremi morali, ma vere e proprie "creazioni" che nascono nell'orizzonte di incertezza che è proprio della medicina. Così è sempre avvenuto fin dal tempo della saggezza ippocratica e della filosofia aristotelica, che collocava le decisioni pratiche che devono essere prese in medicina nell'ambito dell'"arte" (téchne), piuttosto che in quelle del sapere scientifico (epistème).
Anche se tutti facessimo riferimento alle stesse regole e agli stessi valori, esistono libertà e spazi di interpretazione relativi alla singola situazione e all'incontro di due mondi diversi, che rendono diverso l'agire quotidiano del professionista anche in situazioni apparentemente simili. Nell'assistenza il "piano di assistenza standard" serve come guida per guidare i comportamenti che vanno modulati sul singolo paziente.
121
Qualunque sia il ruolo specifico che sono chiamati a svolgere ― come medici, come pazienti o come familiari ― coloro che devono prendere delle decisioni difficili in cui sono implicati fatti obiettivi e valori personali, benefici e danni, preferenze e scelte che fanno corpo con l'unicità irripetibile di una vita individuale, tendono a diffidare di filosofi e teologi. Questi propongono magari soluzioni ineccepibili, ma che spesso hanno il difetto di non adattarsi alle situazioni.
L'etica clinica, senza essere sinonimo di pressapochismo, è un esercizio particolare della razionalità umana: quella che deve essere esercitata nel contesto di un sapere incerto e deve tener conto contemporaneamente della norma e delle eccezioni, dei principi e delle circostanze, di ciò che è formalmente "corretto" e di ciò che in una situazione concreta risulta "bene" o "male minore". Questo ragionamento pratico ha il suo coronamento non nella deduzione astratta, ma in quel giudizio prudenziale che Aristotele chiama phrónesis e che i latini hanno tradotto con il termine prudentia.
Il professionista sanitario che si è esercitato nel giudizio "prudente" sa che non è stato mai possibile praticare una buona medicina che non fosse anche intrinsecamente etica, ovverosia penetrata di quella razionalità comune alle decisioni cliniche e alle scelte morali. Oggi cambia semmai il ruolo del paziente, al quale si richiede maggiore disponibilità a lasciarsi coinvolgere nei diversi scenari terapeutici e nelle scelte conseguenti, rinunciando ad affidarsi a quel paternalismo medico che ama nascondersi dietro il generico appello alla "scienza e coscienza". Ma la struttura dell'etica clinica resta la stessa e il giudizio prudenziale continua a essere la sua pietra angolare.
Se i sanitari sentono la bioetica come estranea al sapere che è loro proprio, i "bioeticisti" (come si comincia a chiamarli, con un brutto neologismo di stampo americano) farebbero bene a farne l'occasione per un ripensamento della loro disciplina. E magari a domandarsi come integrare nel dibattito pubblico sulle scelte a cui la medicina ci obbliga quel sapere morale allo stesso tempo universale e concreto, cieco come la giustizia ma anche parziale come l'amore, che caratterizza le buone scelte etiche che si fanno al capezzale del malato.
Se l'etica coincide con la condivisione responsabile e la ricerca permanente di un progetto comune, può questa esigenza essere racchiusa nello specialismo di una disciplina? Compito della bioetica è in un certo senso "democratizzare" la medicina e il sapere medico e farli uscire dal campo tecnico per far capire, con riflessioni, discussione, quanto possa essere collegato al quotidiano della vita, delle politiche sanitarie e del diritto. Per poterlo fare è sempre necessario ricorrere al "caso" eclatante, che fa nascere posizioni contrapposte ed è emotivamente coinvolgente? È accettabile (o inevitabile) che la bioetica, somministrata "in pillole" alla popolazione, si sia piegata alle tecniche di diffusione mediata? È preferibile un dibattito "in pillole", che rischia di polarizzare le posizioni o l'assenza di dibattito?
UNA GRIGLIA PER L'ANALISI DI SITUAZIONI CLINICHE
Non si conosce bene se non facendo. Vale non solo per le attività che richiedono una certa manualità, ma anche per una disciplina eminentemente intellettuale come la bioetica. In particolare la bioetica clinica. Non si tratta di ricavare da esperti delle soluzioni preconfezionate, ma di imparare a elaborare le proprie analisi e giungere a conclusioni argomentate. A ciò è finalizzata la griglia proposta qui di seguito. Può essere paragonata a quelle istruzioni che accompagnano ― poniamo ― un mobile acquistato smontato, che l'acquirente può assemblare da solo. In questo caso, però, non ci sarà una soluzione unica e standardizzata. La griglia assicura solamente che non vengano trascurate delle dimensioni essenziali nell'analisi del caso.
Una specificità di questo modello, rispetto a numerosi altri che sono stati proposti, è la preoccupazione di inserire organicamente la giustificazione etica del comportamento in un contesto più ampio, che include i vincoli legali e deontologici ― il comportamento obbligato ― e la ricerca
122
di una sanità che non soltanto sia buona, ma lo appaia anche ― il comportamento eccellente―.
La nuova sanità ha infatti introdotto una modifica negli obiettivi ai quali deve tendere l'erogazione dei servizi sanitari. L'etica medica tradizionale identificava come unica finalità cui deve tendere l'impegno professionale dei sanitari il bene del paziente: devono fare ciò che è appropriato per la sua guarigione, riabilitazione, palpazione. Il paradigma moderno ci dice che il paziente vuol partecipare alle decisioni che lo riguardano quale soggetto attivo e responsabile. Nel modello post-moderno, che identifichiamo in modo sommario con l'organizzazione di tipo aziendale, i sanitari sono invitati a trattare questo paziente come un cliente, includendo la sua soddisfazione tra gli obiettivi a cui tendere. La buona medicina dei nostri giorni non è più solo quella eticamente giustificabile, ma la medesima che si propone la qualità eccellente: sia la qualità valutabile dell'operatore, sia quella valutabile dal cittadino che usufruisce dei servizi.
Il concetto di responsabilità del professionista sanitario si è così dilatato e complessificato. Se intendiamo la responsabilità in senso letterale, ovvero come la capacità di fornire risposte a delle esigenze che costituiscono dei vincoli all'azione, possiamo distinguere tre diversi livelli di responsabilità. Il primo e più elementare è quello dell'osservanza delle norme ― legali, deontologiche o altro ― che regolano l’operato del sanitario. In primo luogo ci dobbiamo chiedere a che cosa siamo tenuti. L'osservanza delle norme ci dà una medicina "sicura". Schematicamente:
|
I. Il comportamento obbligato ● A che cosa siamo tenuti: ― per legge? ― per deontologia professionale? ― per regolamenti e normative aziendali? ● Verifica: Quali conseguenze medico-legali (penali/civilistiche) o deontologiche possono derivare dal comportamento in questione?
|
Senza svalutare l'importanza, specie in epoca di conflittualità giudiziaria crescente, di una pratica della medicina che offra sicurezza al professionista, dobbiamo però riconoscere che non siamo ancora nell'ambito di una medicina "buona", ovvero eticamente giustificabile. Lo schema seguente propone un percorso, guidato dai classici principi formulati dalla bioetica contemporanea, a cui sottoporre una decisione clinica concreta:
|
II. Il comportamento eticamente giustificabile A. La difesa del minimo morale 1. Evitare ciò che nuoce o danneggia il paziente (principio di non maleficità) ― Il paziente potrebbe ricevere un danno per la salute o per la sua integrità dal trattamento previsto? ― Si sta omettendo un intervento che potrebbe impedire un abbreviamento della vita del paziente o un danno permanente? 2. Opporsi a discriminazioni e ingiustizie (principio di giustizia) ― In una società giusta tutte le persone meritano uguale considerazione e rispetto. In questo caso il paziente è discriminato per motivi di ordine ideologico, sociale, razziale o economico? ― Esistono considerazioni di ordine sociale (aziendale) che inclinano a offrire al paziente un livello di assistenza medica inferiore a quanto clinicamente appropriato? (segue)
|
123
|
B. La promozione del massimo morale 3. L'orientamento al bene del paziente (principio di beneficità) ― Sulla base della diagnosi e della prognosi, quale trattamento medico ― scientificamente corretto ― si può proporre? ― Tale trattamento influenza positivamente la prognosi nel caso specifico? ― Come vengono valutati rispettivamente i benefici e i danni? ― Esistono alternative terapeutiche? Ognuna di queste alternative quali aspetti potrebbe comportare (abbreviazione della vita, sofferenze fisiche e morali, peggioramento dello stato di benessere)? 4. Il coinvolgimento del paziente nelle decisioni che lo riguardano (principio di autonomia) ― Chi prende la decisione diagnostico-terapeutica (il medico, la famiglia del malato, il malato stesso)? ― Se decide il malato, attraverso quale processo informativo è stato messo in grado di decidere (semplice presentazione delle alternative; modulo scritto da firmare; calde raccomandazioni di aderire al progetto terapeutico)? ― Che cosa si conosce del sistema di valori del paziente e del suo atteggiamento nei confronti dei trattamenti medici (intensivi, rianimativi, palliativi)? ― Il paziente è stato informato circa i trattamenti proposti, i rischi e benefici potenziali e le possibili alternative? ― È stata offerta al paziente la possibilità di avere un secondo parere (second opinion)? ― Se il paziente non può essere coinvolto nella valutazione e nella scelta, chi può fare le veci del paziente nel prendere le decisioni?
|
L'etica non totalizza la qualità: certe scelte possono essere eticamente ineccepibili ― e il sanitario sentirsi in armonia con la propria coscienza ― senza tuttavia rispondere al terzo livello della responsabilità, riferito al perseguimento della qualità che accompagna le interazioni percepite come eccellenti. Anche a questo proposito un insieme di interrogativi sistematici può guidare la ricerca:
|
III. Il comportamento eccellente ● Riferendoci al "quadrilatero della soddisfazione", possiamo ottenere che le persone coinvolte nel trattamento del caso (professionisti, pazienti, familiari, autorità sanitarie) raggiungano la posizione della "giusta soddisfazione" (o almeno della "giusta insoddisfazione")?
● Quale svolgimento dovrebbe avere il caso clinico per poter essere raccontato come una storia di "buona sanità"?
|
Medicina sicura, medicina buona, medicina eccellente: non sono tre medicine, ma una sola pratica, quale ci richiede la società complessa nella quale viviamo.
124
Confrontare le diversità e le incertezze in un campo come quello della bietica, dove ci si aspetterebbe certezze e direttive, non è mancanza di rispetto per ipotetiche norme e valori. Riconoscere ciò che esiste e succede e assumere la responsabilità collettiva non equivale ad abdicare a giudizi di valore, ma è l'unico modo per evitare atteggiamenti superficiali e routinari: l'etica diventa argomento di dialogo e di cultura. Sono queste le condizioni per farne l'occasione non di obbedienza a principi, ma della libertà della scelta nel rispetto dei principi. Ecco alcuni concreti casi clinici, che suscitano negli infermieri e negli altri sanitari coinvolti perplessità e opinioni etiche divergenti:
● Appena posizionata sul lettino operatorio, la paziente inizia a piangere, parla piano, non si capisce quello che dice, sembra straniera. L'anestesista si prepara a iniettare i farmaci per addormentarla e il ginecologo inizia a prepararsi per effettuare l'intervento. Un'infermiera dice: "Sembra che voglia dire qualcosa". Il medico risponde: "Ma no, sarà un po'agitata". L'infermiera insiste: "Eppure sembra che dica qualche cosa; vorrà rinunciare all'intervento?". Il medico: "Ma no, quelle che decidono di rinunciare all'IVG non salgono neanche sul lettino. Lei è salita e quindi è consapevole". E mentre lo diceva aveva già iniettato l'anestetico per addormentarla.
● L'infermiere si rende conto che il paziente non ha ben compreso le implicazioni di un intervento chirurgico sulla sua salute. Il paziente sarà sottoposto a un trapianto di fegato e parla di recupero della salute, ripresa di tutte le sue attività, della possibilità di condurre nuovamente una vita normale. Non menziona la terapia immunosoppressiva con tutti i suoi problemi, la necessità dei controlli, i possibili rischi. L'infermiere si associa al suo entusiasmo e non fa nulla per cercare di capire cosa ha compreso il paziente delle informazioni date.
● L'infermiera, che frequenta da tempo la parrocchia del suo quartiere, conosce la situazione economicamente svantaggiata della famiglia e sa che, nonostante le rassicurazioni della madre, il bambino a domicilio non potrà ricevere l'assistenza di cui ha bisogno (alimentazione, condizioni igieniche dell'abitazione ecc.). La descrizione fatta dalla madre della situazione socioeconomica è infatti diversa da quella reale. Le due soluzioni che si potrebbero prospettare sono un prolungamento della degenza (difficile, dati i vincoli ospedalieri) o far intervenire gli assistenti sociali per un periodo di affido, almeno finché il bambino non si è ripreso. Mettere o non mettere in comune l'informazione ottenuta in ambienti diversi da quello ospedaliero? Tutelare il diritto della madre a tenere a casa il figlio o far prevalere il rischio di eventuali complicanze per il bambino? Deve prevalere il rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni o la tutela del minore?
● Paziente con cancro del polmone non più operabile. La paziente non accetta l'idea che non ci sia più nulla da fare. Non "fare nulla" avrebbe su di lei un effetto psicologico devastante. Si discute l'ipotesi di cominciare una chemio a basse dosi, che si sa già non potrà avere alcun effetto sulla malattia. Tuttavia, la paziente insiste per avere una terapia. Si discute l'idea di somministrare un placebo; ma la paziente, che conosce e si aspetta gli effetti della chemioterapia, si sentirebbe presa in giro. Si inizia il trattamento che provoca nausea, malessere e inappetenza. La paziente dopo un mese, come era stato ipotizzato, muore.
125
Pistoia, Ospedale del Ceppo
Seppellire i morti
La rappresentazione delle sei opere di misericordia come illustrazione di una citazione biblica ha la sua origine nell'iconografia cristiana e si trova dapprima esclusivamente nell'ambito ecclesiastico, per esempio nel portale del Redentore del battistero di Parma o nei portali delle cattedrali gotiche, spesso in rapporto diretto con la rappresentazione del giudizio universale.
I primi ospedali medievali non sorsero solo per rispondere a bisogni sociali. Come fondazione di fraternità cristiane ― spesso a carattere laico ― devono la loro origine al bisogno di penitenza connesso al desiderio di un cristianesimo praticato con coerenza, così come era stato predicato da Francesco di Assisi. Non è da meravigliarsi, perciò, che all'inizio non si sia sviluppata una iconografia specifica dell'ospedale, bensì si sia attinto al repertorio dell'iconografia cristiana, assumendo i temi che sembravano più appropriati.
Nel Trecento il ciclo fu ampliato, aggiungendo una settima opera di misericordia: seppellire i morti. Il diritto di ogni battezzato a una sepoltura cristiana, sancito dal diritto canonico probabilmente come conseguenza delle grandi epidemie che in quel secolo affliggevano la popolazione, diventa così un tema iconografico rivolto a tutti, come appello alla misericordia.
Nel fregio di Santi Buglioni viene rappresentata non solo la sepoltura, ma anche ― nella metà di destra, qui riprodotta ― l'ufficio dei defunti. Il morto giace, a piedi nudi, su un giaciglio molto semplice, coperto solamente di un panno ornato di croci. È vestito con una lunga tunica bianca con cappuccio, le mani, lunghe e magre, sono giunte sul corpo, gli occhi sono chiusi, il capo posto su un cuscino ornato. Il volto, leggermente reclinato verso l'osservatore, esprime un pacifico sonno. La morte dolce potrebbe essere considerata come un accenno al buon trattamento ricevuto in ospedale, che il committente si impegna a garantire attraverso la sua esemplare gestione. Dietro il giaciglio stanno, in piedi, tre amministratori in cotta bianca: pittoricamente costituiscono uno sfondo luminoso per il cadavere. Mostrano gli strumenti liturgici per la benedizione della salma: un incensiere, una croce con uno stendardo a lutto e un aspersorio per l'acqua santa. Al capezzale il celebrante legge da un libro di preghiere e ai piedi del letto sta, come rappresentante della comunità in lutto, una vecchia donna, forse una religiosa, in lacrime, con il corpo piegato sulle mani giunte. Non dà l'impressione di una persona reale, ma rimanda piuttosto all'immagine di una delle Marie che piangono sul Cristo nella rappresentazione della passione. Come anche in altre parti del fregio, l'artista mescola nelle scene ritratti di contemporanei, rappresentazioni tipiche e figure bibliche. In questo modo si sottolinea l'universalità della scena, che come arte senza tempo trascende la realtà storica contingente.
Christina Riebesell
126
127
capitolo
8
L'ETICA COME EDUCAZIONE DELLO SGUARDO
In un approccio iniziale, possiamo descrivere la sfida che la formazione etica rappresenta per la sanità servendoci di un'analogia, che desumiamo dalla epistemologia genetica di Jean Piaget. Secondo il celebre studioso dello sviluppo cognitivo dell'essere umano, nella rappresentazione dello spazio propria del bambino si può individuare una soglia che costituisce il passaggio dal pensiero concreto (nella terminologia di Piaget: "realismo intellettuale") a quello del pensiero astratto. Soltanto dopo aver passato questa soglia ― che secondo le ricerche di Piaget va collocata intorno ai 7-8 anni ― il bambino giunge a riconoscere l'esistenza di molteplici punti di vista spaziali, e soprattutto a comprendere che i rapporti spaziali fenomenici fra gli oggetti possono mutare col mutare dei punti di vista. Prima di allora il bambino, pur osservando le cose da un punto di vista spaziale, ignora per lungo tempo l'esistenza contemporanea di altri punti di vista possibili; non è dunque in grado di rendersi conto che il suo stesso è "un punto di vista".
Lo studio sperimentale che ha portato a individuare queste tappe evolutive (Piaget, 1948) è stato condotto, tra gli altri espedienti, mediante un plastico che riproduceva delle montagne. Un pupazzetto era collocato, successivamente, accanto a ognuno dei quattro lati del plastico; al soggetto veniva chiesto di indicare in quale modo ogni volta il paesaggio era visto dal pupazzo-osservatore:
MANCA FOTO
128
Finché nei bambini predomina il pensiero concreto, risultano incapaci di differenziare la prospettiva relativa al punto in cui essi si trovano dalle altre prospettive possibili. I bambini non sonò consapevoli che le posizioni relative delle tre montagne mutano col mutare del punto di osservazione; in altre parole: il bambino che ancora si muove nell'ambito del pensiero concreto non riesce a immaginare che altri possano vedere la realtà diversamente da come la vede lui, dalla sua prospettiva.
La formazione etica che è necessario introdurre in sanità può essere ricondotta a un'educazione dello sguardo, acquistando la capacità di cogliere altre dimensioni della qualità delle prestazioni sanitarie che sfuggono ai professionisti della salute che non sanno immaginare altri punti di vista oltre il proprio. Anche per il sanitario si tratta di superare una fase di "realismo intellettuale" che porta ad assolutizzare il proprio punto di vista. La qualità valutata dall'operatore è stata finora l'unico parametro di riferimento. A questa bisognerà affiancare la qualità valutata dal paziente e la qualità organizzativa, che permette a un'azienda sanitaria di onorare il contratto di assistenza che ha con l'insieme della popolazione. La nuova sanità ci costringe a muoverci in uno spazio tridimensionale.
In questa prospettiva la priorità assoluta nella formazione va data all'arricchimento dell'immaginazione. Non è inopportuno ricordare che il "Piano sanitario nazionale 1994-1996" identifica come compito della nuova sanità la ridefinizione del progetto di civiltà sanitaria e sollecita l'immaginazione per dare contenuto a un miglioramento che si sviluppi sotto il segno della qualità, più che della quantità ("La pressione della scarsità delle risorse orienta a immaginare un servizio alla salute che accetti in senso positivo la sfida dell'autolimitazione").
La sfida all'immaginazione è costituita dal passaggio dalla dimensione che è familiare a ciascuno ― soprattutto se interiorizzata attraverso il processo della socializzazione in un determinato gruppo professionale, che induce ad assumere intuitivamente il punto di vista del medico, dell'infermiere, dell'amministratore ecc. ― a un'altra dimensione. O a diverse altre dimensioni. Anche per la sanità possiamo assumere il compito che con insuperabile humour ha fatto proprio Edwin Abbott nel racconto fantastico Flatlandia: passare da un mondo bidimensionale, abitato da esseri totalmente piatti: segmenti, triangoli, quadrati, poligoni vari e sublimi circoli ― la Flatlandia, o Paese del Piano ― alla Spacelandia, o Paese a tre dimensioni. Possiamo assumere la sua dedica (Abbott, 1996) come un richiamo per il mondo della sanità a continuare a esplorare le sue dimensioni e quindi a reinventare la qualità delle prestazioni: "Agli abitanti dello spazio in generale è dedicata quest'opera da un umile nativo di Flatandia nella speranza che, come egli fu iniziato ai misteri delle tre dimensioni avendone sino allora conosciute soltanto due, così anche i cittadini di quella Regione Celeste possano aspirare sempre più in alto ai segreti delle quattro cinque o addirittura sei dimensioni".
L'ETICA NELLA CLINICA: LA FIGURA E LO SFONDO
Quando l'etica è applicata alla clinica non è un sapere sussidiario di un altro sapere ― quello del filosofo ― ma è il sapere proprio del terapeuta, anche se è costruito con l'apporto delle conoscenze più diverse: medico-biologiche e umanistiche, delle "scienze della natura" e delle "scienze dell'uomo". Per riprendere la felice formulazione di Joseph Fletcher, abbiamo a che fare con una disciplina che si propone di "favorire il matrimonio tra il pragmatismo e l'umanesimo".
La formazione in etica clinica deve certo fornire la possibilità di familiarizzarsi con la modalità argomentativa tipica dell'etica e di acquisire progressivamente uno strumentario lessicale e concettuale appropriato. Tuttavia la finalità di questa formazione non può essere quella di trasformare medici e infermieri in "filosofi morali" in formato ridotto. Né l'etica clinica può venire ipotizzata
129
come un sapere sussidiario del diritto, della medicina legale o della filosofia morale. L'etica clinica non è ― in sé ― che un ampliamento del metodo clinico, già familiare ai medici per analogia ad altre professioni sanitarie, esteso fino a includere i valori etici e le scelte a essi connesse; ovvero, fino a includere nell'atto clinico anche il malato considerato come soggetto morale.
Il crescere del dibattito etico coincide con un'entrata della società nella medicina e con il riconoscimento che la medicina può sempre meno considerarsi come un universo separato dal mondo dei valori e dei criteri di valutazione che reggono il vivere civile di una società. La medicina riafferma così la propria identità di scienza umana, in un momento in cui tanti ne temono la trasformazione tecnologica e disumanizzante. La formazione all'arricchimento dell'immaginazione è un'occasione per ritrovarsi con una responsabilità piena, non più vincolata da gerarchie, ad analizzare un rapporto tra persone.
Un'immagine che può servire a illustrare questa concezione della bioetica clinica come coincidente con la pratica medica, pur essendo diversa, è quella alternanza figura/sfondo che ci è stata resa familiare in particolare dalla psicologia della Gestalt 3. Reagendo a una concezione della percezione visiva secondo cui nell'atto di vedere qualcosa il vedente raccoglie una serie di frammenti visivi e li raggruppa nell'oggetto visto, la psicologia della Gestalt ha teorizzato che il vedere è organizzato fin dall'inizio, ovvero che il processo percettivo del vedere è una Gestalt o configurazione. Il campo visivo di un individuo è strutturato in termini di "figura" e "sfondo".
La "figura" costituisce il punto focale di interesse, mentre lo "sfondo" ne è l’inquadratura o il contesto. Tra l’uno e l’altra esiste un’interazione dinamica, cosicché lo sfondo di un insieme percettivo può diventare figura, mentre la precedente figura diventa sfondo.
MANCA FOTO
A illustrazione di questo fenomeno nei testi scolastici vengono addotte le immagini ambigue. La più nota di queste può essere vista, alternativamente, come un calice bianco su sfondo scuro, oppure due profili scuri, uno di fronte all’altro, su uno sfondo chiaro. La psicologia della forma spiega perché non è possibile vedere le due figure insieme, cogliendo contemporaneamente le due immagini come figure. Tuttavia c'è un momento di passaggio in cui si riorganizza la visione secondo l'una o l’altra forma, attribuendo alla figura precedente la funzione di sfondo.
In un'altra di tali immagini ambigue si può vedere una giovane donna rivolta in tre quarti verso sinistra; ma una persona su cinque, in media, organizza i dati percettivi in modo da vedere il profilo di una vecchia strega. Si può tuttavia favorire il passaggio da una Gestalt all'altra, aiutando a cambiare il ruolo rispettivo della figura e dello sfondo. Allora si riesce a vedere la figura di cui, nella prima organizzazione dei dati percettivi, non si supponeva neppure l'esistenza.
130
Quando ciò avviene, si ha un’esperienza che gli psicologi della Gestalt e i fenomenologi tedeschi hanno denominato Aha Erlebnis (esperienza aha), per l'esclamazione che in genere l’accompagna. Il termine inglese per tale vissuto è insight.
MANCA FOTO
Si tratta di un'organizzazione improvvisa della percezione: senza che nulla sia stato aggiunto nel campo, si vede un'altra figura che prima era presente come sfondo. Il processo è spontaneo, e tuttavia è suscettibile di essere in qualche modo "insegnato", in quanto si può addestrare un percipiente a passare da una figura a un'altra. E dopo un certo numero di prove anche l'immagine più enigmatica è agevolmente interpretabile: segno che l'apprendimento è possibile anche in un processo che pur si presenta con il carattere della spontaneità.
È facile ora concettualizzare, riferendoci ai diversi elementi della psicologia della percezione secondo la Gestalt, il rapporto tra dimensione scientifica e dimensione etica della medicina clinica, considerandole come due possibili "figure", che si stagliano sullo sfondo costituito dall'altra dimensione. Lo stesso materiale che costituisce un caso clinico può essere messo a fuoco come problema professionale-scientifico (in quanto chiede al sanitario una risposta secondo le regole dell'arte del curare), o come problema professionale-etico (nel quale la risposta è modulata sui valori in gioco, che sono non di rado in conflitto).
Il vantaggio di questa concettualizzazione è che l'etica può essere considerata elemento costruttivo del campo fornito dalla situazione clinica, già presente in esso, anche se in funzione di sfondo rispetto al curare quale figura dell'atto medico. L'"insegnamento" dell'etica non è essenzialmente diverso da quell'opera di facilitazione con cui si addestra un inesperto a passare da una Gestalt all'altra, permettendogli di "riconoscere" ciò che già "sa".
Nel cuore della routine infermieristica l'etica si può configurare come un affollarsi di domande e come esigenza di esplorazione epidemiologica della loro frequenza, rilevanza e collocazione nell'uno o nell'altro contesto. La capacità di affrontare un tema dal punto di vista etico deve passare attraverso il riconoscimento concreto di trovarsi in situazioni quotidiane, all'incrocio tra ciò che si crede (o non si crede), ciò che si fa (o si vede fare, o non si vorrebbe fare). Il confronto col dolore può generare domande etiche che non riguardano tanto le procedure specifiche ma la stessa identità professionale dell'infermiere.
L’insight che accompagna questo genere di nuove figure non ha solo un carattere di urgenza morale in quanto si tratta di qualcosa che mi riguarda personalmente, ma esprime anche una vera e propria sorpresa e familiarità insieme. Senza dimenticare quelle connotazioni dell'emozione del "riconoscimento" (esperienza "aha") che possono legittimamente essere qualificate come estetiche. In ogni caso, l'adesione spontanea all'etica quale elemento costitutivo della propria attività professionale che questo approccio comporta, senza manipolazioni e moralismi colpevolizzanti, suggerisce che l’insegnamento dell'etica è possibile, e che esso non equivale a un indottrinamento.
131
COMITATO DI ETICA ED EDUCAZIONE AL DIALOGO
L'introduzione del soggetto in medicina non è sempre un processo irenico; può dar luogo a una rivolta dei soggetti (come documenta l'esperienza dei tribunali per i diritti del malato!). Si avverte nettamente la preoccupante divaricazione tra le competenze etiche e quelle diagnostico-terapeutiche di chi esercita una professione sanitaria. In passato la formazione che il sanitario riceveva lo metteva in grado di far fronte alle questioni etiche che sorgevano nella prassi; oggi, invece, la distanza tra le due competenze cresce vistosamente.
I problemi etici sono più numerosi e di più difficile soluzione; la formazione dei professionisti sanitari, sia quella di base che quella continua, continua a ignorare l'etica come condizione per un buon esercizio della medicina. I professionisti inclinano verso due atteggiamenti estremi: il tecnicismo, che porta a respingere la preoccupazione etica come un'interferenza indebita con una prassi che si legittima mediante il richiamo alla scienza; e il paternalismo, incapace di giustificare a se stesso le ragioni delle scelte, se non richiamandosi genericamente a decisioni prese "in scienza e coscienza". Siamo in piena crisi della "ragione medica" pratica.
Un comitato di etica che sorge in questo contesto culturale concreto dovrà fare i conti con lo scollamento avvenuto tra prassi sanitaria e riflessione sui valori. Dovrà proporsi prioritariamente uno scopo pedagogico e formativo, che può essere sintetizzato nel seguente programma: alfabetizzare la coscienza morale dei sanitari e introdurre il giudizio etico come una parte costitutiva del processo clinico; senza, tuttavia, proporsi di "far la morale" ai sanitari! Ogni progetto di moralizzazione suscita, come controreazione, un atteggiamento di rifiuto o di banalizzazione dell'istanza etica.
I comitati di etica potranno affermarsi solo con i sanitari, non contro di essi. Dovranno perciò guardarsi dall'avallare un modello autoritativo, ponendosi a un livello di superiorità da cui giudicare l'operato altrui che favorirebbe solo o la ribellione, o l'atteggiamento infantile dell'adattamento (incoraggiando a comportarsi da "bravi bambini", che non fanno mai niente senza aver domandato ai "grandi", che hanno l'autorità, se è permesso farlo!). I comitati di etica potranno sfuggire a queste insidie se si attesteranno su una linea di difesa "minimalista" del loro compito.
Non si tratta solo di dissipare il sospetto che i comitati di etica abbiano una funzione poliziesca, ma di indirizzare il loro uso, positivamente, verso un rinnovamento dell'etica. Il loro maggior contributo in questo senso è quello di spostare l'asse della pratica etica dall'adeguamento alle norme alla ricerca delle stesse. Ci troviamo così trasportati nella situazione delle origini, almeno per la filosofia occidentale, nella quale il dialogo costituisce il clima che fa nascere la ricerca etica.
Il dialogo socratico è un metodo per trattare un tema etico, su cui si hanno pareri diversi, in modo argomentativo. La proposizione che esprime una norma morale non è imposta facendo pesare l'argomento dell'autorità (si tratti dell'autorità della legge o di quella di una morale religiosa conosciuta per rivelazione); non ha neppure l'autorevolezza che riveste una norma deontologica, nella quale si esprime la consapevolezza maturata dall'esperienza professionale sui comportamenti professionalmente corretti. Una norma etica ha solo l'autorità interna che deriva dal peso degli argomenti con cui viene sostenuta. Il confronto e la ricerca mediante il dialogo sono iscritti, perciò, nel codice genetico del pensiero etico sviluppato dall'occidente.
La dialogicità, tratto caratteristico della riflessione etica all'inizio della nostra tradizione filosofica, è anche una condizione essenziale per l'esistenza e il funzionamento di un comitato di etica. Essa non si impone solo per ragioni esterne e opportunistiche, come può essere la considerazione del pluralismo ideologico, quale elemento irriducibile della nostra cultura; la necessità del dialogo non nasce neppure dalla costatazione che la pratica biomedica odierna presenta
132
problemi così complessi che nessuna persona da sola ha tutta la competenza necessaria per risolverli. La dialogicità è, ben di più, l'espressione originaria del pensiero etico.
Condizione essenziale per il dialogo è una considerazione positiva dell'essere umano (è stato compito storico di Carl Rogers e della sua pratica del counseling quello di riportare tale atteggiamento positivo al centro dell'interazione sociale). Una seconda condizione è la fiducia tra gli interlocutori. La fiducia naufraga là dove si ritiene pregiudizialmente che gli altri giochino in modo sleale, oppure quando si abbia la presunzione di avere la risposta giusta già pronta, cercando solo il modo per imporla. Senza la fiducia reciproca e la convinzione dell'eccedenza della verità rispetto a tutte le opinioni, nessun comitato di etica potrebbe funzionare, per quanto accurato e previdente sia il suo regolamento.
Le associazioni mentali connesse con l'idea di comitato in genere non sono molto positive. Si pensa al comitato come un'istituzione inefficiente (di qui il detto: "Se vuoi che una cosa sia fatta, falla; se non vuoi che si faccia, istituisci un comitato per farla"...); oppure a un luogo di compromessi ("Il cammello è un cavallo disegnato da un comitato": è un'altra squalifica dell'idea stessa di comitato). Nel migliore dei casi, il comitato evoca un organismo rappresentativo (comitato per i festeggiamenti, comitato esecutivo), che agisce in nome e per conto di altri.
Se invece ci lasciamo guidare dall'etimologia, la parola "comitato" ci conduce verso una serie di esperienze umane correlate all'essere con gli altri (in latino: comitari, comes, communitas ecc.). L'elemento unificante è l'esperienza del camminare insieme, del condividere, dell'essere comunità, della co-esistenza che si sviluppa in pro-esistenza. Se manca di questa fondamentale dimensione, un comitato di etica rischia di essere non-etico!
Un comitato così concepito non può reggersi su una base ideologica, ma ha bisogno di un punto di vista integrativo più alto. Nell'ambito della sanità, questo può essere costituito dal comune riferirsi a una medicina per l'uomo totale, che integri la conoscenza dell’uomo derivante dalle scienze biomediche con quella fornita dalle scienze umane. Di queste ultime, l'etica costituisce un'articolazione importante, ma non certo unica o esclusiva. L'etica e le altre discipline che costituiscono le medical humanities si richiamano reciprocamente, hanno bisogno l'una delle altre. Senza la considerazione di tutte le dimensioni dell'uomo malato, ricostruendo l'intero campo dell'umano, l'etica si appiattisce in pura normatività. Un comitato di etica che si riducesse a produrre norme da fruire passivamente assomiglierebbe a un fast-food, così diseducativo nei confronti dell'assunzione delle responsabilità etiche come i santuari del "mordi e scappa" lo sono rispetto all'alimentazione.
L'habitat dell'etica è l'orientamento ai bisogni integrali dell’uomo. Se questo non esiste, l'etica sarà fatalmente recepita come un corpo estraneo in ambito sanitario, che vuole imporsi, in modo più o meno morbido, a un mondo medico recalcitrante. Perché il giudizio etico diventi un prodotto umano, deve avere le sue radici in un processo creativo. La formazione morale è troppo spesso concepita come la trasmissione di giudizi morali elaborati dalle generazioni precedenti, ai quali le nuove generazioni sono invitate a uniformarsi. Ma la semplice osservanza delle regole morali, considerate come regole di procedimento per risolvere i problemi etici che la vita presenta, non basta a creare il comportamento moralmente buono. Non è sufficiente imparare ad associare la risposta "giusto" o "sbagliato" a determinati quesiti, saltando il momento creativo della "produzione di un giudizio etico".
I comitati di etica, costituendosi come laboratorio di formazione al giudizio etico, possono svolgere un'utile funzione educativa. Se la riflessione si esercita in essi in un clima di ricerca, di tolleranza e di reciproco ascolto, diventano uno strumento pedagogico di formazione della coscienza, e quindi un autentico fattore di umanizzazione. I comitati sono anche il luogo naturale di integrazione tra le professioni; medici e infermieri possono superare, in un comune
133
orientamento a un servizio alla persona che richiede competenze diverse, il contenzioso storico legato all'organizzazione gerarchica propria della sanità.
Il pluralismo sarà d'obbligo in una riflessione etica di questo genere: non possiamo illuderci che un comitato possa giungere a conclusioni unanimemente considerate valide e obbliganti. Non potrà perciò produrre regole che valgono per tutti. Ma sarà già un risultato considerevole sviluppare, tutti insieme, una sensibilità che permetta di riconoscere i problemi etici dell'ambito della cura della salute e delle scienze della vita, di trovare soluzioni per quelli che è possibile risolvere e di imparare a vivere con quelli che non hanno soluzione.
134
135
terza parte
PROBLEMI DI BIOETICA CLINICA
136
137
Roma, Ospedale di Santo Spirito in Sassia
L'infanticidio: la leggenda delle origini
L'ospedale di Santo Spirito in Sassia, fondato da papa Innocenzo III, divenuto ormai cadente, fu demolito e completamente ricostruito da Sisto IV a partire dal 1473-1474. Questo progetto è da considerarsi, insieme a Ponte Sisto, la commessa principale nell'ambito delle iniziative edilizie di pubblica utilità intraprese da Sisto IV per i preparativi dell'anno santo 1475. Già nel 1476, coperto il tetto, si potè dare inizio alla decorazione dell'interno della Corsia Sistina. Un ciclo di 46 affreschi monumentali correva lungo la parte superiore della costruzione, divisa in due da un tiburio. Si tratta del primo ciclo storico biografico del Rinascimento; allo stesso tempo può essere considerato il ciclo più dettagliato mai creato dell'autorappresentazione ufficiale del papa Della Rovere. Sisto IV incluse tuttavia nel programma anche il fondatore dell'ospedale originario: 7 delle 46 scene raccontano la leggenda della fondazione e la storia dell'ospedale sotto Innocenzo III.
Il ciclo inizia all'angolo di nord-ovest con la scena dell'infanticidio. L'iniziativa di fondare l'ospedale può essere ricondotta al costume delle madri romane di uccidere e poi gettare nel Tevere i figli indesiderati. Con l'ospedale il papa ha inteso porre rimedio all'atroce abitudine. A sinistra in una sala quattrocentesca con arcate si vede una donna sdraiata sul letto che ha appena partorito un bambino indesiderato. Il suo sguardo obliquamente rivolto verso l'alto e l'eloquente gesto del braccio sinistro esprimono la sua disperazione. Il neonato si trova in braccio a una serva.
L'artista segue la tipologia iconografica di uso comune per le rappresentazione della nascita di Gesù o Giovanni Battista. Contrariamente a quelle, tuttavia, questa nascita è contraddistinta dall'assenza di familiari e visitatori che prestino il loro aiuto, e si svolge quindi senza testimoni. Manca inoltre qualsiasi segno di gioia e amore, come per esempio il bagnetto preparato affettuosamente per il neonato. La metà di destra dell'affresco mostra la stessa serva già menzionata nella scena della nascita, che con passo deciso si reca all'aperto dietro la casa, sbattendo il neonato a testa in giù contro il pavimento. Dal capo gocciola del sangue. La madre, in piedi dietro la serva, partecipa alla scena. Prostrata dal dolore, solleva le braccia: la decisione dell'infanticidio era inevitabile, ma le è costata molto.
Le scene sono commentate da scritte. Nel caso delle 7 scene riferite a Innocenzo III il commento è corredato da un'appropriata citazione del profeta Isaia: come le madri crudeli massacrano i loro bambini innocenti, generati al di fuori della legge.
Christina Riebesell
138
139
capitolo
9
IL CONTROLLO DELLA PROCREAZIONE
L’ORIZZONTE CULTURALE DELLE NUOVE PRATICHE PROCREATIVE
Quello che sta avvenendo nell’ambito della procreazione non ha antecedenti nella storia dell'umanità. La tecnologia applicata alla medicina sconvolge il nostro modo abituale di pensare la maternità-paternità e la figliolanza. Intorno alla procreazione le società hanno posto delle regole morali e delle norme giuridiche, che costituiscono come una griglia che protegge dagli abusi e dalla licenza la delicata funzione di trasmettere la vita. Le cose non sono sempre andate nel migliore dei modi: adultèri, procreazioni illegittime, disconoscimento dei figli sono storie vecchie quanto la memoria dell'umanità; ma nell'insieme si era ragionevolmente soddisfatti della regolamentazione sociale della procreazione.
Le barriere che ai nostri giorni vengono infrante non sono più soltanto quelle del diritto e della morale, bensì quelle che sembravano più inamovibili, perché poste dalla biologia stessa. Per fare un figlio era pur sempre necessario un rapporto sessuale tra uomo e donna, per quanto clandestino e irregolare potesse essere. Oggi non è più così. Il legame tra sessualità, corpo e riproduzione si è sciolto. Inseminazione artificiale, fecondazione in vitro, dono del seme o dell'ovulo, trapianto degli embrioni, locazione dell'utero, inseminazione post mortem: le "vicende dell'amore e del caso", che erano il tradizionale bersaglio delle commedie sul matrimonio, impallidiscono di fronte a ciò che i metodi di procreazione artificiale hanno reso possibile.
E pazienza se si trattasse solo di farse o di rebus per i giuristi (di chi è figlio il bambino concepito in provetta con l’ovulo di una donna, impiantato nell'utero di un'altra donna portatrice e partorito da questa, per essere consegnato alla committente? L’embrione congelato può essere considerato persona a tutti gli effetti, per esempio ereditare se muoiono i genitori?). Talvolta purtroppo le commedie sfociano in drammi. Succede, infatti, che il bambino, concepito per inseminazione artificiale ricorrendo al seme di un donatore anonimo, col consenso del marito, venga successivamente disconosciuto come proprio figlio da quest'ultimo: il bambino può venire a trovarsi nella situazione di non avere né un genitore maschile, né uno femminile. È successo in alcuni casi che il bambino, "commissionato" a una donna locatrice del proprio utero, sia nato malformato, e per questo rifiutato tanto dai committenti, quanto da colei che lo aveva generato. In casi più benevoli il neonato è stato conteso dalla committente e dalla madre per procura, convertitasi alla maternità durante la gravidanza. Quanto basta, insomma, per convincere della necessità di intervenire con misure legislative in un campo così nuovo, soprattutto per tutelare i bambini procreati con i metodi artificiali.
Trovare leggi giuste e sagge è certamente un'urgenza del momento. Ancor più importante appare però l'inizio di una valutazione morale serena delle tecnologie applicate alla riproduzione.
140
Proprio qui incontriamo invece le maggiori difficoltà. Quello che tende a prevalere è un giudizio emotivo, agitato da più o meno espliciti fantasmi. Giustificate o no che siano le preoccupazioni degli umanisti che si interrogano sul futuro, questa angolatura rischia di travisare irrimediabilmente le procedure di procreazione artificiale. I discorsi che sono soliti fare coloro che temono un totalitarismo della tecnologia, a danno della procreazione naturale, risultano irritanti per coloro che sono coinvolti in queste pratiche perché cercano in esse fondamentalmente una risposta efficace all'infertilità.
Questa prospettiva getta un'altra luce sull'insieme delle procedure in questione. Bisogna tentare innanzi tutto di immaginare la portata di una sofferenza legata all'assenza di un bambino, quando è ardentemente desiderato. Per rimediare a questa tragica incapacità di generare, ci sono uomini e donne disposti a tutto. E questa non è solo una caratteristica dei nostri contemporanei. Viene spontaneo ricordare le mogli dei patriarchi biblici. Sara, sterile, ordina ad Abramo di darle un figlio unendosi alla propria schiava Agar: "Vedi, il Signore mi ha impedito di dare alla luce dei figli; va, ti prego, dalla mia serva; forse potrò avere prole da lei" (Gen. 16,1). Dopo due generazioni, la stessa strategia è ripetuta da Rachele. Il dramma intimo della sterilità è per lei ancora più drammatico: "Dammi dei figli ― dice a Giacobbe ― altrimenti ne morirò". E anche lei propone al marito: "Ecco la mia serva Bilha: unisciti a lei; essa partorirà sulle mie ginocchia e io pure avrò figli per mezzo di lei" (Gen. 30,1-3).
La sofferenza spirituale per l'impossibilità di avere un figlio è dunque la stessa, oggi come ieri. Con in più, per gli uomini e le donne del nostro tempo, il rifiuto della frustrazione dei propri desideri e l'abolizione della parola "rassegnazione" dal vocabolario. Per chi vuole un figlio a ogni costo, non c'è prezzo che lo trattenga. C'è chi paga un prezzo in lunghi ed estenuanti esami medici, peregrinazioni presso gli specialisti del mondo intero, interventi invasivi ripetuti. E c'è chi è disposto a pagare un prezzo in denaro.
L'aspetto economico di certe maternità per procura è in sé un elemento secondario, che però suscita grande sensazione e rischia di monopolizzare tutto il discorso. L'opinione pubblica accetta malvolentieri che ci siano uomini che offrono il loro seme per procedure di procreazione artificiale dietro compenso; e ancor più che delle donne si lascino fecondare per conto di una donna sterile e si facciano pagare per portare il bambino fino alla nascita. L'immagine della maternità diventata una merce provoca uno shock: la concezione sacrale della madre, che fa parte del nostro retaggio culturale, viene brutalmente modificata. In un mondo dove tutto si compra e si vende, si vorrebbe che almeno la generazione dei figli rimanesse immune dal denaro. L'assunto implicito è che tutto ciò che dipende da rapporti di denaro sia corrotto, mentre la relazione gratuita fa cadere le obiezioni.
La richiesta di tenere il denaro fuori dalla procreazione, in particolare per remunerare la madre sostituta, ha indubbiamente una parte di verità istintiva. È doveroso però ascoltare le controargomentazioni dei fautori della maternità per delega. I quali rifiutano l'etichetta svalutante di "uteri in affitto" affibbiato alle donne che accettano di portare un bambino per conto di una donna che non può farlo (per mancanza di utero, per esempio). In realtà, non si può parlare né di affitto, né di prestito. Si tratta di una donna che si separa per sempre da un bambino che ha portato, con cui ha scambiato delle informazioni biologiche e tessuto dei legami, che ha vissuto in lei e ha risposto alle sue sollecitazioni. È una donna che si autorizza ad avere una gravidanza, una gestazione e un parto, senza accettare di essere madre dopo il parto. Questo, e non tanto il denaro che eventualmente entra nella transazione, è il cuore del problema; e proprio questa parcellizzazione del processo procreativo suscita i maggiori interrogativi antropologici ed etici.
Finora la maternità era un tutto composto di alcuni elementi concatenati: produrre un ovulo, essere fecondata, portare il feto per nove mesi della gestazione e partorirlo, allevare il bambino. Ora è possibile scindere la sequenza che tradizionalmente costituiva il "fare un figlio". Donne
141
diverse possono intervenire in ciascuna delle fasi; l'aspetto biologico si distacca da quello volitivo-affettivo-spirituale. È questa la vera posta in gioco, che modifica il modo abituale di concepire la maternità. Su questo tema dovremmo essere chiamati a confrontarci e decidere se far entrare questa prassi nei nostri costumi, senza lasciarci troppo suggestionare dal ruolo, tutto sommato secondario, che può giocarvi il denaro.
Ma prima di dibattere sull'opportunità di far entrare il denaro nella procreazione, dovremmo avere chiare le conseguenze, a breve e a lunga scadenza, del primato dato alla generazione attraverso il cuore e lo spirito. Le maternità sostitutive dietro pagamento non fanno che rendere più esplicito un fenomeno che è già ampiamente presente nella nostra società: la disponibilità di alcune persone a passare sopra alla paternità-maternità biologiche, a favore di quella adottiva, educativa, affettiva. È un atteggiamento al quale viene attribuito un carattere di nobiltà, quando si esprime attraverso l’adozione, oppure di turpitudine, quando ricorre all'acquisto illegale di un bambino da rendere proprio figlio.
La compravendita dei neonati è un fenomeno sommerso, ma tutt'altro che raro. Diminuite o rese più difficili giuridicamente le possibilità di adozione, la volontà di avere un figlio a ogni costo non recede neppure di fronte a pratiche condannate dalla legge e dalla sensibilità morale comune. La società, chiamata a decidere se dare o no diritto legale di cittadinanza alle nuove tecnologie riproduttive, si trova confrontata in primo luogo non con l'avidità e il cinismo dei mercanti, ma con il desiderio esasperato di maternità-paternità, disposto a ignorare i legami che una volta si dicevano della carne e del sangue e che oggi si chiamano genetici, a favore dei legami del cuore.
Che la generazione spirituale sia possibile lo dimostrano gli innumerevoli casi di adozione felicemente riuscita. E non saranno certo i Paesi di tradizione culturale cristiana a dimenticarlo: il cristianesimo, infatti, ha proposto con la "Sacra Famiglia" la più clamorosa trasgressione alla concezione biologica della generazione! Le nuove pratiche ci inducono a riflettere più profondamente sull'adozione che è implicita in ogni processo generativo. Intanto perché un padre e una madre che mettono in comune un patrimonio cromosomico per avere un figlio non ottengono mai un bambino come copia identica di se stessi, ma il risultato di una roulette genetica. Questo bambino in parte simile e in parte diverso ― a cominciare dal sesso, che è anch'esso parte di questo gioco delle probabilità ―, dovranno poi in qualche modo "adottarlo", perché diventi figlio proprio. Ma affinché la generazione riesca e sia completa, l'"adozione" è necessaria anche dall'altra parte. Il figlio, che non ha scelto i propri genitori, dovrà "adottarli"; e perché questo avvenga, i genitori dovranno dimostrarsene degni.
Questa dimensione affettiva e spirituale fa parte integrante del processo della trasmissione della vita umana. La separazione del processo biologico da quello relazionale, resa possibile dalle nuove tecnologie, ci aiuta a ricordarlo. Ma, in quanto umanità, siamo così evoluti da poter impunemente sganciare la generazione spirituale da quella biologica? Siamo pronti a considerare nostri padri-madri-fratelli-sorelle coloro con cui condividiamo un progetto di vita, piuttosto che quelli con cui abbiamo in comune una manciata di cromosomi? La litigiosità meschina tra genitori che, stando alle cronache, si sviluppa intorno ai bambini nati con l'aiuto della tecnologia ci avverte che questo traguardo spirituale l'umanità non l'ha ancora conseguito.
CONTROLLO SOCIALE E REGOLAZIONE DEL DESIDERIO PROCREATIVO
Mentre la crescita morale domanda tempo, affinché tutti gli aspetti umani di un problema emergano, ci sono situazioni in cui non si può rimandare l'azione. L'opinione pubblica è troppo allarmata dal diffondersi delle nuove pratiche di procreazione medicalmente assistita perché le autorità pubbliche possano rinunciare a intervenire con i mezzi che sono loro propri. Da quando
142
le notizie di cronaca hanno cominciato a enfatizzare il vuoto normativo che rende possibile qualsiasi intervento ― è diventato uno dei luoghi comuni più ripetuti parlare del far west della procreatica ― è andata crescendo la richiesta di un controllo sociale nell'ambito della procreazione che fa ricorso alle nuove tecnologie.
Quando si cerca di dare concretezza a regole condivise, si scontrano due modelli sociali inconciliabili. Da una parte abbiamo chi rifiuta "a priori" l'idea stessa di un controllo sociale nell'ambito della riproduzione. È la voce, ovviamente, di coloro che hanno già trovato un business di notevoli dimensioni nell'offerta di tali servizi medico-sanitari a una popolazione numericamente ridotta ma estremamente determinata nel perseguimento dei propri obiettivi. Ma è anche la voce di coloro che ritengono illiberali gli interventi di controllo sociale, necessariamente contaminati da pregiudizi e viziati di moralismo, repressivi nei confronti di scelte individuali. L'opzione espressa da tale atteggiamento è a favore della scelta individuale e della non intrusione di istanze di controllo.
Le richieste di segno opposto spingono invece verso un restringimento delle possibilità di intervento riproduttivo tecnologicamente assistito, regolate attualmente dal "mercato" della domanda e dell'offerta. Confluiscono in questo gruppo di pressione esponenti di posizioni morali fondamentaliste, così come reazioni emotive ai casi più trasgressivi rispetto alla moralità comune resi noti dai media (la madre-sorella per dono di ovocita, locazioni di utero con eventuali strascichi giudiziari per riconoscimento della maternità, donazioni di embrioni ecc.). Punti di vista sia religiosi che laici convergono nella richiesta di uno sbarramento posto dalla società al dilagare di pratiche ritenute moralmente aberranti.
Un contributo positivo per uscire dall'impasse delle rigide posizioni a confronto è costituito dall'opportuna distinzione tra controllo sociale e regolazione del desiderio di paternità/maternità che induce a far ricorso alle tecnologie di riproduzione. Controllo e regolazione sono due diverse istanze che non vanno confuse, né utilizzate l'una al posto dell’altra. Sia il controllo sociale che la regolazione della riproduzione umana ― tanto di quella "naturale" come di quella medicalmente assistita ― sono necessari; il controllo e la regolazione hanno però una diversa logica e modalità di esercizio.
Una certa regolazione del desiderio di paternità/maternità è collegata fondamentalmente al bisogno di altri per procreare. Anche se si vuol assumere la famiglia legale come elemento culturalmente determinato e non insuperabile, rimane il fatto che il desiderio e la disponibilità di un'altra persona a procreare costituiscono un elemento di regolazione del desiderio individuale. Nei casi in cui bisogna far ricorso alla tecnologia, per una insufficienza riproduttiva, alla regolazione intersoggettiva dei procreanti si aggiunge un terzo elemento: la soggettività del medico che mette a disposizione il suo sapere e le sue capacità tecniche. In altre parole, la volontà del medico di contribuire a una determinata procreazione, assistendola con i supporti tecnologici, costituisce un elemento di regolazione del desiderio procreativo di una persona o di una coppia.
Nel dibattito pubblico si tende a sorvolare su questo elemento di regolazione. C'è una diffidenza generalizzata verso la capacità di medici e ricercatori di intervenire come elemento attivo di regolazione, mediante una deontologia corretta e trasparente. Per lo più ci si appella a un controllo sociale di queste pratiche mediante un'adeguata legislazione, saltando il momento deontologico. Schiacciata tra la legge e l'etica, la deontologia stenta a trovare un suo ruolo costruttivo. Eppure basta considerare quale apporto una seria riflessione deontologica, come quella condotta in Francia dal circuito delle équipe CECOS, ha fornito alla stessa ricerca di una legislazione equilibrata in quel Paese. Tra le regole deontologiche stabilite dal CECOS, menzioniamo la richiesta del dono gratuito dello sperma nel caso di inseminazioni eterologhe, la condizione che il dono avvenga da parte di una coppia con figli, con l'esplicito consenso della moglie del donatore: tutte condizioni rivolte a elevare le motivazioni sia dei donatori che dei riceventi.
143
Un altro esempio di regolazione del desiderio di paternità/maternità di natura deontologica è offerto dal Comitato nazionale per la bioetica (CNB) nel documento La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico (aprile 1998). Tra i suggerimenti finalizzati a prevenire alcuni dei problemi connessi con le tecniche di fecondazione artificiale, il CNB individua la prevenzione di un'induzione di gravidanza multipla. Casi clamorosi di gravidanze di questo genere hanno allertato anche l'opinione pubblica sulla necessità di assoggettare la procreatica a procedure severe. Su indicazione del CNB, "la stimolazione dell'ovaio deve essere affidata a personale altamente esperto"; deve avvenire in centri "dotati di tutti i mezzi diagnostici per individuare la iperstimolazione e provvedere al rischio di insorgenza di complicazioni iatrogene"; la riposizione in utero di embrioni deve essere "in numero compatibile con la potenziale sopravvivenza di tutti". Queste misure deontologiche sono in grado di prevenire la multigemellarità con i rischi connessi sia per la madre che per il nascituro (il quale va incontro in taluni casi a prematurità più o meno severa), e soprattutto la procedura di selezione degli embrioni ― la cosiddetta "riduzione embrionale" ― che suscita riserve etiche di grande peso.
L'intervento di un professionista sanitario nell'ambito del desiderio soggettivo di un individuo o di una coppia è certamente un processo delicato. Potrebbe dare adito a prevaricazioni venate di paternalismo. Eppure non si deve rinunciare a rivendicare per il medico una "competenza" che non riguarda esclusivamente il piano della patologia della funzione riproduttiva e dell'eventuale risposta tecnologica. Se e in quanto questi interventi restano atti medici, richiedono una valutazione globale che deve tener presente le conseguenze psicologiche e sociali per tutti i protagonisti di questo tipo di riproduzione. Eventualmente la competenza medica potrà essere coadiuvata da quella di altre professionalità, come psichiatri, psicologi, assistenti sociali; ma non si può rinunciare alla dimensione essenziale della professionalità del medico: l'essere cioè ordinata al bene del paziente (è il "principio di beneficità" come criterio di discernimento etico dell'azione medica).
Se la deontologia professionale perde questo delicato equilibrio e inclina dalla parte del controllo, perde la sua capacità di contribuire alla regolazione del desiderio di paternità/maternità. Il pericolo è ancora più grave per l'etica. Molti propendono per un'utilizzazione dell'etica come forma di controllo del desiderio, considerato minaccioso e sregolato in se stesso. Per salvare l'intrinseca vocazione dell'etica a operare con la modalità della regolazione, piuttosto che con quella del controllo, bisogna puntare decisamente sulla sua funzione di educazione del desiderio.
PER UNA PEDAGOGIA DEL GIUDIZIO ETICO
Il tempo delle incertezze, caratteristico di una società complessa come la nostra, può sviluppare delle singolari opportunità per la formazione del giudizio etico. L'ambito della riproduzione con l'ausilio delle tecniche biomediche si rivela singolarmente adatto a questo compito, proprio grazie alle sue novità, mentre su altri comportamenti grava il peso di una tradizione che si è confrontata con essi e ha eventualmente espresso un suo giudizio, di accettazione o di condanna.
È determinante anzitutto chiarire quale funzione viene implicitamente attribuita alle regole morali nell'ambito della tecnologia applicata alla riproduzione. Da esse ci si può aspettare che fungano da diga contro l'irrompere dell'arbitrario e l'agire irresponsabile; oppure che diano esse stesse impulsi positivi alla ricerca e alla sperimentazione, promuovendo l'opera di umanizzazione implicita nella scienza stessa. Il profilo dell'etica cambia sostanzialmente quando si attribuisce alle regole morali una finalità di contenimento, oppure di promozione dell'opera dello scienziato e del medico. Nel primo caso tenderà a prevalere un'impostazione casistica che vorrà entrare nei dettagli per porre freno con precisi dettati comportamentali ai veri o presunti straripamenti della scienza; nel secondo, l'accento cadrà di preferenza sui valori da promuovere, lasciando
144
all'uomo di scienza l'autonomia e la responsabilità per le sue scelte comportamentali.
Giudizi etici impliciti si nascondono, oltre che nelle concezioni antropologiche ― la qualità umana dell'uomo, il suo rapporto con la natura, la funzione delle norme etiche per l'individuo e per la comunità ― anche nei termini con cui le nuove pratiche vengono designate. Con le parole che si usano si possono trasmettere di fatto dei giudizi etici, sottraendosi al confronto di argomentazioni razionali. Tra tutti i termini con cui gli interventi biomedici nella riproduzione vengono designati, "manipolazione" è quello più carico di connotazioni etiche negative. Se si chiamano manipolazioni questi interventi biomedici nel campo della riproduzione, li si colora a priori con un sospetto di illeceità morale.
Al contrario, la designazione "terapie dell'infertilità" proietta su tali pratiche l'aura di accettabilità morale riservata a tutto ciò che è finalizzato alla guarigione. La formalità terapeutica permette di considerare in una luce diversa taluni aspetti pratici dei procedimenti biomedici. Così, per esempio, alcuni moralisti cattolici si sentono giustificati a sospendere le loro riserve sulla modalità abituale di raccolta dello sperma considerando l'atto masturbatorio all'interno di un progetto globale, che lo connota in senso terapeutico, piuttosto che edonistico 4.
Le pratiche finalizzate alla procreazione artificiale ― sottolineano con vigore i medici e i biologi che vi sono coinvolti ― non sono arbitrarie manipolazioni della natura, bensì interventi terapeutici sotto forma di "aiuto alla natura". Per quanto stravaganti possano apparire al senso comune, gli interventi biomedici vogliono essere essenzialmente una risposta all'infertilità. Quando si rivendica per queste procedure la qualifica di "terapia dell'infertilità", implicitamente si richiede una loro valutazione etica positiva, quella stessa valutazione che accompagna le azioni finalizzate alla salute e al benessere. In tal senso orienta anche la designazione di "procreazione assistita".
Ma il beneficio della "terapia" può essere esteso a tutto l'arsenale oggi disponibile di tecnologie riproduttive? Qui si apre un campo importante per il discernimento etico. L'estensione della categoria di "terapia" a situazioni in cui prevale un desiderio a connotazioni psicopatologiche, o motivazioni futili, o addirittura confinanti con il capriccio, è abusiva. Lo sforzo per delimitare ciò che è terapeutico da ciò che non lo è si rivela un momento costitutivo della formazione di un giudizio etico.
Il fatto di considerare la sterilità una "malattia", e il rimedio all'infertilità un'opera terapeutica, solleva alcuni problemi dal punto di vista antropologico. Se la medicina si proponesse di rispondere a tutti i desideri e le convenienze della popolazione, le conseguenze sarebbero di enorme portata, tanto sul piano della politica sanitaria, quanto su quella della deontologia medica. Una medicina sociale dovrebbe rendere accessibili a tutti le costose pratiche della procreazione artificiale. Nella concezione liberale della sanità, invece, il medico, trasformato in prestatore
145
di servizi, si troverebbe inevitabilmente preso nell'ingranaggio commerciale che regola la domanda e l'offerta, perdendo la facoltà di discernere tra le richieste, sulla base dell'orientamento dell'attività medica alla salute, come richiede una corretta deontologia professionale.
Una via intermedia è quella che, pur optando per una medicina sociale, distingue tra le varie prestazioni: alcune possono fondarsi sulla solidarietà allargata della società e quindi essere assicurate a chi ne ha bisogno, altre invece vengono ricondotte alla responsabilità individuale. Un documento di programmazione sanitaria elaborato da un'apposita commissione olandese ― Choices in health care ("Scelte in sanità"), 1992 ― ha analizzato il caso della fecondazione in vitro. In base ai criteri assunti per scegliere quei trattamenti che vanno a costituire il "pacchetto di base" delle prestazioni offerte a tutti i cittadini ― necessità, efficacia, efficienza ―, la commissione ha escluso la riproduzione assistita: "Né gli interessi della comunità, né le norme e i valori della società giustificano una simile solidarietà obbligatoria". Il documento olandese insegna che, senza far ricorso a pregiudizi e a ideologie, si possono ricondurre le risposte all'infertilità entro il contesto della sanità pubblica, senza rinunciare a un'opera di discernimento.
Una terza categoria generale, usata per riferirsi a questa vasta gamma di interventi biomedici, è quella di "tecnologie riproduttive". Anche questa designazione veicola implicitamente un giudizio etico, e precisamente quello soggiacente alla nozione stessa di tecnologia. Nell'ambito culturale dell'Occidente, profondamente compenetrato dell'umanesimo greco della techne e della spiritualità biblica che si ispira all'ordine di "Assoggettare la terra" (Gen. 1,28), le azioni riconducibili alla tecnologia godono, a priori, di una considerazione positiva. In seno al cristianesimo ecclesiale, da questo punto di vista, non sono mai stati coltivati atteggiamenti sospettosi verso la scienza medica, come invece troviamo in alcuni gruppi settari.
La nozione filosofico-teologica di "natura" quale criterio etico ("è buono ciò che è conforme alla natura e alla naturalità dell’atto") non ha escluso l'intervento correttivo sulla natura stessa. Oggi tuttavia la valenza etica positiva di ciò che è espressione di tecnologia si è incrinata. O piuttosto: siamo diventati più consapevoli dell'ambivalenza della tecnologia, che può anche rivolgersi contro l'uomo. L'homo faber, maggiorato in homo technologicus, sente più fortemente che la tentazione a "giocare a fare Dio" è carica di minacce per l'umanità. Il ricorso alla designazione di "tecnologie riproduttive" non consente di evitare un confronto con gli interrogativi etici, come se questi interventi fossero solo tecnologia applicata. Quando la tecnologia acquista un così grande potere, è la tecnologia in se stessa che diventa oggetto di riflessione etica.
L'analisi della terminologia è solo apparentemente un ambito di riflessione pre-etico. In realtà può costituire un laboratorio ideale per avvicinarsi all'etica considerandola non nei suoi aspetti prescrittivi e formali, ma sostanziali: il campo dei valori in cui la decisione operativa è chiamata a confrontarsi criticamente col modello antropologico che si persegue.
Soprattutto i problemi che sorgono nelle tecnologie applicate alla riproduzione si prestano a una verifica della concezione diffusa della morale. Quando si parla di morale, si tende a considerarla come un corpo estraneo che non si amalgama col desiderio umano, ma lo frustra sistematicamente col divieto. Non possiamo escludere in modo assoluto che il discorso etico non abbia rappresentato talvolta un aspetto di questo genere; anzi, specialmente in ambito biomedico, continua molto spesso a presentarlo.
Medici e ricercatori mostrano una comprensibile allergia verso l'etica concepita come un sapere dogmatico, precostituito, che viene elaborato in altra sede: la sede, appunto, dove le istituzioni totalitarie forgiano le loro credenze. Temono che la loro coscienza e il loro operato siano in qualche modo colonizzati da un'istanza esterna, unica accreditata a giudicare ciò che è bene e ciò che è male, morale e immorale, conforme o no alla natura umana. Ciò spiega, per esempio, perché chi opera nel campo delle tecnologie riproduttive preferisca spesso fare appello all'aspetto tecnico piuttosto che a quello umano, e tenda a navigare lontano dagli insidiosi dibattiti
146
sull’etica, appellandosi al pragmatismo. Medici e biologi temono che l'etica sia il cavallo di Troia che può introdurre nella cittadella della scienza la violenza dell’ideologia.
Quando si invoca l’etica nell'ambito delle tecnologie riproduttive, si alza in volo la paura che vengano dei "chierici" (ideologi e funzionari di partito, oppure teologi, progressisti o integristi che siano) a dire ai sanitari che cosa devono fare in questo o quel caso. Purtroppo l'etica e la morale sono sinonimi ― soprattutto in Europa, terra di inveterati conflitti ideologici ― di intolleranza. Evocano il tentativo di imporre agli altri la propria visione, di tracciare sentieri obbligati per la verità, di eliminare mediante la sopraffazione il pluralismo e le divergenze.
Nelle cliniche dove si combatte la sterilità e nei laboratori dove vengono messe a punto procedure di controllo della riproduzione l'etica ha la funzione di operare un discernimento critico del desiderio di procreare. La riflessione etica, condotta in questo modo, può diventare uno strumento pedagogico di formazione della coscienza, e quindi un fattore di umanizzazione, contribuendo alla regolazione del desiderio mediante lo sviluppo della capacità di formulare giudizi morali.
147
capitolo
10
GLI INIZI DELLA VITA
NASCERE MEGLIO
Oggi in Italia si nasce meno. Con una percentuale di 1,2 nati per coppia, il nostro Paese si è posto in testa al trend d'inversione dell'espansione demografica, con una caduta della natalità che comincia a costituire una fonte di preoccupazione per demografi e responsabili delle politiche sociali. Ma nella lista delle priorità non c'è solo l'impegno per un aumento numerico delle nascite: bisogna anche predisporre quanto è necessario perché si nasca meglio.
Nel concetto di qualità riferito alla nascita oggi è intrinseca la dimensione della libera determinazione della coppia. Fare un figlio è una scelta, non un evento biologico sottoposto unicamente al cieco gioco delle pulsioni. Neppure tra i credenti, che pur si pongono nei confronti della vita in una posizione spirituale di generosa partecipazione al compito di trasmetterne il dono, è più in vigore il modello arcaico di accettazione di "tutti i figli che Dio vorrà mandare". Per tutti oggi paternità e maternità si coniugano con un accresciuto senso di responsabilità nei confronti dei figli che si decide di far nascere.
Responsabilità e preoccupazione appaiono come tratti dominanti del reticolo intergenerazionale che caratterizza la famiglia dei nostri giorni. Una felice immagine, tratta dal Quarto rapporto CISF sulla famiglia in Italia, dedicato tematicamente all'analisi dell'intreccio tra le generazioni, ci permette di visualizzare la "relazione preoccupata" che costituisce oggi il collante morale di molte famiglie:
Se Virgilio dovesse riscrivere, ambientandola ai giorni nostri, la fuga di Enea da Troia, probabilmente cambierebbe l'immagine dell'eroe greco che ha sulle spalle l'eroe Anchise e tiene per mano il figlioletto. Intanto dovrebbe provvedere almeno una figura femminile (sposa, sorella o madre che sia), non solo perché ― statisticamente ― oggi è meno probabile una sua scomparsa, ma perché sarebbe "politicamente corretto" attenuare un esclusivismo così smaccatamente sbandierato del protagonismo e della discendenza maschili. Se, poi, andiamo a sovrapporre all'immagine mitica quella sociologica attuale, la missione di Enea risulterebbe alquanto compromessa: sulle sue spalle verrebbe a gravare più di un antenato vivente ― ovvero a "impilarsi" almeno il padre di Anchise, recuperato grazie all'allungamento della vita media ― mentre al suo fianco potrebbe arrancare una coppia di bambini, attenti ai comandi del padre come può esserlo chi "indossa" un walkman. Sin qui un generico scenario occidentale, che, se volessimo renderlo più italiano, dovrebbe provvedere soprattutto la possibilità che Enea si trasformi o in un Eroe Decadente, privo cioè di discendenti, ma magari attorniato da un simpatico cagnolino, o in un Eroe Affaticato che, sempre in contatto via telefonino con i parenti, ansima vedendo caracollargli addosso un adolescente di oltre trent'anni, ben vestito e motorizzato.
Padiglione, Pontalti, 1995.
148
La rarefazione delle nascite alle nostre latitudini non dipende solo dal maggior grado di libertà nelle scelte procreative (limitare il numero delle nascite e distanziarle nel tempo) e dal peso crescente che l'intreccio familiare costituisce per tutti i protagonisti. La rarefazione è dovuta in buona misura anche alla sterilità. Le dimensioni del fenomeno sono poco divulgate. Basti pensare che in Italia nel 1994 sono state più di 18.000 le coppie alle quali, dopo almeno due anni di tentativi infruttuosi di avere un figlio, è stata diagnosticata una causa di sterilità. Considerando un tasso di matrimoni pari allo 0,5% della popolazione nazionale, ogni anno ci si aspetta dalle 50.000 alle 70.000 coppie sterili. La metà di queste richiede una consulenza specialistica. Un numero imprecisato, ma certamente imponente, si avvia per la strada della procreazione medicalmente assistita. Sono dati che possiamo ricavare dal rapporto finale della Commissione di esperti sulla procreazione medico-assistita istituita dal ministero della Sanità il 14.1.1994, presieduta da Elio Guzzanti (Procreazione medico-assistita, 1994). Da allora il bisogno di ricorrere alla medicina per procreare non è diminuito, ma piuttosto aumentato.
La spettacolarizzazione attraverso i media di queste pratiche, che pongono sotto gli indiscreti riflettori della curiosità pubblica solo i nuovi traguardi tecnologici raggiunti e i casi-limite, rischia di far dimenticare il prezzo di queste nascite ottenute con l'ausilio della tecnologia medica. Non tanto il prezzo economico ― anche quello, beninteso: la "procreatica" ha dato origine a un mercato fiorente; molte coppie non esitano a investire nel figlio dei loro desideri le decine di milioni che può venire a costare un programma di fecondazione assistita quando ci si rivolge ai centri che operano nel privato ― quanto quello di sofferenze psicologiche e morali. La frustrazione della volontà di avere un figlio diventa sempre più difficile da accettare, mentre nascere con la tecnica è sempre più banalizzato anche dal punto di vista morale, nella nostra società. In una cultura che ha fatto crescere la convinzione che non esistano più limiti naturali sembra possibile ottenere tutto, purché ci si affidi al "mago della provetta" che promette di risolvere qualsiasi problema.
È impopolare dire che la percentuale di successo delle tecniche in questione è talmente bassa (e i risultati spesso presentati in modo tutt'altro che trasparente) che è molto più probabile un insuccesso che il "figlio in braccio". Uno dei compiti della bioetica in questo ambito dovrà pur essere quello di richiamare alla sobrietà, riportando il discorso sociale sulla procreazione dall'enfasi trionfalista nutrita dai miti dell'onnipotenza al livello di un salutare confronto con i fatti. Il sogno di un figlio da ordinare "alla carta", sempre e comunque disponibile, è più il prodotto di un'abile promozione delle nuove tecnologie che un riflesso della realtà. La nascita di un figlio è ancora il frutto di un mix a dosi variabili di programmazione e sorpresa, di progetto e dono. In questo contesto il counseling alle coppie che ricorrono alla procreazione medico-assistita diventa una tutela della salute, in senso globale, delle persone che percorrono questi cammini accidentati per procreare un figlio.
Sulla necessità di porre un freno alla deregulation attualmente vigente in Italia in materia di procreatica si sta evidenziando un consenso crescente, anche tra esponenti di visioni antropoogiche ed etiche molto divergenti. Non possiamo continuare a permettere che in questo ambito imperversino il capriccio e l'arbitrio. Soprattutto non si può più tollerare che i padri che hanno dato il loro consenso alla fecondazione artificiale con gameti di donatori siano autorizzati successivamente dalla legge a disconoscere il bambino, semplicemente perché nei rapporti interpersonali sono entrati in collisione con la moglie.
È vero che i casi di questo genere sono statisticamente pochi. Tuttavia sono avvenuti e hanno avuto ampia risonanza nelle cronache. A ragione, per il significato che rivestono: una civiltà si riconosce in gesti e fatti che hanno valore simbolico. E una decisione di grande rilievo simbolico è quella di attribuire alla persona del bambino una fisionomia giuridica e morale propria, tutelandola da evenienze infauste come quella di rimanere "orfano" per via di legge. Il bambino non è un'appendice del desiderio dei genitori: va perciò sganciato dalle eventuali fluttuazioni di
149
questo. Tra le varie misure di politica sanitaria per la tutela della salute materno-infantile necessarie, dobbiamo includere anche quella forma di prevenzione che impedisca al nascituro di vedere la luce in un "buco nero" della legge.
In passato la grande precarietà dell'esistenza del bambino alla nascita ― una percentuale impressionante di neonati non superava la dura selezione naturale dei primi mesi di vita ― non favoriva un legame affettivo precoce da parte dei genitori. Oggi lo scenario si è rovesciato. I bambini sono come una merce rara, su cui si riversa un torrente di attese, sogni, desideri di autorealizzazione e bisogno di fecondità della coppia genitoriale. Per permettere loro di nascere bisognerà difendere con la maggior determinazione possibile il carattere di persona di ogni essere umano, fin dalla nascita.
La congiuntura culturale attuale ci obbliga ad aggiungere qualche nuovo tratto al "nascere bene": per nascere "meglio", oltre che con la sicurezza che offre oggi una medicina infinitamente più efficace che in passato, il bambino deve essere accolto con la dignità che spetta alla persona umana. Questo ampliamento delle esigenze sul fronte dell'etica non è senza analogie con quell'arricchimento della cultura del parto di cui è stato protagonista Frédéric Leboyer.
In anni che vedevano una crescente medicalizzazione del parto ha raccontato l'avventura della nascita nel libro Per una nascita senza violenza (Leboyer, 1975). Per reagire a quell'ottica moderna e progressista che fa del parto una malattia da affidare alle cure dei medici, ha proposto la nascita sotto la metafora di un viaggio pericoloso al termine del quale il bambino approda nel nostro mondo. Siccome il suo discorso fu equivocato ― come se semplicemente stesse suggerendo un nuovo metodo per risparmiare alle donne le angosce del partorire ― alzò ancora il tiro con Natività. Si appoggiò agli artisti e ai poeti, per rendere conto di ciò che succede quando una donna partorisce. "Nella nascita ― ha spiegato ― c'è qualcos'altro oltre la fisiologia e la biochimica. Oltre la carne e il sangue. Su questo grande mistero l'artista, il pittore possono forse comunicare cose che l'uomo di laboratorio o il medico-tecnologo non conoscono" (Leboyer, 1982).
Nella nascita c'è più del parto, come nella natività c'è più della nascita. Perché la venuta al mondo di un bambino non è solo un problema tecnico da risolvere in modo corretto, ma un mistero dal quale farsi prendere. Ciò giustifica il grande interesse della bioetica attuale per tutta la fase biologica che precede e segue il parto. Il documento del Comitato nazionale per la bioetica: La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico (aprile 1998) offre la più completa rassegna dei problemi e degli orientamenti etici.
UN BUON LUOGO PER NASCERE
Per convenzione, cominciamo a contare i giorni della nostra vita a partire da quello della nascita. In Cina e in Giappone, prima dell'occidentalizzazione, si riteneva che il bambino alla nascita avesse già un anno. Quello che la scienza ha acquisito oggi alle nostre conoscenze sulla vita prenatale ci aiuta a recuperare questo modo di vedere proprio del pensiero tradizionale. Alla vita di un individuo vanno aggiunti i nove mesi della gestazione: un segmento di vita di cui abbiamo cominciato a scoprire il ruolo determinante su ciò che seguirà.
Quello che sappiamo oggi su tutte le fasi dello sviluppo dell'embrione e del feto era inimmaginabile nelle epoche in cui la vita prima della nascita era accessibile solo al linguaggio della poesia. Alla conoscenza fa riscontro il potere: è aumentata la capacità di intervento sulla vita umana prima della nascita, a suo danno o a suo vantaggio. Il nascituro può essere meglio protetto e tutelato; le patologie del feto possono essere individuate e perfino guarite ― grazie a interventi diagnostici e curativi, anche chirurgici ― prima della nascita. Ma dell'essere umano in gestazione possono essere meglio individuati i caratteri che lo rendono indesiderato, esponendolo così all'interruzione della sua esistenza.
150
A cominciare da un carattere che non ha niente a che vedere con la patologia: il sesso. È un fenomeno crescente il ricorso alla diagnosi prenatale per individuare il sesso del concepito e abortirlo se femmina. Le politiche che hanno imposto il figlio unico a popolazioni tradizionalmente molto feconde ― come la Cina e il subcontinente indiano ―, abbinate a un atteggiamento culturale di svalutazione e disprezzo della donna, sono alla base di una vera e propria ecatombe di feti femminili. L'economista e premio Nobel indiano Amartya Sen ha denunciato con toni drammatici che sono milioni le donne che mancano all'appello a causa di aborti selettivi prodotti dalla preferenza di un figlio maschio. In questo senso possiamo dire che il primo "buon luogo per nascere" è una società accogliente. E accogliente per tutti, maschi e femmine. I sanitari non hanno molti strumenti per influire sulla cultura, oltre quelli della deontologia. Il rifiuto di eseguire diagnosi prenatali finalizzate all'individuazione del sesso, quando dal contesto si può ipotizzare che ciò sia finalizzato a impedire nascite femminili, va in questa direzione.
Il modo in cui la nostra società realizza il dovere di "accoglienza" del nascituro è di offrire una tutela giuridica e sociale della maternità. "La bassa natalità in Europa e nei paesi industrializzati ha reso gli Stati consapevoli della necessità di una specifica protezione della maternità per le lavoratrici, della necessità di proteggere la salute della madre e del concepito, di assicurare una sicurezza adeguata sul luogo di lavoro, in quanto la partecipazione della donna (in età riproduttiva) all'attività economica del paese è un dato incontrovertibile" (CNB, La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico). Di qui le norme che, senza violare il principio dell'eguaglianza formale sancito dalla Costituzione, proteggono in modo particolare le donne nel periodo della maternità: impossibilità di licenziamento, modifiche all'orario di lavoro, divieto a essere esposte ad agenti fisici e biologici tossici, diritto alla retribuzione per il periodo di riposo, diritto di astenersi dal lavoro ― esteso anche al padre ― per il periodo previsto dalla legge. Tra i diritti della partoriente in tema di filiazione va anche annoverato il diritto al segreto del parto e a riconoscere o non riconoscere il figlio naturale.
Con un significato più ristretto possiamo riferire il "buon luogo per nascere" alla medicina. È ben vero che i nove mesi della vita prenatale acquisiti alla vita umana sono diventati un'altra provincia della medicalizzazione intensiva e sistematica. Questo fatto non ha risparmiato punte polemiche nei confronti della medicina ostetrica e ginecologica. Paradossalmente, bisogna dire: perché la sicurezza del parto è uno dei dati più incontrovertibili ottenuti dalla medicina moderna, con uno spettacolare abbassamento statistico della mortalità infantile e materna. "Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento", cantava Leopardi. Attualmente la seconda parte della sua affermazione non corrisponde più a verità (e anche la "fatica" del parto è molto alleviata alla donna). Eppure questi dati non tranquillizzano. Nei confronti della medicina ostetrica esiste un diffuso malessere, legato all'impressione che l'imperativo prioritario della sicurezza per la madre e il bambino abbia portato a uno sviluppo a senso unico: sono stati privilegiati i progressi tecnologici e penalizzati invece alcuni aspetti essenziali per una nascita umana.
Le punte più polemiche hanno brandito slogan femministi, come "riprendiamoci il parto". Con l'appoggio dell'ideologia di un parto ecologico ― ovvero "naturale" ― sono state proposte pratiche alternative a quella medico-ospedaliera, simbolizzate dall’idilliaco parto in casa. Queste posizioni hanno alimentato malintesi e diffidenze nel mondo medico; d'altra parte, va loro riconosciuto il merito di mettere in evidenza l'abisso che frequentemente si apre tra le preoccupazioni del medico (e dell'ostetrica) e i bisogni delle persone coinvolte nell'evento della nascita. Il fronte dell'umanizzazione della nascita porta prepotentemente alla ribalta quei bisogni, legati alla soggettività, che rischiano di essere pagati in pedaggio alla medicina tecnologica.
I bisogni psicologici e relazionali delle donne che mettono al mondo un figlio sono rispecchiati in modo diretto dalle testimonianze raccolte nel libro Le donne raccontano il parto (1999). Il parto è raccontato da una molteplicità di donne, differenti per età, estrazione sociale, acculturazione, professionalità e interessi. All'origine del libro c'è l'impegno legislativo del Consiglio
151
regionale delle Marche, che non intende solo "tutelare i diritti" della partoriente e del bambino ospedalizzato ― omologando al maschile, come spesso accade, la condizione della donna ―, ma riformulare il contratto sociale "femminilizzando la politica".
Per costruire una società diversa, bisogna dare il giusto spazio ai pensieri e alle emozioni che sorgono in quel momento privilegiato della vita che è la nascita. Per questo il primo passo è ascoltare il racconto del parto dalla viva voce delle donne. È meglio lasciare la parola alle donne, "al patrimonio di verità e di senso che hanno saputo trasmetterci su temi di solito trattati dai saperi forti, come la filosofia e la poesia" (Vegetti Finzi, 1999).
A un ascolto attento, risulta che la contrapposizione tra tecnica e umanità nel momento della nascita, così come in molte altre situazioni dell'ambito biomedico, è artificiosa. Non si tratta di scegliere in alternativa l'una o l'altra, ma di utilizzare le risorse tecnologiche della medicina più avanzate solo nella misura in cui sono necessarie, senza permettere loro che, spinte all'estremo e usate senza discernimento, portino a spersonalizzare l'esperienza della nascita.
In concreto, l'approfondita analisi fornita dal CNB ― La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico ― individua alcuni aspetti concreti del parto in cui le preferenze soggettive della partoriente potrebbero scontrarsi con il giudizio tecnico del curante. Uno di questi è costituito della scelta del domicilio quale "buon luogo per nascere", in alternativa all'ospedale.
Il CNB, pur consapevole dei vantaggi sul piano emotivo e psicologico che può offrire la nascita al proprio domicilio e all'interno della vita familiare, deve sottolineare che ciò può essere possibile in un limitatissimo numero di casi in cui la previsione della naturalità dell'evento possa considerarsi altamente probabile. [...]
Una responsabile e serena valutazione dei rischio perinatale e degli esiti neonatali ― com'è documentato ormai da casistiche anche di altri Paesi ― porta a ritenere che debba essere seguita piuttosto la linea alternativa della massima umanizzazione possibile dell’ambiente ospedaliero.
Un altro punto scottante riguarda il parto cesareo a richiesta. Non è in discussione il cesareo su indicazione terapeutica, ma quello che discende da un'opzione della donne cui siano estranee motivazioni mediche. Il CNB registra due posizioni: una valorizza il concetto di autonomia della donna e ritiene che il ginecologo debba assecondare la richiesta della paziente quando questa rifiuta per motivi personali (spesso la paura di soffrire) un evento naturale; l'altro considera il parto cesareo a richiesta e senza indicazione clinica come un intervento di comodo o di compiacenza, e tende perciò a rifiutarlo per motivi deontologici (il medico non è tenuto a interventi che contrastino con il suo convincimento clinico).
Il CNB propende per la seconda linea:
Il CNB ribadisce che non è accettabile l'attuale tendenza a favorire il taglio cesareo non strettamente motivato da obiettive indicazioni cliniche, rimanendo questo un intervento chirurgico che va valutato come tale (indicazioni, controindicazioni, rischi implicati). Va fatto pertanto un forte richiamo alla deontologia professionale anche in questo contesto, e alla paziente opera di convincimento della gestante, ove manchino assolutamente ragioni sufficienti per l'intervento.
Una gestione della relazione condotta con sensibilità potrà prevenire che si giunga a una contrapposizione tra interessi e opzioni guidate da principi diversi ― l'autonomia contrapposta al beneficio del paziente ― e quindi a una rottura dell'alleanza terapeutica. L'etica clinica presuppone che il paziente sia il miglior giudice dei propri interessi; ma allo stesso tempo presuppone che chi cura debba anche prendersi cura della persona a cui rivolge la sua prestazione professionale. In questo caso l'ascolto del vissuto emotivo delle gestanti ― le paure, le esitazioni, il venir meno della volontà di procedere per la via del parto vaginale, interpretando che cosa significa
152
la richiesta gridata di un cesareo durante il travaglio ― previene che si giunga a uno scontro di principi contrapposti, che equivale a una sconfitta sia per il medico che per la paziente.
LA RESPONSABILITÀ VERSO LA VITA NON NATA
La protezione della vita non nata è un problema costante, che si ripresenta invariabilmente nelle diverse società. L'esistenza di leggi volte a sanzionare l'aborto procurato dimostra che il problema è sentito come un interesse pubblico. La più antica è la legislazione babilonese, giuntaci attraverso il famoso codice di Hammurabi, del II secolo a.C.; vi leggiamo: "Se qualcuno avrà percosso la figlia di un nobile e l'avrà fatta abortire pagherà 10 sicli d'argento per il feto perduto. Se questa donna morirà, venga uccisa la figlia del colpevole". Nei tempi arcaici l'aborto è stato condannato come delitto contro la proprietà, piuttosto che come delitto contro la persona. Una posizione analoga si riscontra nella legislazione ebraica, contenuta in Esodo 21,22-23.
Oltre alla legge, la deontologia professionale dei medici è stata tradizionalmente investita del ruolo di opposizione sistematica all'aborto procurato: il medico in quanto medico si impegnava a mettere la sua opera a servizio del prolungamento della vita, non della sua interruzione, fosse pure la vita di un embrione. L'educazione morale e religiosa, infine, ha cercato di formare la coscienza in modo da riconoscere il male intrinseco dell'aborto e da rifiutarlo in modo assoluto. La legge, la deontologia e la coscienza costituiscono perciò la triplice barriera alzata contro l'aborto procurato. Consideriamole nell'ordine.
Dal punto di vista legislativo, le misure giuridiche di regolazione dell'aborto in epoca moderna si possono inquadrare secondo tre orientamenti: la repressione, la liberalizzazione e la restrizione ad alcune "indicazioni". Nessuna delle soluzioni approntate, tuttavia, si rivela soddisfacente. È ancora vivo nel ricordo il dibattito che si è acceso in Italia in occasione della modifica del precedente ordinamento legislativo, di carattere repressivo. Contro la repressione si è levata una protesta da più fronti: da parte delle donne, con la rivendicazione di un diritto a controllare la propria fecondità (secondo il brutale slogan femminista: "l'utero è mio e lo gestisco io"); da parte dei medici, per i danni alla salute che comporta l'aborto illegale e selvaggio; da parte di cittadini sensibili ai problemi dell'equità sociale. A questi, infatti, la repressione dell’aborto, oltre che inefficace, appariva ingiusta. Le donne di ambiente sociale privilegiato possono sfuggire facilmente alle sanzioni, recandosi ad abortire in Paesi a legislazione più liberale.
La repressione finisce necessariamente per sanzionare solo alcuni pochi casi, con una severità che fa pensare a una società che purifica simbolicamente in essi la propria ipocrisia. Altre argomentazioni a favore della liberalizzazione dell'aborto si presentano come una preoccupazione per il benessere di chi nasce, rivendicando per ogni bambino il diritto di essere desiderato e amato, un diritto ritenuto superiore al diritto che il feto ha di vivere. Al posto dell'immagine della madre "martire", per l'impossibilità di procurarsi l'aborto terapeutico, subentra quella del "bambino martire", come conseguenza dell'impossibilità di abortire.
La validità delle argomentazioni a favore dell'aborto è riconosciuta solo da alcuni, mentre il valore della vita umana fin dal concepimento e il dovere di tutelarla mobilita molte coscienze, dentro e fuori l'ambito delle convinzioni religiose. Se tuttavia l'orientamento di liberalizzazione ha finito per prevalere anche in Italia, ciò è dovuto al fatto che l'attuale diffusione dell'aborto tende a farlo accettare come un comportamento socialmente "normale", nel senso della normalità statistica. Più che un fenomeno strettamente socio-economico, che colpisca le parti più sfavorite della società, il ricorso all'aborto è un fenomeno culturale, legato alla maniera di considerare il bambino in funzione dei propri bisogni e progetti.
Nessun Paese ha tuttavia introdotto una legislazione incentrata sul principio del liberalismo
153
assoluto, che lasci indiscriminatamente la decisione sulla vita del bambino alla madre o al medico. L'orientamento prevalente è quello delle "indicazioni" di natura medica o sociale, che consentirebbero il ricorso all'aborto procurato in alcune circostanze. Questa è, almeno formalmente, la scelta della legislazione italiana innovata con la legge 194 del 1978: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
La disciplina è nettamente differenziata a seconda che l'interruzione sia praticata entro o dopo i novanta giorni dal concepimento. L'art. 4 della legge ammette l’interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni, quando la donna "accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o a circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito". La prassi prevista dalla legge comprende una certificazione del medico di fiducia o di una struttura socio-sanitaria, che registri la volontà della donna di interrompere la gravidanza. Passato il termine di sette giorni dalla certificazione ― idealmente previsto per un "ripensamento" o più matura valutazione ―, la donna può ottenere l'interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate.
Per la donna minorenne è richiesto l'assenso di colui che esercita su di lei la potestà o del giudice tutelare. Dopo i primi novanta giorni, la legge (art. 6) prevede che possa essere praticata l’interruzione volontaria della gravidanza quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Al di fuori di questi casi ― che l'intenzione del legislatore vorrebbe ritenere eccezionali ― l'aborto è considerato un crimine, con sanzioni penali che colpiscono la donna e tutti coloro che collaborano, con aggravanti per il personale sanitario. La scelta legale italiana non ha voluto essere, almeno teoricamente, né quella della liberalizzazione, né quella della penalizzazione. Si è voluto regolamentare ― alla luce del sole, in ambiente pubblico ― quei casi in cui la donna avrebbe comunque interrotto la gravidanza, per combattere la piaga dell'aborto clandestino e limitare i danni alla salute. Sull'esito concreto di queste disposizioni legali ci si sta interrogando attualmente, con espressioni critiche sui risultati ottenuti, anche da parte degli stessi fautori della legge.
Quando viene a cadere la barriera costituita dalla legge repressiva, acquista maggior valore la difesa contro la diffusione dell'aborto fornita dalle norme deontologiche della professione medica. La più antica risale allo stesso giuramento di Ippocrate, nel quale il medico si impegna a "non fornire a una donna un mezzo che causi l'aborto". Questa clausola fa spicco sullo sfondo culturale del mondo antico, nel quale, come sappiamo dalle fonti storiche, l'aborto veniva spesso procurato, con l'aiuto di medici o di praticoni. I medici che si ispiravano alla più rigida etica pitagorica si proponevano, invece, di rispettare la vita in tutte le sue forme, e quindi anche quella non nata.
Con l'andare del tempo, l'impegno del medico a non prestare la sua opera per l'interruzione della gravidanza divenne il segno caratteristico del medico che si ispirava all’ethos ippocratico, e in seguito del medico tout court. Suona perciò come una vistosa novità il fatto che i medici italiani nella versione del loro codice deontologico del 1978, che aggiornava quello precedente datato 1956, abbiano lasciato cadere il tradizionale rifiuto dei medici a partecipare a interventi abortivi. "L'interruzione volontaria della gravidanza è regolamentata con legge dallo Stato", recita l'art. 46 del codice deontologico. Dal momento che la normativa introdotta con la legge 194 prevede, alle condizioni che sopra abbiamo visto, la possibilità di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza, il corpo professionale medico rinuncia a porre obblighi deontologici ai suoi membri in quei casi.
154
La legge prevede (art. 9) che il personale sanitario e gli esercenti le attività ausiliare possano sollevare l'obiezione di coscienza, venendo così sollevati dall'obbligo di prendere parte alle procedure per l'interruzione della gravidanza. Ma anche il non sollevare obiezioni di coscienza, e partecipare quindi a interventi abortivi, è compatibile con i princìpi e le norme del codice di deontologia medica. Secondo quest'ultimo, infrazione deontologica ("gravissima"), in particolare se fatta a scopo di lucro, è solo la partecipazione ad aborti volontari all'infuori dei casi previsti dalla legge (art. 47). Quando ciò si verifichi, il medico può attendersi, oltre alle pene comminate dal giudice, anche le sanzioni disciplinari dell'Ordine dei medici, fino alla radiazione dall'albo professionale, con la conseguente impossibilità di esercitare legalmente la medicina.
A seconda delle proprie convinzioni in merito all'aborto, si può condividere o biasimare la trasformazione della norma del codice deontologico. È chiaro che solo in tal modo poteva essere resa operativa la legge. La deontologia ha come scopo quello di rendere possibile il buon funzionamento della professione medica, secondo le aspettative della società. La sua funzione è importante, ma limitata. La tutela della vita non nata si sposta così verso una frontiera più intima, quella della coscienza morale degli individui.
La formazione della coscienza morale dell'occidente a riconoscere nell'aborto un crimine contrario alla legge di Dio è stata assicurata soprattutto dal cristianesimo. Questi aveva già ereditato dal giudaismo una concezione della vita come dono di Dio e l'opposizione a ogni intervento antinatalista. Ma la sua posizione si formulò soprattutto nell'impatto col mondo greco-romano, nel quale l'aborto volontario era diffusissimo. Alla vita prenatale non era attribuita dignità umana; secondo il diritto, infatti, partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur ("il bambino non ancora nato non è uomo"). L'aborto veniva sanzionato solo in quanto poteva ledere il diritto del marito sulla moglie e sulla prole come proprietà.
Il cristianesimo, in frontale contrasto con tale concezione, condannò le pratiche abortive. La motivazione razionale della condanna fu fornita dalle categorie antropologiche greche, ben presto adottate dal cristianesimo dell'antichità. Il dualismo corpo-anima servì a rafforzare l'interdetto di distruggere una creatura in cui Dio era intervenuto con l'infusione dell’anima. Questa concezione, in verità, offrì sostegno a una diversa valutazione morale delle pratiche abortive, a seconda dello stadio di vitalità del feto. Fino al XIX secolo si continuò a parlare, in ambito teologico, di una distinzione tra "feto animato" e "feto inanimato". Ma il magistero ecclesiastico combatté le posizioni più lassiste e fece prevalere la concezione che sposta l'origine di un essere umano con identità personale all'inizio stesso della fecondazione.
La condanna morale dell'aborto negli ultimi tempi è stata spesso ripetuta dall'autorità magisteriale, con termini che non ammettono eccezioni o possibilità di ripensamenti. Il principio su cui si basa la norma morale che condanna e rifiuta l'aborto procurato è la dignità della vita del soggetto umano indifeso, mentre è ancora nell'utero materno. La "Dichiarazione sull'aborto procurato" della sacra Congregazione per la dottrina della fede, del 1974, afferma a tale proposito: "Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Essa ha altri beni, e alcuni sono più preziosi, ma quello è fondamentale, condizione di tutti gli altri. Perciò esso deve essere protetto più di ogni altro ".
Più di recente la dottrina tradizionale è stata ribadita Nuovo catechismo della Chiesa cattolica, del 1992:
La vita umana deve essere rispettata e protetta fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita.
Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto procurato. Questo insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale.
155
La morale cattolica, che si fonda sul diritto naturale, pretende che il rifiuto dell'aborto non riguardi solo il credente. La norma morale, in quanto fondata sulla ragione, può essere universalizzata a tutti gli uomini ragionevoli. Ma quando ha inizio la vita umana da proteggere a ogni costo, in quanto dotata dei diritti inalienabili della persona? Su questo punto non c'è unanimità nell'antropologia contemporanea. Ciò vuol dire che gli esseri ragionevoli, pur facendo un buon uso della ragione, arrivano a dare risposte diverse alla domanda relativa all'inizio della vita propria di una persona.
Attenendosi ai dati dell'embriologia, non si può individuare un momento che possa essere riconosciuto da tutti, incontrovertibilmente, come quello dell'"ominizzazione". L'embriologia ci presenta piuttosto la formazione di un essere umano come un processo continuo di sviluppo, nel quale sono riconoscibili dei momenti critici. Il primo salto di qualità è certamente l'origine del genotipo, al momento della fecondazione a opera dei due gameti. L'essere che si forma ha un codice genetico proprio e una vita distinta dai due organismi paterno e materno, che gli hanno dato origine; se posto nell'ambiente adeguato, si svilupperà secondo il suo dinamismo innato.
Per quanto fondamentale nella trasmissione della vita umana, la fecondazione non risolve gli interrogativi sull'ominizzazione. Il nuovo complesso genetico che si forma è certamente diverso dai due organismi procreanti, ma non ha ancora la caratteristica essenziale della persona, cioè l'"individualità", intesa anzitutto come "non divisibilità". La blastula, infatti, dividendosi, può dare origine, con lo stesso genotipo, a due individui. La formazione di gemelli può avvenire fino al 14° giorno dopo la fecondazione. Questo fatto suggerisce una certa cautela nell'affermare l'individualità personale anche delle blastule non interessate in un processo di gemellaggio.
Un altro momento critico nel processo dello sviluppo è quello dell'annidamento della blastula. Da questo momento il nuovo essere, ancorato alla madre ospitante, inizia la vita in simbiosi. L'annidamento rende concreto e visibile la dimensione della relazione, che è parte costitutiva essenziale della persona. Ora, l'osservazione biologica ci informa che una percentuale altissima delle uova fecondate vanno perdute prima dell'annidamento. Una simile prodigalità della natura inclina alcuni a pensare che, prima dell'annidamento, non si possa parlare in senso proprio di vita umana in senso personale; ci si può sentire perciò autorizzati a procedere con la stessa disinvoltura nei confronti di uova fecondate in vitro e non impiantate.
Un'ultima soglia, infine, è costituita dalla formazione della corteccia cerebrale. La sua struttura di base si forma tra il 15° e il 40° giorno dello sviluppo embrionale. La corteccia cerebrale svolge un ruolo determinante perché si possa parlare di uomo, tanto a livello della specie quanto a quello dell'individuo. Solo per analogia, infatti, un bambino che nascesse anencefalico potrebbe essere considerato un essere umano. Per questo motivo, alcuni tendono a spostare il momento decisivo dell'ominizzazione al momento della formazione della struttura encefalica.
Queste oscillazioni nel definire il momento a partire dal quale si possa parlare con certezza dell'esistenza di un uomo fanno sì che anche il fronte di coloro che pur condividono la convinzione che la vita umana debba essere protetta fin dall'inizio, sia frastagliato. Il pluralismo antropologico si riflette naturalmente sugli orientamenti etici. Mentre alcuni, infatti, considerano aborto procurato qualsiasi intervento nel processo evolutivo dell'embrione, a partire dall'incontro dei gameti, per altri in queste fasi precocissime non si può parlare ancora dell'esistenza di un "uomo".
La posizione più fondamentalista equipara all'aborto gli interventi rivolti a impedire l'impianto dell'uovo fecondato (spirale intrauterina e azione della cosiddetta "pillola del giorno dopo", che per altri non è considerata un aborto ma un'estensione della contraccezione), e anche la distruzione di uova fecondate in modo extracorporeo e non impiantate. Altri invece, pur contrari all'aborto,
156
sono più permissivi finché non si sia configurata in maniera chiara la presenza nell'utero di un essere umano. Quando si abbandonano le distinzioni chiare, ma spesso arbitrarie, della legge, e si accetta che la vita prima della nascita sia tutelata dalla coscienza individuale, bisogna assumere anche le incertezze antropologiche e i conseguenti orientamenti diversi delle coscienze.
DIAGNOSI PRENATALE E ABORTO TERAPEUTICO
Un capitolo di crescenti conflitti si è aperto con la possibilità di ottenere una diagnosi prenatale, e quindi di individuare le caratteristiche del feto: genotipo, sesso, eventuali malformazioni. L'informazione offerta dalla diagnosi prenatale ― ecografia, fetoscopia, amniocentesi ― ha un effetto dirompente nelle decisioni etiche della coppia dei genitori e del medico. È un bene o un male, dal punto di vista etico, l'aumento delle conoscenze oggi disponibili sullo stato del feto?
Se consideriamo le conseguenze, notiamo subito che tale conoscenza si apre su esiti diversi. Può portare a un aumento di aborti procurati, quando il feto è difettoso; ma una diagnosi prenatale negativa può anche tranquillizzare coppie esposte a rischio genetico, indurle a scartare l'ipotesi di un'interruzione della gravidanza a scopo cautelativo e far loro vivere il periodo dell'attesa senza angoscia, con evidente beneficio per i genitori e per il bambino. La diagnosi prenatale può servire anche, di conseguenza, a salvare molti embrioni che altrimenti sarebbero sacrificati da coppie che non sopporterebbero l'ipotesi di avere un figlio malformato.
La possibilità di scoprire i difetti realmente presenti ridurrà il numero di aborti di feti normali sospettati a torto di essere difettosi (come avviene quando la gestante ha contratto la rosolia nel periodo a rischio della gravidanza). La diagnosi precoce, inoltre, può essere anche finalizzata alla terapia precoce. Conoscendo il problema clinico del bambino, si può intervenire tempestivamente e con cognizione di causa alla nascita, con farmaci o chirurgicamente.
Ma realisticamente bisogna riconoscere che la tendenza prevalente è piuttosto quella di individuare le malformazioni per procedere all'interruzione della gravidanza. E questo non solo quando siamo in presenza di malformazioni gravi, addirittura di mostruosità, ma anche quando l'anormalità prevista sarà lieve. Lo scomodo sapere sulle condizioni di salute del feto getta chi deve prendere delle decisioni in braccio a dilemmi torturanti. La possibilità di conoscere in anticipo le anomalie si accompagna, infatti, a un mutato atteggiamento sociale nei confronti dell'aborto in questi casi.
Più precisamente, bisognerebbe parlare di una tacita pressione sociale esercitata sui genitori perché procedano all’interruzione della gravidanza. La simpatia e le espressioni di solidarietà che hanno circondato finora i genitori che dovevano sopportare la "prova" di un figlio handicappato si trasformano in indifferenza o disapprovazione dal momento in cui, pur sapendolo, hanno ugualmente consentito alla nascita di quel figlio. Da genitori martiri della fatalità o chiamati alla vocazione della "croce", rischiano di trasformarsi in incoscienti che mettono al mondo dei candidati all'infelicità e gravano la società di pesi insostenibili. La valutazione sociale tende in questo modo ad attribuire loro il "dovere" morale di ricorrere all'aborto. La divaricazione delle scelte morali si fa in questo campo drammatica. Mantenere il proprio orientamento alla tutela della vita del nascituro, qualunque sia la sua qualità, in un clima sociale di questo genere, può richiedere alla coppia un atteggiamento che si avvicina all'eroismo.
Dal punto di vista legislativo, la legge italiana prevede che l'interruzione volontaria della gravidanza possa essere praticata anche dopo i primi novanta giorni: "a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna". Il dettato della legge riesce
157
con fatica a coprire che ciò che viene presentato come tutela della salute della madre è, in realtà, il riconoscimento del "diritto" ad avere un figlio sano. Nel conflitto irresolvibile tra questo diritto e il diritto del concepito alla vita, l'aborto, con la sua sequela di infelicità e di contraddizioni, è sempre più spesso la scelta che prevale.
CURARE O NON CURARE I NEONATI MALFORMATI?
Nell'aprile 1982 un caso scosse l'opinione pubblica americana. Una bambina (identificata al pubblico come Baby Doe) era nata con sindrome di Down ― mongolismo ― e con una fistola tra la trachea e l'esofago. I genitori furono informati che il difetto poteva essere corretto chirurgicamente con "normale possibilità di successo"; se invece non si fosse intervenuti sulla fistola, questa avrebbe condotto ben presto la bambina alla morte per inanizione o per polmonite. I genitori, che avevano già due bambini sani, decisero di non fornire alla bambina né cibo, né il trattamento chirurgico, "lasciando che la natura facesse il suo corso". La bambina morì sei giorni dopo la nascita, mentre i medici cercavano di ottenere un'autorizzazione a procedere chirurgicamente dal tribunale. I genitori furono incriminati. Un mese più tardi il Dipartimento per la Salute e i Servizi Umani americano inviò una circolare a tutti gli ospedali che ricevono fondi federali per ricordare che
è illegale [...] non somministrare a un bambino handicappato le sostanze nutritive e il trattamento medico e chirurgico necessario per correggere delle condizioni che minacciano la vita, se:
1. l'astensione è basata sul fatto che il bambino è handicappato;
2. l'handicap non rende il trattamento e la nutrizione controindicate dal punto di vista medico.
Il documento concludeva riaffermando il forte impegno del popolo americano e delle sue leggi nel proteggere la vita umana.
Il caso di Baby Doe ci confronta con uno dei problemi più angoscianti che si presentano oggi per i sanitari e per i genitori: il trattamento dei bambini che nascono con gravi malformazioni. Il problema confina con le questioni di fondo relative all'aborto e all'eutanasia; ciò che permette di circoscriverlo è il fatto che il nodo dei conflitti si concentra attorno al bambino già nato, la cui vita dipende esclusivamente dall’intervento medico. La protezione e il sostegno della vita sono sempre e assolutamente giustificati? C'è un punto in cui possono rivolgersi contro il migliore interesse di colui a cui sono rivolti, diventando disumani? Il diritto alla vita è anche obbligo alla vita, in qualsiasi condizione? Tra i principi etici e gli interessi in conflitto, è possibile trovare un orientamento di soluzione?
È necessario in primo luogo cogliere la novità di questa problematica. Fino a un passato molto recente, la situazione dei bambini che nascevano con gravi malformazioni si risolveva molto rapidamente con la morte. In futuro, siamo autorizzati a credere, i progressi della medicina potranno offrire trattamenti efficaci e risolutivi, addirittura prima che il bambino nasca, con terapie intrauterine. Ma nella fase intermedia, in cui ci troviamo, la presente situazione sanitaria pone dilemmi angosciosi ai genitori, ai medici, alla società civile.
Molti neonati malformati possono, grazie a un'attenzione chirurgica o medica di routine, rimanere in vita. Sopravviveranno magari per lunghi periodi, ma gravemente handicappati nel loro potenziale di soddisfazione umana e di comunicazione. Pensiamo ai casi di malformazioni aperte della colonna vertebrale ("spina bifida"), in seguito alle quali i bambini non saranno mai in grado di camminare o di controllare la vescica e l'intestino. Oppure ai neonati che, per lesioni cerebrali da mancata ossigenazione o da emorragia, saranno completamente spastici, incapaci persino di muoversi nel letto. Oppure agli affetti da grave idrocefalia, con conseguenza di ritardi mentali profondi e cecità. In certi casi è possibile essere assolutamente certi dell'esito
158
infausto; in altri, invece, la prognosi è incerta. Inoltre coloro che soffrono di menomazioni usufruiranno dei benefici della medicina che prolungheranno loro la vita. È appurato, per esempio, che tra i bambini Down affetti da un difetto cardiaco, i quali resistono già con gli antibiotici ad affezioni un tempo mortali, uno su tre vedrà il proprio cuore corretto da un bisturi chirurgico.
La morale pubblica ufficiale ― quella rappresentata dalle leggi, dai codici deontologici medici, dalle posizioni morali religiose ― afferma il principio della difesa della vita e inorridisce di fronte all'ipotesi di scelte come quelle che nell'antichità classica avevano adottato gli spartani, di lasciare morire i non adatti. Ma se si passa da ciò che si predica a ciò che si pratica, la divaricazione è notevole. È vero che sono pochi i casi in cui positivamente si decide di sopprimere un neonato o di lasciarlo morire con un procedimento di eutanasia passiva; tuttavia sempre più raramente l'assunzione del compito di far crescere un handicappato fisico o psichico profondo è considerata un valore. Socialmente prevale un atteggiamento contrassegnato dall'ipocrisia, per cui a un'affermazione formale di tutela della vita, in tutte le sue forme, non fa assolutamente riscontro un efficace sostegno alle famiglie che si trovano schiacciate dai problemi dell'assistenza, abbandonate in una società in cui dominano incontrastati i modelli competitivi che non lasciano posto a chi si trova sotto lo standard, sprovviste di adeguati sussidi medico-pedagogici.
La prassi medica, abitualmente guidata dal principio di "fare il bene del paziente", che si traduce nell'impegno a conservare la vita e a vincere le malattie, si trova confrontata con la possibilità che la sua opera non sia un "beneficio" per l'interessato. Come ai tempi di Ippocrate. Anche attualmente la prima regola della condotta medica è di non procurare del male: primum non nocere; ma oggi il "fare un danno" può essere più sottile che in passato; può addirittura passare attraverso il suo apparente contrario, cioè le tecnologie che salvano la vita.
La scelta etica non può prescindere da una riflessione antropologica: qual è il meglio, e per chi? Qual è l'interesse del bambino, della sua famiglia, della società? Il migliore interesse del bambino sembra includere, a priori, la conservazione della vita. Ma questa certezza comincia a incrinarsi se si considera anche la sua futura qualità della vita, che comprende il benessere fisico, la capacità intellettuale e l'adattamento sociale. Se si vuole prendere in considerazione questa prospettiva, non si può più procedere aprioristicamente; bisogna piuttosto considerare in modo differenziato le diverse categorie di deficit che si presentano alla nascita.
Due sono le principali variabili: la qualità della vita mentale associata all'handicap fisico e la speranza di vita. Completamente diverso appare, per esempio, il profilo di un caso con difetto fisico in condizioni statiche (come cecità, deformità ecc.) associato a intelligenza normale, e quello di condizioni fisiche progressive, non trattabili, associate a ritardo mentale. In questo caso il vigore della lotta contro l'inevitabile morte precoce non può essere paragonabile a quello richiesto da un'affezione fisica non progressiva. E ciò senza mettere in discussione il principio del valore di ogni vita umana.
Parlando degli interessi in conflitto, bisogna tener presenti le diverse parti in causa. Quando si prende una decisione "nell'interesse del paziente" ― in questo caso di un paziente che non è in grado di parlare per sé e di esprimere le sue preferenze ― si fa sempre un'opera di interpretazione. In pratica, equivale a domandarsi: se fosse in grado di esprimersi, il bambino che si trova in quelle condizioni chiederebbe l'impiego di sistemi artificiali di prolungamento della vita? Dicendo che la qualità della vita del bambino sarà tollerabile o intollerabile, noi proiettiamo di fatto la nostra esperienza. Questo processo ci può portare anche molto lontano dalla reale esperienza dell'interessato.
Rimane comunque l'angosciosa situazione di dover prendere delle decisioni che riguardano un'altra persona, il bambino, con il rischio che questi possa trovare la qualità della sua vita assolutamente
159
inaccettabile. Si immagini la situazione che si crea nei casi di poliomielite acuta, quando si salvano mediante il polmone di acciaio bambini i cui muscoli respiratori sono paralizzati, e che quindi per la loro esistenza dipenderanno perpetuamente da una macchina. Oppure l'incontinenza fecale persistente presso un'adolescente che fu salvata alla nascita, ma il cui sfintere anale fu perduto nell’operazione di salvataggio... "E se un giorno ci maledicesse per averlo fatto vivere?", si domanderanno angosciosamente alcuni genitori.
L'interesse della famiglia è più difficile da esprimere. Ci può essere una vera resistenza ad ammettere che l'impegno ad assistere un bambino gravemente handicappato può essere sentito come un gravissimo peso rispetto agli altri figli, alla vita coniugale, alla situazione economica della famiglia. Dimostrerebbe, comunque, ben poca empatia chi ritenesse che, dal punto di vista dei genitori, non possono esistere seri motivi per negare il trattamento; oppure chi volesse colpevolizzare le famiglie per aver, magari con lo spirito straziato, preso una tale decisione. Un vero dilemma sorge per il medico quando la famiglia, valutando che i propri interessi abbiano maggior peso degli interessi del neonato, abbia optato per il non trattamento.
Anche gli interessi della società non vanno minimizzati. È chiaro che la decisione dei medici e dei genitori sarà fortemente condizionata dalle risorse pubbliche disponibili per l'assistenza e l'educazione dei bambini handicappati. Se la società vede il proprio interesse esclusivamente nel favorire le forme di vita più adattate, secondo un giudizio di valore che privilegia l'efficienza e la produttività, l'interesse affettivo dei genitori a far vivere il proprio bambino, anche se handicappato, si scontrerà con le scelte sociali. Solo gli interessati possono valutare se hanno possibilità di reggere il confronto, o se rischiano di soccombere in un conflitto impari. Con spirito realistico va ricordato che le risorse per l'assistenza a lungo termine sono scarse in tutto il mondo. Di fronte all'alternativa se impiegare somme ingenti nell'assistenza, o impegnarsi nella prevenzione della nascita di bambini malformati, la scelta di qualsiasi politica cadrà sulla seconda ipotesi.
Chi deve prendere la decisione se curare o lasciar morire un neonato gravemente malformato? Dal momento che il bambino non può decidere per se stesso, la decisione sulla sua vita spetta ad altri. Il medico ha più informazioni: sa, per esempio, la qualità di vita che spetta a un bambino affetto da "spina bifida" o il decorso di una malattia a prognosi infausta. Nell'insieme i medici sono piuttosto inclini, per l'ethos professionale e per i possibili risvolti penali del non-trattamento, ad attenersi a una linea di intervento a ogni costo. Dal momento che negare il trattamento è illegale (anche dare consigli o fare raccomandazioni ai genitori perché si orientino a mettere fine alla vita del bambino può esporre il medico a un processo con imputazione di concorso in omicidio), il medico, anche se volesse porgere ascolto al desiderio dei genitori, non può rinunciare ad applicare misure eccezionali per salvare la vita del figlio neonato.
I genitori sono raramente in grado di decidere serenamente. Lo shock, insieme a sentimenti di colpa, vergogna e collera, li paralizza; tendono ad affidarsi al medico, pur sapendo che le conseguenze maggiori del trattamento o della sua omissione ricadranno su di loro. Nei Paesi anglosassoni si fa talvolta ricorso in questi casi ai comitati etici. Senza pretendere che questi costituiscano un'istanza etica superiore, alla quale medici e genitori possano, deresponsabilizzandosi, demandare le decisioni, non si può negare che tale organo possa apportare un punto di vista più imparziale e offrire un servizio a coloro cui spetta il peso della decisione.
Un altro espediente è quello di nominare un difensore che rappresenti gli interessi del bambino nelle discussioni tra genitori e medico. Anche questo sistema può essere utile, purché non comprometta il rapporto tra medico e genitori, che deve basarsi sulla riservatezza e la fiducia. Il ricorso a terzi, tuttavia, dovrebbe avere sempre il carattere di consulenza. In ultima istanza, la decisione deve provenire dalla diade medico-genitori, chiamata a decidere, caso per caso, che cosa si deve fare e che cosa è opportuno omettere.
160
Qualora la decisione di non sottoporre a trattamento un neonato malformato sembri la più appropriata, subentrano i problemi etici connessi con l'eutanasia. Anche se si valuta il non-trattamento come equivalente a un atto di eutanasia passiva e non attiva, sarà molto difficile giustificare gli sforzi fatti per mantenere in vita un neonato che si è deciso di lasciar morire; porre fine direttamente alla vita, evitando sofferenze inutili, sembrerà facilmente la soluzione più umana all'interno di una scelta che, secondo altri parametri legali ed etici, va considerata disumana: probabilmente, "la scelta migliore fra scelte peggiori". Sapendo, tuttavia, che in questo caso agire come si ritiene corretto secondo coscienza vuol dire andare contro la legge, e decidere quindi di esporsi ai suoi rigori.
161
capitolo
11
SESSUALITÀ E TERAPIA
L'IDENTITÀ SESSUALE: PROBLEMI ANTROPOLOGICI
Secondo l'antropologia ingenua che rappresenta il sentire comune, il dimorfismo sessuale è la condizione normale e naturale. Tendiamo a pensare che esistono due sessi, polarmente opposti senza gradazioni, ognuno con una specifica morfologia, con i propri attributi psicologici, con stereotipi di comportamento e una "naturale" attrazione per gli individui del sesso "opposto". Consideriamo inoltre l'appartenenza a un sesso come un fatto immutabile, una verità eterna. Questa modalità di pensiero affonda probabilmente le sue radici nel fatto che la mente umana trova comodo percepire per contrasto. Il pensiero bipolare è la forma più primitiva di pensiero logico: la classificazione bipolare soddisfa il nostro bisogno di ordine ed elimina dall'esperienza le zone indistinte e confuse.
La tendenza a rappresentarci l’umanità suddivisa tra uomini e donne è indubbiamente giustificata dal punto di vista pragmatico, ma è inadeguata per una comprensione scientifica. Solo recentemente la riflessione antropologico-culturale ha cominciato ad approfondire la complessità del nostro sesso biologico. Ci si è resi conto che in differenti culture si trovano concezioni divergenti circa l'identità maschile e femminile. La stessa distinzione biologica tra maschi e femmine è molto più complessa della definizione tradizionale basata sulla configurazione dei genitali esterni.
Un contributo decisivo è venuto dai tentativi effettuati dagli scienziati, dell'ambito sia biomedico che delle scienze comportamentali, per aiutare persone del sesso ambiguo e transessuali ad adattarsi a un sesso o all'altro. Sappiamo oggi che si diventa maschi o femmine in fasi successive, e che nei momenti critici dell'acquisizione dell'identità può aver luogo una deviazione dalla norma che si configura come patologica. Le teorie tradizionali sulla maschilità e femminilità ― sia quelle ingenue che quelle filosofiche e aprioristiche ― devono confrontarsi con i dati sperimentali e clinici derivanti da più discipline: genetica, embriologia, endocrinologia, neurologia, psicologia medica e clinica, antropologia culturale e sociologia. Grazie a queste conoscenze interdisciplinari, è possibile oggi tracciare l'itinerario che segue la differenziazione sessuale dell'uomo e della donna dal concepimento alla maturità.
L'appartenenza a un sesso, l'essere cioè persona sessuata e percepirsi tale, è designata scientificamente come "identità di genere". Tale identità è la persistenza della propria individualità maschile o femminile (ambigua o ambivalente), come esperienza di percezione sessuata di se stessi e del proprio comportamento: l'essere "io" del mio corpo di uomo/donna. Altra espressione tecnica è quella di "ruolo di genere", corrispettiva all'identità. Indica tutto quello che una persona fa o dice per indicare agli altri o a se stesso l'appartenenza personale a un sesso.
162
La crescita dell'essere umano verso l'acquisizione di un'identità di genere compiuta non comporta solo uno sviluppo di potenzialità presenti fin dal concepimento, ma anche simultaneamente un processo di differenziazione che tende al dimorfismo: uomini e donne hanno diversa morfologia, diverse funzioni endocrine, diverse strutture nervose periferiche e centrali. La differenziazione sessuale si attua normalmente attraverso un programma, nel quale la funzione di elemento pilota è assunta successivamente da fattori diversi. Lo si può immaginare come una corsa a staffetta, nel corso della quale la funzione di determinare il sesso biologico passa da un elemento all'altro.
Il cammino per il quale si giunge a essere un uomo o una donna, a riconoscersi e a comportarsi come tali, è lungo e insidioso. Le turbe dell'identità sessuale possono essere radicate tanto nella differenziazione che ha luogo nella vita intrauterina, quanto nella nascita e nella vita postnatale. La responsabilità risale, rispettivamente, a difetti genetici (anomalie cromosomiche); a un'alterata produzione di ormoni durante i periodi critici dello sviluppo fetale (nell'ermafroditismo si verificano, di conseguenza, incongruenze anatomiche nella morfologia dei genitali esterni); a un'errata attribuzione di sesso alla nascita; o, più semplicemente, all'educazione. Per le persone che, in un momento o l'altro del cammino evolutivo, hanno un incidente di percorso, la conquista della propria identità sessuale diventa un problema arduo, con strascichi di molta sofferenza. Tanto più precoce è l'allontanamento dal modulo normale dello sviluppo, nelle trappe decisive della differenziazione, tanto più gravi e irreversibili sono le conseguenze.
Nell'insieme della popolazione sono comparativamente pochi gli individui che mostrano una discordanza significativa tra il sesso biologico, la loro identità o orientamento sessuale, e il comportamento connesso con il ruolo. Le turbe principali possono essere ricondotte al transessualismo, travestitismo e omosessualità; le diverse forme di parafilia costituiscono variazioni patologiche nella scelta dell'oggetto sessuale.
Il caso più radicale è quello del transessuale. È una persona la cui identità di genere è in conflitto con il proprio sesso biologico, compresa la morfologia genitale esterna. Il transessuale si sente una donna intrappolata in un corpo maschile (parliamo dell'uomo perché il caso contrario ― il transessuale biologicamente donna che abbia un'identità maschile ― è statisticamente molto più raro). Sempre più numerosi sono i transessuali che non si rassegnano a questa situazione e intraprendono il viaggio che li faccia approdare al sesso che sentono come la loro "vera natura".
Dopo il trattamento ormonale, che modifica i caratteri sessuali secondari, alcuni si spingono fino ad alterare chirurgicamente la propria anatomia, per risolvere radicalmente l'incongruenza. L'operazione è solo l'elemento più spettacolare del cambiamento di sesso. Per armonizzare la discordanza tra biologia e identità di genere sono necessarie una quantità di trasformazioni relative agli stereotipi comportamentali dell'uno o dell’altro sesso. Anche il travestitismo è una turba dell'identità sessuale maschile, quasi mai femminile. Si manifesta nella tendenza coatta a identificarsi col sesso opposto o a vestirne gli abiti.
La variazione dell'identità più nota e diffusa è l'omosessualità. Spesso l'identità di genere vera e propria non è propriamente in causa: l'omosessuale non ha dubbi circa la propria identità, ma orienta il proprio interesse erotico verso persone dello stesso sesso. Quando tuttavia l'omosessuale, oltre a convogliare l'interesse erotico verso gli uomini, assume comportamenti effeminati e ama identificarsi con il sesso femminile, i confini con il travestitismo e con il transessualismo diventano fluidi.
In che misura l'orientamento sessuale delle persone dipende da una specie di determinismo naturale? La scelta di un partner sessuale è un elemento dell'apprendimento del comportamento sessuale adeguato, che si acquisisce mediante il processo di socializzazione, oppure esiste un meccanismo biologico che stimola il nostro erotismo? La ricerca scientifica negli animali ha appurato che gli ormoni possono svolgere un ruolo di organizzazione neurologica nel creare la scelta dell'oggetto sessuale; ma la connessione tra livelli ormonali e orientamento sessuale nei
163
soggetti umani è molto più problematica (anche se è attendibile che gli ormoni fetali che organizzano le strutture fetali dimorfiche possono anche influenzare l'organizzazione delle strutture cerebrali dalle quali dipendono i comportamenti sessuali).
Nell'essere umano gioca un ruolo importante lo sviluppo dell'identità e dell'orientamento sessuali che avviene dopo la nascita. Lo confermano i risultati della ricerca clinica relativa all'omosessualità, che tra le turbe dell'orientamento sessuale è la più studiata. Risulta inoppugnabile che i genitori giocano un ruolo determinante per quanto riguarda la salute psicosessuale del bambino e i suoi sentimenti di adeguatezza sessuale. Tuttavia non c'è evidenza che siano i genitori a "creare" un bambino omosessuale. Nelle modalità dell'esistenza umana c'è sempre qualcosa che dipende dalla libertà e dalla decisione personale.
È LECITO CAMBIARE SESSO?
Il corpo umano ha uno stampo sessuale. Oggi però sappiamo, meglio che in passato, che la sessualità, oltre che un dono, è anche un compito. Si giunge a essere uomini e donne attraverso un itinerario che riserva talvolta esiti imprevisti. L'identità e l'orientamento sessuale sono largamente basati sulle caratteristiche sessuali biologiche, ma non ne sono interamente determinati in modo obbligante. Nell'ambito del "dover essere" ciò che per natura si "può essere", si aprono iproblemi dell'etica.
In primo luogo: è lecito cambiare sesso, come pervengono a conseguire i transessuali? Questa formulazione riflette da vicino il modo in cui il problema dei transessuali è visto dall'opinione pubblica. Sulla loro vicenda grava il sospetto di un intervento capriccioso, quasi una sfida alla natura e alla società, nonché l'insinuazione che il passaggio da un sesso all'altro sia, in definitiva, a servizio della prostituzione. La scelta è vista in funzione del piacere, senza considerare la sofferenza lacerante che molto spesso accompagna il transessuale nella ricerca della propria identità sessuale. Il transessuale, da parte sua, vive la sua decisione non come un cambiamento arbitrario, bensì come l’adeguamento del corpo al profilo psicosessuale che sente come proprio.
La richiesta di intervento medico per la riassegnazione del sesso ― con la terapia ormonale e, come ultima tappa, con l'intervento chirurgico ― solleva per il sanitario problemi deontologici ed etici. L'opera medica in questo caso travalica l'ambito terapeutico tradizionale. Il medico non può limitarsi semplicemente ad assecondare la richiesta, senza sottoporla a un certo vaglio per appurare la qualità della motivazione, oltre che le conseguenze sanitarie e psicologiche dell'intervento. Benché la legislazione italiana, con la legge 164 del 1982, non consideri più tali interventi chirurgici come mutilazione perseguibile penalmente (un emendamento della legge finanziaria dell'anno 2000 prevede addirittura che gli italiani che cambiano sesso non debbano più pagare le spese giudiziarie legate al cambio d'identità), i medici sono per lo più ostili; l'opinione pubblica condanna come aberrazione o eccentricità i cambiamenti di sesso. In tale contesto i transessuali sono rinviati al sottobosco della medicina abusiva (e abborracciata: perciò, spesso, con danni gravi all'organismo) e della speculazione.
Per una serena valutazione morale bisogna far perno sull'identità sessuale, stabilizzata al momento della pubertà. Non è su questa che si può agire, perché l'identità, una volta stabilita, non è più in grado di subire cambiamenti. L'incongruenza con il sesso biologico può essere livellata solo operando sul versante somatico (malgrado ciò che può pensare il senso comune, la via che assicura maggiori possibilità di successo è quella di adattare il corpo alla psiche, piuttosto che l'opposto).
Una condizione preliminare, dalla quale non può prescindere l'eticità di un intervento rivolto a modificare la struttura sessuale di una persona, è l'adesione informata e libera al progetto da
164
parte dell'interessato. Questa condizione non sembra sia stata rispettata nel caso di atleti sottoposti a doping che, a loro insaputa, ha avuto conseguenze pesanti sulla loro sessualità.
Il processo contro i responsabili medici dell'organizzazione sportiva dell'ex Germania dell'est ha aperto un capitolo sorprendente: le conseguenze sulla sessualità degli sportivi coinvolti nel doping sistematico. Per anni la Germania dell'est, prima della caduta del muro di Berlino, ha stupito il mondo con schiere di atleti che hanno polverizzato record olimpionici. L'uso sistematico del doping, con l'impiego massiccio di anabolizzanti e altre sostanze proibite ("droghe di sostegno", venivano chiamate con un eufemismo), è stato individuato come il responsabile di tali prodezze. Il cantautore dissidente tedesco Wolf Biermann ha chiamato quella manipolazione a cui è stato sottoposto il corpo degli atleti "il più grande esperimento di vivisezione su vasta scala condotto su esseri umani".
Il doping merita le più severe censure morali per gli aspetti di iniquità che introduce nella competizione sportiva. Quando sono emersi i dati medici relativi al fenomeno del doping di Stato è risultato chiaro che le persone che hanno ricevuto quei trattamenti hanno subito danni specifici, specialmente nell'ambito della sessualità. Le numerose atlete, tutte celebri e vincenti, chiamate a deporre al processo di Berlino, hanno esibito un vasto campionario di effetti secondari devastanti: dalla voce da uomo al corpo coperto di peli, fino ai problemi ginecologici più drammatici: disfunzioni ghiandolari, sterilità, una lunga serie di aborti naturali, atrofizzazioni delle mammelle e anormale sviluppo muscolare. Fino ai casi estremi di cambiamento di sesso.
TERAPIA FARMACOLOGICA DELL'IMPOTENZA
Le nostre attese nei confronti di ciò che la medicina può fare per rispondere ai mali che ci affliggono tendono ad allinearsi verso una soluzione che sia facile, immediata, possibilmente contenuta nella compatta rotondità di una pillola. Ciò vale anche per i problemi di natura sessuale, in particolare per l'impotenza maschile, il disturbo prepotentemente venuto alla ribalta grazie alla pubblicità che ha accompagnato l'immissione nel mercato del Viagra. Uno degli elementi che ha maggiormente acceso le fantasie è stata la sua caratteristica di "farmaco miracoloso". L'associazione tra il miracolo e il farmaco suona più convincente in inglese, dove il secondo si chiama drug, mescolando ambiguamente diversi significati: medicina, pozione magica e droga. Anche quando questo rimedio all'impotenza ci viene proposto da una seria casa farmaceutica, sentiamo risuonare in esso tutte le attese che miti, religioni e arti magiche hanno tenuto vive nel tempo. Ancor più, la biochimica oggi ha tutta l’aria di essere la vera discepola di mago Merlino. Con la magia in meno e la quotazione in borsa delle ditte produttrici in più.
Quando consideriamo la "miracolosa" risposta all'impotenza fornita da una pillola, viene spontaneo associarla al trionfalismo che trapelava dalle affermazioni del prof. Daniel Weinberg, direttore della Divisione clinica per i disordini mentali dell'istituto nazionale di salute mentale di Bethesda, Washington. Illustrando alla stampa i risultati recenti della ricerca sulle malattie mentali, dichiarava: "Per ora della schizofrenia conosciamo veramente solo le cause genetiche, biologiche. E i positivi effetti dei farmaci sui sintomi. Tutto il resto è poesia". Senza nessuna forzatura, si potrebbe applicare il modello anche all'impotenza, affermando che di questa noi conosciamo solo i problemi di vascolarizzazione dei corpi cavernosi e l’effetto sui sintomi che produce il Viagra: tutto il resto è "poesia"...
A beneficio degli immemori che si accingono a buttare nella spazzatura la "poesia", questa comprende cose così disparate come l'erotismo (con i suoi mille stratagemmi, da quelli volgari che confinano con la pornografia a quelli più nobili, che comportano l'idealizzazione dell'oggetto amato), la sublimazione degli istinti e delle pulsioni (maestri di spiritualità, dentro e fuori le religioni
165
istituzionali, hanno insegnato per secoli questa sublime arte alchemica) e l'etica (che indica percorsi per una saggia accettazione dei propri limiti). Poesia è anche, da sempre, quella creatività esistenziale che consiste nell'immaginare un percorso diverso e una nuova identità quando quella precedente ci è venuta meno. Per rimanere nel tema del declino fisiologico della sessualità, riandiamo a esplorare la dolorosa ma salutare crescita di consapevolezza che Arthur Schintzler immagina per il suo personaggio nella novella Il ritorno di Casanova: forse la pillola miracolosa avrebbe potuto rinviare per Giacomo Casanova il confronto con il declino delle proprie capacità amatorie, ma lo avrebbe privato di quella grandezza umana che può nascere dalla sconfitta.
Chi propende per le risposte facili e sicure fomite dalla chimica spesso non nasconde un senso di sufficienza altezzosa nei confronti di tutto il resto, come rivelano le parole del prof. Weinberg riferite ai successi della farmacologia nel controllo delle patologie mentali. Questo resto ― la deprecata "poesia" ― tende a sua volta a sviluppare un senso di inferiorità e a battere in ritirata di fronte al biologismo che trionfa. Oppure risponde al disprezzo con la stessa moneta. Ci sono però altre vie percorribili. Senza svalutare i successi della biochimica, è possibile dare loro il giusto valore di uno strumento, che non può fare a meno della qualità umana di colui che lo usa. Un esempio molto convincente è fornito dalla riflessione che Oliver Sacks ha sviluppato sugli effetti di un altro "farmaco (drug) miracoloso": la L-dopa. In Risvegli il celebre neurologo ha raccontato gli effetti travolgenti che la L-dopa ha ottenuto, scuotendo dal letargo decennale pazienti colpiti da encefalite letargica. Ma all'euforia ha fatto seguito per molti una seria minaccia per un equilibrio costruito con l'intelligenza, la forza morale, la creatività spirituale (sì, insomma, ancora una volta la famigerata "poesia"...).
Può essere utile ― avendo in mente anche il Viagra ― riascoltare le parole con cui uno dei pazienti di Sacks, Léonard L., riassume l'alternante esperienza di tre anni di assunzione di L-dopa: "Da principio pensavo che la L-dopa fosse la cosa più meravigliosa del mondo, e benedivo lei, dottore, per avermi dato l'elisir di lunga vita. Poi, quando tutto è andato male, ho pensato che fosse la cosa peggiore del mondo, un veleno letale, un farmaco che sprofondava la persona negli abissi dell’inferno; e l'ho maledetta per avermela data. I miei sentimenti erano terribilmente confusi, per paura e speranza, odio e amore... Ora accetto le cose così come sono. È stato meraviglioso, terribile, drammatico e comico. E alla fine... triste, e questo è quanto. È meglio che mi si lasci stare: basta con le medicine. In questi tre anni ho imparato molte cose. Ho infranto barriere che mi avevano bloccato per tutta la vita. Ora voglio rimanere me stesso, e lei si tenga pure la sua L-dopa" (Sacks, 1987).
L'opinione pubblica è rimasta colpita da notizie ― per lo più di tono scandalistico ― di mutamenti sconvolgenti avvenuti nella vita personale e familiare di alcuni uomini che, con l'aiuto del farmaco-protesi, hanno riacquistato la potenza sessuale. Probabilmente non ci sarà mai uno scrittore del calibro di Oliver Sacks a raccontare le storie di questo tipo di "risvegli". Ma di una cosa possiamo essere certi: il vero "miracolo" non risulterà essere il farmaco da solo, indipendentemente dalla personalità di chi lo usa. Il miracolo, che non finisce di stupirci, è piuttosto l'animo umano, con la sua spettacolare capacità di adattamenti creativi alle situazioni (con o senza la biochimica).
LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Gli interventi sui genitali femminili sono una pratica diffusa in vaste aree del pianeta: soprattutto in Africa, ma anche in Asia e in Australia. In Africa si distinguono tre principali varianti: la circoncisione "dolce" (che consiste nella rimozione del prepuzio clitorideo; quando si limita a questo intervento, presenta analogie con la circoncisione maschile); l'escissione (ablazione del clitoride e delle piccole labbra); infibulazione (chiusura parziale della vagina dopo l'escissione del clitoride, piccole e grandi labbra e successiva cucitura dei due bordi della vulva). Oltre
166
che alla rilevanza numerica del fenomeno (si calcola che siano più di 110 milioni le donne coinvolte), suscita forte emozione la ricaduta di tali pratiche sulla salute delle donne coinvolte. Alcune subiscono danni immediati dalla mutilazione; altre hanno complicazioni a lungo termine, con problemi nei rapporti sessuali e nel parto (per non parlare delle conseguenze nella sfera psicosessuale).
Fino a una data recente questi interventi non sono stati oggetto di interesse (la stessa Organizzazione mondiale della sanità nel 1958 rifiutò anche solo di prenderli in considerazione). Negli ultimi anni invece numerosi organismi internazionali ne hanno fatto oggetto di denuncia. Con particolare enfasi le mutilazioni genitali femminili sono state condannate, come lesive dei diritti umani, dalla Conferenza su demografia e sviluppo (Cairo, 1994) e dalla Conferenza mondiale sulla donna (Pechino, 1995). Anche i tribunali hanno cominciato a interessarsi di tali interventi, particolarmente in Francia. Le condanne si sono progressivamente inasprite: il massimo delle pene è stato aumentato a quindici anni se le mutilazioni sono praticate su minori di età inferiore a quindici anni, e a venti se a praticarle è un ascendente legittimo.
Tuttavia la "criminalizzazione" di questo insieme di interventi sul corpo femminile suscita qualche imbarazzo. Il fenomeno della migrazione ha portato fuori dal loro contesto culturale delle pratiche tradizionali che, per quanto oppressive delle donne, offrivano una risposta a un bisogno profondamente sentito: quello del riconoscimento sociale. Le donne su cui non sono stati praticati questi interventi, ritenuti necessari per "preparare" il corpo femminile al matrimonio, si ritengono staccate dal gruppo, minacciate nella loro identità. Anche il loro sviluppo personale è compromesso, in quanto le donne non "cucite" vengono ritenute equivalenti alle prostitute e non ricevono proposte di matrimonio. "Ovunque si circoncidono le giovani, l'operazione non viene percepita come una mutilazione ma, al contrario, come un miglioramento dello stato naturale dei genitali altrimenti sporchi e pericolosi, la cui ablazione diviene addirittura gratificante per le femmine. Apostrofare una donna come "non circoncisa" è un'offesa terribile che danneggia pure i suoi eventuali figli. La mancata escissione o infibulazione le impedisce di maritarsi, avere figli e integrarsi naturalmente nella vita sociale; la ragazza rimane un'emarginata derisa e umiliata" (Atighetchi, 1997).
La perplessità di chi deve giudicare queste pratiche cresce quando sono le madri a chiedere insistentemente l'intervento sulle proprie figlie, o non di rado le ragazze stesse, per non sentirsi discriminate dal gruppo delle coetanee. La bella sicurezza con cui l'Occidente in passato definiva "barbari" i costumi diversi dai propri si tramuta in esitazione quando si diventa consapevoli della complessità con cui una cultura struttura i comportamenti e della irriducibile pluralità delle culture. "Giudicare l'altro" è diventato molto più complesso.
Trasportata in ambito sanitario, la problematica delle mutilazioni genitali femminili crea particolare perplessità nei professionisti. La presenza di donne escisse e infibulate nelle nostre strutture ospedaliere non è più una rarità confinante con l'esotismo per medici, ostetriche, infermieri. Sarà quanto meno necessaria una base minima di conoscenze etno-antropologiche e di sensibilità umana per non far scattare la barriera dei pregiudizi o non interagire nei modi più grossolani (irrisione, condanna...).
La comprensione non può estendersi fino a una collaborazione per tali pratiche, quando venisse richiesta. Né è giustificata una considerazione di "male minore" (visto che la circoncisione sarà eseguita, probabilmente con i mezzi rudimentali della tradizione e senza alcuna garanzia igienica ― da "mammane" appositamente giunte dai paesi d'origine e pronte a spostarsi da una città all'altra al richiamo di qualche genitore ― tanto vale praticarla con garanzie mediche...). Anche se non esiste una legge specifica che condanni e persegua penalmente le pratiche di mutilazione genitale, queste non sono compatibili con le norme in vigore: la circoncisione femminile, quand'anche fosse richiesta da una maggiorenne su di sé, non sarebbe permessa
167
dal codice civile (art. 5) che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando comportino una mutilazione permanente. Il responsabile dell'intervento è perseguibile in base all'art. 582 del codice penale, che punisce le lesioni personali. Anche il codice di deontologia medica esclude tale possibilità: "Il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomare l'integrità psichica e fisica e ad abbreviare la vita o a provocarne la morte" (art. 35). Le mutilazioni genitali sono indubbiamente lesive della salute, soprattutto per le conseguenze ostetrico-ginecologiche e psichiche di lunga durata.
"Che cosa si può fare? Che cosa è giusto fare?", si chiede una studiosa di antropologia culturale molto coinvolta con le esigenze di rispetto delle diverse culture, ma allo stesso tempo lucidamente consapevole che nessuno in Occidente può essere favorevole alle mutilazioni genitali femminili (Ciminelli, 2000). Alcuni Paesi africani ― tra i 28 in cui le mutilazioni sessuali vengono ancora correntemente praticate ― hanno intrapreso delle risolute campagne abolizioniste. Dal 1998, per esempio, il Senegal ha bandito l'infibulazione, riconosciuta ora come un crimine punibile con sei mesi di carcere. Ma queste misure repressive hanno ottenuto scarsi risultati, così come le campagne delle organizzazioni internazionali. La maggiore speranza viene da alcune esperienze in cui i rituali cruenti di escissione e infibulazione sono stati sostituiti da riti simbolici ("escissione mediante le parole") o da rituali urbani alternativi all'iniziazione dei villaggi. I comportamenti culturali possono cambiare, anche quelli che assumono valenze religiose: basti pensare al battesimo con acqua che ha sostituito nel cristianesimo la circoncisione ebraica. Ma per queste trasformazioni è necessario il fattore tempo.
168
169
12
LE INVASIONI DI CAMPO DELLA RELIGIONE
L'AIDS è una malattia eccessiva: eccessivamente insidiosa ed elusiva, eccessivamente pericolosa per la vita, eccessivamente rapida per la diffusione. E anche eccessiva nelle reazioni emotive che provoca, in tutti gli ambiti. L'irruzione della nuova sindrome patologica, oltre a sconvolgere il rapporto dell'individuo con il proprio corpo e la dimensione interpersonale, ha turbato anche la relazione che si era col tempo stabilita tra la medicina e l'orizzonte religioso dell'esistenza.
La secolare tensione tra la medicina razional-scientifica e la terapeutica che attinge ispirazione dalla religione ― dalla sua concezione antropologica, dalle normative morali riferite alla volontà divina, dalle strutture e dai rituali propri di ogni religione ― sembrava aver trovato in epoca moderna un punto di equilibrio. Piuttosto svantaggioso per la religione, in verità. Questa veniva infatti praticamente dichiarata incompetente per l'opera della terapia e relegata alla gestione dei significati ultimi dell'esistenza individuale. Di fatto, però, in epoca di secolarizzazione a questa dimensione non viene riservato alcuno spazio nell'organizzazione sanitaria della malattia. Ciò aveva portato alla pratica irrilevanza del sacro nel percorso che costituisce soluzione di un processo morboso verso la restaurazione della salute o verso un tragico esito finale.
Lo scoppio dell'epidemia dell'AIDS sembra aver rimescolato le carte, dando delle nuove chances alla religione. Questa si è trovata inaspettatamente al centro di un'attenzione inusuale, in condizione di competere di nuovo con la scienza medica per la leadership nella mobilitazione generale contro la malattia. I credenti non possono che rallegrarsi per questa riemergenza sociale del pensiero e dell’azione ispirati alla religione. Ma al tempo stesso hanno anche motivo di preoccupazione: insieme agli aspetti più luminosi è affiorato anche il lato d’ombra della religione.
Alcuni ecclesiastici hanno indicato, senza alcuna esitazione, nella malattia un castigo di Dio. L’impatto inquietante di tali dichiarazioni sulla coscienza dei fedeli e sull’opinione pubblica ha indotto diverse conferenze episcopali a rettificare, con dichiarazioni ufficiali, tale punto dottrinale. In questo senso si sono espressi i vescovi francesi ("L’AIDS colpisce l’uomo in ciò è la fonte della sua vita: il sangue e la sessualità. Ma l’AIDS non è una punizione divina; è una malattia che ha le proprie cause. Dio non è un 'sadico'! Dio è amore. Non vuole la sofferenza e la morte dell'uomo") e i vescovi australiani ("L’AIDS non deve essere presentato come un castigo divino per una società permissiva sul piano della sessualità. È sbagliato giudicare le persone che hanno contratto la malattia. Quale che sia il criterio adottato, molti sono degli innocenti").
Quando non è stato tirato in causa Dio in persona, si è invocata la "natura", che attraverso la malattia si vendicherebbe per l'infrazione delle sue leggi. In questione sono, naturalmente, i
170
comportamenti che mettono maggiormente a rischio di contrarre il virus infettivo: omosessualità, promiscuità sessuale, infedeltà nei rapporti matrimoniali, tossicodipendenza. Nelle dichiarazioni di questi religiosi un orecchio attento non fatica a riconoscere una venatura di gioia maligna (i tedeschi la chiamano Schadenfreude, letteralmente: gioia per il danno altrui), che si può tradurre in un trionfalistico senso di superiorità morale ("Ecco dove si va a finire, quando si calpestano i precetti della morale religiosa!").
La palma dell'estremismo nell'atteggiamento di ostilità verso i malati di AIDS spetta sicuramente a un "teologo" islamico egiziano, Abdullah al-Mashad, che è arrivato a proporre per i malati di AIDS la pena di morte... Ma la violenza religiosa non ha bisogno di esprimersi in forme così truculente. Le basta la squalifica morale dei colpiti dalla malattia, e anche la semplice colpevolizzazione, abbinata a un atteggiamento comprensivo per chi si pente e di solidarietà per chi entra in istituzioni di assistenza a carattere confessionale: la "compassione" diventa così uno strumento per il recupero ideologico, per l'autoaffermazione apologetica, un'occasione per campagne di promozione di un'etica repressiva.
Il volto più insidioso della rigida intransigenza religiosa è quello che si presenta come fedeltà dottrinale. Esso si esprime in una riaffermazione dei principi morali radicati nella visione religiosa dell'uomo, con programmatica noncuranza delle circostanze concrete in cui il messaggio viene annunciato. L’atteggiamento equivale a un'affermazione di irrigidimento dottrinale a oltranza, in considerazione di tali circostanze stesse. In pratica, si viene a dire: "Per quanto grave e minacciosa possa essere l'epidemia di AIDS, niente e nessuno ci può far cambiare la dottrina morale!".
La fedeltà a tutta prova ai principi, senza valutazione delle conseguenze, aspira a fregiarsi dell'aureola di eroismo morale. Il diffondersi dell'epidemia è interpretato piuttosto come conferma della pericolosità di qualsiasi forma di cedimento. Ogni retrocessione nella linea della difesa dei principi morali senza compromessi viene percepita come lassismo morale e complicità con il male. Solo in quest'ottica si possono intendere le dichiarazioni di assoluta intransigenza da parte di alcuni teologi morali cattolici, i quali proprio con riferimento all'epidemia di AIDS si compiacciano di sottolineare che la condanna morale del ricorso al preservativo non ammette alcuna eccezione: neppure quando uno dei due coniugi è portatore del virus e rischia perciò di contagiare il partner.
Certi irrigidimenti dottrinali, incomprensibili per il senso comune, rischiano di aprire un grave contenzioso con i poteri pubblici. La loro responsabilità primaria è quella di proteggere la salute dei cittadini. Nel caso dell'AIDS, non potendo ancora fornire un rimedio efficace della malattia, le autorità sanitarie si sentono obbligate almeno a frenare il contagio. La via dell'uso del preservativo come barriera meccanica al virus è dichiarata però assolutamente non praticabile dalle morali religiose più rigorose, che si oppongono anche a ogni campagna di prevenzione che vi faccia ricorso.
Non stupisce che, quando la religione esprime le sue potenzialità di intolleranza, nella società si evidenzi un movimento di rigetto. Nella forma più concisa e dura, il rifiuto dell'ingerenza della religione nel dibattito pubblico sull'AIDS si può formulare con un drastico invito a "tenere la religione fuori dall'AIDS". Quando le religioni esercitano forme di terrorismo teologico; quando le comunità di credenti si mobilitano più sul versante dell'angoscia che su quello della testimonianza profetica, la società reagisce isolandole mediante il cordone sanitario della ragionevolezza.
Questa divaricazione estrema tra l'etica religiosa e l'etica civile è uno scenario infausto. Equivoci e malintesi si moltiplicano. Lo si può verificare riferendoci alla questione del preservativo. Nel dibattito pubblico l'opposizione della Chiesa cattolica a questo strumento contraccettivo è considerata come un boicottaggio delle campagne di prevenzione. Al rifiuto delle interferenze da parte della morale religiosa, alcuni rappresentanti di questa rispondono attestandosi sulle
171
questioni di principio che non ammettono transazioni: la difesa di una sessualità umana legata al matrimonio e aperta alla riproduzione appare essere uno di tali punti non trattabili.
L'animosità suscitata dalla polemica impedisce di chiarire che l’opposizione della morale religiosa alle campagne di profilassi condotte all'insegna del "sesso sicuro" non è animata da un'ostilità preconcetta verso la sessualità, bensì da una resistenza alla tendenza a ridurla a "bene di consumo". La stessa proposta della continenza, che nasce da una morale ad alto profilo religioso, in un contesto avvelenato di contrapposizione tra etica religiosa ed etica civile rischia di essere fraintesa ed essere degradata a mezzo profilattico. Dalla contrapposizione e dall'isolamento la morale religiosa esce deformata e travisata nei suoi intenti. Ma soprattutto la polemica si ritorce negativamente su coloro che dovrebbero invece beneficiare dell'intesa sinergica tra l'etica civile e quella d'ispirazione religiosa: i malati di AIDS.
UNA MALATTIA "DEMONIZZATA"
Una malattia che abbia le caratteristiche dell'epidemia di AIDS non è contenibile totalmente sul piano dei fenomeni naturali: inevitabilmente essa tracima in quello del sacro. È quanto dire che essa viene "demonizzata". La demonizzazione presuppone il sacro, una categoria più ampia e sfuggente del religioso. Tradotta in azione, la demonizzazione induce ad attribuire ai malati caratteristiche diaboliche: sono isolati, evitati, discriminati, al di là di ogni ragionevole misura cautelativa suggerita dalla prevenzione e dalla profilassi. Essendo l'AIDS una malattia che si trasmette mediante liquidi organici ad alto valore simbolico e legata soprattutto a comportamenti trasgressivi dal punto di vista morale, è facile capire come venga alimentato il meccanismo che induce a isolare alcuni malati dal contesto sociale e a riversare su di essi tutta la negatività possibile, del mondo visibile e di quello invisibile.
Le dettagliate descrizioni che storici e letterati hanno trasmesso dei comportamenti in epoca di peste ci hanno reso familiare il procedimento della demonizzazione nei confronti di alcuni malati, che fungono da veri e propri capri espiatori dell'angoscia suscitata da certe sindromi morbose. La sindrome da immunodeficienza acquisita non è che un caso particolare ― solo l'ultimo in ordine di tempo ― del processo simbolico che porta a caricare su una determinata malattia tutto il peso metaforico che è veicolato dal processo morboso e l'angoscia di morte repressa dalla cultura.
È obbligatorio il confronto, a questo proposito, con l'opera della scrittrice e saggista Susan Sontag. Con La malattia come metafora (1979), si è costituita come coscienza critica nei confronti di tutti gli usi impropri del linguaggio attinente alla malattia. Ha proseguito la sua opera con L'AIDS e le sue metafore (1989). Nella sua analisi dell'AIDS sono evidenziati tutti i tratti che predisponevano questa malattia a una travolgente carriera "metaforica": la sua origine oscura, l'esito infausto (simbolo, quindi, di malattia mortale), il fatto di colpire gruppi identificabili ed etichettabili. L'AIDS è diventato così lo strumento privilegiato di tutti i fustigatori di costumi: da quelli che pretendono di parlare in nome di Dio, ai patrocinatori dell'invettiva laica contro la decadenza dei costumi. Domani, forse, la malattia perderà la sua carica di significato metaforico, per diventare una semplice malattia. Così è accaduto, per esempio, per un sintomo come la febbre. Ma oggi è ancora un veicolo privilegiato di metafore, che si risolvono praticamente in una stigmatizzazione dei malati. L'AIDS veicola un virus che si è infiltrato nel nostro sistema semantico, non meno che in quello immunitario. L'antidoto più urgente, sostiene Susan Sontag, è quello di un uso consapevole del linguaggio, che non moltiplichi il male, già enorme, causato dalla malattia.
L'epidemia di AIDS, oltre a essere una sfida per l'umanità alla fine del XX secolo, potrà essere anche una chance per scoprire nuove dimensioni di co-umanità? Non si tratta di interrogativi
172
accademici, per infiorettare con la retorica una realtà tragica. A questa nuova e insidiosa malattia, come a qualsiasi altra, dobbiamo saper far fronte non solo con l'intelligenza della mente e l'efficacia della mano che predispone rimedi, ma anche con la sapienza del cuore. Prima di essere un richiamo a un atteggiamento compassionevole (capace, magari, di creare nuovi ghetti: ispirati, questi, non dalla paura, ma dalla carità!) l'AIDS è un invito a ripensare i nostri comportamenti. Allo stesso modo di ogni altra malattia, anche l'immunodeficienza acquisita è un messaggio da capire, e non solo un sintomo da eliminare.
Immaginando lo scenario dei prossimi anni, non ci limitiamo ad auspicare la scoperta del farmaco o del vaccino che ci permetta di contenere l'epidemia. Pensiamo a una società che abbia imparato a superare i comportamenti istintivi, modellati sulle antiche epidemie della peste e della sifilide; che rifiuti la repressione basata sull'angoscia irrazionale; che contrasti la desolidarizzazione con le persone colpite dal male, trovando modalità di convivenza che rispettino tanto la giusta preoccupazione per la protezione della salute pubblica, quanto i diritti della persona che sono al centro del nostro sistema sociale.
Nella società del futuro l'AIDS potrà inoltre portare dei cambiamenti profondi in due aspetti centrali della realtà antropologica: l'amore e la morte. Con l'AIDS bisognerà saper vivere. E amare. L'amore non si lascia ridurre agli espedienti tecnici del "sesso sicuro". L'educazione sessuale di cui abbiamo bisogno dovrà lasciar sviluppare nuove forme di tenerezza, che concilino l’accettazione della corporeità e del piacere con il senso di responsabilità per la vita del partner.
E con l'AIDS bisognerà saper morire. La consapevolezza della precarietà della vita e della minaccia che incombe costantemente su di essa ci colpisce come una frustata in viso, proprio mentre i progressi della medicina tecnologica ci creano quasi l'illusione dell'immortalità possibile. La minaccia della fine incombente in età giovane o matura ci obbliga a recuperare il senso della morte, che la nostra società pertinacemente reprime. E ad attribuire alla vita il valore che le spetta, indipendentemente dai suoi limiti nel tempo.
Il bisogno di significato, per quanto elusivo possa sembrare, è una dimensione costitutiva della qualità della vita, nella sua dimensione soggettiva. Esso si fa ancora più pressante quando viene brutalmente imposto da una malattia che interviene a sconvolgere un'esistenza, per lo più giovane e nel pieno del proprio progetto vitale. Il primo ostacolo che il malato incontra in questo percorso è il distacco dalla comunità. Più di qualsiasi altro malato, chi è affetto da questa malattia si trova seduto, come Giobbe, su un mucchio di letame, al di fuori del contatto vitale con la comunità. In questo senso agisce la "demonizzazione", che abbiamo visto accompagnare alcune forme di patologia. La vera solidarietà, che si esprime nel "com-patire", anche se vissuta nell'impotenza di rimuovere le cause della sofferenza, crea a questa un volto nuovo. Il sofferente, scoprendosi parte di un tutto integrato, può fare della prova dolorosa la porta d'accesso a un’esperienza di appartenenza, che guarisce la lacerazione più profonda causata dall'emarginazione.
LA SESSUALITÀ AL TEMPO DELL'AIDS
Ricalcando il felice titolo di un romanzo di Gabriel García Marquez ― L'amore al tempo del colera ― vogliamo sottolineare che comportamenti umani apparentemente fuori del tempo e della storia, come l’amore e la sessualità, di fatto cambiano significato in diversi contesti culturali.
Tra i numerosi significati possibili, alcuni esprimono in modo più esplicito il fatto che per l'uomo la vita sessuale è legata alla persona. Questo intendono dire coloro che attribuiscono alla sessualità il significato di comunicazione, scambio o impegno. Tali significati hanno per lo più una connotazione positiva, ma non possiamo escludere che si sviluppino anche sotto il segno
173
della negatività. Cercare di fare una cernita tra questi significati è un lavoro arduo. Dipende molto dalla comunità morale di appartenenza, che non è uguale per tutti. L'astinenza sessuale, per esempio, non ha lo stesso significato per un monaco cristiano e per un ebreo ortodosso, per il quale procreare figli è uno dei più alti doveri morali. Nell'uno e nell'altro caso siamo nell'ambito di morali religiose; la frantumazione dei significati diventa estrema nella diaspora morale delle moderne società secolarizzate.
Inoltre questi significati sono ambigui. Prendiamo il significato di comunicazione. In un rapporto sessuale si può comunicare: "Tu vali per me, il tuo corpo è per me prezioso e desiderabile". Ma con il comportamento sessuale si può anche inviare il messaggio: "Di te non mi importa nulla". Il marito infettato da un'avventura extraconiugale che, pur consapevole di essere contagioso, impedisce al medico di informare la moglie, comportandosi in questo modo comunica appunto a quest'ultima: "Della tua vita non m'importa affatto".
Osservazioni analoghe possiamo fare a proposito dello scambio. Anche lo scambio può avere tanti significati. Il rapporto sessuale di per sé significa scambio. L'AIDS ha come sfondo culturale il periodo di massima "deregulation" sessuale, in cui lo scambio, inteso come passaggio frequente da un partner all'altro, era considerato come un valore. Lo storico della medicina Mirko Grmek sostiene che per questa malattia siamo in grado di risalire al paziente numero uno, quello individuato nel 1984. Questi era un gay che aveva in media 250 partner sessuali l'anno (Grmek, 1989). Per questo tipo di comportamento sessuale lo scambio era un valore.
Fin dall'inizio si è compreso che il problema dell'AIDS si nutriva dello scambio. È stato coniato uno slogan: bisogna essere due per fare l'amore, tre per trasmettere il virus. Come ha affermato Luc Montagnier, se ciascuno avesse meno di 5 partner sessuali all'anno, l'epidemia di AIDS si estinguerebbe. Ma lo scambio non ha soltanto questo aspetto di molteplicità di partner. Nel rapporto sessuale c'è uno scambio molto più profondo, che coinvolge l'esistenza stessa. Nel film francese Les nuits fauves, che mette in scena rapporti estremi che si intrecciano tra giovani deliberatamente collocatisi al di fuori di ogni regola di moderazione, una delle scene più inquietanti presenta una giovane donna, innamorata di un uomo con l'AIDS, che si offre per avere un rapporto sessuale non protetto, perché vuole essa stessa la malattia: "Voglio condividere tutto con te", afferma con trasporto. Il protagonista, da parte sua, dichiara: "Con lei io sono puro", formulando così un'altra forma di scambio (virus contro purezza).
Anche l'impegno implica dei valori ambivalenti. Vuol dire fedeltà; tuttavia, a volte, anche l'impegno come forma d'amore può essere negativo, se non si coniuga con la giusta distanza. Basti pensare a quanti operatori sociali e professionisti sanitari, impegnandosi con estrema dedizione e coinvolgendosi totalmente nei casi umani più desolati di malati di AIDS, arrivano ben presto al termine delle loro forze e cadono nella sindrome del burn out.
I significati, inoltre, possono mutare nel tempo, benché i comportamenti siano gli stessi. A un approccio fenomenologico i fatti appaiono gli stessi, ma i significati cambiano da una generazione all'altra. Il cambiamento di significato incide sui comportamenti. L’irruzione dell'AIDS è avvenuta in un momento particolare della nostra civiltà, che stava coniugando la sessualità con la leggerezza dell'essere e dell'eros. L'epidemia di AIDS è caduta come un meteorite in questo contesto di liberazione, costringendo i comportamenti sessuali a cambiare ancora di segno. La sessualità è diventata il luogo della gravità: tanto grave che potenzialmente ogni rapporto sessuale può portare alla morte.
Dobbiamo registrare anche la speranza che il cambiamento di significato possa indurre a un cambiamento nei comportamenti. Si è auspicato che la crisi dell'AIDS favorisca la riscoperta di una sessualità più diffusa, non confinata nella genitalità. Altri hanno previsto l'introduzione nell'ambito della sessualità di un senso di responsabilità, che nel momento culturale di comportamenti sessuali sviluppatisi sotto il segno della leggerezza non era affatto presente. Soprattutto
174
si è intravista la possibilità che questo cambiamento fondamentale di significato nel comportamento sessuale introdotto dall'epidemia portasse a una possibilità di educazione sessuale.
L'educazione sessuale è il canale privilegiato per contenere l'epidemia di AIDS, per la quale sappiamo che non esiste a tutt'oggi ancora una terapia (e forse una terapia nel senso mitico della pallottola magica da sparare contro il virus ― così come molti pensano ancora sia possibile per il cancro ― non esisterà mai). In questo senso ha agito anche l'indicazione fondamentale dell'OMS. Già nel 1988 Man e Kay, due autorevoli esponenti ddl’Oms, dichiaravano che l'informazione e la prevenzione sono la chiave di volta della prevenzione da HIV, in quanto la trasmissione del virus può essere impedita da un comportamento responsabile adottato con conoscenza di causa (Mann, Kay, 1988).
Educazione sessuale e prevenzione fanno appello a dei valori, e quindi all'etica. Non ogni appello all'etica, tuttavia, serve alla causa del contenimento dell'epidemia. Possiamo evocare due scenari, che costituiscono altrettanti modi di coniugare negativamente etica e prevenzione.
Prevenzione senza etica. Si può capire che sia stata e rimanga una tentazione forte, in quanto la prevenzione in questo ambito si è sviluppata nel segno dell'urgenza. Dobbiamo salvare le persone a rischio dal rischio di contagio, e farlo in fretta: ne va della loro vita. Il senso di urgenza ha avuto delle ricadute pratiche sotto forma di promozione del preservativo, di programmi di sesso sicuro. Alcune di queste campagne di prevenzione hanno avuto la forma di crociata: "o preservativo o morte"; altre invece un tono leggero, quasi sorridente (come l'invito allusivo a non uscire scoperti...).
Il pericolo di queste campagne è di puntare tutto sulla prevenzione meccanica della diffusione dell'infezione, prescindendo dalle implicazioni dei significati, e quindi anche dalle correlazioni con l'etica. Le conseguenze di questa impostazione sono state quelle di portare a una sterilizzazione del sesso. Se almeno il risultato fosse garantito... Invece da numerose ricerche sociali relative all'incidenza dell'AIDS sul comportamento sessuale dei giovani risulta che la conoscenza del pericolo di contagio non basta a modificare i comportamenti. Questi studi hanno riscoperto quello che già si sapeva da tempo, grazie all'abbondante letteratura psicosociologica rivolta ad analizzare altri ambiti dell'educazione sanitaria, come la prevenzione del tabagismo, delle malattie cardiovascolari o delle gravidanze non desiderate mediante la contraccezione. È vero che si possono stabilire delle correlazioni tra conoscenze e credenze, da una parte, e atteggiamenti individuali collettivi verso la malattia, dall'altra; ma i legami sono ambigui, poco logici, o quanto meno sfuggono al rapporto di causa-effetto. È una concezione troppo ristretta della razionalità quella che presume che basti dare informazioni sul rischio per cambiare il comportamento.
La persistenza dei comportamenti a rischio dimostra che per modificare i comportamenti presso gli individui non sono sufficienti le informazioni dei rischi che corrono. Non è in discussione la necessità di proseguire l'opera di informazione, perché le inchieste dimostrano che ancora sussistono nella nostra società delle sacche di ignoranza abissali. Bisogna sicuramente continuare a informare; ma non ci possiamo attendere ingenuamente che l'informazione funzioni in modo automatico, in maniera lineare (più informazione = maggiore diminuzione di comportamenti a rischio).
Nello scenario della prevenzione senza etica si possono inserire anche degli atteggiamenti che si presentano, invece, sotto forma della massima enfatizzazione dell'etica. Il riferimento è diretto a chi propone la castità o la fedeltà coniugale come rimedi contro la diffusione dell'infezione. Malgrado le apparenze, siamo anche qui dalle parti della prevenzione senza etica, in quanto delle importanti virtù morali ― come la fedeltà e la castità ― sono viste non come virtù, ma semplicemente come mezzi per un fine. Conservarsi fedele al proprio coniuge al fine di non contrarre l'AIDS ha lo stesso profilo morale, fatte salve tutte le differenze, dell'uso del preservativo.
175
Etica senza prevenzione. I dibattiti sull'epidemia di AIDS hanno prodotto anche discorsi sviluppati in nome della morale, insensibili all'esigenza della prevenzione. Riaffermare i principi di un'etica ritenuta indipendente dai tempi e dalle culture, e quindi anche da quel particolare condizionamento dei comportamenti sessuali costituito dalla epidemia di AIDS, costituisce una minaccia per la salute stessa. Il diffondersi dell'epidemia dell'AIDS è stata una manna per i nemici del sesso. Anche chi aderisce a una concezione spiritualista dell'uomo si trova in un enorme imbarazzo quando sente i moralisti presentare la monogamia come uno strumento a servizio della prevenzione, come l'unica ricetta sicura per fermare il contagio. Anche se ciò fosse vero, una proposta di questo genere equivale a uno svendere la fedeltà, la quale non è il modo per non contrarre l'AIDS, ma decisamente un’altra cosa.
La scelta monogama del partner è un costrutto sociale. Le culture tradizionali hanno messo in atto varie forme di condizionamento per canalizzare la spinta spontanea a ricercare una pluralità di partner in una scelta monogamica. Questa pressione non esiste più nella nostra società. Per questo oggi si può essere fedeli per scelta e per virtù, e non per costrizione. Essere fedeli è un punto di arrivo. Non possiamo certamente presentare la fedeltà come la via sicura che tutti possono percorrere per evitare l'AIDS, anche se lo consideriamo un obiettivo morale di alto profilo. Questa variante dell'etica senza prevenzione ha una impressionante affinità con la prevenzione senza etica.
Etica e prevenzione si possono abbinare. Non ci sono, però, scorciatoie: bisogna passare per una vera maturazione, anche culturale. E il ruolo che svolgono le donne in questo sviluppo è decisivo. Tutto questo suona come una buona notizia, anche se non autorizza nessun trionfalismo: la crescita di una cultura che sappia coniugare il rapporto sessuale con la comunicazione, lo scambio e l'impegno ha tempi lunghi, forse lunghissimi.
IL SEGRETO PROFESSIONALE SOTTO PRESSIONE
Un caso clinico
Margherita è la caposala del reparto di malattie infettive di un ospedale di provincia che rappresenta anche un punto di riferimento regionale per la cura delle persone sieropositive e affette da sindromi AIDS-correlate.
L'équipe medico-infermieristica del reparto è impegnata sia nell'attività di ricovero dei pazienti, sia nell'attività ambulatoriale, alla quale accedono molti giovani residenti in città e paesi limitrofi. Margherita si occupa personalmente dell'attività ambulatoriale e lo fa con molto impegno, dimostrando ottime capacità professionali e relazionali nei contatti con i pazienti che sono, per la peculiarità della loro condizione, frequenti e ripetuti nel tempo.
Margherita ha una figlia di 18 anni con la quale ha un rapporto molto confidenziale. Un giorno, mentre passeggiano insieme in una città non lontana da quella nella quale vive e lavora, la figlia le indica un giovane e le riferisce che, da circa sei mesi, è il "ragazzo" di Silvia, una cara amica che anche lei conosce. Margherita riconosce con sgomento il giovane: è Marco, un soggetto sieropositivo in cura da più di due anni presso il centro dove lei lavora. Con apparente noncuranza inizia a interrogare la figlia cercando soprattutto di capire quali siano i rapporti fra i due giovani. La figlia le riferisce che l'amica è molto affascinata dal ragazzo, che appartiene a una famiglia molto agiata, studia all'università e risulta essere una persona seria e squisita. Stimolata dalla madre, le confida che Silvia ha rapporti sessuali con lui e che assume la pillola anticoncezionale.
Il giorno seguente Margherita, ancora sconvolta, parla dell'accaduto con il primario del reparto e insieme decidono di convocare Marco, con la scusa di dover anticipare di una settimana l'appuntamento previsto per il follow up. Naturalmente l'argomento è già stato affrontato: tutti i soggetti sieropositivi vengono ripetutamente sensibilizzati e informati sui rischi di trasmissione sessuale della malattia e viene offerta la possibilità di invitare al colloquio presso l'ambulatorio anche i loro partner.
Nei giorni successivi Margherita decide di parlare con Silvia, con la quale ha abbastanza confidenza. La fa
176
invitare a casa dalla figlia e la storia viene fuori facilmente: Silvia parla e racconta volentieri; Margherita riesce a rivolgerle quelle domande che servono, purtroppo, a fugare gli ultimi dubbi. Il giorno fissato per la visita Marco si presenta all'ambulatorio; alle domande specifiche e dirette che Margherita e il primario gli rivolgono si meraviglia ed esprime fastidio, dichiara di non frequentare alcuna ragazza e chiude bruscamente l'argomento assicurando di essere ben a conoscenza dei rischi di un comportamento sessuale non corretto. Quella notte Margherita non dorme e riflette sui fatti: dai molti elementi acquisiti si possono sicuramente escludere casi di omonimia e somiglianza fisica con Marco; Silvia ha parlato molto chiaramente di tutta la storia, compresi i rapporti fisici esistenti tra loro, Marco ha invece negato tutto. Cosa fare? Parlare subito e molto francamente con Silvia, violando, nell'interesse della ragazza, la privacy di Marco? Mettersi in contatto con la famiglia di Silvia, anche se lei è maggiorenne, per evitare alla ragazza il trauma diretto della rivelazione? Affrontare Marco con decisione, dicendogli che lei conosce tutta la verità e intimargli di chiarire tutto subito? Con quali garanzie, però?
Margherita pensa anche a se stessa e alla figlia, che non vorrebbe minimamente coinvolgere nella vicenda. Il giorno seguente Margherita decide di sottoscrivere un'accurata relazione dei fatti; parla con il primario e insieme decidono di rivolgersi al Garante per la privacy per ottenere il consenso a rivelare lo stato delle cose.
L'epidemia dell'AIDS ci costringerà a cambiare anche l'etica medica? È la domanda più generale che possiamo aggiungere a quelle specifiche che si pone l'infermiera nel caso clinico da cui abbiamo preso le mosse. Alcune delle norme di comportamento a cui devono attenersi i sanitari, elaborate nel corso di secoli, sono uscite inalterate, anzi piuttosto rafforzate, dal loro incontro con questa nuova malattia infettiva. È il caso, in particolare, dell'obbligo del sanitario di prestare la propria opera dando la priorità al beneficio del malato (il principio di beneficence, teorizzato dalla bioetica anglosassone), piuttosto che alla propria autotutela. All'inizio del contagio si sono avute notizie ― sporadiche, per la verità, ma non per questo meno allarmanti ― di medici e infermieri che, sotto la spinta emotiva delle "demonizzazioni" a cui la malattia è stata soggetta nell'opinione pubblica e delle inesatte informazioni allarmistiche diffuse in una prima fase sui pericoli di contagio, si sono rifiutati di prestare le cure sanitarie a persone affette da AIDS o sieropositive.
Di fronte al pericolo di smantellamento di uno dei capisaldi dell'etica medica tradizionale, gli organismi professionali hanno reagito richiamando gli obblighi morali che vincolano i sanitari a dare la priorità al bene del paziente. Si tratta delle regole tradizionali, che i medici hanno già stabilito quando peste e vaiolo facevano strage. Valga, a titolo di esempio, l'elencazione delle norme deontologiche ribadite dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici in Francia, già nel marzo 1987. Secondo tali norme, in caso di AIDS i medici sono tenuti a "curare con la stessa coscienziosità e lo stesso rispetto ogni malato, qualunque siano le sue condizioni, la sua reputazione e i sentimenti che ispira: la quantità delle cure non può dipendere dall'amore del medico e dalle sue simpatie; rispettare e far rispettare le misure igieniche e profilattiche attualmente stabilite per il personale curante: questo non deve, a causa di negligenze, correre un rischio aggravato di contagio". Senza incertezze, viene ribadito il punto cardine del rapporto professionale in sanità: il bisogno del malato rappresenta una domanda a cui medico e infermiere non si possono sottrarre, neppure se le attività di cura rappresentano un rischio personale.
Su altri punti del comportamento professionale si sono abbandonate senza esitazioni le norme tradizionali. Così è avvenuto rispetto alla comunicazione della diagnosi al malato. Fino a un recente passato, il sottrarre la verità al malato, quando questa era per lui traumatica o infausta, era considerato non solo legittimo, ma doveroso. In questo senso si esprimeva la Corte d'appello di Milano in una sentenza del 16 ottobre 1964, a proposito di una causa in cui l'informazione prima di un'operazione chirurgica a rischio era stata data ai familiari, e non alla persona interessata: "Risponde ai criteri di ragionevolità che devono caratterizzare la valutazione dei fatti umani oltre l'astrattezza e il formalismo delle norme, che il chirurgo taccia al malato la
177
gravità del suo male e il rischio che un'operazione comporta, criterio sanzionato da una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi e consacrata nei principi deontologici secondo cui il celare aU'ammalato la nuda verità è precipuo dovere, forse il più nobile, del medico cui spetta di vagliare ciò che il paziente debba sapere e quanto debba essergli nascosto".
Basta pensare alla prassi diffusa nei confronti di malattie oncologiche per rendersi conto di quanto questo orientamento guidi ancora l'operato dei medici. Ma nell'ambito dell'infezione da HIV non si è dubitato neppure un istante che, per quanto traumatica e infausta l'informazione possa essere per il malato, questa gli è dovuta. Ed è dovuta a lui, e a nessun altro. Più che la prospettiva dei diritti civili e l'accettazione del nuovo modello di rapporto che si ispira al "consenso informato", in questo caso ha influito la necessità di responsabilizzare il portatore del virus infettivo, affinché assuma i comportamenti adeguati per evitare di propagare il contagio.
Qualunque sia la motivazione, resta il fatto che "una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi e consacrata nei principi deontologici" ― come si esprimeva enfaticamente il Tribunale di Milano ― non è stata neppure presa in considerazione nel caso dell'AIDS. Ha avuto luogo un superamento della menzogna ― o bugia pietosa, o restrizione mentale, comunque la si voglia concettualizzare ― quale comportamento atteso dal medico. Dare false rassicurazioni sarebbe gravemente scorretto dal punto di vista etico (oltre che probabilmente perseguibile da quello penale).
Possiamo a questo punto chiederci come si situi il capitolo tradizionale dell'etica medica relativo al segreto professionale: fa parte dei comportamenti che hanno superato indenni la crisi dell'AIDS o di quelli che vanno rimessi in discussione? Alcuni elementi del quadro sociale contribuiscono a rendere più acuta la problematica del segreto connesso con l'infezione da HIV. Si sono diffuse notizie allarmistiche su soggetti recalcitranti a ogni misura di autocontrollo, i quali vengono quindi a costituire una minaccia per la salute pubblica.
Forse alcune di queste notizie possono essere messe sul conto delle "leggende metropolitane", come quella che ― in contesti diversi ― parla di un uomo o di una donna infettati che, per spirito di vendetta, hanno deliberatamente rapporti sessuali con molte persone, al fine di trascinare il più gran numero con sé nella rovina (è diventato un piccolo classico dell'angoscia dei nostri giorni il racconto della persona che, dopo un incontro occasionale, si risveglia sola il mattino seguente e trova scritto sullo specchio del bagno: "Benvenuto nel mondo dell'AIDS"....). Anche se è prudente fare la tara a questi racconti, non si può negare che diversi operatori ― medici, psicologi, assistenti di comunità ― conoscono casi, che fanno parte della propria esperienza professionale, di persone sieropositive che rifiutano di informare il coniuge o partner e proibiscono al sanitario di farlo. È il caso della caposala Margherita. Situazioni di questo genere creano conflitti morali estremi nei sanitari, che si sentono complici di fatto di un grave danno infetto a degli innocenti.
Alcune delle spinte a rimettere in discussione il vincolo del segreto professionale vengono da interessi di terze parti, come le assicurazioni o i datori di lavoro, che vorrebbero conoscere la condizione sierologia delle persone per fini diversi da quelli del medico. La normativa italiana ha ritenuto opportuno ribadire, anche nel caso di malati di AIDS, il vincolo del segreto professionale (legge 135/1990: Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS). Ma l'etica non può limitare il suo sapere argomentato alle norme giuridiche: deve trovare nell'ambito dei valori quanto serve a motivare i comportamenti. Ora, proprio la tutela del segreto medico illustra il conflitto insanabile tra valori contrapposti che si può instaurare in alcune situazioni.
Nel paragrafo dedicato al trattamento delle malattie mentali (p. 193) presenteremo diffusamente un caso da manuale per illustrare i conflitti che si possono addensare attorno al segreto professionale. Con tutte le differenze, il caso Tarasoff porta un contributo rilevante all'inquadramento della problematica del segreto nei rapporti con i malati di AIDS. Emerge la natura pro-sociale, e non solo individualistica, del segreto medico. A chi ritiene che il segreto in medicina sia inflazionato, avendo assunto l'aura sacrale del segreto religioso della confessione, si può
178
contrapporre la natura essenzialmente utilitaristica del vincolo posto al sanitario. Esso è sorto ben prima che in medicina si annunciasse quella "rivoluzione liberale" che ha portato anche nell’ambito delle cure mediche la rivendicazione dei diritti personali. Il segreto professionale è nato dalla convinzione che non c'è medicina senza fiducia, non c'è fiducia senza confidenza, non c'è confidenza senza segreto.
Che cosa fare quando il segreto diventa intollerabilmente pesante da portare, come nelle situazioni in cui la volontà della persona contagiata di non informare i propri intimi mette questi ultimi pesantemente a rischio? L'aneddotica in merito è molto ricca. Si pensi al caso di un medico che conosce la sieropositività di un proprio paziente e sa che la ex moglie di questi, ora separata, ha contratto un nuovo matrimonio e ha intenzione di affrontare una gravidanza. È moralmente tollerabile il vincolo del segreto anche in situazioni così estreme, dove il silenzio si traduce in una pratica complicità a danno di innocenti? Il segreto ha un carattere assoluto, oppure il suo mantenimento dipende da una valutazione di opportunità da parte dell’operatore? Ma se il segreto è lasciato alla sua discrezione, è ancora un segreto?
Possiamo rendere visivamente più perspicua questa impostazione immaginando che tra la regolamentazione del comportamento medico propria della lunga stagione dell'etica medica e quella nata con l'emergere della bioetica ― la prima quale espressione del paternalismo medico, la seconda prodotta dall'ingresso in medicina dai valori dell'autodeterminazione delle persone, che sono propri dell'epoca moderna ― si crei un campo di tensioni feconde, che sono oggetto di una continua contrattazione. L'etica medica, guidata dall'ideale che consiste nel procurare il maggior beneficio possibile al paziente, non aveva altro vincolo che ciò che il medico ("in scienza e coscienza") riteneva benefico per il malato. Con la bioetica lo scenario della relazione terapeutica si è modificato. Sono entrate a pieno diritto le preferenze del paziente, che fanno riferimento al suo universo morale, ai suoi valori e al suo modo di intendere la vita.
Ciò non vuol dire che ci muoviamo sempre a grandi altezze... Come dimostrano i casi che suscitano tanta perplessità morale nei sanitari, i valori di pazienti che preferiscono mettere a repentaglio la vita del proprio partner, piuttosto che compromettere la propria rispettabilità, si collocano ben al di sotto dei valori minimi della decenza morale. Ma proprio questa complessità, dovuta all'irrompere in medicina degli universi morali soggettivi, porta a valorizzare la partecipazione attiva della coscienza morale del sanitario. Tra chi offre cure e assistenza ― medico, infermiere, psicologo, assistente sociale ― e chi ne beneficia si apre uno spazio di contrattazione. La soggettività del paziente, con i suoi valori e disvalori, attiva la soggettività del sanitario. Questi può far valere le proprie condizioni per prestare assistenza, senza che ciò possa essere qualificato come un’espressione di arroganza che deriva dal potere. La difesa dell'"etica del minimo", al di sotto della quale si diventa complici della sopraffazione, può essere una delle condizioni per mantenere o revocare il patto di solidarietà con il malato. Non è un ricatto da parte del professionista sanitario negare la propria prestazione professionale se il paziente con il suo comportamento mette in pericolo la vita o la salute di altri: è un modo di far valere la dimensione soggettiva del terapeuta. Questi non è una "macchina per guarire", ma una persona con valori morali e visioni soggettive di comportamenti accettabili e non accettabili, che può e deve far entrare nel rapporto terapeutico.
179
capitolo
13
DONAZIONE DI ORGANI E TRAPIANTI
LA MARCIA TRIONFALE DELLA MEDICINA DEI TRAPIANTI
Chi concepisce lo sviluppo della medicina come un itinerario in progressione continua, dove gli ostacoli apparentemente insormontabili vengono abbattuti l’uno dopo l'altro, con realizzazioni sempre più audaci e spettacolari, trova nella storia dei trapianti d'organo un'illustrazione particolarmente adatta alla tesi. Fino al 1959, per esempio, il trapianto tra gemelli identici sembrava l'unico possibile nell'uomo. Tutti i trapianti allogenici di rene precedenti a quella data erano terminati con un insuccesso, a causa della reazione immunologica del ricevente, nota come "rigetto". Nel 1959 furono realizzati due trapianti di reni tra falsi gemelli, uno a Boston, l'altro a Parigi. L'altra data fatidica è il 1967, quando un oscuro chirurgo di un ospedale sudafricano, Christian Barnard, realizzava il primo trapianto cardiaco. Da allora i trapianti hanno conquistato la prima pagina dei giornali e non hanno più abbandonato questo primato di notorietà.
L'esito precario dei primi tentativi non impedì che il fenomeno dei trapianti assumesse fin dall'inizio le caratteristiche che dovevano poi accompagnarlo anche in seguito: risonanze emotive profonde e vasta ripercussione nell'opinione pubblica; dibattito appassionato, all'interno dell'ampio spettro delle opinioni, sulla liceità morale e sulle risonanze sociali ed economiche delle pratiche; "vedettismo" esasperato dei protagonisti ― chirurghi, malati, familiari ―, presi nell'ingranaggio sensazionalistico dei mass media.
Lo schema del progresso medico lineare è particolarmente adatto a suscitare rifiuti o adesioni aprioristiche, a seconda del diverso atteggiamento nei confronti dell'ideologia del progresso. Chi si aspetta da quest'ultimo, inteso come un susseguirsi di nuove conoscenze scientifiche e capacità tecniche, la risposta ai mali dell'umanità, avrà una reazione diversa da chi guarda al progresso con diffidenza, considerandolo una minaccia alla sapienza rispecchiata dalla tradizione. "Sono convinto ― scriveva Keith Reemtsma all'inizio delle violente polemiche sui trapianti ― che il primo uomo delle caverne ad aver trapanato un cranio fu violentemente criticato per il suo tentativo di operazione inedita senza sperimentazioni animali previe e coincindenti, e accusato di aver abbandonato il trattamento medico abituale di piume di gufo polverizzate, d'aver goduto di una troppo ampia pubblicità e dilapidato i fondi pubblici rifiutando di adottare il trattamento di collane di denti di tigre, di essersi immischiato nei disegni misteriosi del Grande Spirito, e soprattutto, è ovvio, d'aver prolungato la vita di un individuo inadatto, e con ciò d'aver messo a repentaglio l'avvenire della razza Cro-Magnon". Sotto la deformazione della satira, sono riconoscibili i principali problemi dibattuti a ogni svolta della vicenda dei trapianti.
180
Il rischio medico, in primo luogo. Anche se l'introduzione della ciclosporina nel trattamento ha reso possibile il controllo del fenomeno del rigetto, i successi continuano a essere pagati con un’alta quota di fallimenti. La questione della liceità morale del trapianto in condizioni di rischio è ovviamente acuta quando si tratta del dono d'un organo da parte di un vivente, minima invece nell'impianto di un organo tratto da un cadavere, quando il trapianto è l'unica chance di sopravvivenza che si può offrire al malato.
Per alcuni l'interrogativo della liceità si pone anche nel caso del trapianto da un animale in un essere umano. Il dibattito è divampato per Baby Fae, la bambina neonata il cui cuore è stato sostituito con quello di un babbuino. La morte del "donatore", in questo caso necessaria e procurata, non è apparsa eticamente giustificabile a quanti hanno maturato nei confronti degli animali un atteggiamento diverso da quello della prospettiva che li considera unicamente come materiale biologico a servizio dell'uomo. Le riserve, in particolare, erano acuite dal fatto che in trapianti di questo genere il carattere sperimentale predomina su quello clinico. Ambedue gli aspetti problematici dei trapianti sono oggi argomento di dibattito a proposito degli xenotrapianti (utilizzo di animali geneticamente modificati per trapiantare organi all’uomo): si nutrono dubbi sulla sicurezza di questa pratica per la specie umana e per alcuni è inaccettabile eticamente la prospettiva che considera gli animali come cava di organi per gli esseri umani.
In ambito medico l'assunzione del rischio e l'audacia dell'intervento non sono incompatibili con l'ethos del sanitario. Se si fosse atteso che il problema della tolleranza degli innesti fosse stato preliminarmente risolto, non saremmo pervenuti alle conoscenze attuali, superiori a quelle acquisibili per mezzo della ricerca biologica fondamentale. Il corretto procedimento richiede che il malato sia informato dei rischi e delle chances. Di fronte alla prospettiva di una morte imminente e certa, molti malati acconsentono a un trattamento sperimentale, anzi lo sollecitano. Il loro consenso ha il carattere di un'ultima mossa nella partita a scacchi contro la morte, con la speranza che, anche se risulterà perdente, le conoscenze acquisite andranno a beneficio di altri malati.
Anche il problema dei costi è stato puntualmente sollevato a ogni tappa dello sviluppo della pratica dei trapianti. L'accento messo dai mass media sull'aspetto umanitario dell'intervento non riesce a tacitare chi si ostina a chiedere i conti. Una politica sanitaria responsabile deve affrontare una programmazione che sappia scegliere tra medicina di punta e investimenti sulla prevenzione.
Non va dimenticata, infine, la dimensione antropologica del dibattito. La pratica dei trapianti ha investito in senso demitizzante organi dotati di alta valenza simbolica. Il cuore, per esempio, da simbolo dell'affettività e della dimensione di profondità della persona è stato ridotto alla funzione di pompa che va sostituita quando è difettosa: come un pezzo di ricambio di un qualsiasi elettrodomestico. Una forte reazione alla febbre dei trapianti è alimentata dal timore di vedere l'essere umano ridotto a una macchina che si può smontare e rimontare a piacere. Oltre ai trapianti di organo ― cuore, reni, fegato, pancreas, midollo e altri tessuti ― la tecnologia biomedica ha reso disponibile una quantità di organi artificiali: dal cristallino di plastica per i malati di cataratta al cuore metallico a batteria, dagli arti elettronici alla pelle di poliuretano.
Gli interrogativi più inquietanti sorgono proprio nella prospettiva che la pratica dei trapianti e degli organi artificiali di sostituzione debba avere successo e diffondersi a percentuali sempre più rilevanti della popolazione. Ha tutti i tratti di un'utopia negativa immaginare un giorno in cui l'umanità sia costituita da una maggioranza di persone con organi trapiantati o artificiali, a sostituzione dei propri, malati o usurati, ma con il cervello senile. Oltre alla questione dei mezzi finanziari per sostenere una tale impresa, sorge un interrogativo fondamentale: è desiderabile un tale obiettivo per l'umanità stessa? La battaglia contro la morte condurrebbe a una vittoria
181
molto discutibile, in quanto il prodotto di rappezzamenti sarebbe piuttosto simile a una caricatura di essere umano. Il rapporto costi-benefici dovrebbe essere denunciato come sbilanciato, più che in senso economico, in senso antropologico.
LA SOCIETÀ SI INTERROGA
Parallelamente alla normalizzazione della pratica dei trapianti ― nel giro di pochissimi anni un intervento di natura tanto audace da meritare di essere catalogato tra i "miracoli" laici della moderna tecnologia biomedica ha perso il carattere di sperimentazione ed è diventato routine ― la società veniva confrontata con problemi nuovi. Non si trattava più di trovare una legittimazione morale ai trapianti, ma di affrontare gli aspetti organizzativi che ne derivano.
Secondo il suggerimento autorevole di J. Hors, segretario nazionale di France Transplant (Hors, 1995), possiamo suddividere il capitolo dei trapianti nella storia della medicina in tre ere. Se consideriamo, infatti, il rapporto che i trapianti di organo hanno con la società, si può rilevare uno svolgimento ciclico ricorrente, qualunque sia l'organo o il Paese. In una prima fase ― che potremmo chiamare l'era dei pionieri ― l'immagine dei trapianti che si riflette attraverso i media e i sondaggi d'opinione è esaltante; l'opinione pubblica risponde con la meraviglia per la padronanza della tecnica e ricolma di lodi i medici che si dedicano ai trapianti. Dal punto di vista organizzativo, la priorità assoluta va ad assicurare la diagnosi di morte cerebrale 24 ore su 24. In questo stadio le regole per la ripartizione degli organi sono rudimentali.
La fase successiva è l'era dei coordinatori. Dopo che il trapianto di organi è diventato un intervento terapeutico di routine, la preoccupazione si sposta sull'organizzazione. Là dove questa ha successo, la pratica dei trapianti conosce uno sviluppo esponenziale. È quanto è avvenuto negli anni Ottanta, fino ai primi anni Novanta. Un ruolo centrale spetta al coordinatore: sia nell'informazione rivolta al grande pubblico e ai medici, sia nella verifica dei dispositivi di prelievo nei centri autorizzati, sia infine nella preparazione di nuovi centri. In questa fase dello sviluppo le legislazioni europee cominciano a dare risposte normative, pur divergendo nelle condizioni poste per autorizzare i prelievi e nel ruolo da attribuire alla famiglia e al consenso al trapianto.
La terza era ― sempre seguendo la periodizzazione proposta da Hors ― è quella del cittadino. L'atteggiamento del grande pubblico ha cominciato a modificarsi. Oltre a un bisogno di sicurezza, che si traduce nella richiesta di conoscere i rischi di contrarre malattie infettive con il trapianto d'organo o di tessuto, due altri bisogni si impongono in questa fase: quello della trasparenza e il bisogno di un'etica universale. La trasparenza è richiesta soprattutto nei criteri di allocazione degli organi. La disperazione dei malati posti in lunghe liste d'attesa ― anche più di 10 anni per avere il trapianto di un rene ― nutre il sospetto circa la scelta dei donatori. L'euforia filantropica propria dell'era dei pionieri cede il posto ad atteggiamenti di esplicita xenofobia: non si vogliono privilegiare i non residenti o, per quanto riguarda l'Italia, i cittadini di quelle regioni che si dimostrano totalmente insensibili al reperimento degli organi.
Un altro punto caldo del dibattito è diventato quello dell’etica sottostante alla pratica dei trapianti. Mentre le associazioni dei donatori continuano a proporre l'ideale di un dono gratuito, anonimo e liberamente consentito, la società deve affrontare il pratico diffondersi di un mercantilismo che si affianca al modello della gratuità: gli organi vengono venduti e comprati, in transazioni che superano i confini nazionali e coinvolgono donatori viventi spinti dalla miseria a vendere un organo per sopravvivere. Nello stesso tempo si fanno sentire voci di protesta di cittadini che giudicano la pratica dei trapianti inaccettabile da un punto di vista sia antropologico (dissenso sul criterio cerebrale nel riconoscimento della morte), sia etico. Si veda in Italia, in tal senso, le vivaci battaglie condotte dalla "Lega contro la predazione degli organi".
182
Nel nostro Paese l'era del cittadino è particolarmente turbolenta. Ciò spiega in buona parte il lungo travaglio che è stato necessario per raggiungere un consenso sulle modifiche da apportare alla legge del 1975, ritenuta unanimemente superata; tuttavia fino al 1999 non si è riusciti a varare una nuova legge. L'opinione pubblica sembra aver abbandonato l'entusiasmo degli inizi ed esprimere sempre maggiori riserve. L'inversione di segno nell'opinione pubblica è stata influenzata soprattutto dalle notizie relative a comportamenti condannabili dal punto di vista morale: commercio di organi, prelievi non autorizzati, addirittura omicidi perpetrati per avere "pezzi d'uomo di ricambio".
Quante di queste notizie sono fondate e attendibili? Quanto va, invece, addebitato alla fiorente fabbrica delle "leggende metropolitane", quelle storie false ma verosimili che si diffondono a macchia d'olio tra la gente, senza possibilità di esercitare su di esse un controllo? Coloro che per mestiere devono fornire le informazioni, nei giornali o alla televisione, molto spesso non sono d'aiuto per rispondere a queste domande. I trapianti hanno cattiva stampa, nel duplice significato dell'espressione: se ne parla male, e se ne parla in modo incompetente. Giornalisti e conduttori televisivi non si impegnano a riportare il discorso sulla terra ferma dei fatti e della ragione. Rimestano nelle emozioni, aggiungendo tocchi di colore. Si diffonde così presso il pubblico ― che in Italia non ha mai brillato per il grado d'informazione scientifica ― un'immagine grossolana delle pratiche dei trapianti. Il coma viene confuso con la morte cerebrale. Si accredita la fantasia di pratiche di prelievo di organi fatte artigianalmente nelle camere mortuarie, quando invece proprio la tecnologia richiesta impedisce la clandestinità.
Cresce così la diffidenza verso ogni forma di trapianto. I medici che li eseguono sentono aumentare il malessere attorno a sé, quasi fossero dediti a un'attività riprovevole. Non li circonda più l'aureola dei tempi dei pionieri. La disponibilità a donare organi decresce. L'Italia è in Europa il Paese con minor numero di donazioni, seguita solo dalla Grecia. Il futuro è ancor più nero, in quanto non si avverte un'inversione di tendenza e i Paesi europei ai quali eravamo soliti rivolgerci per i trapianti hanno dichiarato che non sono più disponibili a fornirci organi, in assenza di un impegno da parte nostra a favore delle donazioni.
LA CULTURA DEL DONO
Il dibattito intorno ai trapianti di organo ha avuto il merito di portare in piena evidenza i valori positivi sottesi a questa pratica. L'incapacità dell'etica medica tradizionale di giustificare, con i suoi principi, il prelievo di un organo da donatore vivente ha provocato un ampliamento di orizzonte. L’intervento chirurgico era ipotizzato in passato solo a favore di colui che lo affrontava, e giustificato in ragione del vantaggio per la salute che ne riceveva. Sempre in questa prospettiva, era considerata lecita anche una mutilazione, purché ne risultasse un beneficio per l'individuo come totalità psico-organica. In questo caso non è più considerato un arbitrario atto dispositivo del proprio corpo, ma acquista un valore terapeutico.
Che valenza terapeutica può avere l’espianto di un proprio rene sano, a beneficio di un congiunto che ha i propri irrimediabilmente malati? L'esitazione dei moralisti ad accettare la legittimità del dono da un vivente di un organo doppio ― quella di un organo dispari, essenziale per la vita o per la salute, non è stata mai presa in considerazione, perché presupporrebbe il suicidio del donatore ―, non è senza fondamento. Per l'etica medica tradizionale la cura dell'integrità della propria vita fisica impone che non si disponga del proprio corredo biologico in modo autolesionistico, provocando un danno grave o una deformazione indelebile al proprio corpo (riserve di questo genere non esistono ovviamente per il dono del sangue, che si rigenera). Perché la rinuncia a un organo prezioso come il rene, implicante una limitazione irreversibile in colui
183
che se ne priva, possa essere giustificata, bisogna andare oltre il principio dell'integrità personale e accedere a una dimensione in cui l'orientamento al bene dell'altro determina la moralità dell'azione. In questo caso al principio della difesa della propria integrità si sostituisce il principio di carità, come ispiratore di un comportamento nobile e altruista.
Affinché il trapianto di organi avvenga in un contesto di alta ispirazione ideale, bisogna che la pratica sia preservata da ciò che può inquinarne la nobiltà; è necessario inoltre, positivamente, che sia promossa una cultura del dono. Riguardo al primo aspetto, l'imperativo fondamentale è quello di evitare ogni commercializzazione degli organi. È un problema che non si pone nel nostro Paese, dove la legge vieta una tale compravendita. La legge 458 del 1967, relativa ai trapianti di rene da vivente, cita esplicitamente come condizione che avvenga "a titolo gratuito". In altri Paesi, come negli Stati Uniti, in assenza di una norma legislativa di questo tenore, avvengono domande e offerte relative a organi da trapiantare, nonché al sangue per le trasfusioni. Un commercio di questo genere appare turpe alla nostra sensibilità, in quanto necessariamente fondato sullo sfruttamento della miseria abbinata alla disperazione. "La miseria offre, la società risponde": con questa formulazione a effetto già Victor Hugo condannava nel romanzo I miserabili lo scontro economico che portava le donne più povere a vendere perfino i capelli per farne parrucche per i ricchi.
La clausola della gratuità è moralmente obbligante anche nel caso di trapianto da cadavere. Le associazioni finalizzate a promuovere una cultura della donazione ― prima tra tutte in Italia l'AIDO: Associazione italiana donatori d’organi ― mettono esplicitamente in evidenza il senso di solidarietà a favore dei malati che hanno bisogno di organi da cadavere per poter sopravvivere. Debitamente informate ed educate, molte persone si rendono conto dell'utilità del proprio organismo, o di sue parti, anche dopo la morte. Anche genitori straziati per la morte di un figlio trovano una qualche consolazione nella prospettiva che almeno un suo organo sia determinante per la vita di un'altra persona.
L'etica dei trapianti ha enfatizzato la cultura del dono, quale ispirazione morale, ma ha poco approfondito la natura antropologica del dono stesso. Nel dono si riflettono alcuni tratti di quella complessa rete di rapporti che costituisce la società. È quanto osservò l'antropologo culturale e sociologo Marcel Mauss in un celebre scritto apparso nel 1923: Saggio sul dono: forma e motivi dello scambio nelle società arcaiche. Il contributo di Mauss ha una forma che sembra quasi definitiva, tanto che pochi studiosi hanno ripreso l'argomento. C'è da segnalare, all'inizio degli anni Settanta, la riflessione di Titmus, riferita soprattutto al dono del sangue (Titmus, 1971). Più di recente ha rivisitato il tema del dono il sociologo francese Jacques Godbout, in un'opera imponente: Lo spirito del dono (Godbout, 1993).
A suo avviso, il dono è una categoria che ci permette di capire il funzionamento non solo delle società arcaiche, ma anche di quella contemporanea. Il punto di partenza di questa riflessione è fornito dalle conclusioni di Mauss, secondo il quale nelle società arcaiche il dono ha la funzione di "fatto sociale totale": esso mette in moto la totalità delle società e delle sue istituzioni. Il dono è espressione dello scambio sociale e costituisce la precondizione perché una società sia possibile.
La fenomenologia delle nostre società è ovviamente diversa. La solidarietà allargata si esprime in altre forme rispetto a quelle riscontrabili nei raggruppamenti sociali arcaici; le moderne democrazie, per esempio, hanno risposto ai bisogni di salute, sicurezza e assistenza attraverso la creazione del welfare state. Tuttavia il dono ― inteso in senso ampio, non solo come regalo, ma includendo anche ogni bene e servizio ― continua a rimanere centrale anche nell'organizzazione della società.
La principale differenza tra il dono arcaico e quello che esprime il principio della ridistribuzione universalistica dei beni nelle nostre società è che il nostro è un dono senza destinatario. Lo Stato sociale non distribuisce i beni nel modo in cui essi circolano nelle società primarie (di cui la famiglia è l'istituzione centrale). La solidarietà moderna accentua la separatezza, l'indipendenza degli
184
attori sociali. Nella ridistribuzione dei beni promossa dallo Stato, gli individui sono sottratti dal sistema di interdipendenza che vige nelle reti che nascono dai legami primari: la solidarietà che lega i cittadini nello Stato sociale è diversa da quella che vige all'interno di una tribù o di una famiglia; essa presuppone tra loro una "estraneità" analoga a quella che regola i rapporti tra sconosciuti.
Tenendo presente lo scenario dello Stato sociale, che costituisce una novità nell'organizzazione della convivenza, possiamo affermare che la circolazione dei beni e servizi contribuisce al legame tra gli individui nella società in tre modi diversi e inconfondibili (cfr. Di Nicola, 1994). C'è la modalità del sistema reciprocità-dono, che vediamo realizzato nelle società arcaiche e permane sempre attuale nella famiglia. Esso si fonda sul principio che il dono crea il debito in colui che lo riceve; beni e servizi nella loro circolazione legano le persone direttamente le une alle altre. All'estremo opposto troviamo il mercato, in cui i beni circolano indipendentemente dal legame tra le persone: la transazione si conclude con lo scambio tra merci e denaro, senza alcuno strascico di rapporti interpersonali. In posizione intermedia si situa la modalità di circolazione dei beni che ha lo Stato come promotore. In questa dimensione i soggetti, liberati dai legami interpersonali diretti, sono trattati secondo il principio dell'uguaglianza e ricevono in base ai loro bisogni, senza tuttavia che si crei il debito e l'obbligo della riconoscenza che si ha quando il dono ha un destinatario diretto.
Mercato, Stato e sfera della reciprocità sono retti da principi diversi, non riconducibili l'uno all'altro e non interscambiabili. Proprio la situazione del bene costituito dagli organi per i trapianti può illustrare le tre diverse modalità. In condizione di mercato, l'organo è considerato un bene oggetto di transazione economica: colui che offre e colui che acquista sono in contatto solo in vista del passaggio della merce dall'uno all'altro. Onorato il contratto, non c'è debito e non c'è riconoscenza. Nel caso invece di una donazione di organo all'interno della famiglia (rene da vivente, trapianto di midollo...), il legame rinforza quello esistente, col risultato di portare l'interdipendenza a punte parossistiche (complicate talvolta da ricatti morali, colpevolizzazioni del familiare renitente al dono, senso esasperato di debito in colui che accetta il sacrificio o il rischio del familiare donante...).
La donazione di organi come pratica inserita nella cura della salute offerta dallo Stato, pur nelle diverse organizzazioni del servizio sanitario, garantisce il criterio universalistico di accesso alle risorse, senza tuttavia creare dei legami. Il destinatario di un organo donato, infatti, abitualmente non sa da dove proviene il dono, né è tenuto a contraccambiare, come sempre avviene quando si crea un senso di debito. La stessa organizzazione di strutture che gestiscono il dono degli organi mira a evitare le personalizzazioni del dono stesso e a impedire che questa pratica graviti entro il sistema reciprocità-dono che è proprio dei legami interpersonali.
Malgrado la persistenza del dono nelle forme di convivenza sociale moderne e post-moderne in cui si concretizza il bisogno primario insuperabile di legami basati sulla interdipendenza, per noi oggi ha un valore centrale il meccanismo di solidarietà allargata e istituzionalizzata gestita dallo Stato. Solo questa modalità di "dono" può garantire, nella moderna società complessa, i requisiti essenziali di uguaglianza e correggere le disparità più stridenti legate al censo e ai privilegi. È necessario continuare a coltivare forme di reciprocità, modernizzando le loro espressioni (il volontariato e le associazioni di mutuo aiuto sono, da questo punto di vista, eccellenti realizzazioni che attualizzano i sistemi di reciprocità-dono). Tuttavia la reciprocità non può sostituire quel sistema universalistico di distribuzione di beni e servizi che offre oggi lo Stato mediante la sua organizzazione pubblica del servizio sanitario.
Ci si può chiedere se la resistenza massiccia al diffondersi di una cultura del dono di organi che registriamo in Italia non sia riconducibile a una fondamentale diffidenza nei confronti dello Stato, a beneficio di quelle modalità di circolazione dei beni che privilegiano la reciprocità, come appunto avviene nella famiglia. L'ostilità alla donazione potrebbe così essere interpretata come
185
un segno ulteriore di quel ritardo nella maturazione di un senso civico dello Stato, che caratterizza la cultura italiana.
Una considerazione, infine, merita la proposta di sostenere il passaggio verso la concezione solidaristica che presuppone lo Stato sociale ricorrendo a forme di incentivazione. Una di queste può essere costituita dalla creazione di un particolare "circuito della solidarietà", nel quale condividere oneri e vantaggi. Ciò presuppone, in pratica, la possibilità per coloro che non sono disponibili per ricevere e donare gli organi di escludersi dal circuito. Questa possibilità negativa diventa sempre più urgente nella società multietnica e pluriculturale nella quale viviamo. Nello stesso tessuto sociale convivono degli "stranieri morali", vale a dire persone che non condividono le stesse convinzioni e non si orientano secondo gli stessi ideali di "buona vita". Per alcuni ricevere e dare organi è un tabù o una via impraticabile dal punto di vista morale. Una società pluralistica deve trovare il modo di rispettare queste scelte.
In senso positivo, la richiesta di essere inclusi nel circuito della solidarietà, per quanto riguarda la circolazione di quel bene raro che sono organi e tessuti del corpo umano, comporta la scelta di rendersi disponibili al prelievo per poter beneficiare del dono. Lo strumento del circuito privilegiato per la donazione e il trapianto si situa a metà strada tra lo strumento pedagogico dell'incentivazione e la misura amministrativa per ottimizzare l'uso di risorse scarse.
La creazione di due circuiti ― quello di coloro che si escludono sia dall'utilizzo degli organi che dal loro dono e il "circuito della solidarietà", che implica la disponibilità attiva e passiva a far propria questa pratica ― è un'idea quanto meno degna di essere discussa. Per vedere meglio i problemi che crea (dobbiamo considerare i circuiti rilevanti solo per gli individui o anche per le famiglie? come collochiamo i bambini?), ma anche per esaminarne la praticabilità sociale. Un punto emerge con chiarezza: se si vuol evitare di creare due classi di cittadini, è necessario che la scelta di appartenere a l'uno o all'altro circuito sia pienamente informata e consapevole. Non possiamo evitare, perciò, di passare attraverso un dibattito che coinvolga tutta la società e giunga capillarmente a ogni cittadino, permettendogli di decidere con piena consapevolezza a quale circuito iscriversi.
DEONTOLOGIA ED ETICA A TUTELA DEI TRAPIANTI
Nei codici deontologici dei professionisti sanitari la pratica dei trapianti è considerata positivamente. È previsto l'impegno sia dei medici che degli infermieri in questa direzione. Alcune norme deontologiche che accompagnano la pratica dei trapianti meritano una segnalazione. Indichiamo in primo luogo quella contenuta nel documento dell'Associazione medica mondiale dedicato alla determinazione del momento della morte (Sydney, 1968): "Qualora il trapianto di organi sia possibile, la decisione che la morte è presente dovrà essere presa da due o più medici, e costoro non dovranno essere gli stessi medici che eseguiranno l'operazione di trapianto". La finalità di questa indicazione comportamentale è sia di tutelare l'emotività del medico, sia di salvaguardare la reputazione sociale dei trapianti. Se il chirurgo che effettua il trapianto fosse lo stesso che partecipa alla decisione di staccare il respiratore, sarebbe esposto a un notevole stress emotivo; ma soprattutto gli nuocerebbe l'inevitabile immagine di "avvoltoio" che si aggira attorno al donatore moribondo auspicando, o magari anticipando, il momento di poter entrare in azione... Un'indagine frutto di fantasie contorte, certamente; ma compito delle misure deontologiche è quello di reagire non solo agli abusi attuali e possibili nel corso della pratica medica, ma anche a quelli immaginati, sottraendo la materia da cui prendono corpo i fantasmi. La divisione delle due équipe non è dunque una formalità a servizio dell'ipocrisia, ma una misura prudenziale e protettiva.
Una pratica dei trapianti condotta con senso di responsabilità professionale porrà la debita attenzione
186
al problema del consenso tanto al prelievo quanto all'impianto dell'organo. Non solo per una correttezza formale, che evita di incappare nella legge, ma ancor più per assicurare l’esito globale del delicato procedimento. La decisione di un trapianto di organo o dell'innesto di un organo artificiale deve essere presa insieme dal medico e dal paziente. Si può ipotizzare che questi rifiuti con tutta lucidità l'intervento proposto, perché a suo giudizio i costi, compresi quelli psicologici ed emotivi, eccedono i benefici. In questo caso la decisione va ratificata e sostenuta da parte del medico, senza che il rifiuto di un intervento così straordinario sia fatto equivalere a un suicidio.
Altri malati hanno bisogno di tempo per maturare la loro decisione. Già la proposta del trapianto può essere in sé uno shock, in quanto fa prendere loro coscienza per la prima volta della gravità della malattia. Avranno bisogno di essere illuminati gradualmente sui rischi e benefici, sulle limitazioni alla libertà e la qualità della vita che si possono aspettare, perché il loro consenso sia veramente informato. Altrimenti il medico può cadere sotto il sospetto di imporre surrettiziamente al malato la propria decisione, non collimante però con quanto questi ritiene essere il proprio bene.
Una norma deontologica vivamente auspicata da molti è quella della copertura della pratica dei trapianti con il segreto professionale. I proiettori dei mass media puntati sui donatori e sui loro familiari, sui riceventi, sui chirurghi e su quanti partecipano in qualche modo ai trapianti, hanno un effetto devastante per lo stile che dovrebbe accompagnare un'attività medica. È indicativo, come segno dell'estremo a cui può giungere il malcostume, che i malati americani che stanno per essere sottoposti a un trapianto cardiaco sono invitati a sottoscrivere una dichiarazione in cui dicono di essere a conoscenza che tra i rischi a cui vanno incontro, oltre alle complicazioni possibili di tipo clinico, c'è anche quello di "essere perseguitati dalla stampa per il resto della loro vita".
Alcune volte è possibile intravedere come i chirurghi che si offrono al sensazionalismo dei mass media lo facciano non esclusivamente a servizio del proprio narcisismo, ma come mezzo di pressione politico-sociale, per ottenere le misure legislative ed economiche necessarie per la promozione di questo tipo di medicina. Tuttavia resta l'impressione di una stridente dissonanza con la norma deontologica del segreto medico, una norma pensata a vantaggio sia del paziente che della professione medica stessa.
Un'altra norma deontologica consigliabile è quella di tutelare l'anonimato di coloro che ricevono gli organi. È una misura comportamentale che non sempre viene rispettata, anzi talvolta è stata violata in modo clamoroso. La vicenda del bambino americano Nicolas Green, ucciso dai rapinatori in Calabria, i cui genitori hanno disposto la donazione di tutti i suoi organi espiantagli, si è svolta sotto i riflettori della stampa. È stato dato grande risalto ai destinatari degli organi, anche con incontri pubblici con i genitori di Nicolas. L'intenzione era quella di incentivare la cultura delle donazioni. In pratica, si vengono così a creare due registri: quello dei donatori ― e riceventi ― celebri e quello degli anonimi. La regola dell'anonimato ― esplicitamente prevista dalla nuova legge sui trapianti 91/1999, art. 18 comma 2: "Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente" ― è suggerita dalla volontà di proteggere i sopravissuti da fenomeni psicologici che sono stati descritti come "sindrome del segugio" (genitori in cerca del ricevente il cuore del proprio figlio deceduto, per alimentare l’illusione di sentire ancora battere il cuore del figlio...). Ovviamente il segreto protegge anche i riceventi da comportamenti che possono sviluppare un carattere persecutorio.
187
capitolo
TERAPIA E ASSISTENZA AI MALATI ONCOLOGICI
LA DIMENSIONE ETICA
I malati oncologici non richiedono di essere trattati secondo un'etica particolare: in tutto e per tutto, la loro condizione clinica invoca i valori e le norme che reggono il rapporto tra medico e paziente. Tale rapporto, tuttavia, è in una fase di transizione. Nei nostri giorni sta avvenendo il passaggio a rapporti pensati nel contesto dei valori della modernità, che si contrappongono alla concezione paternalista tradizionale in medicina.
I punti nevralgici del nuovo modello etico sono costituiti da:
● Il bene del paziente. Non è più individuato unilateralmente dal medico. I valori e le preferenze del paziente contribuiscono a definire quale sia il bene perseguibile. Ciò vale soprattutto in oncologia, dove si aprono spesso alternative terapeutiche diverse, con benefici attesi, rischi e conseguenze pesanti sulla qualità di vita. Non sempre l'obiettivo di massimizzare la speranza di vita è condiviso dal paziente, il quale può identificare come bene auspicabile una vita più breve, ma senza gravi mutilazioni o condizioni di vita ritenute indegne.
● Il consenso informato. È richiesto per i trattamenti sperimentali (cfr. Dichiarazione sulle ricerche biomediche, 1964; Norme di buona pratica clinica, 1990; Convenzione europea perla protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina, 1997).
Anche i trattamenti invasivi e le procedure potenzialmente pericolose, in quanto comportano la possibilità di comparsa di eventi avversi di una certa gravità, non sono eticamente giustificabili senza il consenso esplicito del paziente. Per alcune di queste procedure ― come nel caso di trasfusioni sanguigne ― esiste un vero e proprio obbligo formale di informare il soggetto e di chiedergli il consenso. Ma anche per tutto l'insieme delle procedure terapeutiche possiamo per lo meno parlare di obbligo morale di fornire l'informazione. Indipendentemente dall'intenzione ― più che legittima ― del medico di mettersi al riparo da possibili rivendicazioni future del paziente, che possono alle volte arrivare alle aule giudiziarie, non è più accettabile attualmente che il medico si assuma in prima persona la responsabilità di decidere un intervento che potrebbe essere dannoso per il paziente.
Il documento del Comitato nazionale per la bioetica: Informazione e consenso all'atto medico (1992) auspica un consenso informato ― inteso quale "più ampia partecipazione del paziente alle decisioni che lo riguardano" ― tutte le volte che esistono alternative terapeutiche con diversa ricaduta sull'aspettativa e sulla qualità di vita del paziente. Secondo il Comitato, l'informazione da promuovere
188
"è finalizzata non a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra medico e paziente, ma a porre un soggetto (il paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia effettivamente tale; in altri termini, porlo in condizione di scegliere. Un'informazione corretta è perciò soprattutto chiara nell'indicare i passaggi decisionali fondamentali in una direzione o in un'altra, e cioè le alternative che si presentano: spetterà al curante presentare le ragioni per le quali viene consigliato un determinato provvedimento piuttosto che un altro".
Secondo il codice deontologico degli infermieri italiani del 1999, l'informazione e il consenso costituiscono un momento essenziale del rapporto con la persona assistita: "L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all'assistito di esprimere le proprie scelte" (4.2).
● Il ruolo del paziente. Nel modello etico tradizionale il malato contribuisce alla buona medicina impegnandosi a essere docile e osservante delle prescrizioni mediche, in un rapporto di affidamento fiduciale. Egli non ha, di per sé, nulla da dire in merito all'atto terapeutico, che rimane affidato a quanto il medico stabilisce per il suo bene. Tutto quello che il malato deve fare è di diventare "paziente", in tutti i significati del termine (anche in senso morale, in quanto la pazienza è la principale virtù che è chiamato a esercitare). Il buon paziente è un paziente "osservante" (compliant).
Nell'epoca della bioetica, quando il paziente ha diritto-dovere di partecipare alle decisioni che lo riguardano, il buon paziente assume un ruolo attivo. Non basta che si limiti a essere docile e a seguire le prescrizione mediche: deve fare scelte responsabili e a questo fine deve essere messo in grado di scegliere mediante l'informazione fornita dal medico.
Il nuovo modello di qualità del rapporto medico-paziente incontra una profonda resistenza, sia da parte del mondo medico che da parte dei cittadini, in quanto sovverte dei comportamenti che hanno una tradizione secolare. È un passaggio epocale: spostandosi da un modello all'altro, i valori consolidati che fanno il buon medico e il buon paziente si modificano. Possiamo dire che stiamo assistendo all'inaugurazione di una nuova epoca della qualità e dell'etica in medicina e che i pazienti oncologici si trovano per necessità nell'avanguardia del cambiamento.
ETICA E CULTURE LOCALI
Mentre l'etica prescrive i comportamenti, le scienze sociali e comportamentali descrivono i modi in cui vengono organizzate le risposte alle diverse situazioni. L'apporto dell'antropologia culturale è molto utile per mettere in luce la variabilità nell'ambito dei comportamenti sociali legati alla cura del cancro. Tra i contributi più interessanti della ricerca italiana recente si segnala la ricerca antropologica condotta da Deborah Gordon ed Eugenio Paci in Toscana circa la pratica di informare o non informare i malati di cancro (Gordon, Paci, 1997). Nello spirito di una ricerca etnografica ― che mira a comprendere i comportamenti e le motivazioni che li ispirano a partire dall'ottica dei protagonisti, escludendo ogni intento valutativo o normativo ― lo studio mirava a esplorare le pratiche dominanti, i vissuti e i costrutti teorici che le giustificano diffusi tra i professionisti sanitari circa la comunicazione: a) con i pazienti in generale; b) con i pazienti affetti da cancro o da altre malattie potenzialmente fatali; c) con le persone in contesti non sanitari.
Le domande rivolte con questionario rispecchiavano l'ipotesi che le pratiche comunicative riferite al cancro non siano comportamenti isolati, ma rappresentino un approccio tipico a problemi di natura analoga. Le pratiche mediche e i vissuti relativi alla malattia e alla cura del paziente (chi prende le decisioni, chi detiene le informazioni, gli assunti relativi a che cosa serve per stare meglio, dove attingere la speranza, il significato da attribuire al cancro, in che cosa consiste una "buona morte") si coagulano in modo coerente intorno a due modelli, che portano l'uno a rivelare
189
al malato il male da cui è affetto, l’altro a nasconderglielo. Le modalità di comunicazione relative al cancro sono costitutive di vissuti e pratiche di portata più ampia.
Gordon e Paci non si sono limitati a contare quanti tra gli operatori sanitari sono per il "dire" e quanti per il "tacere". Hanno studiato invece come questi orientamenti sono collegati, in profondità, con le convinzioni che riguardano la vita, la morte e la sofferenza; con il modo di gestire le "cattive notizie" anche in contesti diversi da quello della salute; con i modelli fondamentali di educazione (orientata a promuovere l'autonomia personale oppure a consolidare la dipendenza dai genitori e dalla famiglia); con le modalità che vengono utilizzate preferenzialmente per aiutare qualcuno in difficoltà. Questi modelli globali possono essere chiamati "narrazione culturale". La "narrazione culturale" dà ragione di ciò che si intende produrre. Schematicamente, la narrazione culturale di "protezione sociale" organizza i comportamenti con l'intento di proteggere il paziente, mentre la narrazione che possiamo chiamare di "autonomia-controllo" si prefigge di favorire il controllo della situazione da parte dell'individuo.
La "narrazione della protezione sociale" potrebbe cominciare così: "In principio c'erano Dio e la famiglia, che hanno creato i bambini e proteggono i deboli nei momenti di difficoltà". La vita e le persone sono fondamentalmente fragili e bisognose di protezione. La sofferenza non può essere eliminata, ma può e deve essere ridotta al minimo, in parte attraverso la protezione del gruppo sociale: qualsiasi mezzo utilizzato dal gruppo a questo fine è buono, anche inventare storie e mentire. Ai duri colpi della vita si fa fronte mantenendo la continuità della vita quotidiana. La maturità non è un processo lineare: si rimane bambini per tutta la vita di fronte a Dio, ai genitori, alle persone più anziane. Questo comporta che in caso di malattie ci saranno altri che assumeranno in toto la responsabilità delle cure. Il primo dovere è proteggere gli altri dalla sofferenza, non dare "dispiaceri". Lo stile comunicativo predilige il silenzio, l'ambiguità dei messaggi, la comunicazione indiretta. Il campo sociale è immaginato come una efficace difesa di fronte a verità che farebbero soffrire (come, appunto, una diagnosi di cancro). Per questo la "narrazione della protezione sociale" tende a una pratica comunicativa in cui chi detiene le informazioni sulla malattia ― il medico e la famiglia ― non le trasmette al malato.
La narrazione sottostante alla pratica della comunicazione aperta della diagnosi ― che in ambito medico si traduce soprattutto nella promozione del consenso informato ― potrebbe iniziare il suo racconto della creazione con: "In principio c'era l'individuo". Nella "narrazione culturale di autonomia-controllo", infatti, l'individuo è sovrano: sulla sua vita, sul suo corpo, sulla propria identità personale. Solo la persona coinvolta sa cosa è meglio per se stessa ed è davvero capace di prendere le decisioni che la riguardano. L'autonomia e l'autodeterminazione sono valori primari e rappresentano dei diritti fondamentali di ogni essere umano. L'informazione è essenziale per poter scegliere. Per questo è necessaria una comunicazione chiara ed esplicita. Vista dalla prospettiva della narrazione dell'autonomia e del controllo, la non rivelazione della diagnosi appare come una grossolana negazione dei diritti umani e impedisce il controllo della propria vita, del corpo, della mente. Il medico e la famiglia che sottraggono l'informazione appaiono in questo modello oppressivi e paternalistici. In modo schematico, le due "narrazioni culturali" possono essere rappresentate come segue:
|
Narrazione culturale: "autonomia-controllo"
|
Vissuti e pratiche |
Narrazione culturale: "protezione sociale" |
|
Individuo
|
Priorità |
Gruppo sociale |
|
Paritario
|
Natura del mondo sociale |
Gerarchico |
|
Mondo fisico, "oggettività" |
Chi o che cosa stabilisce la verità |
Mondo sociale, autorità
|
190
|
Narrazione culturale: "autonomia-controllo"
|
Vissuti e pratiche |
Narrazione culturale: "protezione sociale" |
|
Individuo, esseri umani, scienza, tecnologia, progresso, conoscenza e azione
|
Fonte di speranza
|
Gruppo sociale, Dio, destino, protezione sociale, unità/continuità del quotidiano, "non sapere" |
|
Trasferimento di informazioni
|
Modalità prevalenti di vivere la comunicazione |
Parola detta come capace di evocare una situazione, oltre che di trasferire informazione
|
|
Controllo attraverso la conoscenza, azione preventiva
|
Modi prevalenti di affrontare il pericolo |
Adattamento, cercare di creare un'altra storia, protezione sociale |
|
"Soluzione del problema", oggettività, condivisione
|
Modi prevalenti di affrontare la sofferenza |
Evitare di pensare e di parlare del problema, distrarre, proteggere
|
|
Infinitamente perfettibile e conoscibile
|
Natura della vita |
Misteriosa, imprevedibile, sempre problematica |
L'apporto della ricerca è di dare uno sfondo antropologico-culturale ai problemi del consenso informato, che evidenzia la frattura tra i diversi modi di praticare la medicina e le giustificazioni teoriche che vengono offerte dei comportamenti: "In Italia diventa sempre più chiaro che le pratiche tradizionali devono attraversare un processo di cambiamento. Si osserva una insoddisfazione diffusa nei confronti della comunicazione che si instaura nelle situazioni, ancora relativamente frequenti, in cui non si rivela la diagnosi: diversi pazienti hanno l'impressione che la mancanza di informazione significa 'non riconoscerli come persone'; che fornire loro una diagnosi diversa da quella reale significa 'mentire' o organizzare una 'congiura del silenzio'; la protezione è vissuta come oppressione, potere, atteggiamento difensivo ('risparmiare l'altro' vuol dire solo risparmiare se stesso). Molte famiglie continuano a non rivelare la diagnosi al paziente, ma psicologicamente si sentono isolate e senza sostegno; molti medici non se la sentono di continuare a vivere con la menzogna, ma sono costretti a continuare a comportarsi in questo modo sotto la spinta delle famiglie e della propria incertezza. Anche delle tensioni che si registrano sono da imputare alla presenza contemporanea all'interno del sistema di queste due diverse versioni di narrazioni e pratiche divergenti relativamente alla rivelazione della diagnosi" (Gordon, Paci, 1997).
Non si tratta di contrapporre semplicisticamente una cultura americana, basata sull'individuo, l'autonomia, l'informazione, a una cultura europea o ancor più italiana, centrata sulla protezione che if gruppo sociale ― in particolar modo la famiglia ― offre al singolo. I mondi culturali "locali" sono trasversali a queste distinzioni macroscopiche. Le diverse posizioni riguardo all'informazione dipendono dal mondo esistenziale in cui le persone vivono, anche in aree culturalmente omogenee (come la Toscana, in cui è stata condotta la ricerca). La pratica del consenso informato dovrà cercare di realizzare un nuovo equilibrio che permetta una maggiore espressione dell’individualità all'interno dei rapporti molto avvolgenti della famiglia e di un mondo sanitario protettivo, ma contemperi allo stesso tempo l'individualismo estremo del modello autonomista, preservando l'importanza dell'appartenenza al gruppo sociale.
191
CHE COSA SI PUÒ IMPARARE VIVENDO CON IL CANCRO
Le decisioni che presi [sui trattamenti da seguire] non furono facili; so che le decisioni che l'individuo deve prendere in questo tipo di situazione sono tra le più ardue che gli capiterà mai di affrontare. Ho imparato che non posso sapere quale scelta farei al posto di un altro e so che questo mi fa dare un sostegno autentico alle scelte compiute da altri. Una mia amica, che mi faceva sentire bella anche quando non avevo più capelli, mi ha detto qualche tempo fa: "Non avevi fatto la scelta che avrei fatto io, ma non importava". Le fui grata per non aver messo questo ostacolo tra noi in quel momento, che fu ovviamente il più difficile della mia vita. Poi le dissi: "Non puoi sapere quale sarebbe stata la tua scelta. Io non ho scelto quello che pensavi tu, ma neppure quello che io stessa pensavo che avrei scelto.
Wilber, 1995.
Negli ultimi sei mesi della sua vita, io e Treya eravamo entrati in una straordinaria sintonia spirituale, e l'uno serviva l'altro in ogni modo possibile. Avevo smesso di lamentarmi, quell'autocompatimento tanto normale nelle persone di sostegno (caregiver), derivante dal fatto che per cinque anni avevo messo da parte la mia carriera per poterla aiutare. Tutto questo era finito. Non avevo assolutamente alcun rimpianto, provavo solo gratitudine per la sua presenza, per la grazia straordinaria di servirla. Lei aveva smesso di lamentarsi perché il suo cancro aveva "mandato in pezzi" la mia vita. Il fatto puro e semplice è che noi due avevamo fatto un patto, a un livello profondo, che entrambi avremmo partecipato fino alla fine alla sua prova, quale che ne fosse stato l'esito. Fu una scelta profonda, sulla quale eravamo entrambi molto, molto lucidi, in particolare negli ultimi sei mesi. Prestavamo semplicemente il nostro servizio reciproco, scambiando sé e altro, e pertanto riuscivamo a intravedere quello Spirito eterno che trascende sé e altro, "me" e "mio".
Wilber, 1995.
I due brani sono tratti da un libro di natura autobiografica, che racconta le vicende cliniche e umane di due persone coinvolte in una lotta cinquennale con una patologia oncologica. Protagonisti sono una donna, Treya Wilber, colpita da una carcinoma della mammella, e suo marito, Ken Wilber, uno psicologo molto noto a livello internazionale per essere uno dei leader della corrente nota come "psicologia transpersonale''. Il libro è costituito dal diario di Treya, che finirà col soccombere alla malattia, e dai commenti del marito. Il titolo ― Grazia e grinta ― esprime le due dimensioni di "resistenza e resa" che determinano il progetto di vita di una persona, dopo l'incontro inatteso con la malattia; il sottotitolo dell'edizione italiana ― "La malattia mortale come occasione di crescita" ― esplicita invece l'orizzonte che il libro apre al lettore che si lasci coinvolgere da quella vicenda personale.
È di grande importanza far resistenza all'associazione mentale che porta a legare il cancro alla morte. Il messaggio culturale che è urgente trasmettere è piuttosto quello che di cancro si guarisce. Tuttavia il confronto con la morte è un momento della "salute", inteso in un senso antropologicamente più ricco. Ogni malattia che minacci seriamente la vita può essere l'occasione per avviare un ripensamento che porta a cambiare la vita; la malattia oncologica, proprio per gli interrogativi che suscita con la prospettiva della fine, ha quasi una vocazione connaturata a identificarsi con la meditazione della morte.
La meditatio mortis ha avuto un posto d'eccezione nella spiritualità del passato. Non era prerogativa degli uomini di religione: anche i poeti se ne occupavano. Massimamente quando la mente degli artisti era in sintonia con i temi religiosi che costituivano la cultura del tempo. Come per il poeta inglese del XVII secolo John Donne, nel suo Inno a Dio, il mio Dio, nella mia infermità (1971). Morire significa, nel suo orizzonte di fede, diventare musica di Dio; meditare sulla morte equivale ad accordare il suo strumento ("e ciò che allora dovrò fare penso prima dell'ora''):
Mentre i miei medici, per loro amore,
sono diventati cosmografi ed io
192
loro mappa, stesa su questo letto
perché da loro sia mostrato come
io scopra qui il mio passaggio a Sud-Ovest
per fretum febris, per
questi stretti morire
io giubilo, che in tali stretti vedo
mio Occidente.
La via della "buona morte" è per il poeta un viaggio avventuroso, come la travagliata ricerca del passaggio a sud-ovest per raggiungere l'Oriente viaggiando verso l'Occidente, che tanto affaticò i navigatori fino a Magellano. L'immagine di un varco da scoprire tra i ghiacciai della Terra del Fuoco si attaglia perfettamente alla ricerca di una buona morte.
Alcuni secoli sono passati da allora. Tutte le coordinate sono cambiate: le rappresentazioni che ci facciamo della morte e dell'aldilà, i modi di organizzare l'intervento medico per affrontare la malattia, le risposte sociali alle minacce che incombono sulla vita. Ma la ricerca del "passaggio a sud-ovest" è rimasta purtuttavia un valore prioritario nella vita degli uomini più consapevoli.
La vicenda personale di Ken Wilber e di sua moglie Treya riconduce questo interrogativo astratto a quell'orizzonte concreto costituito dalle decisioni angoscianti che devono essere prese in presenza di una malattia potenzialmente mortale. Non a torto, il cancro è stato promosso a simbolo ― o "metafora", come lo chiama Susan Sontag ― della malattia carica di dilemmi terapeutici ed etici (Sontag, 1981). Quando viene diagnosticata un'aggressione tumorale all'organismo, prende avvio una situazione che si sviluppa sotto il segno dell'incertezza.
Purtroppo sono ancora una piccola minoranza le patologie per le quali la medicina può prevedere un rimedio che si imponga sugli altri, considerato ottimale dal punto di vista dell'indicazione terapeutica, dell'efficacia dei risultati, dall'assenza di danni inferii alla qualità della vita del malato. Nella stragrande maggioranza dei casi non abbiamo che strategie terapeutiche molteplici ― non solo considerando le tante medicine "alternative", ma anche all'interno della medicina ufficialmente accettata come sinonimo di conoscenza scientifica ― previsioni incerte sulla loro capacità di dar scacco alla malattia, valutazioni delicatissime del bilancio tra benefici ipotetici e danni certi. Non a caso Treya presenta l'incertezza tra l'affrontare o no una chemioterapia come una raffinata versione moderna della tortura medievale.
La perigliosa ricerca del passaggio a sud-ovest è confluita, sul finire del XX secolo, nella questione tanto dibattuta della partecipazione del malato alle decisioni che lo riguardano. Sappiamo che in merito alla comunicazione al paziente di una prognosi infausta si sono formate due posizioni antitetiche, che riposano su certezze profonde non disposte a farsi rimettere in discussione dagli argomenti contrari. Chi è convinto che una prognosi che si affaccia sulla morte non vada condivisa con il malato ― tutt'al più con i suoi familiari ― motiva questo comportamento con alte ragioni ideali. È per risparmiare al malato un evento emotivamente catastrofico che si deve fare ogni sforzo per tenere lontano dal suo sguardo l'orrore della morte certa. Ma anche chi difende la posizione contraria, orientato a informare il malato della propria situazione, si giustifica con motivi ideali, che ruotano attorno al rispetto del malato e tendono a prevenire un altro tipo di sofferenze psicologiche: quelle che si aggrumano attorno al sistema di menzogne necessario per mantenere il malato nell'ignoranza della sua situazione.
I partigiani dell'uno e dell'altro modello formano come due tribù compatte. Per quella orientata in senso tradizionale, le decisioni relative a cure e trattamenti sono responsabilità del medico (e della famiglia), che scelgono ciò che "è meglio" per il paziente. Di fronte alla morte, l'obiettivo prioritario diventa la difesa del fragile dalla cattiva notizia, tenendolo all'oscuro. Per l'altra tribù, invece, l'informazione riguardo alla diagnosi, alla prognosi e al trattamento appartiene
193
al paziente; è un suo diritto, perché deve conoscere e capire per poter decidere. L'ideale a cui tende è quello di rendere il paziente giudice di ciò che è meglio per lui.
È probabile che più di un lettore italiano, ripercorrendo le tappe della lotta quinquennale di Treya e Ken Wilber con il cancro, avverta un senso di estraneità nei confronti dei modelli di comunicazioni usuali tra medici, pazienti e familiari nella cultura americana. Soprattutto se i suoi convincimenti di fondo ― riguardo alla vita e alla morte, agli eventi critici e al modo più appropriato di farvi fronte, al compito dei sanitari e al ruolo della famiglia ― sono quelli del gruppo sociale per il quale è prioritario evitare a ogni costo il confronto diretto del malato con la possibilità della propria morte. Ma, superato lo spaesamento, potrà valutare i benefici che quel modo di affrontare la malattia è in grado di arrecare.
Non si tratta di far violenza alla persona malata, buttandole in faccia una verità traumatizzante (neppure se le intenzioni fossero quelle di evitare a qualcuno di venir meno alla sua condizione umana, secondo i propositi espressi con piglio aggressivo dal poeta Saint-John Perse: "Se un uomo accanto a te lascia cadere il suo viso di vivente, gli si tenga con forza la faccia contro il vento"). Forse l'espressione stessa "dire la verità" va evitata, perché rischia di deformare il senso stesso di questa situazione. Essa fa pensare, infatti, a un possesso unilaterale di un sapere vero e certo da parte di qualcuno ― il professionista sanitario ―, il quale potrebbe a sua discrezione trasmetterla o tenerla per sé.
Niente di più fuorviarne. Si tratta invece di una condivisione d'informazioni, fatta con tatto e misura, nonché nel rispetto dei tempi psicologici della persona, che permette al malato di partecipare al sapere predittivo ― per definizione incerto ― di cui dispone la medicina. Possiamo cogliere come segno di una maggiore ponderatezza in questo ambito cruciale del rapporto medico-paziente il fatto che l'autorevole Encyclopedia of Bioethics americana, nel passaggio dalla prima edizione (1978) alla seconda (1995), ha sostituito la voce Truth telling ("Dire la verità") con Information disclosure (Comunicazione delle informazioni). Il malato ha bisogno di tutte e sole quelle informazioni che lo mettono in grado di mantenere il ruolo di protagonista nei confronti della malattia che lo porterà alla morte, così come è stato protagonista della sua vita fino all’affacciarsi della malattia mortale. Non si tratta più solo del comportamento "giusto" nella transazione che intercorre tra chi offre e chi riceve le cure mediche, secondo le regole che la bioetica contemporanea va riscrivendo. Quello che è in gioco è il comportamento saggio, rispetto alle esigenze di una saggezza che trascende i tempi e culture.
Per far fronte a una malattia che minaccia la vita è necessario mobilitare l'uomo nella sua interezza e attingere alle scienze umane nella loro complessa articolazione: filosofia e religione, psicologia ed etica. A questa condizione non solo la morte può essere assunta nella coscienza, ma diventa essa stessa l'occasione per la suprema dilatazione della coscienza. Allora la morte brutta, disumana, angosciante ― la "piccola" morte, che sembra diventata la prerogativa dell'uomo tecnologico ―, può ancora essere la "grande morte", la morte personale ― o piuttosto transpersonale ― che Rainer Maria Rilke auspicava, sotto forma di laica preghiera, per l'uomo del nostro secolo (Rilke, 1950, ed. orig. 1901):
Signore, dà a ciascuno la sua morte,
la morte che da quella vita viene,
in cui ebbe amore, anima, angoscia.
Perché noi siamo solo guscio e foglia.
La grande morte che ciascuno ha in sé,
è il frutto intorno a cui tutto si svolge.
194
195
15
PREVENZIONE E SCREENING DI MASSA
È meglio essere sani che malati o morti.
Questo è l'inizio e la fine del solo argomento reale
a favore della medicina preventiva. È sufficiente.
Geoffrey Rose, 1992.
"PER IL BENE DEL PAZIENTE"?
Da quando l'epidemiologia e la biostatistica hanno fornito strumenti analitici a favore della salute, individuando i cambiamenti da introdurre nella società e nei comportamenti individuali per impedire lo sviluppo di fenomeni patologici, la medicina ha aggiunto un nuovo compito a quelli tradizionali. I migliori tra i medici si sono sentiti impegnati non solo a curare i pazienti per l'enfisema o il cancro ai polmoni, ma a prevenire le malattie respiratorie lottando per la salubrità dei posti di lavoro ed educando i pazienti ad astenersi dal fumo; non si limitano ad assistere i traumatizzati da incidenti stradali, ma fanno pressione per ottenere maggiore sicurezza nelle auto da parte delle case produttrici e l'imposizione dell'obbligo delle cinture di sicurezza da parte delle autorità civili. Questa è la medicina preventiva cresciuta sul tronco della medicina del passato e ispirata al suo stesso valore fondamentale: fare ciò che è nel migliore interesse dell'individuo e della sua salute.
Tuttavia la prevenzione concepita secondo lo spirito della medicina tradizionale è caratterizzata da un tratto marcatamente "paternalistico". Nel modello culturale della medicina tramandatoci dal passato il beneficio che viene al soggetto da un intervento di terapia ― in questo caso, di prevenzione ― è stabilito da una "auctoritas" scientifica della quale il cittadino non è un interlocutore attivo, ma il presunto beneficiario. Così avviene, per esempio, negli screening di massa. Quando si decide di intervenire su ciascun individuo di una popolazione definita mediante idonei test clinici, strumentali o di laboratorio, con Io scopo di identificare particolari fattori di rischio o patologie in fase preclinica, la popolazione oggetto dell'intervento (donne in una determinata fascia d'età per la prevenzione di carcinomi dell'utero o della mammella, uomini per il carcinoma della prostata...) viene mobilitata in nome di un'autorità scientifica che ha deciso ― per il bene delle persone interessate ― che cosa deve essere fatto. Nei casi più felici la proposta di screening è corredata di una dimostrazione di efficacia (documentata riduzione di mortalità totale o almeno specifica; assenza di eventi invalidanti) e di appropriatezza (il test di screening deve essere accettabile, non pericoloso, economico e dotato di buona sensibilità). Ma talvolta così non avviene. È il caso, per esempio, dello screening HCV ― per l'epatite C ― proposto ai cittadini italiani. La vicenda supera l'aspetto aneddotico per acquistare un significato esemplare di cattivo
196
uso della prevenzione, discutibile dal punto di vista non solo scientifico ma anche etico.
Nel febbraio 1996 televisione e giornali diffondono spot e locandine nei quali si invitano tutti i cittadini a controllare le transaminasi. Non ci si può fidare di sentirsi bene, in quanto ― insinua la campagna pubblicitaria ― i sintomi dell'epatite C sono subdoli: "aspetto sano, appetito normale, assenza di dolore"... L'iniziativa, promossa dalla Lega per la lotta contro le malattie virali, riceve l'appoggio del ministero della Sanità. La stampa per medici e quella rivolta al pubblico riferiscono l'iniziativa con devozione. I dubbi espressi da qualche medico di famiglia vengono trattati in modo sprezzante dall'infettivologo promotore, che definisce "trogloditiche" le valutazioni critiche del progetto.
La campagna procede come previsto, con incursioni in nove città italiane di roulotte della Croce Rossa per dosare le transaminasi ai passanti fermati per strada. Solo un anno dopo l'avvio della campagna i promotori indicono una "conferenza di consenso" per valutare se sia opportuno condurre uno screening nella popolazione generale. La risposta ― a sorpresa ― è negativa e la campagna viene revocata (per il resoconto dettagliato della vicenda: Satolli, 1997). Non si tratta solo di uno spiacevole incidente provocato da un eccesso di zelo per il "bene del paziente": è un episodio emblematico di quanto possa spingersi lontano nell'"espropriazione della salute" (per riprendere l'espressione classica di Ivan Illich in Nemesi medica) una medicina preventiva pensata sul modello paternalista.
Lo slittamento di finalità della medicina è intrinseco al passaggio dalla medicina curativa a quella preventiva. Sullo sfondo ideologico di quest'ultima individuiamo la concezione di salute quale pieno benessere fisico, psichico e sociale, e non solo assenza di malattia, diffusa dall'OMS (nel cui statuto è inclusa la dichiarazione che "il godimento della salute al più alto livello è uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di ideologia politica, di condizione economica e sociale"). A differenza della malattia, la presenza della salute non è oggettivamente verificabile. O meglio: lo stato di salute o malattia è funzione dell'impegno diagnostico profuso.
Se già nel 1923 la commedia di Jules Romains sul dottor Knock poteva mettere in dubbio l'utilità sociale di un "trionfo della medicina" che trasforma i sani in malati ― secondo il credo del dottor Knock: "I sani sono dei malati che si ignorano"... ―, la situazione si è radicalizzata con l'impegno dei medici a rendere la pratica della medicina economicamente compatibile con i suoi costi. È un fenomeno particolarmente vistoso nei Paesi che hanno adottato sistemi di pagamento a tariffa, DRG, managed care o altre modalità che incentivano l'accanimento diagnostico. Secondo una brillante descrizione di ciò che sta avvenendo negli ospedali americani, "un paziente in buona salute è solo uno che non è stato sottoposto ad adeguati accertamenti. Una volta in ospedale, gli accertamenti 'confermeranno' problemi multipli di salute e sostanziali opportunità per un DRG creep ― cioè l'insidioso scorrimento verso l'alto delle categorie di DRG ― per massimizzare le entrate" (Maynard, Bloor, 1995).
Non possiamo impedirci di sviluppare un salutare sospetto sistematico che quanto viene presentato al paziente dalla medicina curativa e da quella preventiva "per il suo bene" sia veramente nel suo migliore interesse. Saranno necessarie volta a volta delle prove di efficacia, tanto per l'una quanto per l'altra medicina: accanto alla evidence based medicine, dunque, anche una evidence based prevention.
ANCHE LA PREVENZIONE SOTTO IL SEGNO DELL'AUTONOMIA
Oltre al superamento dell’atteggiamento paternalistico, la medicina preventiva deve assimilare il rispetto dell'autonomia della persona. Non basta fare il bene del paziente, ma bisogna farlo con il suo consenso, in modo da rispettare il diritto a gestire le scelte che riguardano il corpo e
197
la salute. In una parola, la medicina deve rispettare il diritto all'autodeterminazione personale.
Anche la medicina preventiva può infrangere i valori tutelati dall'autonomia della persona. Il ventaglio delle violazioni è molto ampio e differenziato. In ordine di gravità, il primo posto spetta alle misure preventive che ricorrono alla coercizione violenta per impedire il sorgere delle malattie o la trasmissione di caratteri genetici indesiderati. L’eugenismo ― soprattutto quello praticato in Germania dal regime totalitario nazista ― si è guadagnato la triste fama di aver calpestato i diritti fondamentali della persona in nome della tutela della razza. Ci piacerebbe poter dire almeno che questa modalità di prevenzione sia stato un caso isolato, al quale la coscienza morale dell'occidente ha tolto ogni diritto di cittadinanza. Purtroppo non è così.
Sono trapelate di recente informazioni secondo le quali la sterilizzazione forzata è stata praticata per legge nei Paesi scandinavi fino a non molto tempo fa. Le leggi per la sterilizzazione di "tipi razziali inferiori" sono entrate in vigore in Danimarca nel 1929, in Norvegia nel 1934 e in Svezia nel 1935, e hanno continuato a giustificare interventi su soggetti ― soprattutto donne con handicap e "indigenti di razza mista" ― che ufficialmente risultavano sottoporsi alla sterilizzazione volontariamente. La legge in Svezia è stata abolita in sordina solo nel 1976. A quasi 100.000 donne nei tre Paesi scandinavi sarebbe stato negato, in modo coercitivo, il diritto alla riproduzione, per ridurre la probabilità che tra le generazioni future vi fossero persone non sane, che potessero quindi pesare sulla società. Anche sulla Francia si è stesa l'ombra della violazione sistematica di diritti umani: stando alle denunce della stampa, nel Paese si è praticata e si continua a praticare la sterilizzazione forzata di handicappati e minorati mentali, contro la loro volontà o a loro insaputa.
Il problema della tutela dei diritti, abbinato al rispetto della privacy, è emerso a proposito dello screening per l'HIV, da praticare obbligatoriamente su quanti vengono a contatto con operatori sanitari, per proteggere questi ultimi dai rischi di infezione. Sono state proposte anche indagini obbligatorie sui sanitari, per tutelare i pazienti dalla trasmissione del virus da parte di operatori infetti. La tendenza prevalente è stata quella di non far ricorso a misure coercitive. Per i sanitari è sembrata meno dirompente nei confronti del rapporto fiduciario con i pazienti l'indicazione di prendere in ogni caso le precauzioni prescritte quando nella pratica medica o di nursing vengono a contatto con i liquidi organici dei pazienti che possono trasmettere l'infezione. Per quanto riguarda i pazienti, dal momento che il rischio è estremamente ridotto, il bene pubblico può richiedere loro di non esercitare il diritto di sapere se il medico che li cura è sieropositivo, se questo intervento nella privacy dovesse peggiorare la situazione di tutti, compromettendo la qualità dei rapporti.
La casistica delle situazioni in cui, in nome della salute e della sicurezza, vengono richiesti dei test relativi alla salute del personale neH'ambito del lavoro, è molto ampia. Si possono ricercare informazioni sullo stato di salute attuale o futuro (individuando la predisposizione genetica a determinate malattie); test appropriati possono rilevare se la persona nella sua vita privata fuma, beve alcolici o fa uso di droghe; in alcuni posti di lavoro si va a ricercare ― sotto l'etichetta di "rischi riproduttivi" ― se le donne sono incinte o, più generalmente, fertili. La giustificazione di intrusioni così pesanti nella vita delle persone può assumere una triplice forma: il test può essere motivato o come protezione offerta al lavoratore, per il suo stesso bene (una motivazione tipicamente paternalistica); o per proteggere terze parti (questa ragione ha più potere persuasivo, anche se in pratica è rilevante sono in pochi casi eccezionali negli ambienti di lavoro); oppure per tutelare il datore di lavoro da eventuali costi per spese sanitarie.
La tentazione di ricorrere ― in chiave preventiva ― a sistematiche misure di indagine sul personale dipendente o su quello da assumere andrà sicuramente crescendo. Per questo è necessario che, in nome del principio etico dall'autodeterminazione, si vigili per assicurare a tutti uguale trattamento e uguali opportunità. In particolare quando le misure preventive interferiscono con gli "stili di vita". Con questa espressione spesso si considerano insieme comportamenti
198
relativi al fumo e al consumo di alcol e droghe, nonché pratiche sessuali associate al rischio di HIV. Dal momento che questi comportamenti, a differenza del patrimonio genetico, sono considerati dipendenti dalla volontà, i test relativi non sono disapprovati dall’opinione pubblica tanto fortemente quanto le indagini genetiche. È un motivo per proteggere con più attenzione l'ambito della vita privata da controlli etichettati come medicina preventiva, che da intrusività molesta potrebbero degenerare in totalitarismo soft da "Grande Fratello" orwelliano. In nome della salute, del benessere sociale o del controllo dei costi si rischia di esercitare una pressione, inconciliabile con i valori democratici della libertà e della dignità, su intere classi di persone.
Con il principio dell'autodeterminazione ― infine ― dobbiamo confrontare una serie di interventi di prevenzione ed educazione sanitaria che, senza essere né coercitivi, né intrusivi ― come gli esempi che abbiamo preso in considerazione ― possono tuttavia compromettere la libertà personale. "Nella misura in cui la promozione della salute e l'educazione sanitaria sono intese come alternative alla regolazione coercitiva dei comportamenti, esse non minacciano l'autodeterminazione degli individui, bensì la potenziano. Di fatto l'educazione aumenta l'autonomia, in quanto fa emergere le conseguenze del proprio comportamento e le possibili alternative. Tuttavia c'è una zona grigia tra l'innocua offerta di informazioni e la coercizione sfacciata, e in questa categoria vanno inclusi alcuni degli strumenti utilizzati dagli educatori della salute". Non è necessario giungere a forme di coercizione non democratica perché si ravvisi un uso inaccettabile delle conoscenze mediche per far pressione su larghi gruppi di popolazione, affinché cambino i loro comportamenti "non sani".
Le campagne di educazione sanitaria non sono una neutra esposizione di fatti; esse cercano di convincere a modificare comportamenti e abitudini, e perciò frequentemente si servono della manipolazione. I più efficaci programmi "educativi" riescono a far sentire in colpa o a disagio il soggetto quando assume comportamenti giudicati non sani (l'utopia di un mondo capovolto immaginata da Samuel Butler nel celebre romanzo utopico Erewhon si muoveva nella stessa direzione: il malato era indotto a sentirsi colpevole per la sua malattia; compreso il malato di cui nel capitolo XI viene raccontato il processo, che si conclude con la severa condanna per il "grave delitto di tubercolosi polmonare". Anche questo nella logica della prevenzione: "Il giudice era fermamente convinto che la punizione inflitta al debole e all'ammalato fosse il solo modo di prevenire il diffondersi del decadimento fisico e delle malattie e che, alla resa dei conti, l’apparente severità della sentenza avrebbe risparmiato alla società una sofferenza dieci volte maggiore di quella subita dall'accusato"). Il paradosso del malato colpevolizzato è stato realizzato nella nostra società dal diffondersi dell'atteggiamento etichettato come victim blaming. L'espressione inglese sta a significare che la colpa è fatta ricadere sulla vittima stessa, che viene criticata per il male che l'ha colpita.
Altre strategie manipolative sono quelle di sovrastimare il rischio (per esempio, per indurre le persone a vaccinarsi volontariamente, mentre i non vaccinati sono in genere protetti dalla vasta maggioranza di quelli che lo sono) e di nascondere il grado di cambiamenti necessari per promuovere la salute, se questa informazione rischia di tradursi in non-compliance. Senza voler sostenere che qualsiasi manipolazione "educativa" sia incompatibile con il principio etico del rispetto dell'autonomia personale, bisogna tuttavia riconoscere che non è questo l'ideale verso il quale si muove quella promozione della salute che vede il suo obiettivo nell'empowerment dei consumatori.
L'EMPOWERMENT DEL CITTADINO NEI CONFRONTI DELLA PREVENZIONE
L'empowerment del cittadino nei confronti delle attività di tutela e promozione della salute implica che nessuno è autorizzato a decidere per l'altro ciò che va fatto o omesso in base a una considerazione del bene del paziente, a livello sia curativo che preventivo, che presuma di essere
199
"oggettiva" e in quanto, tale si ritenga dispensata dal confrontarsi con i valori e le preferenze della persona coinvolta.
Questa impostazione teorica generale è diventata attuale anche nell'ambito di una delle attività di sanità pubblica e medicina preventiva più consolidate: lo screening mammografico per la diagnosi precoce del tumore della mammella nelle donne anziane (cfr. Satolli, 2001). I medici sono stati incoraggiati a promuovere il test e a indurre le donne a sottoporvisi in base a un bilancio positivo, ritenuto incontrovertibile dalla ricerca epidemiologica, tra rischi e benefici. Questa sicurezza incomincia a vacillare. I dati di uno studio, condotto in Svezia tra il 1987 e il 1996, hanno messo in evidenza possibili esiti problematici di questa pratica. La ricerca è stata pubblicata dalla rivista dell'Associazione medica svedese (disponibile all'indirizzo internet http://www.farmanet.com) e ripresa dal "British Medical Journal". In Italia è stata presentata da "Tempo Medico" n. 626, 24 marzo 1999.
Lo studio ha seguito 600.000 donne, di età tra i 50 e i 69 anni, che sono state invitate a sottoporsi allo screening ogni due anni (per un totale di 1.932.353 mammografie e una partecipazione di circa l'80% delle donne invitate). La riduzione della mortalità è risultata solo dello 0,8%, vale a dire 55 morti evitate. Ma sull'altro piatto della bilancia pesano 100.000 diagnosi falsamente positive; inoltre circa 16.000 donne hanno avuto la diagnosi di cancro anticipata di tre anni, senza che si sia potuto fare nulla per evitare loro la morte, ma deteriorando con certezza la qualità della loro vita.
Estrapolando dai dati pubblicati e in base ai registri svizzeri di tumori, Gianfranco Domenighetti ha calcolato che in Svizzera, su 1000 donne di età superiore a 50 anni, lo screening salverebbe la vita solo a 4 donne delle 32 che sviluppano un cancro al seno, mentre da 100 a 250 sarebbero le mammografie falsamente positive (di cui da 15 a 30 biopsie dovute a questi esiti falsamente positivi) e 25 donne avrebbero una diagnosi confermata 3 anni prima, senza alcun aumento della speranza di vita (Domenighetti, 2000).
Ciò che si può legittimamente concludere da questi studi non è una rimessa in discussione dell'utilità dello screening mammografico, ma un diverso approccio a esso, considerando gli effetti negativi che vanno imputati allo screening stesso (falsi positivi e peggioramento della qualità della vita a seguito di una diagnosi precoce, non compensata dalla possibilità di incidere sul decorso del processo morboso). Un'etica medica rispettosa del valore dell'autonomia dovrebbe mirare a far sì che la decisione di sottoporsi o no allo screening sia una scelta individuale. Il problema diventa quindi quello della qualità dell'informazione da fornire alle donne arruolate nello screening, affinché conoscano gli esiti, le controindicazioni e le alternative, decidendo autonomamente quale percorso seguire. Come ha affermato Maureen Roberts ― direttore clinico dell'Edinbourgh Breast Cancer Screening, morta di cancro alla mammella ― la decisione spetta alle donne, non agli epidemiologi o ai medici: "La decisione spetta a loro e un resoconto affidabile dei fatti deve essere disponibile sia al pubblico che alle singole pazienti" (Roberts, 1991). Anche se ciò che deve essere detto alle donne non corrisponde a ciò che esse vorrebbero sentirsi dire.
Ma è così, in pratica? Qual è la qualità dell’informazione fornita, relativamente ai rischi e ai benefici dello screening mammografico? Una ricerca australiana, pubblicata sul British Medical Journal, ha preso in esame 58 brochure rivolte alle donne per sensibilizzarle allo screening. Nel comunicare i rischi di cancro alla mammella, l'accento viene messo quasi esclusivamente sull'incidenza, ovvero sul rischio di sviluppare il cancro nel corso della vita, piuttosto che su quello di morire di cancro (solo una brochure fornisce l'informazione sulla mortalità). Tre informano sulla sopravvivenza al cancro alla mammella, ma in termini molto approssimativi ("più del 70% delle donne sopravvive", "due terzi delle donne sopravvivono", "la maggior parte delle donne sopravvive a questa malattia"). L'informazione sull'accuratezza dei test di screening è fornita solo occasionalmente ("la mammografia individua il 90% dei cancri alla mammella"; tre brochure
200
affermano che le mammografie non sono accurate al 100%, ma senza ulteriori dettagli). La conclusione dello studio è molto negativa relativamente alla qualità dell'informazione fornita. Si può manipolare la partecipazione allo screening non solo con i mezzi più grossolani dello spavento indotto alle donne, ma anche mediante una comunicazione parziale dei dati epidemiologici: "la decisione informata da parte dei consumatori richiede una presentazione disinteressata di tutti i fatti pertinenti" (Slaytor, Ward, 1998).
A conclusioni analoghe giunge Domenighetti dopo aver analizzato il contenuto di brochure svizzere destinate a promuovere lo screening tra donne sopra i 50 anni. I messaggi centrali riguardano i seguenti fatti: il cancro alla mammella è il tumore più frequente nelle donne; nel corso della vita una donna su 10 sviluppa un carcinoma mammario; la diagnosi precoce è il miglior modo per combattere questo cancro e per ridurre la mortalità; l'efficacia del trattamento dipende strettamente dalla precocità della diagnosi; partecipare al programma di screening mammografia) è il miglior modo di combattere questo cancro; se la mammografia rivelasse qualche anomalia, il medico inviterà la donna a sottomettersi a indagini ulteriori (ma la grande maggioranza di anomalie non sono cancri).
Il contenuto dell’informazione fornita è essenziale per una sottostima o sovrastima dei reali rischi e benefici. Partendo dal dato epidemiologico che, tra 1000 donne che si sottopongono allo screening ogni due anni per 10 anni, si ottiene la riduzione di mortalità solo per 4 casi ― e conseguentemente 996 donne si sottoporranno alle procedure di screening senza alcun aumento di speranza di vita ― giungiamo alla conclusione che la partecipazione allo screening non avrà lo stesso valore per tutte le donne eligibili. Una scelta informata, a livello individuale, sulla base di quel "resoconto fedele dei fatti" auspicato da Maureen Roberts, si apre su scenari diversi. In concreto, possiamo immaginare che, soppesati accuratamente rischi e benefici, una donna possa anche decidere responsabilmente di non sottoporsi allo screening.
201
capitolo
16
OSPEDALE O DOMICILIO?
Un caso clinico
La signora Clorinda G. viene trasferita dalla U.O. di Medicina generale all'Unità terapia intensiva coronarica (UTIC) per blocco atrio-ventricolare destro di 3° grado. La signora ha 103 anni e vive in casa con la figlia ottantenne; entrambe, pur avendo una "bella età", sono autonome nelle attività quotidiane. Le due signore vivono insieme da diversi anni, da quando la figlia è rimasta vedova. La figlia riferisce che la mamma le è stata di grande sostegno, pur essendo la più "vecchia"; lei rifiuta l'idea di dover arrivare un giorno a dover inserire la madre in una casa di riposo. Clorinda e la figlia sono inoltre aiutate da due nipoti sposate con figli, che vivono nella stessa cittadina.
La signora viene ricoverata in Medicina generale per diabete tipo II scompensato e con problemi respiratori dopo un periodo influenzale non completamente superato. Durante la degenza, dopo vari accertamenti diagnostici, le viene riscontrata un'insufficienza cardiaca. Richiesta una consulenza cardiologica e fatte ulteriori indagini, viene disposto il trasferimento nell'UTIC e inserita nella lista per l'intervento di impianto di pacemaker definitivo. Il medico che eseguirà l'intervento parla con una nipote e la figlia di Clorinda, spiegando loro la necessità di intervenire per salvaguardare la vita della paziente, senza chiedere nessun consenso. L'intervento dell'impianto dello stimolatore cardiaco viene eseguito correttamente.
La notizia del fatto rimbalza sulle TV e giornali locali, in un contesto di informazioni sulle attività del reparto cardiologico, presentate dal medico che ha eseguito l'intervento. Durante la degenza Clorinda nei momenti autorizzati per le visite dei congiunti spesso è sola, è preoccupata e ansiosa per la figlia e le nipoti. Per questo motivo gli infermieri cercano, quando è possibile, di passare del tempo con lei, visto che è considerata la nonnina del reparto.
La nipote che si è interessata a Clorinda chiede ai medici di trattenere la nonna qualche giorno in più rispetto alla normale degenza. Il motivo per cui la nipote fa questa richiesta è perché ha paura che la mamma non sia in grado di accudire la nonna e la vuole inserire in una casa di riposo. Clorinda viene dimessa, non sapendo la nuova destinazione. Saluta tutti invitandoli a casa propria.
QUANDO I SANITARI GIOCANO IN TRASFERTA...
La proposta delle cure domiciliari e dell'ospedalizzazione a domicilio non è più una novità in Italia. Mentre ovunque nella sanità ci scontriamo con analisi divergenti dei fatti e con opinioni contrastanti sulle misure da prendere, in questo settore tutto sembra fluire verso un pacifico consenso: le ragioni dell'etica e le analisi sociologiche, i conti degli economisti e gli interessi degli utenti. I fautori delle cure domiciliari hanno infatti a loro favore argomenti difficilmente confutabili, tanto di ordine sanitario (inadeguatezza delle strutture ospedaliere rispetto alle esigenze
202
dei malati anziani e cronici), quanto economico (relativo minor costo delle prestazioni fornite a domicilio) e umanistico (compreso il problema etico di garantire quella migliore qualità di vita che induce le persone ad affermare la vita stessa).
Eppure le cure domiciliari stentano a decollare. Non mancano esperienze in atto: queste sono tuttavia sostanzialmente marginali e si rivelano incapaci di incidere in modo efficace sul sistema abituale di erogazione delle cure sanitarie, centrato sull'ospedale. Senza indulgere a quel moralismo che parte alla ricerca del colpevole, cerchiamo di capire anche quei motivi di resistenza che non dipendono solo dalla cattiva volontà umana, dall'inerzia delle istituzioni o dagli ostacoli politici. Il passaggio dalle cure ospedaliere a quelle domiciliari è più che una questione organizzativa: implica un cambiamento profondo nel modo di concepire la medicina, il rapporto con il paziente, il senso e il fine dell'attività terapeutica. In pratica, il passaggio dalle cure ospedaliere a quelle somministrate al domicilio del paziente equivale a un cambiamento di paradigma. Ciò spiega più adeguatamente di qualsiasi analisi parziale il motivo di quella resistenza che sembra condannare le cure domiciliari a rimanere nel limbo dei pii desideri.
Quando si passa dall'ospedale al domicilio del paziente, a prima vista il cambiamento sembra irrilevante. Il malato resta lo stesso, la sua patologia non muta; si modifica solo il contesto in cui la cura viene somministrata. Ma proprio questo contesto, apparentemente secondario, merita di essere considerato con molta attenzione. Esso rivela, a un'analisi più accurata, un influsso decisivo nel modellare i comportamenti, tanto del sanitario quanto del paziente. Una ricerca originale, capace di rilevare elementi contestuali di solito disattesi, è quella condotta dall'antropologa americana Andrea Sankar: Patients, physicians and the context: medical care in the home (1988). La ricerca è stata condotta in una facoltà di medicina il cui curriculum richiedeva agli studenti la partecipazione a un programma di home care, nell'ambito del tirocinio di due mesi in "Family Medicine''.
Le ricerche comportamentali in ambito sanitario si basano solitamente sulla diade medico-paziente: il contesto è invisibile, in quanto è dato per scontato. Andrea Sankar ha analizzato, invece, i cambiamenti del comportamento dei tirocinanti proprio in funzione del contesto in cui avveniva la somministrazione delle cure. Al livello più esterno, la trasformazione qualitativa del modo di comportarsi dei tirocinanti si esprime nel cambiamento della prossemica, ovvero nella comunicazione interpersonale che avviene mediante l’uso dello spazio (Hall, 1968). Rispetto all'ospedale, in casa cambiano le relazioni spaziali. Il sanitario, abituato a muoversi nel setting ospedaliero, solitamente improntato a denotare l'autorità professionale e l'efficienza tecnologica, può trovarsi in situazioni di perplessità; per esempio: dove e quando mettersi a sedere? Prendere l'iniziativa di questo gesto, oppure aspettare di esservi invitati? I tirocinanti presi in considerazione nella ricerca a cui ci riferiamo all'inizio tendevano a comportarsi da medici, prendendo l'iniziativa di sedersi senza essere invitati. Ben presto, però, si rendevano conto della stonatura e cambiavano atteggiamento.
Uno dei tirocinanti ha usato, per esprimere il suo vissuto, la metafora sportiva del giocare "in trasferta": "La home care è un gioco tutto diverso... Tu sei a casa loro, nel loro campo, ed è difficile comandar loro... Il risultato è che, se vuoi avere qualche successo, sei obbligato a sviluppare un tipo di rapporto più significativo con il paziente. Non te la puoi cavare con le chiacchiere superficiali con cui di solito te la cavi con i pazienti ricoverati". In questa osservazione possiamo intravedere alcune implicazioni più profonde di questa specie di "svolta copernicana" che fa muovere verso il paziente colui che, nel contesto ospedaliero, è il sole immobile verso cui gravita il malato in cerca di guarigione. Il campo da gioco è il simbolo di una modalità di rapporto che mette in questione il potere.
Giocando in trasferta, il medico si rende conto che non ha più il controllo usuale sul paziente. La visita fisica, per esempio, deve essere in qualche modo negoziata. Il paziente ha il potere, soprattutto
203
nello stabilire i confini della privacy: decide lui se e fino a che punto svestirsi. Il passaggio alla visita richiede una transizione verbale, spesso anche uno stacco fisico: il sanitario deve passare dall'atteggiamento di ospite a quello di medico. Anche il congedo richiede negoziazioni complicate. Il malato vuol contraccambiare la prestazione medica con gesti di ospitalità, per esempio offrendo un caffè o pasticcini. Giunge così alla massima evidenza il fatto che il setting domiciliare tende a strutturare il rapporto medico-paziente sulla modalità ospite-ospitante (divergendo dai rapporti propri dell'ospedale, dove il medico, oltre ad avere una posizione dominante per la sua attività professionale, è anche l'ospitante, e il malato l'ospite). Il domicilio, quindi, diventa la sintesi più concentrata della territorialità e del potere a essa connesso.
Il cambiamento del contesto non ha solo conseguenze sulla modificazione del comportamento esterno: provoca qualcosa che è riconducibile a una nuova Gestalt (vale a dire, secondo la psicologia della percezione, un tutto strutturato che è più della somma delle parti e tende a imporsi al soggetto percipiente). Nel setting domiciliare emerge qualcosa di nuovo: il contesto da sfondo diventa figura.
L'accentuazione di questo aspetto percettivo ci permette di modulare diversamente il rapporto tra l'etica e le cure domiciliari. Si è soliti mettere a fondamento dell'etica medica la "responsabilità" per l'altro. Tradotto in termini di cure domiciliari, ciò equivale all'impegno a conferire all'assistenza medico-sanitaria quella misura che meglio corrisponde alle esigenze del malato. La preferenza data alle cure domiciliari si fonda allora sulla volontà di rispettare i bisogni affettivi e cognitivi del paziente, non sottraendogli ciò che contribuisce in modo privilegiato alla sua identità. Senza mettere in discussione questo aspetto, va però richiamata anche una dimensione dell'etica che è più fondamentale ancora della responsabilità: l'attenzione. Correlare le cure domiciliari all'attenzione all'altro implica la capacità per l'operatore sanitario di "vedere" dimensioni del paziente e della sua malattia che nel setting ospedaliero non avrebbero mai la possibilità di emergere.
Nella nuova Gestalt che si struttura quando il contesto da sfondo diventa figura la malattia acquista un diverso profilo. Tutto nella casa parla del paziente e della sua famiglia in modo diverso rispetto all'ospedale. La malattia, specie se cronica, non può più essere ridotta a una patologia definita in termini del sapere bio-medico. Emerge in primo piano tutto il non biologico ― i fattori sociali, psicologici e spirituali ― che specialmente nella malattia a lungo termine si connettono con quelli biologici in modo inseparabile. Nelle cure domiciliari l’ideologia della medicina olistica ― curare tutto l'uomo, considerando tutto il paziente come persona ― da discorso accademico e ideale a carattere esortativo può diventare una concreta realtà operativa.
La home care non è, quindi, un semplice trasferimento logistico nell'abitazione del paziente di ciò che si fa in ospedale. Comporta, piuttosto, un diverso modello di cure mediche, quasi un cambiamento di paradigma in medicina. E forse questa trasformazione può essere individuata come la causa delle maggiori resistenze tra i sanitari al diffondersi delle cure domiciliari. Basti pensare ― per citare solo uno degli elementi di maggior rilievo ― alla considerazione che in questo paradigma dovrebbe spettare alla famiglia del malato. Essa non può più essere un elemento di contorno, che si cerca il più possibile di isolare (riducendo la sua presenza alle ore di visita in ospedale). Va considerata come fondamentale risorsa per la cura del malato, oppure come il principale ostacolo a essa: un bene, il più delle volte, ambivalente, ma imprescindibile per ogni vero progetto terapeutico. Allo stesso tempo, però, entrare nel "territorio della famiglia" comporta l'ingresso in un ambito estraneo alla formazione professionale che ha avuto il personale sanitario, allontanandosi da ciò che è socialmente accettato come "fare medicina". Un atteggiamento di questo genere è registrato anche presso i giovani medici del programma di cure domiciliari osservati da Andrea Sankar. Uno di questi giunge, dopo due mesi di tirocinio, alla conclusione che "qualcun altro dovrebbe prendersi cura dei malati cronici,
204
non il medico"; altri tirocinanti hanno sviluppato una specie di nichilismo terapeutico, ritenendo che, piuttosto che dagli interventi medici, il benessere del paziente dipende da quelli sociali e psicologici.
Le cure domiciliari provocano nei sanitari un vero disagio, in quanto modificano la filosofia stessa della medicina. Al tempo stesso questa prospettiva ci permette di dare maggior spessore all'appello all'etica. Non si tratta solo di legittimare o delegittimare determinati comportamenti: l'etica comincia con l'attenzione, ovvero con la capacità di vedere. Il più delle volte ciò indica una destrutturazione di schemi e forme precedenti, parziali anche se validi. Tra questi dobbiamo considerare la concezione della malattia e del malato che fa corpo con la medicina ospedaliera.
"Curare la persona intera" rimarrà un'esortazione moralistica, finché la formazione medica e la pratica sanitaria dipenderanno solo dal setting ospedaliero. Si delinea qui un orizzonte di crescita per il medico di medicina generale: non solo verso la riconquista di un profilo positivo di qualificazione professionale, ma anche verso la scoperta del contributo peculiare che può apportare con una diversa concezione della medicina. È una prospettiva particolarmente importante nei confronti della malattia cronica e della geriatria. La visita domiciliare si rivela uno strumento educativo privilegiato per formare l'operatore sanitario a una concezione rispettosa della realtà. Anche l'infermiere che opera nell'ambito delle cure domiciliari è portatore di una diversa cultura medica e di un atteggiamento più attento alla soggettività del paziente.
ESIGENZE ETICHE DELLE CURE A DOMICILIO
Scegliere lo scenario per la cura e l’assistenza dei malati ― l'ospedale o il domicilio ― è un nodo decisionale molto delicato. Dalla scelta dipendono sviluppi di grande importanza, con ricadute sia sulla quantità di vita che si può fornire al malato, sia sulla qualità della stessa. Se all'etica non attribuiamo solo un carattere esortativo-predicatorio, ma anche una funzione di aiuto nella scelta tra le alternative, dobbiamo chiederle di guidare in forma metodica la decisione relativa all’ambiente migliore per assistere il malato nella fase finale della sua vita.
Intuitivamente comprendiamo che un luogo può essere "migliore", cioè più appropriato, di un altro. Dall'etica ci aspettiamo che ci aiuti a ragionare valutando in che cosa consista il "meglio". Per procedere in forma schematica, sottoponiamo la scelta preferenziale a due interrogativi: meglio per chi? E: meglio rispetto a che cosa? Il primo aspetto rimanda piuttosto agli aspetti procedurali dell'etica (chi deve prendere la decisione? quali parti in causa hanno diritto di far valere le proprie esigenze? in caso di conflitto; gli interessi di chi hanno diritto di priorità?). Il secondo interrogativo ci orienta verso gli aspetti sostantivi nell'etica, cioè i valori che le scelte intendono tutelare.
Sembra ovvio che quando ci si domanda se sia meglio l'ospedale o la casa per assistere il malato, soprattutto nella fase terminale della vita, si pensi al suo bene. Così è, così deve essere. L'etica medica tradizionale ha affidato in particolare al professionista sanitario il ruolo di "avvocato" del malato, sapendo che questi si trova in una condizione di fragilità da cui altri potrebbero trarre un indebito vantaggio. Perché intorno al letto di un malato ― in particolar modo di un malato cosiddetto "terminale" ― si addensano numerosi interessi, che possono entrare in conflitto.
I familiari, ai quali spesso spetta la decisione finale sull'alternativa tra casa e ospedale, portano nella scelta motivazioni e interessi diversi, senza escludere quelli che pescano nel torbido. La famiglia, che magari ha assicurato un'assistenza logorante per un tempo lunghissimo, potrebbe propendere per una soluzione che acceleri la fine. Oppure potrebbe volere, sempre per motivi poco nobili, proprio il contrario.
205
Un caso clinico
Il signor Francesco, 93 anni, da mesi sta andando verso la fine. È assistito a casa da una signora molto più giovane, che nel corso degli anni da infermiera è diventata sua convivente. Non hanno mai celebrato le nozze, per una promessa che il signor Francesco aveva fatto, molti anni addietro, a sua moglie sul letto di morte, che non si sarebbe più risposato. Tuttavia i parenti sanno che parte consistente del notevole patrimonio è destinata nel testamento alla convivente. I nipoti iniziano una causa per far dichiarare il signor Francesco incapace di intendere e di volere, con l'intento di contestare il testamento. L'udienza è fissata per metà gennaio. Poco prima di Natale, l'anziano malato sta declinando rapidamente, a casa, dove ha sempre voluto restare, assistito dalla convivente, che ha organizzato un servizio infermieristico 24 ore su 24.1 nipoti accusano la donna di non fare quanto era medicalmente appropriato per il malato. Fanno pressione sul medico di famiglia perché sia trasferito nell'ospedale della cittadina dove risiede. La convivente non può opporsi, per non destare sospetti, e deve accettare un trasferimento straziante per il vecchio, che è ancora lucido. In ospedale le condizioni peggiorano. I parenti, preoccupati che il malato non possa farcela per l'udienza di metà gennaio, brigano perché sia trasferito in un grande ospedale di una città vicina, che è dotato del servizio di rianimazione. Arrivano anche a offrire una somma consistente al primario della rianimazione perché lo accetti e lo tenga in vita fino all'udienza. Il primario rifiuta, sdegnato. Il signor Francesco riesce a morire nei primi giorni di gennaio.
Anche senza essere così spudoratamente disonesti, gli interessi della famiglia possono essere in rotta di collisione con il miglior interesse del malato. Oggi, in epoca di ospedali resi responsabili dei bilanci e di sanità confrontata con i vincoli dell'economia, il medico ― e i familiari ― potrebbero trovarsi a dover difendere il malato da chi vorrebbe dimetterlo dall'ospedale, perché curarlo a casa è meno dispendioso per ['"azienda". Il malato va tutelato nei confronti di interpretazioni ragioneristiche dei DRG, che potrebbero portare a utilizzare le modalità di pagamento a tariffa contro l'interesse del malato ad avere le cure appropriate, nel luogo appropriato.
La tutela del malato dalle misure restrittive che derivano dall'attuale "scarsità fiscale" costituisce un'attualizzazione nuova di quella "avvocatura" che è parte essenziale dell'etica medica di ieri e di sempre. La scelta tra gli interessi delle parti in causa non è sempre un processo lineare. Esistono, infatti, dei legittimi diritti, sia dei familiari che dalla società, che possono porre dei limiti al diritto del malato stesso che si faccia per lui tutto il possibile. Al caso clinico precedente, tratto dall'esperienza vissuta, accostiamo un riferimento letterario, che sa cogliere in modo drammatico il conflitto tra i diritti dei vivi e i diritti dei morenti, che si ripercuote sulle scelte cliniche. Lo attingiamo da La montagna incantata di Thomas Mann. Lo scenario è quello del Berghof, un sanatorio dove sono curati i malati di tubercolosi; date le limitate capacità terapeutiche dell'epoca, spesso l'esito della malattia era il decesso. Uno di coloro che sono arrivati al capolinea è un gentiluomo austriaco. Una infermiera spiega a due altri ospiti del sanatorio la situazione:
Da un pezzo aveva dato prova di essere un gentiluomo tenace, ma negli ultimi tempi nessuno riusciva a capire con che cosa respirasse; vero è che da qualche giorno si teneva su con enormi quantità di ossigeno e solo nelle ultime ventiquattro ore aveva consumato la bellezza di quaranta bombole da sei franchi l'una. Era una grossa spesa, come i signori potevano calcolare, senza dire che la moglie, tra le cui braccia era deceduto, era assolutamente priva di mezzi.
Questa scelta suscita la vivace disapprovazione di uno dei malati:
A che scopo prolungare la tortura e quella costosa vita artificiale in un caso del tutto disperato? Certo, non c’era da prendersela con lui se aveva consumato alla cieca il prezioso gas vitale, considerando che glielo avevano imposto. I curanti avrebbero invece dovuto essere più ragionevoli e lasciarlo andare in
206
santa pace per il suo inevitabile cammino, prescindendo dalla condizione finanziaria o anzi tenendone conto. Anche i vivi hanno i loro diritti.
In notevole anticipo sui tempi ― il romanzo è apparso nel 1924 ― Thomas Mann ha colto un conflitto di interessi tra le parti in causa nell'allocazione delle risorse, che avrebbe reso sempre più difficili le decisioni cliniche sul finire del secolo. Ci ricorda che la decisione clinica va collocata concretamente in un contesto fatto di rapporti affettivi, legami, conflitti; il bene del malato non può essere isolato dal bene della famiglia e, essendo spesso il malato in queste condizioni incapace di prendere le decisioni per se stesso, dalle interpretazioni che i familiari sono costretti a fare del suo bene.
Anche la considerazione degli interessi della società può essere soggetta a un'interpretazione positiva. Le cure "futili" ― in quanto il gradimento del malato non compensa i notevoli costi per la società, che ha a disposizione solo risorse limitate per la sanità ― non superano la prova della "appropriatezza sociale". Il bene dell'individuo e il bene della società non possono ignorarsi reciprocamente, ma vanno opportunamente bilanciati.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'etica, un prezioso aiuto è offerto dai principi, elaborati dalla bioetica americana. Si tratta degli ormai celebri principi di beneficità (beneficence), non maleficità, autonomia e giustizia. Le scelte, comprese quelle relative al luogo dove concludere la vita, vanno confrontate con l'orientamento condiviso costituito dai principi. Dobbiamo domandarci, in altre parole, se la scelta del domicilio o dell'ospedale faccia il bene del malato (beneficencé), non gli procuri un danno ("non maleficità"), rispetti la sua decisione autonoma e sia in accordo con le esigenze dell'equità. Un apporto ulteriore alla bioetica dei principi è stato offerto da Diego Gracia, il quale ha proposto una gerarchizzazione tra i principi stessi. Ciò vuol dire che, quando entrano in conflitto, prevale il principio gerarchicamente più alto.
Al primo posto devono essere collocati i due principi della "non maleficità" e della giustizia. Questi dipendono dalla convinzione generale che tutti gli esseri umani devono essere trattati con uguale considerazione e rispetto. I comportamenti collegati a questi principi non dipendono direttamente dalla volontà delle persone. Non possiamo fare del male a qualcuno, anche se ce lo chiede. Lo stesso avviene con la giustizia: sul piano sociale si commette un'ingiustizia quando le persone non vengono trattate con uguale considerazione e rispetto, qualunque siano le loro preferenze soggettive. Gli obblighi della "non maleficità" e della giustizia si possono stabilire non criteri universali e comuni, che valgono per tutti, e vincolano indipendentemente dalla volontà delle persone.
Il principio di autonomia, invece, richiede che i valori e le preferenze delle persone siano rispettati. Per quanto importante sia, gerarchicamente è inferiore alle esigenze della "non maleficità" e della giustizia. Il principio di beneficità, a sua volta, richiede che il bene (beneficence) sia riferito alla situazione concreta di una persona, a ciò che nella sua valutazione corrisponde a un valore: non si può fare del bene a un altro contro la sua volontà, benché siamo obbligati a non fargli del male anche se, per assurdo, lo desiderasse.
Nel sistema etico proposto da Diego Gracia il livello in cui l'azione è retta dai principi di "non maleficità" e di giustizia corrisponde all'"etica del minimo", alla quale siamo obbligati tutti per forza superiore; il livello ispirato alla beneficità e controllato dalla "autonomia" dell'individuo corrisponde all'"etica del massimo". Quest'ultimo dipende dal sistema di valori personali, dagli ideali di perfezione e felicità che abbiamo fatto nostri. Una è l'etica del dovere, l'altra è l'etica della felicità.
I valori e le preferenze del paziente hanno un grande peso quando la decisione relativa allo scenario delle cure ― l'abitazione, l'ospedale, l'hospice, la RSA? ― incide sull'ideale di "buona vita" a cui la persona tende. Da questo punto di vista, nessuno è più in grado del paziente stesso di decidere quale sia "il meglio" per lui. La situazione familiare, l'articolazione personale della speranza,
207
i legami residui, il grado di evoluzione spirituale realizzata, la tollerabilità dei sintomi sono altrettante variabili che rendono "migliore" l'uno o l’altro ambiente.
Questa prospettiva, che attribuisce pieno rilievo alla "beneficità" del trattamento così come è percepita dal paziente stesso, costringe il sanitario a rimettere in discussione la prospettiva tipica dell'etica medica tradizionale, che identifica nel prolungamento della vita l'unico bene da perseguire. L'etica medica, centrata sulla difesa del "minimo morale", ha piuttosto valore di controllo e di tutela dagli abusi; la bioetica, che promuove l'autonomia e l'autodeterminazione, è l'orizzonte proprio della modernità. L'una non può far a meno dell'altra, se vogliamo procedere verso la giusta decisione.
Le cure domiciliari richiedono una pratica della medicina in cui i servizi di diagnosi e cura non siano inferiori allo standard fornito dalle istituzioni ospedaliere; allo stesso tempo, per il fatto di svolgersi nel domicilio stesso del paziente, la dimensione personalizzata delle cure è destinata a soddisfare le più alte richieste di qualità avanzate dalla medicina umanistica.
Una quantità di figure professionali ― medici, infermieri, fisioterapisti, operatori tecnici ausiliari, assistenti sociali, psicologi ― assicurano, insieme a prestatori di opera non professionali ― familiari, volontari ― lo svolgimento delle cure domiciliari. Ogni professionista sanitario orienta la propria azione secondo le esigenze normative espresse dal codice deontologico della propria professione. Le linee-guida che suggeriamo non sostituiscono i codici deontologici. Si limitano a proporre le esigenze etiche comuni che, al di là dei vincoli delle singole professioni, reggono il comportamento di tutti coloro che sono coinvolti nelle cure domiciliari.
UN CODICE DEONTOLOGICO PER LE CURE DOMICILIARI
Sulla base delle precedenti considerazioni teoriche, si può procedere a delineare alcuni orientamenti comportamentali che traducono in modo più operativo le esigenze etiche delle cure domiciliari.
● Il paziente a domicilio. Le cure domiciliari costituiscono una singolare opportunità di dare forma vissuta al "diritto alla salute", che la Costituzione riconosce al cittadino e che la pratica sociale ha sviluppato come diritto all'autodeterminazione. La cura a domicilio può essere così intesa come una opportunità che realizza concretamente la libertà di scelta delle persone rispetto al modo di curarsi.
● Cure domiciliari e autonomia della persona. La cura a domicilio tutela, più di quanto possa fare il contesto ospedaliero, l'autorealizzazione delle persone, la qualità della vita e l'armonizzazione dell'attività sanitaria con i valori soggettivi, le convinzioni e le preferenze del paziente.
● La famiglia. Ogni famiglia è costituita da una rete di relazioni vissute e da un insieme di valori condivisi. Nella rete dei rapporti familiari si sviluppano altresì relazioni conflittuali, che possono costituire occasione di prevaricazioni sui più deboli.
I professionisti sanitari devono saper valorizzare la famiglia, che costituisce una risorsa preziosa e molto spesso il presupposto stesso perché si possano fornire cure domiciliari. Tuttavia dovranno essere avvertiti delle dinamiche in atto nella famiglia ed essere in grado controllarle, affinché non diventino un limite alla libertà del paziente.
● L'informazione. Il consenso del paziente a sottomettersi alle cure che gli sono state proposte è una condizione fondamentale perché le cure mediche e infermieristiche possano essere
208
eticamente giustificate. Solo l'informazione adeguata rende possibile l'autodeterminazione. Essa è necessaria per un consenso moralmente valido. È illecito usare la coercizione o la manipolazione per ottenere il consenso del paziente.
Nell'ambito delle cure domiciliari l'informazione deve mettere il paziente in grado di valutare il livello e il tipo di cure che riceve a casa (rispetto a quelle possibili in un presidio ospedaliero), nonché benefici e limiti dell'assistenza domiciliare.
Al medico, all'infermiere e agli altri operatori sanitari spetta di informare il paziente e di rispondere alle sue richieste di informazione, ognuno per il proprio ambito di competenza. Qualora le domande superino le proprie conoscenze o competenze, il paziente sarà rinviato al professionista che può rispondere alla richiesta.
Nelle cure domiciliari il diritto del paziente a partecipare attivamente al trattamento e a fare le scelte essenziali che riguardano la vita e la salute in conformità con i propri valori ― diritto sempre più riconosciuto dal consenso contemporaneo sulla buona pratica medica ― è il principio che ispira tutti i professionisti.
● Diritto alla riservatezza. La privacy e il diritto alla riservatezza al domicilio del paziente si impongono con forza particolare. Il sanitario è ammesso nel domicilio in qualità di ospite: anche nell'esercizio di attività professionali di cura, non dimenticherà gli obblighi connessi con le regole dell'ospitalità.
Il diritto alla riservatezza si estende a tutte le informazioni che l'operatore sanitario acquisisce al domicilio del paziente. Memore della restrizione già contenuta nel Giuramento di Ippocrate ― "Tutto quello che durante la cura e anche all'infuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra" ― il professionista che pratica le cure domiciliari si atterrà scrupolosamente al segreto professionale (salvo i limiti previsti dalla legge, di cui il paziente dovrà essere messo al corrente).
● Gli operatori. Le cure domiciliari richiedono l'intervento di un'équipe affiatata e collaborativa (pur facendo ogni figura professionale riferimento alle regole della propria professione e al proprio codice deontologico). I diversi operatori devono essere formati alla modalità di lavoro interprofessionale e al rispetto di un piano di lavoro personalizzato, da tutti condiviso.
La collaborazione tra i diversi professionisti non deve mettere in ombra il principio che esiste un'unica responsabilità della cura.
● Conflitti etici del medico curante. Le richieste del paziente, capace di intendere e di volere, possono entrare in conflitto con le convinzioni morali del sanitario. L'esercizio della sua libertà di coscienza lo autorizza in questi casi a rifiutarle.
Qualora il conflitto sia con le richieste della famiglia, il medico orienterà il proprio operato alla tutela del migliore interesse del paziente.
Nel conflitto con gli interessi di terze parti, prevalgono i criteri professionali ed etici del medico. Il medico orienterà la propria azione alle indicazioni del codice deontologico e a quelle dell'Ordine professionale.
● Conflitti etici dell’attività di nursing. Nelle cure domiciliari la figura dell'infermiere tende ad assumere funzioni che di fatto eccedono i compiti che la cultura sanitaria e l'ordinamento giuridico gli attribuiscono. Di conseguenza, l'infermiere può venire a trovarsi in conflitti ― con il paziente, con i familiari, con terze parti ― analoghi a quelli del medico. In tal caso, gli orientamenti precedenti valgono anche per l'infermiere.
209
● I consulenti e gli specialisti. L'intervento di consulenti e specialisti non deve oscurare il principio della unitarietà della cura, che si esprime mediante la programmazione e un piano di assistenza personalizzato. Ne deriva come corollario le responsabilità del medico curante.
● La formazione alle cure domiciliari. Le figure professionali coinvolte nelle cure domiciliari dovranno essere accreditate mediante un training formativo che tenga in considerazione le particolari condizioni di esercizio della medicina a domicilio del paziente. La formazione dovrà sviluppare le competenze degli operatori anche nell'ambito dei problemi etici e relazionali.
210
211
17
LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI
PARLARE? TACERE? MENTIRE?
La scena di un vecchio film ci permette di visualizzare, grazie a una situazione tipica nell'ambito sanitario, come avvenga una comunicazione anche in assenza di informazione. Si tratta del film Vivere del regista giapponese Akira Kurosawa, del 1952, un classico della storia del cinema. Il protagonista, un umile impiegato del catasto di Tokyo, va a farsi visitare da un medico per persistenti dolori allo stomaco. In sala d'attesa ha un colloquio informale con un veterano degli ambulatori medici. Dapprima l'interlocutore gli descrive esattamente i sintomi del cancro allo stomaco (che sono quelli che lamenta il nostro paziente...). Poi passa a predire il comportamento del medico: se questi, guardando la radiografia, minimizza, nega risolutamente che si tratti di cancro, scherza e gli dice che può mangiare tutto quello che vuole, può essere certo: la diagnosi di cancro è confermata! Al paziente restano solo pochi mesi di vita. E proprio in questo modo indiretto il nostro impiegato verrà a conoscere la sentenza che lo riguarda. Anche in assenza di un'informazione veritiera, la comunicazione relativa al suo stato di salute è giunta fino a lui.
È possibile, dunque, comunicare senza informare; inversamente, si può informare senza comunicare. I fautori dell'introduzione nella pratica clinica del modello di rapporto che considera come valore unico e assoluto l'"autonomia" del paziente e la sua titolarità all’informazione rischiano di trasmettere, sì, informazioni, ma violando il soggetto e calpestando le sue emozioni, invece di instaurare un processo comunicativo. La percezione delle esigenze connesse con la comunicazione nell'ambito delle cure sanitarie, che eccede largamente i contenuti informativi che si possono trasmettere con le parole, è necessaria per affrontare una delle questioni più spinose dell'etica clinica: bisogna comunicare o tacere una diagnosi infausta?
"Dottore, è grave?" La domanda, in cui si riversa la più profonda preoccupazione di chi si sente minacciato dalla malattia, è uno dei punti nevralgici del rapporto medico-paziente. Pronunciata in modo pacato o con animo visibilmente angosciato, provoca sempre un turbamento nel sanitario sollecitato a rispondere. Dal terreno delle certezze ― relative, ma pur sempre affidabili ― della scienza medica, si trova proiettato in quello insidioso di un rapporto interpersonale, in cui tanto il tacere la verità quanto il comunicarla possono produrre un imprevedibile danno nel paziente. Il sapere in questo campo non è soltanto quello dei riscontri oggettivi e verificabili, ma è soggettivo, ambiguo, e passa attraverso il delicato processo dell'interpretazione.
Spesso il medico si trova paralizzato in un conflitto, da cui non sa come uscire. È consapevole degli inconvenienti del silenzio: sottrae in tal modo al paziente le informazioni di cui questi ha bisogno per prendere le decisioni sulla propria vita; si assume le responsabilità di decidere
212
al posto di un altro; rischia comportamenti ipocriti con il paziente, il quale, costretto ad adeguarsi al gioco della simulazione, perde la possibilità di ogni vero contatto con il suo ambiente.
Ma anche comunicare la diagnosi ― evidentemente nei casi di prognosi infausta o mortale ― può comportare seri inconvenienti. Lo shock della notizia può avere esiti antiterapeutici: il malato può cadere in una forte depressione, smettere di mobilitare le proprie forze per sopravvivere; addirittura potrebbe anche giungere a procurarsi la morte col suicidio. Sono numerosi i professionisti della sanità che ritengono una gratuita crudeltà verso il malato comunicargli la prognosi infausta. Tacere, quindi, ed essere reticenti? E, qualora ciò non sia possibile, mentire? Oppure attestarsi sul fronte della verità: sempre, a tutti i costi?
In pochi ambiti del comportamento medico una condotta stereotipata è tanto nociva come in questo. Al medico si domanda di tener conto della personalità del malato, di interpretare la sua richiesta, di essere attento a come si modifica nel tempo la sua domanda e quali sono gli atteggiamenti emotivi che l'accompagnano. Ciò è possibile solo all'interno di un rapporto che si sintonizzi sulla gamma "relazione d'aiuto-relazione interpersonale", in cui emerge ciò che rende unica ogni persona. In questo ambito le ricette generali (dire sempre la verità... non dirla mai) sono di poca utilità. Compito dell'etica è di elaborare delle indicazioni, intermedie tra il comportamento stereotipato e l'unicità del caso individuale, che orientino il comportamento del medico.
Partendo dalle più generiche rivelazioni di tendenza, osserviamo che oggi il problema della verità al malato si pone in un contesto diverso rispetto al passato. La prospettiva tradizionale partiva dagli obblighi del medico verso il paziente. Era ritenuto dovere del medico informare il paziente, in quanto l'informazione faceva parte del bene che il medico era tenuto a procurare al malato. In un'ottica religiosa, questo dovere era rinforzato dall'obbligo di provvedere al bene spirituale del malato, inducendolo, con la comunicazione della gravità del suo male, a occuparsi dell'anima e della salvezza eterna.
La sensibilità odierna valuta questo atteggiamento, ancorato sul senso dell'obbligo del sanitario verso il paziente, come viziato di paternalismo. La prospettiva che oggi prevale è quella che parte dai diritti del paziente. Viene considerato un diritto fondamentale della persona conoscere la verità e ricevere l'adeguata informazione necessaria per prendere le decisioni terapeutiche ed esistenziali che lo riguardano. Senza una conoscenza del proprio stato di salute e della prognosi, non si può dare un consenso libero e informato alla terapia proposta; eventualmente rifiutarla; in ogni caso, mantenere il controllo del proprio destino.
Il dovere della verità, corrispettivo al diritto da parte del malato, non è assoluto; ammette perciò delle deroghe. Anche se la presunzione generale è a favore della trasparenza, circostanze particolari possono indurre a nascondere in tutto o in parte la verità. Il dovere di informare non va inteso come un "accanimento" a far sapere la diagnosi a ogni costo. Il paziente può anche esprimere la volontà di non sapere: sia esplicitamente ("Se ho un cancro o se sono condannato, preferisco non sapere"), sia implicitamente (per esempio "dimenticando" ciò che in precedenza si sapeva...). Anche questa volontà deve essere rispettata.
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLE DECISIONI CLINICHE
Un caso clinico
Un medico racconta: "Il signor M., di 70 anni, era ricoverato nel nostro ospedale (una clinica specializzata in pneumologia). Da una broncoscopia risultò un tumore polmonare in stato avanzato, che aveva già raggiunto i due bronchi e la trachea. La forte dispnea aveva reso necessario l'immediato ricorso a una laserterapia, con un leggero e provvisorio miglioramento della dispnea. Quattro giorni dopo il ricovero, il signor M. stava peggio e la sua morte era imminente.
213
La famiglia era stata informata della prognosi infausta. Resomi conto della situazione critica, feci chiamare subito la famiglia. Questa era composta dalla moglie, due figli verso la quarantina, con rispettive mogli, e una figlia di circa 30 anni.
Il figlio più grande mi parlò per primo e volle sapere come si fosse arrivati allo stato attuale. Gli spiegai che, come già sapeva, il padre soffriva di un tumore maligno progressivo. Ciò fu fortemente contestato dal figlio: affermò che nessuno glielo aveva detto. Mi informai presso l'infermiera, la quale mi disse di essere stata presente ai colloqui con cui erano stati informati i due figli.
Cercai di spiegare la situazione ancora una volta al figlio; gli dissi che il padre soffriva di un tumore progressivo dei bronchi e che le nostre possibilità terapeutiche erano giunte al termine. La morte sarebbe probabilmente sopravvenuta entro poche ore. Il figlio rimase interdetto. Disse più volte che questo non poteva essere: la settimana prima il padre stava seduto in giardino; poteva ben essere un tumore maligno, ma una morte così rapida non era possibile. Mi supplicò di fare tutto il possibile per suo padre: la medicina è oggi così progredita che deve essere in grado di fare ancora qualcosa; avremmo potuto applicare ancora la laserterapia, ricorrere alla respirazione artificiale o alla macchina cuore-polmoni: per suo padre doveva essere tentato tutto il possibile. Anche l'altro figlio era d'accordo con il fratello: si doveva tentare ogni trattamento, anche il più aggressivo.
Un colloquio con il primario, che discusse di nuovo la situazione con i due figli del paziente, non li soddisfece. Nell'équipe medica discutemmo se non era ancora possibile un intervento con il laser. Ci appariva rischioso e, anche se fosse riuscito, avrebbe assicurato al paziente solo una breve sopravvivenza molto dolorosa, in estrema dispnea e senza la possibilità di essere dimesso dall'ospedale. La nostra conclusione era che i pesi sarebbero stati maggiori dei benefici. Tutti noi medici eravamo d'accordo che non avremmo dato il consenso per un tale trattamento, nel caso in cui si fosse trattato di nostro padre.
Nel frattempo il signor M. era entrato in coma. Discutemmo la situazione ancora una volta al letto del malato, dicendo in parole semplici a tutta la famiglia ciò che prima avevamo deliberato tra di noi. Il primario ripeté ancora che l'intervento comportava un altissimo rischio e che egli perciò lo sconsigliava. Chiese poi all'infermiera, che era presente, quale fosse la sua opinione. Questa disse spontaneamente che lei avrebbe lasciato la decisione alla famiglia.
Il primario tracciò ancora una volta i due scenari: da una parte il paziente in uno stato di assopimento, verosimilmente senza dolori, vicino alla morte che incombe circondato dalla sua famiglia (diventata nel frattempo ancora più numerosa); dall'altra, un intervento medico aggressivo, che potrebbe portare alla morte sul tavolo della broncoscopia, molto probabilmente senza alcuna possibilità di tornare ancora una volta a casa sua. La sua opinione era che il "non fare" era la migliore via da seguire; ma in ogni caso era pronto a eseguire l'intervento, se la famiglia proprio lo voleva.
La famiglia si consultò per circa mezz'oretta; dopo di che, ci comunicò che non voleva nessun altro intervento. La moglie e la figlia ci fecero capire chiaramente che erano d'accordo con noi mentre per i figli fu più difficile accettare il "non volere fare qualcosa". Il signor M. morì un'ora più tardi. La famiglia ci ringraziò; lasciò l'ospedale in grande cordoglio, ma senza collera".
Che posto occupa la famiglia in quel processo deliberativo attraverso il quale i curanti cercano di fare della buona medicina? Il racconto del caso clinico ― assolutamente non eccezionale, nel quale potremmo trovare realizzato un modello diffuso di pratica medica consapevole ― ci ha presentato un'équipe sanitaria che nel prendere le decisioni tiene presente non solo il malato ma anche la sua famiglia. Questa è stata coinvolta nel processo decisionale circa il corso dell'azione, con rallentamenti, esitazioni, discussioni, esercizio dell'arte della persuasione. Alla fine la decisione solo apparentemente era la stessa proposta inizialmente dall'équipe curante. In realtà, il processo che li ha coinvolti tutti li ha anche modificati.
Il ruolo della famiglia emerge in particolare in quella situazione che per un medico di cultura latino-mediterranea ― considerata come antitetica a quella anglosassone ― costituisce il dilemma etico per antonomasia: si deve o no comunicare una diagnosi a prognosi infausta a
214
un paziente? A ridosso di questo interrogativo si colloca quello relativo al ruolo della famiglia. Ovvero: se il medico decide di sottrarre l'informazione al malato, è tenuto a darla ai suoi familiari?
Se seguiamo l'evoluzione delle regole deontologiche, formulate dal codice dei medici italiani, possiamo renderci conto delle oscillazioni sul ruolo che spetta alla famiglia. Ancor più: nel giro di appena vent'anni, le varie redazioni del codice hanno registrato un cambiamento di 180 gradi. Dalla famiglia vista come l'interlocutore privilegiato del medico si è arrivati alla famiglia completamente delegittimata a gestire le informazioni a beneficio del proprio familiare.
Il punto di partenza è costituito dal codice deontologico del 1978, che rispecchia la prassi tradizionalmente ritenuta corretta. L'articolo 30 affermava:
Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non alla famiglia.
L'orientamento era cambiato nella revisione datata 1989 (art. 39):
Il medico può valutare l'opportunità di tenere nascosta al malato e di attenuare una prognosi grave o infausta, che dovrà essere comunque comunicata ai congiunti. In ogni caso la volontà del paziente, liberamente espressa, deve rappresentare per il medico elemento determinante al quale ispirare il proprio comportamento.
Dal confronto tra queste due redazioni del codice ― tra le quali intercorre appena un decennio ― risulta che le modifiche del comportamento consigliato al medico riguardano solo dettagli marginali. La parola "famiglia" è stata sostituita da "congiunti". Anche in Italia, infatti, l'immagine tradizionale della famiglia, in cui le relazioni esistenti di fatto rispecchiano sostanzialmente ciò che risulta all'ufficio di stato civile, cede il passo a situazioni più mobili e "irregolari". La nuova formulazione permetteva di equiparare alla famiglia anche un convivente, ovvero chiunque avesse un rapporto significativo con il malato.
Veniva inoltre individuata la "volontà del paziente" come criterio guida per il comportamento del medico. È un primo timido accenno al superamento di quell'orientamento "paternalista" che ha sempre caratterizzato la medicina, secondo il quale è il medico che decide al posto del paziente, per il suo bene. Tuttavia non si tratta di una vera adesione al principio dell'autonomia del paziente; tant'è vero che il ruolo della famiglia non viene attenuato, bensì accentuato (il medico deve comunicare la prognosi ai congiunti!). Si intravede sullo sfondo l'ethos di quella struttura familiare che la ricerca antropologica ha chiamato "familismo". Questo comporta meccanismi di controllo sociale che orientano le scelte degli individui e dei gruppi. Particolarmente nelle situazioni di crisi ― come è al massimo grado una malattia a prognosi infausta ― la regia delle decisioni viene sottratta all'individuo e assunta dal gruppo familiare.
L'innovazione ― o piuttosto il cambiamento radicale ― è intervenuta con la redazione del codice deontologico del 1995. Un intero paragrafo ― l'art. 29 ― esplicita il comportamento che il medico deve tenere nell'informare il paziente, il quale appare come il diretto interlocutore del sanitario e l'unico titolare delle notizie di diagnosi e prognosi che Io riguardano. Va esplicitato che solo con la redazione del codice del 1995 appare il concetto di "consenso informato", che era estraneo alla deontologia medica tradizionale (art. 31). L'informazione alla famiglia (art. 30) recede sullo sfondo; o piuttosto, è condizionata dalla volontà del malato di coinvolgere i suoi congiunti. Viene quindi delegittimata la prassi corrente, che affida a questi ultimi il giudizio di opportunità se informare o no il paziente stesso.
Il profilo generale dell'informazione, secondo la deontologia medica, viene così a delinearsi:
● Art. 29. Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, la prognosi, le prospettive
215
terapeutiche e le loro conseguenze, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta. Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza.
La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale.
Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione ai pazienti in condizione di degenza, in accordo e collaborazione con il medico curante.
● Art. 30. Il medico è tenuto a informare i congiunti del paziente che non sia in grado di comprendere le informazioni relative al suo stato di salute o che esprima il desiderio di rendere i suddetti partecipi delle sue condizioni.
● Art. 31. Il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato.
Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta in tutti i casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente.
La successiva revisione del codice, datata 1998, introduce un ulteriore giro di vite, in quanto recepisce le norme introdotte nel frattempo che regolano la privacy (legge 675/1996: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"). In accordo con la nuova prospettiva, anche le persone più vicine affettivamente al paziente vengono considerate "terze parti" rispetto al medico e al malato:
● Art. 31. Informazione a terzi. L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
L'evoluzione delle regole comportamentali proposte dai codici deontologici medici circa l'informazione, il consenso e il coinvolgimento della famiglia fa emergere due modelli ideali: uno centrato sull'individuo e rivolto a tutelare la sua autonomia; l'altro orientato alla persona nella sua dimensione relazionale e preoccupato di promuovere la solidarietà. Il modello individualista-autonomista è il più recente. In contesti culturali nei quali la priorità è data ai vincoli interpersonali (famiglia e comunità come soggetti che prendono le decisioni) il diritto dell'individuo di essere informato e di decidere diventa dirompente rispetto al modello della tradizione.
Lo spostarsi del pendolo verso l'autonomia non ha l'aria di essere un'oscillazione dovuta alla moda: la cultura della modernità sente che è "giusto" non privare l'individuo delle informazioni che fanno di lui un soggetto, e non solo un oggetto di cure premurose. L'autonomia pone un limite al paternalismo medico e tutela l'individuo dalle intrusioni della famiglia. Questa rischia di essere una realtà agglutinante, che si sovrappone all'individuo. Quando il medico prende le decisioni con il consenso della famiglia, scavalcando la volontà della persona malata, rischia di colludere con i familiari, ai danni del paziente. Nei casi peggiori possiamo ipotizzare situazioni in cui i familiari hanno interesse a decisioni cliniche che prevedono un accorciamento della speranza di vita del malato (per un testamento, un'eredità ecc.). Sono casi di rilevanza giudiziaria, più che etica.
216
Più insidiosi sono i casi in cui la famiglia cerca un'alleanza strategica col medico che tagli fuori il malato daH'informazione non per motivi volgarmente utilitaristici, ma ispirata da ragioni nobili. Sono le situazioni in cui la famiglia fa quadrato attorno al malato su cui incombe una prognosi infausta per risparmiargli sofferenze morali. La famiglia sceglie, d'accordo con il medico, di sottrarre l'informazione al paziente "per il suo bene", ossia per evitargli uno shock. In questo modo, però, non solo viene sottratta all'individuo la possibilità di confrontarsi ― se questa è la sua preferenza ― consapevolmente con il proprio destino e di prendere le decisioni opportune in tempo utile; ciò che è peggio, la protezione che la famiglia crea attorno a lui per tenere lontane le "cattive notizie", lo isola dai familiari stessi che sanno e minaccia di murarlo in una solitudine emotiva e relazionale. Benché motivata dalla volontà di prendersi cura del proprio congiunto, una iperprotezione di questo genere si rivela ambigua e controproducente. Il modello fatto proprio dalle versioni più recenti del codice deontologico autorizzano il medico, quando le famiglie adottano strategie che privano il malato della sua autonomia, a osare di affrontare la disapprovazione della famiglia, per tutelare il diritto del malato a gestire la propria vita.
La riflessione bioetica ha messo in evidenza che alcune pratiche biomediche hanno un forte impatto sulla famiglia. Basti pensare alle tecnologie applicate alla riproduzione, che scardinano punti di riferimento antropologici che si ritenevano saldamente fondati sulla biologia (identità del padre e della madre, sequenza temporale delle generazioni...). L'attenzione, pur legittima, rivolta a queste pratiche ha distolto dal considerare la ripercussione che hanno sulla famiglia anche le decisioni cliniche quotidiane, non riconducibili agli interventi che modificano in modo così vistoso i processi biologici naturali.
Di fatto, la medicina e la famiglia sono due grandi sistemi che tendono a funzionare autonomamente; fanno ricorso l'una all'altra solo quando si scontrano con i propri limiti. È vero che, in misura crescente, l'organizzazione sociale delle cure sanitarie ha sottratto alla famiglia questo compito, affidandolo a istituzioni a ciò deputate (ben lo avvertono i familiari dei malati ricoverati in ospedale, che sentono di essere una presenza estranea, solo tollerata entro ambiti di tempo e di spazio ben delimitati). Ma la famiglia espropriata rischia di essere investita di nuovo, e in modo pesante, del compito di cura e assistenza quando la medicina pubblica istituzionale non è più in grado di far fronte ai suoi impegni. La famiglia viene allora coinvolta per la cura dei malati cronici e per l'assistenza di malati in fase terminale.
Alla famiglia dobbiamo riconoscere solo un valore strumentale, oppure le spetta un ruolo di soggetto, con valori propri e preferenze che vanno considerate nelle decisioni cliniche? Nella pratica della medicina l'attenzione va abitualmente agli interessi del paziente interpretati in modo rigidamente individuale: la sua vita e la sua salute in primo luogo; eventualmente anche le scelte dipendenti dalla sua concezione di qualità della vita. L'individuo è per lo più considerato in uno splendido isolamento e i legami con coloro che condividono la sua vita e le sue scelte sono passati sotto silenzio, come irrilevanti. Ora, nelle altre scelte che costituiscono il tessuto quotidiano dell'esistenza non è cosi: non si sceglie un lavoro, e neppure una semplice vacanza, indipendentemente dal "sistema famiglia", che ne subisce i contraccolpi. Non si capisce perché dovrebbe essere altrimenti nelle scelte che riguardano la salute e le decisioni cliniche.
Gli interessi della famiglia che richiedono di essere presi in considerazione in un processo decisionale sono solo marginalmente quelli economici (almeno così avviene in sistemi sanitari a copertura sociale, come il nostro SSN; è diverso il caso dei Paesi dove la copertura assicurativa è solo parziale, per cui i malati sono obbligati a tener presenti le ripercussioni che una spesa sanitaria avrà sul bilancio della famiglia). I legittimi interessi della famiglia sono anche di altro profilo. Nel caso clinico che ha fornito l'avvio alle nostre considerazioni si trattava di problemi emotivi, come l'elaborazione del distacco e la sensazione di "aver fatto tutto il possibile". Anche
217
queste preoccupazioni non sono irrilevanti in medicina; si deve prestar loro attenzione e tenerle nella debita considerazione.
I problemi che nascono dall'informazione e dal coinvolgimento della famiglia nelle decisioni cliniche non possono essere risolti da una formula che abbia validità universale. Non possiamo dire, semplicisticamente, che la partecipazione della famiglia e il suo consenso nelle decisioni cliniche sia un "di più" facoltativo, come lascia intendere la bioetica centrata sull'autonomia dell'individuo. Ma non si può neppure affermare che la considerazione primaria della famiglia e dei suoi interessi salvaguardi sempre le esigenze dell'etica: potrebbe essere, al contrario, uno strumento di prevaricazione del gruppo sull’individuo. Possiamo solo immaginare che i comportamenti dei sanitari, pur assimilando la cultura dei diritti individuali, non dimentichino di tenere nel debito conto il posto che hanno i legami interpersonali e le relazioni familiari.
218
219
capitolo
18
TRATTAMENTO DELLE MALATTIE MENTALI
UN DILEMMA ETICO
Un caso giudiziario, discusso presso la Corte Suprema della California, può darci lo spunto ― al di là dell'interesse propriamente giuridico del fatto ― per delle considerazioni che ci introducano nel vivo dei problemi etici in psichiatria. Un medico psichiatria è stato querelato dai genitori di Tatiana Tarasoff, una ragazza rimasta vittima di uno psicopatico. Questi aveva confidato allo psichiatria, presso cui era in trattamento, la sua intenzione di uccidere la ragazza, che aveva rotto il fidanzamento, quando questa fosse tornata da un viaggio. Il medico aveva fatto internare il suo paziente in un ospedale psichiatrico; dopo un periodo di osservazione, tuttavia, il futuro omicida era stato dimesso. Lo psichiatria si era astenuto dall'avvertire i genitori di Tatiana del pericolo che la ragazza correva.
In tribunale la giuria si divise su due posizioni contrastanti. Quella di maggioranza dichiarò lo psichiatra colpevole di negligenza professionale, anche se Tatiana non era sua paziente. "Quando un terapeuta stabilisce ― si legge nella sentenza ― o, secondo il livello di competenza richiesto dalla professione, dovrebbe essere in grado di stabilire, che un suo paziente presenta un serio grado di pericolo di violenza nei confronti di un altro, è obbligato a proteggere la vittima da tale pericolo"; per esempio, comunicandolo alla polizia. Pur riconoscendo che, per il pubblico interesse, bisogna salvaguardare il carattere confidenziale della comunicazione terapeutica, in quanto questo protegge il diritto del paziente alla privacy e contribuisce all'efficacia della cura delle malattie mentali, tuttavia nel caso specifico la confidenzialità era scavalcata dal pubblico interesse per la sicurezza dall'aggressione violenta.
L’opinione della minoranza, invece, difendeva l'operato dello psichiatra. Questi aveva tutelato i diritti del paziente, non violando la regola della confidenzialità. Non solo; così facendo, aveva contribuito al bene pubblico. Se infatti la regola della riservatezza di ciò che il paziente dice al suo psichiatra venisse infranta, il trattamento psichiatrico sarebbe frustrato e i pazienti perderebbero la fiducia incondizionata nel medico. Il pericolo di aggressioni violente aumenterebbe, invece di diminuire, perché molte persone sarebbero dissuase dal cercare l’aiuto psichiatrico. Qualora si internassero tutte le persone che fanno minacce, la società risulterebbe danneggiata: coloro che presentano effettivamente un rischio di violenza sono pochi, mentre la maggioranza innocua, una volta internata, non potrebbe avere i benefici psicoterapeutici del trattamento basato sulla fiducia.
Il caso Tarasoff ha il vantaggio di introdurci in modo diretto nei problemi etici connessi con la cura delle malattie mentali. Grazie a esso, il problema etico perde il suo carattere astratto: trovarsi
220
in un dilemma significa dover scegliere, pur sapendo che nessuna azione sarà perfetta. Forti ragioni morali e fondate considerazioni deontologiche sostengono le argomentazioni opposte dei giudici, che rappresentano rispettivamente la maggioranza e la minoranza. Ambedue le parti avanzano correttamente dei princìpi morali a sostegno delle differenti conclusioni a cui giungono.
La maggioranza nel disapprovare l'operato dello psichiatra si rifà al principio della "beneficità" (curare la salute, incrementare la qualità della vita, non nuocere ad alcuno) che ispira la condotta del medico; l'opinione di minoranza considera, a giustificazione dello psichiatra, che ha agito coerentemente con il principio dell'autonomia del soggetto e in accordo con la regola della confidenzialità, così importante nel rapporto terapeutico rivolto a curare le malattie mentali. Né l'una né l'altra parte ha ragioni che possano dimostrarsi incontrovertibilmente giuste: alcune evidenze mostrano che il comportamento dello psichiatra è moralmente corretto, altre che è moralmente sbagliato.
Questa situazione si presenta spesso nella soggettività dell'agente, il quale sente che per ragioni morali contemporaneamente dovrebbe e non dovrebbe compiere certi atti e ometterne certi altri. Tale condizione si aggrava in una società pluralista, dove ci sono più fonti di valori; ne consegue un pluralismo di punti di vista morali su diversi problemi. Una particolare tensione si fa sentire nella psichiatria, per il fatto di trovarsi a cerniera tra l'interesse terapeutico dell'individuo e quello di sicurezza e di ordine che riguarda la società. Anche il dibattito sull'aspetto terapeutico o repressivo della psichiatria si fonda, in ultima analisi, sulla pluralità dei valori etici.
LA PSICHIATRIA È AL SERVIZIO DELLA REPRESSIONE?
La pratica psichiatrica è oggetto di una discussione etico-politica particolarmente vivace. Per alcuni aspetti la medicina che si occupa delle malattie mentali rientra nella più ampia sfera dei problemi bioetici; per altri invece occupa un posto a sé. Già la presentazione del caso Tarasoff ci ha fatto intravedere che la psichiatria si apre su due versanti: quello medico, inteso a favorire la salute e il benessere dell'individuo, e quello sociale, rivolto a reprimere i comportamenti devianti dannosi per il bene pubblico. Il suo esercizio avviene secondo due modalità distinte: la pratica medica di un libero professionista, al quale il paziente si rivolge di propria iniziativa per avere aiuto, e gli aspetti coattivi di un ospedale o clinica psichiatrica, in cui il malato mentale può essere indirizzato e obbligato a essere curato, anche contro la sua volontà.
Il dibattito suscitato dal movimento dell'"antipsichiatria" ha messo sotto accusa alcune forme di questo secondo aspetto. Le istituzioni per l'internamento dei malati mentali sono state indicate come luoghi di emarginazione e repressione dei comportamenti socialmente indesiderati. Il criterio per l'internamento, costituito dalla pericolosità "per sé e per gli altri", è stato spesso esteso all'indesiderabilità (e in tale senso è stato utilizzato da alcune famiglie nei confronti di qualche membro scomodo o sgradito).
Talvolta il semplice non conformismo sociale poteva giustificare l'ospedalizzazione forzata. Conseguente a questa era il trattamento terapeutico, anche malgrado l'opposizione del paziente. L’argomentazione soggiacente può essere così articolata: la malattia mentale, a differenza di qualsiasi altra forma morbosa, influenza proprio la capacità dell'individuo di riconoscere il proprio bisogno di terapia. Per il suo bene, dunque, questa gli viene fornita, anche contro la sua volontà. Ne deriva uno "zelo terapeutico", giustificato in modo paternalistico, che può dar adito a gravi abusi e violazioni della libertà individuale.
Il controllo degli individui per il bene del gruppo non è illegale. La società lo esercita in forme
221
diverse, ma contemporaneamente lo limita e lo disciplina accuratamente. Il controllo e la repressione possono essere esercitati solo da persone autorizzate, e agli individui la legge riconosce il diritto legale di difendersi. Questa tutela diventa impossibile quando il controllo è esercitato dalle istituzioni psichiatriche, sotto la motivazione della terapia, o da altre "istituzioni totali" (prigioni, esercito...), con giustificazione psichiatrica.
La denuncia del rapporto implacabile che esiste fra violenza sociale e debolezza dell'identità individuale non è nuova. L'ha già espressa all'inizio del XX secolo lo scrittore austriaco Karl Kraus, imbastendo una feroce satira della psichiatria giudiziaria. Lo spunto gli era stato offerto dal processo relativo alla principessa Luisa di Sassonia che, colpevole di adulterio, era stata internata in un manicomio, per iniziativa del marito, e dichiarata inferma di mente dai più illustri clinici psichiatri di Vienna. Analizzando le argomentazioni, Kraus smascherava il sofisma: veniva considerato come sintomo di malattia mentale il fatto che la principessa, rivelando una deplorevole carenza del principio di realtà, insistesse a proclamarsi sana di mente e ritenesse un sopruso il suo ricovero coatto in manicomio. Dunque ― deduce Kraus ― la principessa per essere sana dovrebbe riconoscere di essere pazza. Di qui la definizione sferzante dello scrittore: l'uomo finisce con lo psichiatra (in risposta al detto di uno statista austriaco, secondo il quale l'uomo incomincia dal barone...)!
La stessa inattaccabile violenza repressiva delle istituzioni psichiatriche si può trovare oggi presso i clinici che considerano un fenomeno psicopatologico la paura dei pazienti per un trattamento elettroconvulsivo. Se questi rifiutano il trattamento per motivi che allo psichiatra appaiono sproporzionati e irragionevoli, e quindi sintomo di disturbo mentale, possono essere soggetti a ulteriori manipolazioni coercitive, sempre per motivi "terapeutici". La persona, infatti, può essere etichettata come malato mentale per il fatto che rifiuta un trattamento che lo psichiatra prescriverebbe a un malato mentale. Il film di Milos Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo ha portato a livello di massa la consapevolezza del pericolo repressivo insito nelle moderne tecniche terapeutiche della psichiatria. Il protagonista, internato in una istituzione psichiatrica a causa di comportamenti socialmente molesti, non si adegua alle regole interne dell'istituzione; viene perciò sottoposto a "terapie" sempre più dure ― passa successivamente attraverso la psicoterapia di gruppo, gli psicofarmaci, l'elettroshock e la lobotomia, scendendo tutti i gironi dell'inferno psichiatrico ―, fino a essere ridotto a un’innocua larva umana.
Il movimento dell'antipsichiatria si è nettamente demarcato dalla psichiatria medica, per riportare i comportamenti etichettati come malattia mentale nell'ambito delle scienze umane e dei problemi sociali. Con la discussa legge 180 (approvata il 13 maggio 1978) otteneva di tradurre il dibattito teorico sulla psichiatria in una nuova politica sanitaria della salute mentale. Questa prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici, denunciati come luoghi di segregazione e di degradazione, nonché il reinserimento e l'assistenza dei malati mentali nel territorio.
CONTROLLO DEL COMPORTAMENTO E CONSENSO
Nel groviglio di problemi di ogni ordine ― politici, sociali, epistemologici, legali ― che caratterizzano l'attuale situazione psichiatrica, una questione che concerne principalmente l'etica è il problema del consenso alle terapie psichiatriche. A prima vista, nell'ambito della salute mentale il consenso sembra presentarsi in modo completamente diverso rispetto alla salute fisica. Le differenze ovviamente esistono, ma è necessario integrare la prima impressione con il riconoscimento di un fondo di sostanziale analogia. Per toccare subito la differenza più evidente, è vero che la cura psichiatrica può, per disposizione della legge, essere imposta d'autorità, anche contro la volontà del paziente; ma questa è un'evenienza che si realizza anche nell'ambito
222
della medicina somatica, quando si vuol tutelare il bene della salute, che è sociale, oltre che privato. Si pensi, per esempio, al caso dei trattamenti sanitari obbligatori.
Un'altra differenza riguarda il concetto stesso di salute mentale: i professionisti psichiatrici possono avere una loro concezione di salute e malattia, che diverge dalla valutazione autonoma degli interessati. Nel caso degli psicotici, che non hanno mai avuto o hanno perso il contatto con la realtà, la divaricazione tra salute mentale e percezione dei propri problemi può diventare drammatica. Si rende necessaria allora l'imposizione coatta di terapie, senza riguardo per la volontà autonoma dei pazienti, i quali ritengono di non averne bisogno.
Tuttavia, anche nel caso della medicina fisica, il concetto di salute non è esente da una considerazione di valore. Sempre più ci rendiamo conto che la medicina moderna è totalitaria nell'imporre i suoi parametri di salute e malattia, nel medicalizzare situazioni fisiologiche (per esempio la donna incinta o partoriente considerata come malata) e nell'intervenire arbitrariamente per il bene presunto della persona. La questione del consenso informato si pone quindi tanto nella cura della salute fisica, quanto in quella della salute mentale, con differenze più di grado che sostanziali.
La giustificazione morale per la cura non consensuale delle malattie mentali si fonda per lo più sulla possibile divergenza tra il desiderio conscio e quello inconscio di essere curato. L'esemplificazione più chiara ci è fornita da certi casi di tentato suicidio. La persona che è scampata alla morte può dichiarare di rifiutare qualsiasi trattamento e di volere che la si lasci morire. Tra le parole e i fatti, tuttavia, si può rilevare una notevole divergenza. Le parole rifiutano l'aiuto, mentre i fatti ― il tentato suicidio come richiamo di attenzione, il contributo inconscio a far sì che il suicidio fallisca ― lo invocano.
Se il sanitario si attenesse solo alla richiesta consapevole ed esplicita, verrebbe meno ― oltre ovviamente agli obblighi di ordine legale ― all'alleanza terapeutica che lo lega la paziente come persona, quindi anche alla sua realtà inconscia. Ci muoviamo qui sul terreno scivoloso dell'interpretazione, che potrebbe dar adito anche alle peggiori prevaricazioni. Un caso estremo di questo genere è l'uso della psichiatria per "normalizzare" i dissidenti politici nei regimi totalitari. L'ideologia determina in questo caso sanità e malattia mentale; le strutture di potere utilizzano l'arsenale delle terapie psichiatriche per "guarire", vale a dire per eliminare espressioni di pensiero e comportamenti in contrasto con le direttive ideologiche del partito.
L'Associazione psichiatrica mondiale ha elaborato delle norme etiche, con valore di codice deontologico, a cui devono ispirarsi gli psichiatri di ogni Paese. Per quanto riguarda il consenso il testo, noto come "Dichiarazione delle Hawaii" (1977), prevede:
Non si deve intraprendere alcuna procedura, né fornire alcun trattamento, contro o indipendentemente dalla volontà del paziente, a meno che il paziente non abbia la capacità di esprimere i propri desideri o, a seguito della malattia psichiatrica, non sia in grado di vedere qual è il proprio miglior interesse oppure, per le stesse ragioni, costituisca una grave minaccia per gli altri. In questi casi si può e si deve procedere a un trattamento coercitivo, purché sia fatto nell'interesse del paziente e in un periodo ragionevole di tempo si possa presumere un consenso informato retroattivo e, quando è possibile, si ottenga il consenso di qualche familiare del paziente.
Il problema del consenso informato in psichiatria non permette una soluzione per principio; tanto più importanti appaiono perciò le indicazioni pratiche che possono evitare il pericolo di abusi. Una di queste, indicata dall'Associazione psichiatrica mondiale, è la limitazione temporanea del trattamento coercitivo, perché, passata l'emergenza, il paziente stesso possa assumere o respingere la terapia. Un'altra indicazione, connessa alla precedente, è il rifiuto di trattamenti che abbiano effetti irreversibili, e che quindi il paziente non sarà più in grado di ratificare. Il discorso si sposta così sui metodi stessi, alcuni dei quali sollevano perplessità e riserve dal punto di vista etico.
223
ALCUNE TERAPIE PSICHIATRICHE
Gli interrogativi circa l'uso repressivo della psichiatria e il consenso informato si addensano in particolare attorno a tre pratiche psichiatriche: l'uso di farmaci psicotropi, le terapie elettroconvulsive e la psicochirurgia. Quanto ai primi, è un dato storico assodato che la grande svolta della psichiatria contemporanea è dovuta alla disponibilità di farmaci psicoattivi, con la capacità cioè di influenzare le funzioni intellettuali e l'umore.
La psicofarmacologia ha permesso di rinunciare ai mezzi coercitivi brutali del passato e di svuotare gli ospedali psichiatrici. Grazie agli psicofarmaci, i sintomi del comportamento psicotico possono essere controllati, facilitando così il reinserimento del malato nella comunità. L'ospedale psichiatrico, così come l'abbiamo conosciuto fino agli anni Settanta del XX secolo, quale luogo di contenzione, è scomparso. Ma se si considera la qualità della vita di questi pazienti dimessi, le prospettive sono meno idilliache.
Sovraccarichi di farmaci, in uno stato mentale spento od offuscato, ridotto spesso a reazioni lente e meccaniche, come di automi, ci si domanda se per questi pazienti l'essere dimessi dall'ospedale sia un progresso qualitativo. Tuttavia, finché non saranno sviluppati nuovi farmaci che siano effettivamente in grado di "curare" le psicosi, o finché non si svilupperanno nella comunità le risorse umane adeguate per "prendersi cura" di tali pazienti, il ricorso alla psicofarmacologia attuale sembra obbligato, almeno come male minore.
Riserve più marcate cadono sulle terapie che ricorrono alla stimolazione elettrica del cervello (elettroshock). Era osservazione di antica data che alcuni malati mentali miglioravano temporaneamente, dopo un attacco spontaneo. Il passo decisivo fu l'induzione deliberata di convulsioni, ricorrendo alla corrente alternata, a iniezioni intravenose o ad altre sostanze. A seguito del trattamento convulsivo il paziente resta per alcuni minuti senza coscienza e piuttosto confuso; accusa anche una sensibile perdita della memoria. Ma gli psichiatri ritengono che i vantaggi nel sollievo dai sintomi siano superiori ai danni arrecati, e che perciò queste procedure vadano considerate come una vera e propria terapia. Originariamente il trattamento elettroconvulsivo fu introdotto per la schizofrenia; ora è riconosciuto più efficace per il trattamento dei disordini emotivi, particolarmente per la depressione. Viene riconosciuto particolarmente indicato quando si ha un'imminente probabilità di suicidio.
Una tempesta di controversie ha accompagnato fin dall'inizio l'uso delle terapie elettroconvulsive. Mancando conoscenze assodate sulla modalità di funzionamento fisiologico di questo tipo di interventi, si tratta di una cura empirica, di cui non siamo ancora in grado di stabilire le conseguenze a lunga scadenza sul funzionamento del sistema nervoso. Quanto conosciamo degli effetti immediati è già preoccupante: molti clinici hanno l'impressione che dopo frequenti applicazioni di elettroshock la personalità del malato sia spenta. Forti riserve cadono anche sulla possibilità di un consenso informato da parte del paziente, il quale non è messo in grado di poter giudicare con cognizione di causa ciò che gli viene presentato autorevolmente come una "cura", e quindi come intervento terapeutico intrapreso a suo beneficio, per quanto doloroso e invalidante.
Un ulteriore sviluppo delle terapie elettroconvulsive è una stimolazione elettrica del cervello a opera di elettrodi impiantati in profondità nel cervello stesso. Dal livello della ricerca si è passati rapidamente a quello delle applicazioni cliniche, con riferimento all'inibizione di attacchi epilettici e al trattamento di alcuni tipi di psicopatologia. Il carattere sperimentale di questa terapia è ancora più marcato che per l'elettroshock. Di conseguenza, più radicali sono i dubbi sulla liceità morale di questo intervento. La modifica del cervello, infatti, tocca la personalità più di qualsiasi altro tipo di manipolazione.
In questo caso mediante la stimolazione elettrica del cervello si controlla il comportamento di un’altra persona. Anche se ciò avviene per proteggere la società (si pensi al caso di uomini
224
che siano stati protagonisti recidivi di violenze sessuali a bambini e che in tal modo siano impediti di soggiacere ancora ai loro impulsi incontrollati), la negazione della libertà e della dignità di una persona sottoposta a tale trattamento è un prezzo che l'etica vieta di pagare.
Sull'eticità dell'elettroshock è stato coinvolto direttamente il Comitato nazionale per la bioetica, mediante la richiesta se non sia opportuna una sospensione cautelativa di tale terapia. Il parere del CNB, pubblicato nel settembre 1995, non ha preso in considerazione l'efficacia clinica della terapia elettroconvulsivante ― valutazione che può essere solo di competenza tecnico-scientifica ― bensì la relazione di tale intervento con ia tutela della personalità del paziente e della sua dignità. Il CBN,
allo stato attuale, e richiamando la particolare rilevanza etica dei principi generali in materia di consenso informato, ritiene che non vi siano motivazioni bioetiche per porre in dubbio la liceità della terapia elettroconvulsivante nelle indicazioni documentate nella letteratura scientifica.
quadri clinici specifici, per i quali si ritiene che l'elettroshock mantenga la sua validità terapeutica, sono la depressione endogena grave, la depressione delirante, alcuni gravi quadri maniacali e la catatonia acuta con esito infausto. Il CBN conclude il suo parere con una raccomandazione: che nelle strutture dove viene attuata la terapia elettroconvulsivante il comitato etico locale segua e valuti tale pratica.
Consideriamo da ultimo la psicochirurgia. Il trattamento di malattie psichiatriche mediante interventi chirurgici sul cervello è stato già sviluppato negli anni Trenta e conosciuto col nome di "lobotomia". Prima dell'introduzione dei farmaci psicoattivi, negli anni Cinquanta, era considerato l'unico procedimento per venire a capo di disturbi psichiatrici irriducibili. La pratica attuale è più mirata e si limita a intervenire su due regioni del cervello: sui lobi frontali, per le forti depressioni, schizofrenia, stati d'ansia e nevrosi ossessive; sui lobi temporali e sull'ipotalamo, per il comportamento estremamente aggressivo e violento, in particolare per le violenze sessuali.
Quando tra gli anni Sessanta e Settanta la psichiatria diventò uno dei più discussi temi di politica, la psicochirurgia figurò tra i principali capi di imputazione. I problemi che essa solleva sono di diverso ordine: medico (che cosa produce esattamente l'intervento chirurgico sul cervello? Si può qualificare come terapia un procedimento che ha tuttora un carattere empirico-sperimentale e i cui effetti sono irreversibili?); antropologico (siamo di fronte a un'irresponsabile intrusione nel santuario più intimo della persona umana? Modificare il cervello equivale a un "assassinio dell'anima"?); sociale (la psicochirurgia è inevitabilmente usata come sistema di controllo sociale, per modificare il comportamento di chi esercita un'aggressione contro altri; i medici in questo caso vengono a svolgere un ruolo di agenti controllori della società, che etichetta come patologico il comportamento non gradito, piuttosto che di terapeuti alleati del paziente); etico, infine. Ci si domanda, da quest'ultima prospettiva, se la pratica di questi interventi possa essere filtrata in modo da prevenire abusi e da permettere solo quelli che abbiano un'esplicita finalità terapeutica.
Realisticamente bisogna riconoscere che il giudizio terapeutico è spesso inquinato da altri elementi. Nella diagnosi, infatti, interferiscono i disturbi sociali. I candidati alla psicochirurgia sono in primo luogo persone che si comportano in modo offensivo verso la società e i propri familiari. La finalità terapeutica e quella punitiva sono così imbricate, che risulta difficile districarle. Anche quando si riesca a mantenersi nell'ambito della terapia, la concezione dell'uomo interferisce nella valutazione del rapporto costi-benefici. La promessa di togliere una grande sofferenza psichica deve essere confrontata col rischio di spegnere la personalità, di danneggiare la memoria, di diminuire la creatività. In una visione spirituale dell'uomo questi elementi sono così importanti che l'intervento psicochirurgico va considerato solo un'extrema ratio, non un procedimento di routine.
225
USO E ABUSO DI FARMACI E DROGHE
Un fenomeno maggiore dello scenario psichiatrico contemporaneo è la diffusione crescente dell'uso di farmaci per combattere gli stati di malessere globalmente designati come ansia, depressione, tensione ecc. Sta avvenendo una medicalizzazione generalizzata del male di vivere. Le tristezze, i lutti, le difficoltà e le fatiche della vita quotidiana sono etichettati come "depressione"; ogni dolore e inquietudine connessi con l’esistenza stessa ricevono una risposta medica sotto forma di farmaco.
Probabilmente l'inflazione di psichiatri non è irrilevante nella psichiatrizzazione dei mali esistenziali. Si realizza in pratica una collusione tra la mancanza di tolleranza del dolore psichico e morale ― che ha prodotto nell'uomo contemporaneo un "diritto" a essere immuni da sintomi quali tristezza depressiva, senso di colpa, insonnia ― e la tendenza degli psichiatri a prescrivere pillole per risolvere i problemi personali. L'abitante tipico delle metropoli post-industriali riesce a far fronte alla vita quotidiana solo grazie a un cocktail di farmaci, quali antidepressivi, ansiolitici, sonniferi (e stimolanti ― anfetaminici ― per controbilanciare l'effetto dei primi).
Il fenomeno a cui assistiamo equivale a un vero e proprio camuffamento chimico del dolore, del lutto, dell'inquietudine. Sembra quasi realizzata la visione anticipatrice di A. Huxley, il quale nel romanzo Splendido mondo nuovo (1932) aveva descritto l'uso di una droga, il "soma", una specie di pillola della felicità che permetteva di attraversare la vita, dalla nascita alla morte, senza conoscere le tensioni e i dispiaceri dell'esistenza. Sorge a questo proposito una domanda di natura antropologica: la cognizione del dolore è una condizione necessaria per accedere a una superiore qualità umana, che comprenda lo sviluppo di virtù personali, empatia, saggezza, conoscenza dei limiti, senso di responsabilità? Oppure è un'inutile zavorra, da cui conviene liberarsi nel modo più radicale?
Una risposta a tale questione antropologica precede il giudizio morale da portare sull'uso generalizzato dei farmaci per eliminare i malesseri psichici ed emotivi. Chi ritiene che il pathos sia una dimensione essenziale della vita umana, non può che considerare con preoccupazione il diffondersi dell'uso di ingerire pillole per liberarsi di pensieri ed emozioni sgradevoli. Il modello ha necessariamente un'azione demoralizzante sui bambini, ai quali viene proposto un comportamento da cui è escluso il ricorso alle capacità spirituali per resistere alla sofferenza, interrogarla e trasformarla. Questa appare la migliore premessa per la cultura della droga, di cui con voce unanime si lamentano i danni tra i giovani.
A ben vedere il linguaggio della droga, quale via d'uscita per eludere i problemi personali, pervade già il mondo dei mass media, quando reclamizzano prodotti per alleviare sintomi minori legati allo stress emotivo. L'etica della gratificazione "qui e ora" fa corpo con l'uso ricreativo ed edonistico delle droghe. Ogni repressione dello smercio e del consumo si rivela clamorosamente inutile, se viene lasciato inalterato il modello antropologico ed etico di fondo.
BIOETICA E PARADIGMI DELLA MALATTIA MENTALE
Un ulteriore contributo della bioetica alla riflessione sulla malattia mentale e sul sistema di cure appropriate consiste nel far emergere gli assunti impliciti delle diverse discipline e pratiche professionali che si occupano della salute mentale. I sintomi della sofferenza psichica, infatti, assumono un diverso significato a seconda del contesto professionale in cui sono inseriti. Ogni professione si appoggia a un corpo dottrinale teorico (che mostra la tendenza a irrigidirsi in una "ortodossia") e si esprime in una pratica condivisa (rafforzata spesso da una specifica codificazione deontologica). Le diverse professioni costituiscono sovente dei mondi autonomi, senza comunicazione, senza accessi reciproci.
226
Una situazione di questo genere si verifica anche nei confronti della sofferenza mentale o psichica. Si possono distinguere tre profili professionali che rispondono all'interpellazione del disturbo psichico: la psichiatria, la psicoanalisi/psicoterapia e la pastorale religiosa. Ogni professione lavora con un paradigma interpretativo, più o meno esplicito ed elaborato, della malattia mentale; ognuna accentua una dimensione dell'essere umano o attribuisce il primato a un diverso elemento. Mentre la psichiatria sottolinea il primato della dimensione somatica ― neurologica o biochimica del cervello ― la psicoterapia accentua il primato della persona e la prospettiva religiosa si orienta verso la dimensione transpersonale. Quando i referenti dottrinali si irrigidiscono in dogmatismo, tendono a negare il valore di altri sistemi e di altri approcci pratici.
I tre profili professionali si modificano con il tempo. Il paradigma psichiatrico-sintomatico è stato profondamente scosso dalla svolta avvenuta in medicina con la recente scoperta di farmaci efficaci. Nella medicina dell'inizio del nostro secolo (e in buona parte anche dopo) la diagnostica procedeva più celermente della terapeutica. I migliori medici sapevano diagnosticare egregiamente l'ubicazione e la modalità delle malattie; ma, quanto al trattamento, erano in grado tutt'al più di palliare i mali, non di curare le cause. La rivoluzione farmacologica ― con l'uso di antibiotici a largo spettro, corticosteroidi, psicofarmaci ecc. ― ha permesso di bloccare le manifestazioni morbose, anche senza conoscere le loro vere cause. L'introduzione degli psicofarmaci ha sconvolto il nichilismo terapeutico della psichiatria tradizionale, che per questo era costretta a ricorrere ai sistemi di contenzione in uso negli ospedali psichiatrici. La possibilità di eliminare i sintomi non ha condotto a rimettere in discussione il paradigma psichiatrico-sintomatico; anzi non pochi psichiatri hanno ripiegato su un organicismo sempre più radicale.
La pratica psicoterapica ― di cui la psicanalisi costituisce il caso eccellente ma non esclusivo ― ha in abominio il procedimento esclusivamente sintomatico. Nel suo paradigma il sintomo è piuttosto un messaggio da interpretare; costituisce una crisi in un'autobiografia o in un sistema relazionale, che equivale a un appello e a uno stimolo al cambiamento. La terapia consiste essenzialmente nel far parlare ciò che è stato "scomunicato" (nel senso letterale della parola, ossia sottratto alla comunicazione).
Questo paradigma si può anche trovare, senza alcuna forzatura, nella medicina tradizionale, che sapeva ancora leggere il sintomo come segno. Con gli sviluppi dell'arte medica più recenti, l'interpretazione dei sintomi, finalizzata alla svolta e al cambiamento, è diventata estranea alla pratica medica, per essere riservata all'esercizio della psicoterapia. Questa divisione di compiti e funzioni è stata profondamente interiorizzata dal paziente dei nostri giorni: dal medico (psichiatra) ci si aspetta che tolga il sintomo, senza lavoro interpretativo o di scavo; chi vuole altro, va dallo psicoterapeuta. Il medico curante si trova così costretto a colludere col desiderio del paziente, teso a coprire con il farmaco più efficace il male più profondo che si manifesta nei sintomi (ansia, insonnia, depressione, disturbi neurovegetativi...). I pazienti stessi non accetterebbero un procedimento diverso.
Un terzo scenario è costituito dal paradigma religioso. Anche qui bisogna riconoscere una rilevante trasformazione storica, che ha portato la religione istituzionalizzata a lasciare progressivamente il campo dei fenomeni psichici, compresi quelli a contenuto religioso, a discipline specialistiche. L'ambito spirituale si è psichiatrizzato. Oggi non si rischia più di finire sul rogo se si pretende di aver avuto "commercio con il diavolo"; ma neppure si ha l'opportunità di avere l'onore degli altari per visioni e rivelazioni... (semmai, se qualcuno confessa al padre spirituale di sentire delle voci, ha un'alta probabilità di ricevere, di rimando, l'indirizzo di uno psichiatra di fiducia!).
È piuttosto al di fuori delle istituzioni religiose che più di recente si è appuntata l’attenzione verso espressioni psichiche, abitualmente interpretate in senso psichiatrico, ma che potrebbero essere invece il segno di un'"emergenza spirituale" (Stanislav Grof, uno psichiatra che si è dedicato
227
all’esplorazione delle possibilità della coscienza umana, parla di "emergenza spirituale" a proposito di stati di coscienza che esprimono la possibilità di accedere a una consapevolezza più alta, che è insieme trasformazione interiore delle persone e condizione terapeutica: Grof, 1988). Il movimento transpersonale afferma con forza una concezione antropologica che vede nell'uomo anche una potenzialità spirituale, che tende a stati di coscienza unitiva con il Tutto, meglio descritti con il linguaggio dei mistici che degli psichiatri. Esso sta educando la comunità scientifica, che non scelga di chiudersi pregiudizialmente a tale ipotesi, a nutrire quanto meno il sospetto che ci possa essere una dimensione di crescita che punta in questa direzione. Il sospetto appare più saggio della sufficienza scientista.
Nel paradigma transpersonale i sintomi psichiatrici non sono più solo interpretabili come segno di una stasi nella crescita personale, ma come il richiamo di una dimensione che trascende la persona. I sintomi possono essere il linguaggio di uno stato di coscienza superiore (anche se lo Champollion che possa interpretare questi geroglifici non sembra ancora nato...!). Noi ci aspettiamo che la bioetica sappia tenere aperto un orizzonte in cui tutt'e tre i paradigmi professionali menzionati abbiano una loro giustificazione e possano trovare una proficua complementarietà. Il discorso relativo all'utilità degli psicofarmaci e alle relative indicazioni, a seconda delle diverse situazioni, è demandato a una medicina clinica, che non dimentichi la complessità del fenomeno umano.
228
229
capitolo
19
LA TERAPIA DEL DOLORE
Un caso clinico
Il signor Nedo P. viene ricoverato in Ospedale di Comunità, trasferito dalla U.O. di medicina generale con la diagnosi di tromboflebite arto inferiore sinistro da metastasi diffuse per carcinoma polmonare. Per Ospedale di Comunità si intende una struttura sanitaria territoriale che prevede ricoveri a ciclo di 24 ore (per periodi non superiori a 120 giorni) e ricoveri a ciclo di 12 ore. Non è, quindi, né una struttura per lungodegenza, né un albergo sanitario. Prevede diversi momenti assistenziali, garantiti sia dai servizi territoriali che da quelli ospedalieri. Questo tipo di istituzione è particolarmente indicato per la fase post-acuta di pazienti anziani a rischio di non autosufficienza e in vista della stabilizzazione di patologie croniche.
L'obiettivo del ricovero in Ospedale di Comunità è quello di stabilizzare la sintomatologia tromboflebitica e di impostare una terapia antalgica per un'eventuale ritorno a casa seguito dal servizio dell'A.D.I. (assistenza domiciliare integrata). Circa due anni fa al signor Nedo, dopo alcuni episodi di difficoltà respiratoria, è stato consigliato dal medico curante un rx torace, che ha evidenziato una massa polmonare. Ulteriori accertamenti hanno confermato una diagnosi di carcinoma polmonare. Non essendo possibile un intervento chirurgico demolitore, viene consigliata una radio e chemioterapia. Nedo e i familiari sono a conoscenza dell'importanza e della gravità della malattia e affrontano il delicato periodo con costanza e apparente serenità.
La radio e chemioterapia dopo circa due anni sono risultate inefficaci. La malattia si è ulteriormente aggravata, producendo metastasi. Vista la loro diffusione, il prosieguo della terapia è stato ritenuto inutile. Con il sopraggiungere di una tromboflebite e di dolori diffusi il paziente viene ricoverato in medicina, per la durata di circa un mese.
Durante il periodo di degenza in medicina e in Ospedale di Comunità il signor Nedo è lucido e cosciente sullo stato di avanzamento della malattia; per questo prega i familiari di stargli vicino 24 ore su 24. Nedo ha una grande paura di morire e chiede costantemente al curante che gli venga somministrata una terapia antalgica efficace, non solo per togliere o attenuare il dolore fisico, ma ― come riferisce lui ― "una terapia che nei momenti più brutti o nel momento finale mi renda incosciente... perché non voglio vedere la morte in faccia". Il desiderio di Nedo, purtroppo, non è stato realizzato. Il periodo di degenza, fino alla morte di Nedo, è stato di dieci giorni; in questo lasso di tempo è stata somministrata una terapia del dolore non adeguata. Fin dal suo arrivo in Ospedale di Comunità a Nedo viene somministrata una fiala di FANS (Voltaren) al dì. Al medico di famiglia viene chiesto dal paziente, dai familiari e dagli infermieri una terapia antidolorifica più forte e specifica. Il medico si dimostra molto "parsimonioso" nell'aumentare o cambiare terapia, perché secondo lui una terapia con oppiacei o similari è troppo "forte". Nedo è rimasto cosciente fino alla morte. Quando è morto la sua terapia consisteva soltanto nella somministrazione di 2 fiale di lixidol al dì più una fiala al bisogno.
230
UNO SCANDALOSO RITARDO ITALIANO
Tra quanto è possibile e giusto fare per eliminare e controllare il dolore fisico e quanto in pratica viene fatto riscontriamo una vistosa differenza. Oggi abbiamo conoscenze precise relative alla fisiologia del dolore. E soprattutto disponiamo di un arsenale vastissimo di metodologie di intervento ― non invasive e invasive, neurochirurgiche e psicologiche, oltre a tutta la gamma di terapie farmacologiche ― che permettono di combattere il dolore nella quasi totalità dei casi.
A questa capacità viene attribuito dalla nostra cultura un valore altamente positivo. Non è soltanto l'etica che nasce da una visione secolare che enfatizza i comportamenti volti a combattere il dolore. Anche le morali di matrice religiosa concordano sostanzialmente su questo punto. Questo richiamo vale in particolare per il cristianesimo, al quale è stata talvolta indebitamente attribuita una coltivazione malsana del dolore. Il "dolorismo" può essersi appoggiato al cristianesimo, ma non ne è un figlio legittimo. La posizione dottrinale cristiana si iscrive in un equilibrio tra il feticismo del dolore di coloro che lo considerano come valore supremo, e la fobia del dolore, che induce a vedere in esso il non-valore assoluto. La teologia cristiana valorizza il dolore ― soprattutto quello connesso con la fase finale della vita e il distacco dal corpo ― attribuendogli un denso significato antropologico e salvifico; senza tuttavia fame un idolo, perché non è il dolore in sé che purifica e salva, ma solo la grazia che produce l'amore.
La morale cattolica ufficiale si ispira ai principi formulati in un celebre discorso di Pio XII al congresso della Società italiana di anestesiologia (24 febbraio 1957). In modo realistico, il pontefice ha riconosciuto che "a lungo andare, il dolore impedisce il raggiungimento di beni e di interessi superiori. Può accadere che esso sia preferibile per una determinata persona e in una determinata situazione concreta; ma, in generale, i danni che provoca costringono gli uomini a difendersi da esso. Indubbiamente non si riuscirà mai a farlo scomparire completamente dall'umanità, ma si possono contenere in più stretti limiti i suoi effetti nocivi". Di conseguenza, secondo la dottrina morale cattolica "il paziente desideroso di evitare o di calmare il dolore può, senza inquietudini di coscienza, avvalersi dei mezzi trovati dalla scienza". È accettato come lecito il ricorso ad analgesici che portano anche alla perdita della coscienza, purché questo mezzo sia giustificato da un intento terapeutico, e l'accettazione di trattamenti antalgici che hanno come effetto secondario quello di abbreviare la vita, purché motivi veramente validi li giustifichino.
Con il tempo l'orientamento dottrinale non è cambiato, se il Catechismo delia Chiesa cattolica, del 1992, a proposito del dolore e del suo contenimento nella fine della vita afferma: "L'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischiò di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate".
Né diversamente suonano le formulazioni morali di altre tradizioni religiose. Riportiamo, a titolo esemplificativo, le conclusioni cui giunge Amos Luzzatto dopo un'analisi accurata dell'atteggiamento ebraico:
La tradizione ebraica, nella sua parte maggiore, non ha fatto propria una specie di vocazione alla sofferenza e al dolore, anche se le circostanze storiche l'hanno spesso costretta a sopportare l'una e l'altro [...]. Il dolore cessa di rappresentare un ideale simile all'ascesi o un aspetto fondamentale del rapporto dell'uomo con Dio, che si sposta a un altro e più elevato livello; e ritorna a essere una sgradevole ma non evitabile esperienza di vita che, certo con l'aiuto di Dio, ma soprattutto con il permesso e con la compiacenza di Dio, l'uomo ha il diritto di contrastare con i suoi mezzi.
Luzzatto, 2000.
Alla legittimità culturale ed etica riconosciuta alla lotta contro il dolore si accompagna l'iscrizione delle azioni rivolte a tale fine tra le priorità del servizio sanitario pubblico. Il "Piano sanitario
231
nazionale per il triennio 1998-2000", che si propone come un "patto di solidarietà per la salute", individua l'assistenza alle persone nella fase terminale della vita tra gli obiettivi da privilegiare. Nell'ambito del quarto obiettivo ― "Rafforzare la tutela dei soggetti deboli" ― il Piano indica l'assistenza alle persone affette da patologie evolutive irreversibili, per le quali non esistono trattamenti risolutivi. Nell'ambito del patto di solidarietà, la sanità pubblica si impegna a fornire a queste persone "un'assistenza finalizzata al controllo del dolore, alla prevenzione e cura delle infezioni, al trattamento fisioterapico e al supporto psicosociale". Tra le azioni da privilegiare il Piano individua l'erogazione di assistenza farmaceutica a domicilio tramite le farmacie ospedaliere e il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e antalgica.
Se la capacità clinica di controllare il dolore, fortemente legittimata dal punto di vista sia etico che sociale, fosse tradotta in atto, non si vedrebbe la necessità di lanciare un progetto internazionale sotto lo slogan programmatico "Verso un ospedale senza dolore". Il progetto è stato originariamente varato dall'ospedale St. Lue di Montreal con l'intento di modificare gli atteggiamenti verso il dolore e il comportamento sia dei professionisti sanitari che della popolazione, in particolare dei malati ricoverati. Dal Canada il progetto è poi passato ad altri Paesi: la Francia ― dove il ministro della Sanità ha avviato un progetto triennale per diffondere la pratica delle cure palliative e mobilitare gli operatori sanitari a utilizzare tutti i mezzi necessari per il controllo del dolore ― la Svizzera, il Belgio, la Spagna, gli Stati Uniti. Anche in Italia si è annunciata un'attenzione al progetto, anche se relativamente isolata (cfr. Visentin, 2000).
Proprio in Italia, invece, la sensibilizzazione alla terapia del dolore dovrebbe aver luogo con carattere di urgenza. La situazione italiana è descritta, con tono di denuncia, da una lettera aperta inviata al ministro della Sanità e sottoscritta da diverse associazioni e società scientifiche (la lettera è stata pubblicata dalla rivista Tempo Medico del 25 febbraio 1998). Il primo firmatario è l'Associazione europea per le cure palliative. Quindi è chiaro: la richiesta parte da chi si occupa di malati per i quali la medicina non ha più risposte curative. Ciò non vuol dire che l'arte medica non abbia più niente da fare. In particolare può fare ciò che le concezioni mediche dell'antichità consideravano come l'opera "divina" per eccellenza: togliere il dolore. Questo è appunto uno degli obiettivi principali delle cure palliative.
Per controllare il dolore sono necessari farmaci oppiacei, soprattutto la morfina. Da quasi un ventennio ^Organizzazione mondiale della sanità ha elaborato delle linee-guida per il trattamento efficace del dolore (scala analgesica OMS). Sono tre i gradini da percorrere, a seconda dell'intensità del dolore. Farmaci antinfiammatori non steroidei per il dolore lieve, oppioidi deboli per quello moderato e oppioidi forti per quello severo. Soprattutto per il dolore da cancro, la morfina e altri analgesici oppioidi sono considerati essenziali, tanto che il loro consumo annuale viene assunto come un indicatore sensibile per valutare l'efficacia dei programmi di controllo del dolore da cancro. Da quando l'OMS si è impegnata in questa campagna umanitaria tra tutte ― la lotta al dolore evitabile ― si è registrato un progressivo aumento della morfina nei Paesi che già avevano un alto livello di utilizzo. Fino al 1984 il consumo di morfina è stato stazionario, mentre negli anni successivi è progressivamente aumentato, fino a quadruplicare nel 1993.
Questa tendenza si è registrata solo nei dieci Paesi che già avevano un livello alto di utilizzo di morfina. Quelli che ne facevano un basso uso, invece, hanno ulteriormente diminuito l'uso di farmaci antalgici efficaci. L'Italia è tra questi. Anzi, a nostra vergogna dobbiamo riconoscere che l'Italia occupa uno degli ultimi posti nel consumo terapeutico di oppioidi. Ciò vuol dire che migliaia di persone finiscono la vita con dolori gratuiti, che la medicina sarebbe in grado di evitare. La lettera indirizzata al ministro della Sanità intendeva portare al centro dell'attenzione un problema reale di "malasanità", molto più grave di quelli sui quali è solita scandalizzarsi la stampa.
La denuncia contenuta nella lettera non è completa: manca la dimensione sociale dello
232
scandalo costituito dal dolore non necessario. Questa emerge da un'altra considerazione: i pochi centri di terapia del dolore che esistono in Italia non sono distribuiti in modo uniforme. Si registra una grande rarefazione di risposte istituzionali al problema del dolore nell'Italia centrale, e praticamente il vuoto in quella meridionale. Se possiamo ipotizzare che la malattia cada sulle persone alla cieca, facendo torto a chi colpisce ma senza ingiustizie, dobbiamo invece riconoscere che il dolore è molto selettivo: predilige coloro che abitano al centro-sud del Paese, e tra questi i poveri, che non possono far ricorso ai servizi offerti ― a pagamento ― dalla sanità privata.
Perché la lotta al dolore è gravata da tante scandalose omissioni? Abbiamo la sensazione che qualcosa non sia andata per il verso giusto nell'evoluzione della medicina, se oggi alla capacità tecnica di tenere sotto controllo il dolore non corrisponde un impegno fattivo e una realtà rilevante di persone liberate dal dolore non necessario. Alcune risposte all'interrogativo non dobbiamo andare a cercarle molto lontano. Basti pensare quanto pesano sui comportamenti prescrittivi l'inerzia burocratica e la miopia amministrativa.
Al fine di evitare abusi, le normative italiane hanno costruito intorno alla prescrizione di farmaci oppioidi un percorso a ostacoli tra i più complessi. La legge 685 del 1975 e il Dpr 309 del 1990 ― nel quale vengono accumunate le norme per l'impiego dei farmaci antalgici e l'azione repressiva nei confronti del mercato illegale delle sostanze d'abuso! ― prevedevano che per prescrivere tali farmaci i medici dovessero possedere un ricettario ministeriale, da ritirare e controfirmare presso le sedi degli Ordini dei medici; la prescrizione doveva essere in triplice copia (ognuna delle quali scritta a mano!); le ricette dovevano essere conservate per almeno due anni; la prescrizione doveva essere limitata al fabbisogno di otto giorni (una norma che ha creato la perla di stupidità burocratica di medici e farmacisti che sono stati multati perché hanno rispettivamente prescritto e venduto una confezione di tre cerotti antalgici a lento rilascio, ognuno con azione prevista per tre giorni, quindi uno in più di quanto prescritto dalla legge!); la prescrizione doveva essere redatta a tutte lettere con estesa indicazione delle dosi e della via di somministrazione, la dichiarazione di responsabilità in caso di dosaggio giornaliero superiore alla quantità prevista dalla farmacopea; sanzioni rilevanti erano previste per i professionisti, medici e farmacisti, in caso di errori, anche meramente formali, nella prescrizione, registrazione, dispensazione, conservazione e smaltimento del farmaco.
A fronte di questa selva di norme, che implicitamente inducono a considerare la prescrizione di un farmaco antalgico analoga all'erogazione del metadone per i tossicodipendenti, si aprivano vie di fuga facilmente percorribili. Se il medico non dispone del ricettario, si può ritenere dispensato dal prescrivere questi farmaci. E dal momento che molti medici sono restii a farvi ricorso ― in parte per le complicazioni burocratiche, in parte perché non hanno ricevuto la formazione necessaria in ambito di cure antalgiche ― questa diventa per molti malati la barriera principale che impedisce loro l'accesso alla morfina e altri farmaci oppiacei. Tra le richieste concrete contenute nella lettera al ministro della Sanità ― già fin dal 1998! ― c'è quella che riguarda il possesso del ricettario ministeriale reso obbligatorio per tutti i medici di medicina generale convenzionati.
In parte le norme limitative per la prescrizione dei farmaci antalgici sono state superate dalle disposizioni contenute nella recente legge che regola l'utilizzazione dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore (la legge è stata approvata nel gennaio 2001 ed è entrata in vigore il 6 marzo 2001). La nuova legge mira a semplificare i procedimenti che riguardano la consegna, il trasporto e la prescrizione dei trattamenti terapeutici finalizzati al controllo del dolore. Alcune modifiche dei comportamenti sanitari sono vistose: mentre prima le prescrizioni dei farmaci non potevano superare gli otto giorni, ora possono superare i trenta; i medici non potevano approvvigionarsi di stupefacenti attraverso l'autoricettazione, mentre con la nuova legge
233
possono farlo e detenere le quantità necessarie; gli infermieri non potevano trasportare i farmaci oppiacei al domicilio dei pazienti, oggi invece gli infermieri impegnati nei servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a farlo. Per quanti siano i meriti delle nuove disposizioni, la legge ha tuttavia solo uno stretto carattere di regolamentazione, a deroga della normativa precedente (cfr. Benci, 2001). Per modificare i comportamenti sarà necessario un intervento più in profondità, sulla cultura sottostante e sulla stessa etica medica.
LE RAGIONI CULTURALI
Oltre alle carenze di tipo organizzativo, che ci possono spiegare perché il trattamento del dolore viene trascurato, altre indicazioni possono essere rintracciate nell'ambito della cultura, là dove i nudi fatti sono connotati come valori e si elaborano i comportamenti. Ebbene, la cultura è capace di dare maggiore o minore rilievo al dolore, talvolta di renderlo addirittura invisibile. E se il dolore sfugge al nostro sguardo, si sottrarrà anche a ogni tentativo di combatterlo.
L'aspetto più paradossale è che il dolore, di per sé, tende a farsi vedere e a farsi sentire: chi ha dolore urla, in modo vistoso dichiara la sua presenza di essere sofferente e attira l'attenzione su di sé e sul proprio dolore. Eppure noi abbiamo l'incredibile capacità di riuscire a non vedere anche la realtà più evidente. In altre parole, noi vediamo solo la realtà che siamo disposti a vedere, mentre anche ciò che è visibile e palese, non lo vediamo semplicemente perché non lo vogliamo vedere. Non ci mancano esempi storici che documentano la singolare selettività delle nostre capacità percettive. Per secoli la sofferenza, la degradazione, il dolore fisico degli schiavi negri era sotto gli occhi degli schiavisti, eppure essi non lo vedevano. Nel secolo scorso, all'epoca dell'espansione industriale, la condizione miserabile dei bambini che lavoravano nelle fabbriche era sotto gli occhi di tutti, ma solo gli occhi di qualche artista, come Dickens, di qualche filantropo, o di qualche teorico della rivoluzione sociale hanno saputo vederla.
Per rimanere nell'ambito ristretto del dolore fisico, non può non impressionarci la testimonianza di un neonatologo circa la persistente cecità al dolore dei neonati e dei bambini più piccoli da parte dei medici stessi: "Si è negato a lungo ― con tutta una serie di dimostrazioni di tipo scientifico e di sperimentazioni di vario genere ― che il neonato potesse sentire dolore. Fino a venti anni fa si decideva che si trattava di dolore sottocorticale, che la coscienza del dolore non c'era, che i neonati non se lo ricordavano, che veniva percepito ma non localizzato, non elaborato, che vi erano in circolo le endorfine che impedivano di sentire il dolore; insomma, la pratica era che gli interventi chirurgici sul neonato, in particolare sul neonato prematuro, venivano fatti senza anestesia. Nei centri più avanzati gli si dava un bicchierino di cognac, come nel caso della chiusura chirurgica del dotto arterioso di Botallo, che richiede un intervento sul torace e quindi su una zona molto sensibile" (Orzatesi, De Caro, 1998).
L'interesse a promuovere sempre migliori interventi terapeutici non è andato di pari passo in medicina con un uguale impegno a controllare il dolore. Non da oggi. Un'osservazione pungente di Michael Crichton relativa al ritardo con cui i prodotti anestetizzanti sono stati introdotti in chirurgia può essere estesa ad altre stagioni della medicina. Dopo aver descritto quanto fossero cruenti e dolorosi gli interventi chirurgici prima che, verso la metà del XIX secolo, si facesse ricorso all'anestesia, Crichton annota: "Sarebbe ragionevole aspettarsi che questo deplorevole stato di cose spingesse i chirurghi a cercare modi per alleviare il dolore e a prendere in considerazione qualsiasi nuovo farmaco in grado di dare questo risultato. Ma di fatto questo non avvenne: gli analgesici erano noti già da quarant'anni prima che si pensasse di usarli nella chirurgia. Se, come sostiene Poincaré, la scoperta predilige le menti preparate, i medici devono essere considerati stranamente impreparati" (Crichton, 1995).
234
Le sofferenze ― sia fisiche che morali ― degli altri rischiano di sottrarsi alla nostra attenzione benché siano così macroscopiche, apertamente sotto gli occhi di tutti. In casi simili, la disattenzione fisica è del tutto simile alla disattenzione morale, per colpa della quale l'intelletto non si accorge di quelle considerazioni che sono troppo insistenti e tangibilmente chiare (la scelta morale è una questione di "visione", prima e più ancora di decisione; l'attenzione è perciò fondamentale).
Nell'insieme la civiltà di cui siamo figli, pur promuovendo la lotta al dolore, ci ha reso meno capaci di far fronte alla sofferenza: è l'accusa contenuta nel celebre saggio Nemesi medica di Ivan Illich (Illich, 1976 e 1991). La tesi di fondo è che la medicina moderna, con la medicalizzazione delle cure, si risolve in una espropriazione della salute. Illich ha chiamato "iatrogenesi culturale" l'aspetto più insidioso del fenomeno, che ha origine quando l'impresa medica distrugge nella gente la volontà di soffrire la propria condizione reale. "La medicina organizzata professionalmente ― affermava Illich in quel pamphlet che non ha perduto la sua attualità ― è venuta assumendo la funzione di un'impresa morale dispotica tutta tesa a propagandare l'espansione industriale come una guerra contro ogni sofferenza. Ha così minato la capacità degli individui di far fronte alla propria realtà, di esprimere propri valori e di accettare il dolore e la menomazione inevitabili e spesso irrimediabili, la decadenza e la morte". Il culmine di questa impresa è individuato nella "soppressione del dolore". Ciò ha portato a una società anestetizzata.
Con questa espressione non si intende mettere sotto accusa quanto la medesima è in grado di fare per impedire di sentire sulla propria pelle la sferza del dolore, ma ciò che viene messo in atto per impedire che il dolore si trasformi in una esperienza personale. Ogni cultura dispone di quattro fondamentali risorse per trasformare il dolore: parole, miti (spiegazioni religiose e mitiche del senso e della funzione del dolore), modelli morali ("arte di soffrire bene") e farmaci. Con la medicalizzazione del dolore assistiamo alla crescita elefantiaca di quest'ultima risorsa e alla decadenza di tutte le altre. Quando poi ― come abbiamo visto nel caso dell'Italia ― anche la risposta farmacologica è carente, ci troviamo meno equipaggiati delle società che ci hanno preceduto nella gestione del dolore che accompagna le vicende morbose del corpo.
Una medicina veramente umana si costruisce solo sull'assunto-base opposto a quello corrente, il quale implicitamente presume che la malattia abbia un carattere di "in-sensatezza". La prassi corrente sottolinea la richiesta fatta al malato di affidarsi a chi è deputato alla cura del suo male. Le aspettative istituzionalizzate ― vale a dire, ciò che la società abitualmente si aspetta dal malato, e a cui questo deve informarsi se non vuole che il suo comportamento sia considerato come anomalo ― mirano esclusivamente all'abolizione del sintomo, non all'interrogazione appassionata di esso, affinché lasci nelle mani del malato qualche traccia del messaggio esistenziale che ha per lui. L'uomo malato viene così apparentemente decolpevolizzato nei confronti dei mali che l'affliggono, mentre in realtà è deresponsabilizzato.
La conquista del senso nascosto nel pathos partecipa del carattere notturno e misterioso della lotta di Giacobbe con l'angelo (cfr. Gen. 33,23-33). La benedizione che rimane nelle mani del lottatore può avere un carattere doloroso, che lo costringerà a zoppicare per tutta la vita. Nel quadro dell'antropologia teologico-biblica, là dove la guarigione è iscritta dentro l'opera della salvezza, l'emergere del senso della sofferenza ci appare come un momento costitutivo del processo della "soteria" (una realtà più vasta della guarigione in senso clinico, in quanto partecipa del carattere trascendente della salvezza). L’acquisizione di senso ottiene che dalla passività distruttiva di ciò che l'uomo subisce nel corpo scaturisca una possibilità di crescita.
Il senso non può essere donato a nessuno: va trovato all'interno dell'esperienza, grazie a un vero e proprio "lavoro semantico". La creazione del senso della propria patologia è come una porta che si apre solo dal di dentro: nulla si ottiene forzandola dall'esterno. Ma la ricerca può essere facilitata o impedita. Chi si vuol porre in relazione d'aiuto ― come professionista sanitario o
235
come essere umano solidale _ ha bisogno più di "esprit de finesse" che di "esprit de géométrie". Dovrà ricorrere ― in un dosaggio ogni volta da inventare ― all'azione e all'omissione (nel senso di rinuncia a operare con ostinazione), alla parola e al silenzio, alla presenza e alla distanza.
LE RESPONSABILITÀ DELL'ETICA MEDICA
Quando diciamo che il dolore, per quanto manifesto, viene reso invisibile dall'insensibilità morale non intendiamo solo il grossolano atteggiamento degli schiavisti 0 dei capitalisti proprietari delle fabbriche del XIX secolo nei c0nfonti della sofferenza che li circondava; e neppure la tranquilla disinvoltura con cui i chirurghi procedevano a operazioni sui neonati senza anestesia. Anche delle concezioni morali di alto profilo possono costituire un filtro che impedisce di vedere il dolore. Dobbiamo riconoscere che esiste anche un'etica medica che non aiuta a vedere il dolore, anzi nasconde il dolore che abbiamo sotto gli occhi.
C'è una pagina letteraria famosa, tratta dal romanzo I Buddenbrook di Thomas Mann, che ci permette di dare concretezza all'affermazione che anche l'etica può contribuire a mascherare il dolore. In una scena culminante l'anziana madre del console Thomas Buddenbrook giace sul letto di morte. L'agonia si protrae dolorosamente. La morente, in grandi difficoltà respiratorie, chiede ai due medici che l'assistono un calmante per dormire. Supplica: "... Qualcosa per dormire... Dottori per pietà! Qualcosa per dormire!". Ma i medici sanno che l'azione di un sedativo abbrevierebbe la vita; per cui respingono la richiesta, rifacendosi a dei vaghi motivi etici che non sanno articolare, ma che nondimeno sentono come vincolanti. Annota Thomas Mann:
Ma i medici conoscevano il loro dovere. Bisognava in ogni caso conservare ai parenti il più a lungo possibile quella vita, mentre un calmante avrebbe subito provocato la resa dello spirito senza più opposizione. I medici non sono al mondo per facilitare la morte, ma per conservare la vita a qualunque prezzo.
In favore di ciò spingono anche certi principi religiosi e morali, dei quali avevano sentito parlare all'università, anche se in quel momento non se li ricordavano bene
Mann, 1992, ed. orig. 1901.
Questo tipo di sensibilità morale fa sì che la madre del console Buddenbrook muoia al termine di un'agonia terribile, per la quale i medici hanno ritenuto loro dovere non fare niente, per quanto la morente abbia cercato di indurli a lenire il dolore appellandosi alla loro compassione ("Per pietà"!). Consideravano infatti il dolore della morente come un dolore necessario. La nostra sensibilità morale si ribella. Eppure dobbiamo riconoscere che la tendenza che Thomas Mann rileva nella medicina del secolo scorso (ispirata a un'etica che imponeva al medico l'obbligo di far vivere l'ammalato il più a lungo possibile, senza individuare anche nel lenimento del dolore un obbligo etico prioritario) non è estranea alla medicina del nostro tempo. Anzi, ai nostri giorni tende a diventare estrema.
L'interrogativo etico (quale il dovere del medico di fronte a un malato che gli chiede un calmante che può abbreviargli la vita?) poggia su una questione culturale e antropologica relativa ai fini della medicina. Se identifichiamo come obiettivo della medicina esclusivamente la guarigione, entriamo molto facilmente nel vicolo cieco che coinvolge la medicina medesima: si sente mobilitata a fare tutto il possibile per guarire, ma non fa niente ― O quanto meno non agisce con un impegno analogo ― per sedare il dolore.
Questa osservazione non deve essere interpretata come un atto di accusa contro i medici per aver deformato la concezione della medicina: mentre in passato era sufficientemente bilanciata fra il dovere di guarire e il dovere di lenire il dolore, oggi è invece tutta polarizzata sul dovere unico di guarire, di prolungare la vita, di tentare tutto il possibile per aggiungere qualche
236
giorno o qualche ora all'esistenza del morente. Questo atteggiamento dei medici è un problema culturale, in quanto sta a significare che tale offerta deriva da una specifica domanda.
La richiesta alla medicina di fare sempre di più per guarire, per prolungare la vita e, in ultima analisi, per assicurare l'immortalità, proviene dagli uomini e dalle donne del nostro tempo. Noi non accettiamo più di morire; abbiamo rimosso la cultura della morte intesa come un momento della nostra vita, caricando la medicina delle nostre attese di immortalità. Chiediamo oggi alla medicina quello che una volta si chiedeva alla religione, quasi che la medicina sia diventata la nostra "religione laica", e i medici e la scienza il sacerdozio di questa religione.
Perché dobbiamo rassegnarci alla morte, dal momento che non solo possiamo prolungare la vita, ma forse siamo in grado anche di raggiungere l'inversione del meccanismo di degrado che ci porta alla morte, e quindi possiamo diventare immortali? C'è una collusione profonda tra una medicina che si sente potente ― anzi onnipotente ― e una cultura che si sente immortale o che aspira all'immortalità. In questo incontro fatale fra una domanda e un'offerta speculari ne fa le spese soprattutto chi ha bisogno di una medicina diversa, quella che chiamiamo "palliativa". Si tratta di una medicina che non tiene conto solo delle malattie e si accorge anche delle sofferenze; che sa cambiare marcia ed è in grado di capire, a un certo punto, che la priorità non è più la lotta a oltranza alla patologia in atto, né il dare scacco alla morte, ma diventa l'accompagnare, favorendo il processo naturale della fine della vita nella maniera più indolore possibile.
IL NURSING DEL DOLORE
Grazie ai progressi della medicina, molte più persone vivono con la malattia, invece di soccombere a essa. Nella situazione di cronicità gli interventi di assistenza, di competenza infermieristica, prevalgono su quelli curativi, di competenza medica. L'alleviamento del dolore e dei sintomi è parte integrante dell'assistenza. Tanto più che l'infermiere ha una maggiore vicinanza e quotidianità di rapporto con il malato: la sua è una posizione privilegiata per rilevare il dolore e per valutare l'efficacia delle misure antalgiche intraprese. Ne consegue un particolare potere e responsabilità dell'infermiere rispetto alla terapia del dolore. In tale posizione di potere l'infermiere influenza in modo determinante il decorso della terapia antalgica se i sintomi di dolore del malato vengono rilevati, presi più o meno seriamente in considerazione e alleviati.
Il ruolo dell'infermiere nella terapia del dolore è tanto più importante in quanto nel contesto clinico l'alleviamento dei sintomi è lasciato alla sua discrezione. A differenza di quanto avviene, per esempio, per la somministrazione di un antibiotico ― la prescrizione è fatta dal medico, viene scritta in cartella e se ne fa relazione al cambio di turno ― non sono in vigore metodi sistematici che responsabilizzano l'infermiere al compito di alleviare i sintomi. Le prescrizioni scritte sono limitate per Io più agli analgesici e non sempre vengono annotati i loro effetti; raramente viene fatto un rapporto sistematico, tra un turno e l'altro, circa il controllo dei sintomi dolorosi del paziente. Dal momento che il dolore di solito non costituisce una minaccia per la vita, ha una bassa priorità nell'assistenza.
Oltre che di una vicinanza strategica al malato e al suo dolore, l'infermiere si avvantaggia di un diverso sguardo nei confronti della sofferenza. L'approccio medico è condizionato da una precomprensione fisica del dolore. Lo considera come una sensazione con un rapporto in qualche modo prevedibile con uno stimolo nocivo o con un'attività neurofisiologica anormale. Quando il medico raccoglie il lamento di una persona che ha dolore, si dispone a determinarne la causa. Così come il medico è autorizzato a stabilire se una persona è o no malata, allo stesso modo decide se debba sentire dolore, basandosi sulla sua diagnosi di tipo fisico. È importante che il medico
237
usi questo approccio; ma è una disgrazia per il malato se viene utilizzato solo questo modo di considerare il dolore.
L'infermiere non deve fare una diagnosi fisica. Il suo sguardo è libero quindi per cogliere altri aspetti del dolore, considerandolo come una sensazione che ha un determinato significato per il malato. Le caratteristiche personali ― psicologiche e sociali ― sono almeno altrettanto importanti di quelle fisiche per determinare la risposta al dolore. L'infermiere può così considerare il dolore nel contesto della persona totale, superando l'idea che ci debba essere un rapporto predicibile tra lo stimolo e la sensazione del dolore. Senza svalutare l'importanza clinica di ciò che vede e misura il medico, si può tuttavia affermare che solo attraverso l'approccio che può avere l'infermiere il dolore mostra tutto il suo spessore, in quanto dolore umano.
Il punto di vista relazionale presuppone una modifica profonda dell'atteggiamento nei confronti del paziente con dolore: il clinico non si considera legittimato a saperne di più della persona che il dolore Io sta provando (secondo lo schema riassumibile nello slogan "doctor knows best" ovvero "il dottore ne sa di più"...); al contrario, si presume che il paziente sappia circa il dolore e il suo sollievo cose che il sanitario non conosce. Forse in nessun altro ambito della relazione di cura è appropriato, come nel caso del dolore, che il rapporto con la persona assistita inizi con l'ascolto ("L'infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali": Codice di deontologia degli infermieri, 4.2).
Due elementi garantiscono l'efficacia del nursing del dolore. Anzitutto il rapporto. Non si può esagerare nel valutare l'importanza di stabilire una buona relazione, attraverso la quale trasmettere al paziente il messaggio che chi l'assiste è dalla sua parte, impegnato con lui nella lotta contro il dolore, in tutte le sue manifestazioni. L'impegno è più facile quando l'infermiere prova una simpatia genuina per il paziente. Negli altri casi, deve soccorrerlo l'etica professionale (se è vero che questa può essere colloquialmente riassunta nella disponibilità e occuparsi con la stessa intensità dei pazienti simpatici come di quelli che suscitano antipatia...).
Un buon nursing del dolore deve, in secondo luogo, adottare l'insegnamento rivolto al paziente come una strategia di controllo efficace. Se il paziente è assunto come partner, gli saranno fornite informazioni accurate circa la probabilità dell'insorgere del dolore, la sua intensità e la sua durata. La reticenza o la disonestà dell'équipe curante circa il dolore è vissuta dal malato come un tradimento. È una situazione che si verifica non infrequentemente con riguardo al dolore postoperatorio o a quello legato a procedure invasive, quando il paziente non è adeguatamente preparato mediante la spiegazione di che cosa gli viene fatto e perché. Con il paziente verrà concordato un piano di controllo del dolore e ci si atterrà alle sue decisioni. Il nursing del dolore ha bisogno non tanto di un paziente docile, quanto di una persona di cui si è provveduto a realizzare l'empowerment mediante l'informazione.
238
239
capitolo
20
LE CURE PALLIATIVE
QUANDO LA MEDICINA DI FA MATERNA
C’è voluto molto tempo. E soprattutto la sofferenza di innumerevoli persone. Sono state necessarie delle battaglie, ingiuste ed eccessive come tutte le battaglie. Ci si è scagliati contro i medici, accusandoli di indulgere all’"accanimento terapeutico", di aver perso il senso della misura e addirittura l'originaria ispirazione della loro professione. Si è dovuto passare attraverso massicce campagne di opinione, che hanno fatto sorgere organizzazioni rivolte a rivendicare all'individuo il diritto a una morte degna, sottraendosi all'arbitrio dell'apparato medico. È stato necessario che si arrivasse a proposte di una legislazione favorevole che permetta l'eutanasia, in nome di un'umanizzazione del morire. Siamo dovuti passare per queste strade ambigue e tortuose, ma alla fine qualcosa è successo.
Ci siamo accorti, finalmente, di quanto si muoia male nella nostra società. Per tanti motivi: non ultimo quello culturale, vale a dire la rimozione della morte come momento inevitabile e necessario della vicenda umana. Ma si muore male anche a causa della medicina stessa. Non per colpa delle sue insufficienze, bensì ― paradossalmente ― a causa della sua efficacia. Abbiamo oggi, nell'Occidente sviluppato e tecnologico, una medicina idealmente efficace, che riesce a procurare la guarigione in una quantità di malattie, che in passato sarebbero state fatali. Ma questa medicina non può guarire sempre: è inevitabile. Per quante volte si riesca a salvare la vita di una persona, alla fine ci sarà pur sempre un malato che non guarisce e che va verso la morte. Ora, la nostra straordinaria medicina curativa ― di cui siamo giustamente fieri, che vogliamo promuovere e potenziare ― non è adatta ad assistere il paziente che muore. Per questo oggi si muore così male. Ce ne siamo accorti e abbiamo cominciato a cambiare strada. Da questa consapevolezza sono nate le cure palliative.
Si può pensare che il termine "cure palliative" non sia felice. Il peggior nemico per le cure palliative è il loro stesso nome. È come, per una persona, farsi prendere sul serio presentandosi con un cognome ridicolo... Nel linguaggio comune quando si parla di un "palliativo" si intende "un rimedio che attenua il male senza guarirlo" (è la definizione che dà il dizionario). L'associazione mentale più frequente è quella che considera un intervento palliativo come l'opposto di una cura efficace. Come arrivare a far intendere che le cure palliative sono, invece, grande medicina? È necessario, inoltre, collocare questo tipo di attività medica rispetto al resto della medicina: è una specialità medica? Una disciplina? Oppure, addirittura, l'opposto della medicina, in quanto rinuncia a guarire? Si tratta forse di creare, sotto l'egida della medicina palliativa, un'agenzia umanitaria su cui scaricare gli insuccessi della medicina curativa? Gli interrogativi sono legittimi, le riserve giustificate.
240
Il ricorso alla terminologia collaudata e accettata in altri Paesi ― in primo luogo quelli anglo-sassoni, che parlano correntemente di Palliative medicine e di Palliative care ― ha il vantaggio di legittimare l'appoggiarsi alle realtà, scientifiche e istituzionali, che altrove hanno preceduto le nostre realizzazioni. Le riserve nei confronti del nome sono particolarmente giustificate se qualcuno interpretasse la palpazione come un'attività opposta rispetto a quella terapeutica. Perché la medicina palliativa non è altro che la medicina tout court. L'aggettivo "palliativo" è strumentale: vuol aiutare la medicina a recuperare una sua dimensione, che è stata messa in ombra dagli sviluppi recenti. Quando la medicina se ne sarà riappropriata, l'aggettivo potrà scomparire nel sostantivo, come il lievito nella pasta. E chi farà della palpazione potrà dire che sta semplicemente esercitando l'arte medica. Prima però di rinunciare all'aggettivo qualificativo, dovremo essere sicuri che la "controrivoluzione" necessaria per far ritrovare alla medicina la strada che porta al paziente come essere umano sia stata compiuta.
La medicina delle cure palliative è la medicina di sempre. È un modo di esercitare l'arte terapeutica che, rispetto a ciò che conosciamo sotto il nome di medicina, ha tuttavia un carattere di complementarietà. Così come il maschile e il femminile sono due modi diversi, ma complementari, di realizzare la comune natura umana. L'accenno al femminile non è casuale. La medicina palliativa deve molto alle donne. Sono donne le leader carismatiche del movimento: Dame Cecily Saunders, la fondatrice del St. Christoper's Hospice; Elisabeth KÜbler Ross, che ha elevato a conoscenza scientifica la psicologia del morente. È "femminile" la sensibilità che ha permesso di vedere la sofferenza del malato terminale: una sofferenza che non si limita al dolore fisico provocato dalle malattie degenerative, ma comprende dimensioni psicologiche, sociali, spirituali.
Questa medicina di sapore materno non va semplicemente contrapposta all'altra, quella curativa. Se non altro perché il controllo del dolore, che è il primo imperativo delle cure palliative, rimane un atto medico che non può fare a meno delle conoscenze farmacologiche più sofisticate. Il trapasso dalla dimensione curativa a quella palliativa della medicina è graduale. Il discernimento dei tempi e dei modi della transizione dall'una all'altra richiede grande capacità empatica da parte del terapeuta.
Per cogliere i rapporti che intercorrono tra le due dimensioni ci può essere di nuovo utile il parallelismo tra il maschile e il femminile. Queste sono, sì, due modalità diverse e complementari di realizzare la natura umana; ma hanno bisogno l'una dell'altra. Non solo nell'umanità come genere, ma anche nella stessa persona: la donna migliore è quella che non ha represso il suo animus, ma piuttosto quella che l'ha accettato e integrato. Lo stesso vale per l'uomo con la sua anima. Analogamente a ciò che avviene nella singola persona, dove le due polarità psicosessuali devono entrare in un gioco di integrazione, possiamo dire che la dimensione curativa e quella palliativa della medicina non devono escludersi, ma completarsi reciprocamente.
MEDICINA, NON ARS MORIENDI
È necessario resistere alla seduzione di collocare le cure palliative nel vuoto che si è creato là dove la cultura moderna, radicalmente immanentista, ha disimparato a guardare oltre il limite della vita terrena. In ambito religioso la preparazione alla morte ha costituito, fino a un'epoca molto recente, un cardine della predicazione e della devozione privata. Al credente veniva insegnato che viveva per morire, e moriva per la vita eterna. Il sacerdote, in quanto professionista del sacro, era lo specialista della morte, considerata come cerniera tra la vita terrena e l'"altra vita". L'ars moriendi, che intendeva promuovere la capacità di morire bene, è stata per secoli un genere letterario molto coltivato. Le cure palliative non devono essere intese come un surrogato di quell'arte, che in quanto tale è andata perduta.
241
Oggi il morire non è più competenza di nessuno: né dei tradizionali medici dell'anima, né degli attuali sacerdoti della scienza medica. I primi sono stati allontanati dal letto dei morenti, i secondi si sono sempre più esclusivamente identificati come professionisti dell'ars curandi e hanno perso ogni contatto con l'ars moriendi. Elemento marginale e residuale dell'organizzazione sanitaria rivolta a guarire, il morente può solo contare sulla buona volontà di qualche isolato professionista. Per lo più infermiere, osserva Arold Brodkey. Nel libro con cui il grande scrittore americano, morto di AIDS, riflette sul suo ultimo soggiorno in ospedale (Questo buio feroce. Storia della mia morte) documenta l'abbandono in cui viene a trovarsi il malato per il quale non ci siano più prospettive di cura:
Gli ospedali sono diventati un casino, non ce l'hanno fatta. Il crollo della cospirazione borghese che era la cultura urbana in Occidente si manifesta negli ospedali sotto forma di decadenza totale, visibile e radicale. Tutto è approssimativo e traballante, persino la pulizia e la somministrazione delle cure. Ma forse a causa dell'ostinata gentilezza d'animo di alcune persone, per una determinazione a impersonare la bontà, o per una sorte di assuefazione alla priorità dell'emergenza, oppure perché salvare qualcuno dalla morte ha un significato che soddisfa la loro anima e il loro senso del ruolo che occupano nell'Universo, quando stai morendo arrivano a occuparsi di te le infermiere e le aiuto infermiere migliori.
Brodkey, 1999.
Le cure palliative, pur partendo dalla consapevolezza che si rivolgono a malati non destinati alla guarigione, né alla cronicità, bensì avviati verso la fine della vita, possono a giusto titolo rivendicare il loro orientamento alla salute, non meno dei trattamenti curativi e riabilitativi. Saper guardare nella direzione della morte arricchisce il concetto stesso di salute. La salute, infatti, non è piena se è costruita sulla rimozione della morte, se esclude il naturale procedere della vita organica verso la fine. Al contrario, la salute che sappia guardare in faccia la morte, e assumerla, si orienta a sublimarsi nella "Grande Salute" (Nietzsche).
La medicina per il malato che non va verso la guarigione, ma verso la conclusione della vita, trova nella salute un importante orientamento. Le cure palliative non si definiscono a partire dalla morte, né come una medicina che aiuta a morire: sono una medicina per l'uomo, che rimane un vivente fino alla morte (in una prospettiva antropologica spiritualista, rimane un vivente anche dopo la morte!).
La situazione che si crea quando si tiene la morte in vista comporta due accentuazioni nella pratica clinica abituale: la preoccupazione per la palliazione del dolore e dei sintomi in generale e la qualità della comunicazione con il malato. Della terapia del dolore abbiamo parlato nel capitolo precedente. Lo stato di terminalità costituisce un giro di vite nell'urgenza di controllare il dolore (che peraltro si estende a qualsiasi condizione patologica). Le cure palliative appropriatamente considerano il dolore come il nemico per eccellenza.
Analogamente possiamo affermare che la comunicazione con il malato non è esclusiva della fase terminale della malattia. Le cure palliative mettono solo nella massima evidenza che il malato non può essere solo qualcuno di cui si parla, ma deve essere qualcuno con cui si parla. Solo questo tipo di comunicazione permette di considerare il malato che non guarisce come un soggetto.
QUANDO LA COMUNICAZIONE È IL PROBLEMA
Tutti gli interrogativi che si è soliti porsi in merito alla situazione del malato in fase terminale ― sa o non sa? il medico è obbligato o no a comunicargli la prognosi? deve dirlo ai familiari piuttosto che al malato stesso? il malato è favorito o danneggiato dalla comunicazione della verità? quali sono le conseguenze per il malato e i suoi familiari della congiura del silenzio?
242
Un malato informato è più o meno collaborativo con il medico? ― ruotano attorno alla comunicazione.
L'evidenza assunta dalia comunicazione in questo ambito della pratica medica non depone a favore della comunicazione stessa. Quando, infatti, nei rapporti interpersonali la comunicazione si fa centrale, possiamo dedurne con relativa certezza che siamo di fronte a un indice di relazione "malata". Lo conferma autorevolmente Paul Watzlawick, uno dei maggiori esperti della comunicazione umana: "Quanto più una relazione è spontanea e 'sana', tanto più l'aspetto relazionale della comunicazione recede sullo sfondo. Viceversa, le relazioni 'malate' sono caratterizzate da una lotta costante per definire la natura della relazione, mentre l'aspetto di contenuto della comunicazione diventa sempre meno importante" (Watzlawick, 1971).
La regola riceve una verifica empirica nelle relazioni amorose: le coppie in crisi, invece di fare l'amore, imbastiscono eterni discorsi per definire il loro rapporto... Quando la comunicazione è inceppata, ci si accorge di essa, in quanto diventa un sintomo dolorante. Qualcosa di analogo succede nell'ambito sanitario con i malati inguaribili. Tutti i protagonisti di queste situazioni ― medici, infermieri, familiari, i malati stessi ― soffrono per un ingorgo della comunicazione. Questa emerge così fortemente in primo piano, come problema, perché tra le persone coinvolte si è creata una sconnessione, che produce un'impasse o un circolo vizioso (si parla non all'altro, ma all'idea che ci si fa dell'altro, il quale a sua volta si costruisce una sua immagine dell'interlocutore e interagisce con essa...). Nella comunicazione si crea così un nodo.
Questo termine ci rimanda agli schemi paradigmatici con cui Ronald Laing ha descritto i rapporti intrapsichici e interpersonali malati. I grovigli che si creano li ha chiamati, appunto "nodi".
Eccone uno tipico:
Giovanni pensa
di non sapere
ciò che lui pensa
che Maria pensa
che lui non sa.
Ma Maria pensa che Giovanni lo sa.
Così Maria non sa
di non sapere
che Giovanni non sa
che Maria pensa
che Giovanni non sa
e Giovanni non sa di non sapere
che Maria non sa di non sapere
che Giovanni non sa
che Maria pensa che Giovanni sa
ciò che Giovanni pensa di non sapere
Giovanni non sa di saperlo
e non sa
che Maria lo sa.
Maria non sa di non saperlo,
e non sa
che Giovanni non sa di saperlo
e che non sa che Maria non lo sa.
Non hanno problemi.
Laing, 1969.
243
È ovvio che l'osservazione "non hanno problemi" è ironica... Allo stesso modo è superfluo annotare che simili garbugli sono fonti di indicibili sofferenze. Basta che nel "nodo" descritto da Laing sostituiamo Giovanni e Maria con altri protagonisti (il medico e i familiari da una parte, il malato dall’altra) per avere una descrizione fedele dell'ingorgo di comunicazione che avviene attorno al malato inguaribile.
Se la comunicazione non fluisce in modo sano, ristagna in maniera patologica. Perché, in ogni caso, non si può non comunicare. Questo è il primo assioma stabilito da Watzlawick nella sua Pragmatica della comunicazione umana. La comunicazione, infatti, è un comportamento; e non esiste l'opposto del comportamento. Chi, in una situazione di vicinanza, si chiude nel mutismo, comunica che non vuol comunicare. Le parole e il silenzio, l'attività e l'inattività: tutto, nell'interazione, ha valore di messaggio. La questione, quindi, diventa: che cosa comunica il nostro comportamento, quando rifiutiamo di comunicare con il malato inguaribile? La risposta è univoca: gli comunichiamo la sua morte! Non soltanto la morte organica, che avverrà in un tempo futuro, più o meno prevedibile, ma soprattutto la sua morte sociale, in parte già avvenuta.
Gli sviluppi della medicina hanno portato a focalizzare l’attenzione del diritto e dell’etica, nonché delle scienze biomediche, sul problema del segmento finale della vita umana. In un individuo, dove fa la sua ultima sosta la vita? Siamo stati costretti a spostare progressivamente questa tappa: dal respiro e dal battito del cuore fino all'attività del cervello; nel cervello stesso bisognerà, a sua volta, distinguere tra inattività della corteccia e quella del tronco... Il problema di definire l'ultimo tratto della vita umana è importante per la scienza e per la pratica medica, se non altro per le sue ricadute nell'ambito dei trapianti di organi. Affascinati da questa prospettiva, abbiamo dimenticato una questione non meno importante dal punto di vista esistenziale: quella dell'inizio della fine. Ovvero, della morte sociale.
L'essere umano non è solo un organismo animato, ma è anche essenzialmente un membro della società. Quando si recide il legame vitale con la comunità, muore come essere umano. Questo tipo di morte non ricalca esattamente la morte fisica: può avvenire prima o dopo, rispetto alla cessazione della vita organica. Ci sono tribù in Africa che considerano morta una persona solo quando non si parla più di essa: è un esempio estremo di divaricazione tra morte sociale e morte organica.
LaÙ morte sociale, inoltre, non è un avvenimento "puntuale": si verifica a gradi. Attraversa vari stadi; come la malattia stessa, può essere leggera, grave, fatale, oppure reversibile. La progressione della morte sociale è favorita dal fatto che la morte, nel modo in cui si verifica abitualmente in ospedale, è un processo che si dilunga nel tempo: non ha niente in comune con la morte che si vede al cinema, che ha sempre il carattere della rapidità. Nel lungo tempo che la persona impiega a morire, si verifica gradualmente la sua morte sociale.
L’ospedale è un osservatorio eccellente, che permette di registrare come si passa dal regno dei vivi a quello dei morti: cessano le cure usuali, l'interesse medico si affievolisce fino a scomparire (a meno che non sia un "caso interessante" in un ospedale che abbia anche finalità di didattica o di ricerca), i morenti sono separati dai familiari; talvolta ricevono già i trattamenti riservati alle salme...
Nell'esperienza dei più la morte sociale comincia quando si cessa di essere considerati soggetti che possono prendere decisioni responsabili sul proprio destino. La preoccupazione di evitare alla persona che non può guarire lo shock di conoscere la propria situazione porta coloro che sanno ― i sanitari e i familiari ― a farsi carico della gestione della parte finale della vita del malato inguaribile, sottraendogli l'informazione. In questo modo lo si è già condannato a morte come soggetto.
Sia le parole che il silenzio hanno il loro lato tragico. Volendo evitare il dramma dell'informazione, si precipita in quello della mancanza di verità. Il silenzio, che può essere un salutare
244
correttivo della retorica banalizzante delle parole e può talvolta offrire la solida consolazione derivante dalla muta solidarietà, in queste condizioni è solo un vuoto di parole. Comunica al malato che non è più qualcuno con cui si possa comunicare. Gli comunica, cioè, che socialmente può già considerarsi morto.
NELLA CASA DELLA PAROLA C'È PIÙ DELLA PAROLA
Ma i pazienti inguaribili, avviati verso la morte, vogliono sapere della loro situazione? Questo interrogativo continua a offrire lo spunto per innumerevoli dibattiti. L'abituale mancanza di informazioni al malato sulla sua prognosi infausta può essere letta in diversi modi. Qualcuno fa responsabile della "congiura del silenzio" i medici e i familiari: sono loro che non vogliono parlare, o per malinteso paternalismo, o per risparmiarsi il peso di dover sostenere emotivamente un paziente confrontato con una prospettiva tragica. Altri, invece, attribuiscono la volontà e li preservano dal trauma di un'informazione non desiderata. O forse i malati fanno finta di non sapere, perché i medici e i familiari non vogliono parlare… Dove sta il torto e la ragione, in questo scenario cangiate?
La pragmatica della comunicazione umana ci ha insegnato a sbrogliare matasse di questo genere riferendoci alla "punteggiatura" delle sequenze di eventi. Quando in un rapporto comunicativo si creano delle catene che tendono a prolungarsi all'infinito (l'esempio più tipico è quello di una coppia che litiga: lei brontola, lui si chiude in se stesso; lei brontola perché lui si chiude, lui si chiude perché lei brontola; allora lei brontola ancora di più, mentre lui risponde chiudendosi ancora di più: teoricamente, questa catena non ha fine…), ambedue i modi di punteggiare gli avvenimenti sono possibili e corretti. Non si tratta di dare ragione all'uno o all'altro, adottando la sua punteggiatura degli eventi, ma di trovare un modo di spezzare la catena.
Uno di questi modi sono le ricerche empiriche. Il tema del consenso informato, di grande interesse per l'etica medica, ha stimolato una quantità di indagini, dalle quali risulta che la falsa attribuzione del desiderio di informazione è uno degli errori più comuni nella pratica clinica. Tra ciò che i pazienti desiderano conoscere e quello che i medici pensano che essi vogliono conoscere, esistono discrepanze rilevanti.
In una delle prime ricerche di questo genere, condotta negli Stati Uniti da Watzkin e Stoeckle, sono stati registrati 336 incontri tra medici e pazienti in diversi contesti clinici, compresa la pratica privata e gli ambulatori ospedalieri. Si è chiesto ai medici di indovinare il desiderio dei pazienti di essere informati e l'utilità dell'informazione per il paziente. Anche ai pazienti si è domandato di fornire un'autovalutazione. La maggioranza dei pazienti desiderava conoscere quasi tutto e pensava che l'informazione sarebbe stata loro utile. Ma nel 65 per cento degli incontri i medici sottovalutavano il desiderio di informazione e l'utilità clinica dell'informazione stessa (Waitzkin, Stoeckle, 1976).
La stessa ricerca fornisce un altro dato importante. I ricercatori chiesero anche ai medici quanto tempo pensavano di aver dedicato a informare. Confrontando questa percezione soggettiva con il tempo oggettivamente risultante dalla registrazione degli incontri, risultò che in media i medici stimavano il tempo dedicato all'informazione nove volte più del tempo effettivamente impiegato a informare!
Ai risultati prosaici, ma istruttivi, di questo tipo di ricerche bisogna aggiungere l'esperienza di cha ha infranto la barriera del silenzio e si è messo, senza preconcetti, a parlare con i malati, anche quelli inguaribili e avviati verso la morte, sulla loro situazione. Fa ormai parte irrinunciabile del patrimonio di esperienze acquisite nelle cure palliative la convizione che si gestisce meglio la situazione di terminalità quando è possibile esprimere le proprie e mozioni, comunicarle a qualcuno,
245
246
condividere i propri stati d'animo. Da quando Elisabeth Kübler Ross ha cominciato a disobbedire alla consegna del silenzio con i morenti, dominante negli ambienti ospedalieri, si è aperto un capitolo nuovo di conoscenze dell'animo umano e dei suoi bisogni nel momento in cui si avvicina alla soglia estrema della vita. Quanto sappiamo sugli stadi del morire, sull'organizzazione della speranza e sulle modalità simboliche della comunicazione fa parte ormai della medicina odierna, allo stesso modo della chimica dei neurotrasmettitori e delle reazioni immunologiche.
Buona parte degli equivoci che si registrano nell'ambito dell'informazione al malato grave riposano sul fatto che vengono presi in considerazione solo gli aspetti verbali della comunicazione. Ora, la comunicazione non si identifica con la parola. Il linguaggio ha sicuramente un'importanza unica per la specie umana, che da esso viene caratterizzata. Ma non è l'unico canale attraverso il quale comunichiamo. Quando ci avviciniamo ai segmenti estremi della vita umana ― la nascita e la morte ― scopriamo con sorpresa quanto abbiamo ancora in comune con i nostri antenati mammiferi.
L'avvicinarsi della morte provoca un'estrema regressione, che ci fa diventare, come i bambini e come gli animali, sommamente ricettivi alla comunicazione analogica che accompagna il discorso. E anche se le parole si organizzano abilmente per sostenere delle menzogne, i comportamenti tradiscono la verità: tanto quella di colui che muore, come quella di chi l'assiste. Sembra un paradosso: le espressioni più sublimi che possiamo attribuire agli esseri umani ― la solidarietà, l'amore, la compassione ― passano attraverso il canale povero dei gesti. Gli atti di natura corporea e il contatto fisico sono destinati a portare un peso metafisico che sembra sproporzionato. Attraverso i gesti umili della "carne comune" (M. Merleau-Ponty) si esprime il mistero della reciprocità delle coscienze.
247
capitolo
II
LA FINE DELLA VITA
IL CONFINE TRA LA VITA E LA MORTE
La linea di confine tra la vita e la morte non è sempre facile da tracciare. Fino a non molto tempo fa la morte veniva determinata in modo empirico, in base alla cessazione del battito cardiaco e all'arresto della respirazione. Anche se il riconoscimento della morte spettava al medico, per gli adempimenti medico-legali, chiunque era in grado, passando uno specchio davanti alla bocca e alle narici del deceduto, di verificare se c'erano o no segni di vita: se lo specchio non si appannava, o se la fiamma della candela non tremolava, si poteva concludere che la vita era cessata.
Nel giro di un paio di generazioni questi risultati per stabilire il decesso sono diventati preistorici. L'elemento determinante è stato lo sviluppo in medicina delle tecnologie di rianimazione. La respirazione e circolazione sanguigna artificiali suppliscono l'autoregolazione dell'organismo umano quando la persona è in coma; una quantità di vite umane possono essere salvate in questo modo. La frontiera tra la vita e la morte si è spostata: non risiede più nella capacità di respirare autonomamente, ma nell'assenza di danni cerebrali irreversibili, che annullano la possibilità di vita sensitiva e cognitiva. Lo strumento per rilevare se il cervello è morto o vivo è l’elettroencefalogramma, che misura l'attività delle cellule cerebrali. Se l’elettroencefalogramma è "piatto" ― vale a dire le cellule cerebrali non esercitano più a loro attività elettrica ― e questa situazione si prolunga per un certo periodo di tempo, il coma sarà irreversibile: la persona in coma, cioè, non tornerà più a uno stato di coscienza e a una vita di relazione.
È legittimo a questo punto comportarsi come se la persona avesse superato la soglia che divide i vivi dai morti? L'interrogativo apre una serie di questioni. Antropologiche, in primo luogo: si può far coincidere la vita umana con la vita vegetativa? Si può continuare a considerare come un essere umano un organismo sprofondato irreversibilmente nel buio della coscienza che fa seguito alla distruzione del sistema nervoso?
Un'altra forte spinta a ridefinire il momento della morte viene dalla medicina stessa, più precisamente dalla pratica dei trapianti di organo. Dal momento che gli organi da utilizzare devono essere prelevati dal cadavere in un tempo non troppo lontano dalla morte, è importante decidere quando la persona sia già morta, malgrado il proseguimento di qualche forma di vita vegetativa. Tuttavia la determinazione del momento della morte clinica non è importante solo in vista dei trapianti: serve anche a salvaguardare il diritto di ciascuno a morire con dignità. Oggi, infatti, il prolungamento artificiale della vita rende possibili situazioni in cui l'apparato della tecnologia medica si frappone tra l'individuo e la propria mente, rendendogliela impossibile.
248
Nei secoli XVIII e XIX, secondo la ricostruzione dello storico della morte Philippe Ariès, la grande paura era quella della morte apparente: un panico generale si era diffuso nella popolazione all'idea di essere sepolti vivi e di sorvegliarsi in fondo a una tomba. La paura predominante dei nostri contemporanei è un'altra: quella di essere trasformati in un "vegetale", che langue per un tempo indefinito in quella terra di nessuno che la terapia intensiva ha creato tra la vita e la morte (e magari di essere utilizzato in quello stato per esperimenti scientifici: grande scalpore ha suscitato in Francia la notizia, diffusa dai medici stessi, che una persona in coma da tre anni era stata usata a fini di sperimentazione...). La definizione della morte clinica, fatta con riferimento alla perdita irreparabile della funzionalità del sistema nervoso centrale, va anche a beneficio dell'individuo, proteggendolo da un interventismo terapeutico a oltranza che lo blocca sulla linea di confine. Poter infine essere dichiarato clinicamente morto equivale a una liberazione!
Non sorprende che la necessità di fornire indicazioni chiare su un argomento così centrale nelle concezioni socialmente condivise sulla vita abbia indotto il Comitato nazionale per la bioetica a dedicare uno dei suoi primi documenti alla "Definizione e accertamento della morte dell'uomo" (15 febbraio 1991). L'intento dichiarato del CNB è quello di "offrire una base di approfondimento rigorosamente scientifica, muovendo sempre dall'esigenza esclusiva del rispetto e della tutela della vita umana", per rispondere allo sconcerto che si diffonde nella popolazione circa la definizione esatta della morte e del momento in cui essa si verifica. La frequente mancanza di chiarezza nella divulgazione del dibattito scientifico ha, infatti, "contribuito a suscitare o perpetuare paure e pregiudizi nei confronti di una corretta diagnosi di morte".
In una prima parte teorica il documento procede a definire la morte; la seconda parte dà indicazioni pratiche sull'accertamento della morte stessa. La morte è identificata con la "perdita totale e irreversibile della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale". Il problema cruciale riguarda i criteri di accertamento, in particolare il passaggio dai I problemi cardiaci a quelli neurologici, incentrati sul concetto di morte cerebrale. Questa è intesa come "danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l'arresto cardiaco anossico".
Il Comitato sceglie, dal punto di vista terminologico ― sulla base di una precisa opzione antropologica ― una definizione unitaria della morte, rifiutando la morte "aggettivata". Parlare, infatti, di morte clinica, morte cardiaca, morte cerebrale, morte corticale ecc. genera confusione e disorientamento, in quanto fa intendere che esistono molte morti e modi diversi di morire. Nella prospettiva adottata, la morte avviene quando l'organismo cessa di "essere tutto", mentre il processo del morire termina quando "tutto l'organismo" è giunto alla completa necrosi. Quando , si parla di morte cardiaca, in realtà ci si riferisce ai criteri cardiocircolatori per la diagnosi di morte dell'intero organismo; analogamente, quando si parla di morte cerebrale, si intendono i criteri neurologici per accertare la morte nella sua totalità. Il CNB suggerisce, al fine di evitare equivoci, di non usare le espressioni abbreviate di morte cardiaca e morte cerebrale, anche se ormai di uso comune.
Una conseguenza rilevante di questa impostazione è il rifiuto del criterio di morte costituito ; dalla necrosi della sola area corticale del sistema nervoso centrale, pur rimanendo integre e funzionanti le strutture tronco-encefaliche (la cosiddetta morte corticale). Se questo criterio di accertamento venisse accettato, i malati che si trovano in stato vegetativo cronico potrebbero essere dichiarati morti.
L'operatività della definizione adottata dal Comitato ha dato buona prova di sé quando in Italia è scoppiato il caso Valentina (marzo 1992), una neonata anencefala, che i genitori e alcuni medici volevano dichiarare disponibile per l'asportazione di organi a fini di trapianto. I criteri adottati dal Comitato nazionale non autorizzavano la diagnosi di morte; hanno quindi
249
guidato la scelta di rispettare la vita della neonata e di rinunciare al trapianto di organi.
Per quanto riguarda l'accertamento della morte, essendo i criteri anatomici (morte per devastazione) e i criteri cardiocircolatori (morte cardiaca) comunemente accettati, il CNB dedica la sua attenzione esclusivamente agli aspetti controversi dei criteri neurologici (morte cerebrale). In presenza di una lesione cerebrale organica che induce il sospetto di una morte cerebrale, il rianimatore deve ricercare tutti i fattori che possano fornire la certezza dell'avvenuta morte cerebrale. Il tempo di osservazione attualmente prescritto (12 ore) può essere ridotto con l'impiego di alcuni esami strumentali che consentono di confermare la diagnosi di morte cerebrale ottenuta attraverso il rilievo di un EEG piatto. Per l'accertamento della morte in età pediatrica e nel neonato devono essere adottati altri criteri, che prevedono un periodo di osservazione più lungo. L'accertamento della morte è un dovere del medico indipendentemente dalla finalità di trapianto e impone, comunque, la sospensione delle terapie.
La morte clinica, tuttavia, non ci autorizza a pretendere di sapere che cosa avviene negli estremi momenti di vita di un individuo. I racconti di persone che si sono risvegliate da un coma profondo bastano a inquietarci, in quanto testimoniano la permanenza di una sensibilità e di un vissuto di immagini e di emozioni, quando tutti attorno a loro li consideravano morti. Non sappiamo che cosa comporta, nella profondità della psiche, e soprattutto nella dimensione spirituale dell’essere umano, il processo del morire. Il sapere scientifico deve dichiarare il suo limite; ci soccorre, invece, la sapienza delle tradizioni religiose, che domandano un rispetto del morente nella morte e oltre. Anche il cadavere, infatti, continua a partecipare alla qualità umana della persona a cui è appartenuto.
IL PROLUNGAMENTO MEDICO DELLA VITA
Il termine della vita è diventato un'area scottante, dove confluiscono sfide antropologiche tra le più radicali. Ciò obbliga l'etica biomedica contemporanea a ripensare, in considerazione del bene stesso dell'uomo, le norme morali che in passato hanno validamente regolato questo ambito. L'intervento massiccio delle nuove tecniche ha cambiato volto alla morte. Questa ha perso la sua "naturalezza": nelle aree industrializzate e urbanizzate il trapasso avviene ormai quasi esclusivamente in un contesto medico, per lo più in ospedale, spesso sotto terapia intensiva in rianimazione. Grazie a questa disciplina medico-chirurgica, tanto spettacolare quanto efficace, la durata della vita ha potuto essere notevolmente prolungata. Ma il tenere in scacco la morte si è rivelato quanto meno una benedizione ambigua.
La possibilità di rendere la vita vegetativa indipendente dai livelli superiori della coscienza diventa, almeno in alcuni casi, un dono malefico. Si può assistere allora alla paradossale rivendicazione del diritto di essere dichiarati morti! La vicenda dell'americana Karen Ann Quinlan ha assunto in questo ambito il ruolo di caso emblematico, di quelli che hanno il merito di portare un problema etico a livello della coscienza popolare. Nell'aprile 1975 la ragazza era caduta in coma profondo, con lesioni cerebrali irreversibili, che non le avrebbero permesso di tornare indietro da una sopravvivenza puramente vegetativa. I genitori chiesero ai medici di lasciarla morire in pace; questi invece, in nome dell'etica professionale che impone loro di fare di tutto per prolungare la vita, rifiutarono, e le applicarono un polmone di acciaio. I Quinlan chiesero allora all'autorità giudiziaria l'autorizzazione al distacco dal respiratore artificiale. Ne seguì un processo a più riprese, che vide schieramenti appassionati prò e contro il desiderio dei genitori. Questi ottennero infine dalla Corte Suprema del New Jersey la sospensione delle misure di rianimazione (maggio 1976), anche se la povera Karen Ann doveva ancora "vegetare" per anni, prima di spegnersi naturalmente, l'11 giugno 1985.
La vicenda Quinlan, tuttavia, aveva ormai posto di fronte all'opinione pubblica il problema:
250
ci sono situazioni in cui la morte sembra che la si debba conquistare lottando contro l'apparato medico. I medici intraprendono il prolungamento della vita con buona coscienza, richiamandosi ai principi etici che ispirano la professione. Se le norme del passato, in un mutato contesto culturale, portano a pratiche disumane, è forse giunto il momento di riconsiderare le norme stesse.
Lo scenario del morire si trasforma: ciò è vero non solo per il morente, ma anche per chi si occupa di lui dal punto di vista sanitario. I medici, in particolare, sembrano rimettere in discussione uno dei principi deontologici a cui tradizionalmente si sono ispirati: il rifiuto a usare la propria arte per abbreviare in qualsiasi modo la vita del paziente. Somministrare la "morte per pietà" non è più, se si assume questa prospettiva, il gesto inconsulto con cui qualcuno cerca disperatamente di rispondere alla sfida estrema di una situazione eccezionale. Diventa, piuttosto, un preciso dovere del medico, il quale solamente può giudicare quando è giunto il momento di mettere la parola "fine" alla vita di un uomo.
Questa concezione sconvolge ogni riferimento tradizionale. Paradossalmente, mentre sempre più forte si va facendo il movimento di opinione che contesta non solo all'individuo ma anche allo Stato il diritto di disporre della vita di un uomo ― premendo affinché, di conseguenza, la pena di morte sia bandita dalla legislazione di tutti gli stati civili ―, ora qualcuno osa rivendicare un simile diritto per il medico. Si scardina così uno dei punti fissi della deontologia professionale alla quale tradizionalmente i medici si sono ispirati. Fin dall'antichità, quando i medici con il Giuramento di Ippocrate hanno formulato esplicitamente gli impegni che si assumevano nei confronti del paziente, si sono obbligati a non dare la morte, neppure a chi la richiedesse: "Giammai ― giurava il medico ― mosso dalle preghiere insistenti di qualcuno, propinerò medicamenti letali, né commetterò mai cose di questo genere". Che cosa succederebbe se questo pilastro dell'etica medica venisse a cadere?
La "Guida europea di etica e di comportamento professionale dei medici" (1982) giustifica la proibizione di praticare l'eutanasia con l'argomento della fiducia che deve poter essere posta nei sanitari: "Ricorrere a un medico vuol dire in primo luogo affidarsi a lui. Tale azione, che domina tutta l'etica medica, proibisce, di conseguenza, alcune azioni a essa contrarie. Così il medico non può procedere all'eutanasia. Deve sforzarsi di placare le sofferenze del suo malato, ma non ha diritto di provocarne deliberatamente la morte... Questa regola, conosciuta da tutti e rispettata dal corpo medico, deve essere la ragione e la giustificazione della fiducia posta in lui. Nessun malato, handicappato, infermo o senile, alla vista del medico, chiamato al suo capezzale, deve avere dubbi a questo riguardo".
I motivi addotti a difesa del comportamento tradizionale dei medici suonano plausibili. Ma colpisce il fatto che allo stesso argomento della fiducia del paziente nei confronti del medico facciano ricorso anche coloro che sollecitano una modifica delle norme della deontologia medica. La fiducia del malato ― sostengono ― è accresciuta, se questi sa che può contare sul medico non solo per guarire, ma anche per morire. L’angoscia più profonda del morente dei nostri giorni è quella di essere abbandonato, nel momento in cui, secondo la scienza medica, "non c'è più niente da fare", in nome di un contratto morale implicito nell'alleanza terapeutica, il malato vuole poter contare sul medico fino all'ultimo, anche per poter finire i suoi giorni.
C’è un aspetto di ipocrisia ― incalzano i critici ― in certi alti proclami della medicina come servizio alla vita: prima la medicina stessa crea delle situazioni disumane, poi rifiuta di assumerne le responsabilità, trincerandosi dietro i principi deontologici! Troppo spesso il medico, richiamandosi ai "valori ippocratici", di fatto abbandona il malato, perché la morte non è di sua competenza. Come in tutte le situazioni in cui predomina l’ideologia, i sublimi ideali rischiano di diventare uno schermo dietro a cui si nasconde una realtà piuttosto meschina...
Questi attacchi alla deontologia tradizionale, per quanto provocatori ed eversivi, non sono necessariamente insensati. Il loro risvolto positivo sta nel richiedere che si rifletta, nei termini;
251
concreti della pratica medica attuale, sulla finalità della professione medica. La medicina curativa, per tradizione, non si occupava della morte, e quindi neppure dei moribondi. Per questo poteva dichiararsi compattamente schierata sul fronte della vita. Ma le nuove condizioni del morire obbligano i sanitari a occuparsi anche della morte dell'uomo. Sarebbe abusivo derivare da questo orientamento una legittimazione a priori di interventi rivolti ad abbreviare la vita di un paziente; ma non è neppure più legittimo appellarsi ai principi ippocratici come alibi per evitare di affrontare le questioni scomode che solleva il morire nel nostro tempo.
Vuol dire, dunque, che nella cittadella della medicina si sta creando una breccia, attraverso la quale entrerà l'eutanasia? L'appassionato confronto su questo tema, che è uno dei punti più delicati della bioetica contemporanea, si nutre abbondantemente di equivoci. In primo luogo di fraintendimenti semantici, cioè sul significato delle parole, che inquinano la comunicazione tra persone pur animate da un retto intendimento. Non potendo dipanare pienamente la matassa, cerchiamo almeno di definirne i contorni.
Il principale responsabile dei malintesi che si addensano intorno ai comportamenti da tenere nei confronti della vita a termine è la parola stessa: eutanasia. Di fatto il dibattito si svolge più attorno a questa parola che in merito a specifici comportamenti: sì o no all'eutanasia? Bisogna introdurre delle disposizioni legislative che permettano l'eutanasia? È giusto che i medici smobilitino un antico fronte, rendendosi disponibili all'eutanasia? Nei dibattiti di questo genere si crede di parlare della stessa realtà, ma l'intesa è illusoria, in quanto gli interlocutori hanno in mente situazioni completamente diverse. Il termine eutanasia è una tipica "parola-attaccapanni", alla quale ciascuno attribuisce un particolare significato. L'ambiguità della parola suggerisce di tenere separati i diversi problemi per i quali si ricorre al termine eutanasia.
Sono almeno sei ambiti diversi ai quali si fa riferimento con lo stesso termine:
― l'"addolcimento" degli ultimi momenti della vita del malato (secondo il significato etimologico della parola, che nasce dall'accostamento di due parole greche: eu e thomatos, eutanasia viene qui a significare una morte armoniosa, senza strazio);
― la lotta contro la sofferenza, che può comportare il ricorso ad analgesici che fanno perdere coscienza al malato, ovvero, come effetto secondario, possono anche indirettamente abbreviare la vita, in quanto deprimono la funzione respiratoria;
― il prolungamento della vita a ogni costo, correlato al problema dell'astensione terapeutica (quando ciò avviene, si ha un "lasciar morire", che alcuni preferiscono chiamare eutanasia passiva);
― la soppressione dei tarati per ragioni eugeniche, come è stata teorizzata e praticata in Germania durante il Terzo Reich (da questo precedente storico l'eutanasia ha conservato un significato sinistro, che rende quasi impossibile riabilitare la parola);
― la constatazione della morte secondo i criteri clinici, malgrado il perdurare di apparenze di vita;
― infine, il porre termine deliberatamente alla vita di una persona, su richiesta esplicita o presunta di quest'ultima, in nome della compassione per chi sta soffrendo in una condizione ritenuta ormai disumana.
Il dibattito acquisterebbe il pregio della chiarezza se si parlasse di eutanasia non indiscriminatamente per tutte le situazioni sopra citate, ma in senso specifico e delimitato: per esempio, solo nell'ultimo caso preso in considerazione.
QUANDO L'EUTANASIA È UN PROGRAMMA POLITICO
La vicenda è nota, almeno nei suoi contorni generali: durante l'epoca nazista fu messo in atto un programma a opera delle autorità statali tedesche che prevedeva l'uccisione sistematica dei malati mentali e di persone con gravi handicap. Eppure pochi possono dire di conoscerne con
252
esattezza i contorni. È come se un fatto così enorme tendesse a sfuggire a una messa a fuoco precisa. In particolare in Germania è stata attivata una dimenticanza sistematica che assomiglia a un processo psicologico di rimozione.
A illustrare la difficoltà a far entrare quei fatti nella coscienza storica dell'occidente può essere utile ripercorrere le sorti del primo libro dedicato al tema. Uscì in Germania già nel 1948, a opera della psichiatra Alice Ricciardi von Platen. All'origine c'era il lavoro di una commissione, creata dall'Ordine dei medici tedesco, incaricata di far luce sul comportamento dei medici così come era emerso dal processo condotto contro di loro a Norimberga dal Tribunale militare americano. I crimini imputati ai medici prevedevano esperimenti sui prigionieri e crudeltà efferate in nome della ricerca scientifica. L'Autrice documentò il cosiddetto programma di eutanasia, voluto personalmente da Hitler, che portò a morte circa 70.000 persone, la metà dei lungodegenti negli ospedali psichiatrici.
I materiali raccolti riguardano in realtà una piccola area della Germania (la provincia dell'Assia-Nassau) sulla base dei documenti forniti dal Tribunale militare americano; tuttavia sono illustrativi del modo in cui venne messo in pratica il programma dell’eutanasia in tutto il territorio del Reich e soprattutto delle motivazioni teoriche che lo sostenevano. Ma l'Ordine dei medici era quantomeno ambivalente: dopo aver creato ufficialmente la commissione di lavoro, non si impegnò a fame conoscere i risultati. L'Ordine non aveva interesse che la popolazione tedesca fosse informata dell'operato di così tanti medici ai posti di comando nelle stazioni di sterminio. In breve, il libro scomparve dalle librerie (come in casi analoghi, non è fuori luogo il sospetto che ci sia stata una deliberata volontà di requisire le scomode testimonianze).
Come un fiume carsico che riappare in superficie, il libro è stato riproposto in Germania nel 1993, per iniziativa dell'eminente psichiatra Klaus Dörner (di questa seconda edizione è disponibile una traduzione italiana: Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente, Ricciardi, 2000). Altri segnali annunciano che il programma eutanasico tedesco, a lungo rimosso, tende a riaffiorare in superficie. Il dolore di una madre, che si è visto togliere e "pietosamente uccidere" dal regime nazista il proprio bambino, la cui unica colpa era quella di essere nato con la sindrome down, riemerge dopo molti anni attraverso una storia romanzata: Il piccolo Adolf non aveva le ciglia. Il racconto è stato scritto da Helga Schneider, che ha raccolto le memorie della madre del piccolo Adolf (la mancanza di ciglia è uno dei segni che annunciano il mongolismo del neonato). Non meno inquietante del clima dell'epoca, con lager camuffati da cliniche e i programmi di uccisione spacciati per cure specialistiche, è la rievocazione delle granitiche convinzioni ideologiche trasmesse dal regime. Partecipare alla soppressione delle vite senza valore era considerato un atto che esprimeva alte virtù civiche. Nel racconto di Helga Schneider, il padre del piccolo Adolf, un fanatico nazista che aveva dato a suo figlio il nome del Fuhrer, quando si rende conto che il figlio è affetto da handicap si dichiara orgoglioso di obbedire a un ordine che prevede l'eliminazione dell'infante: "Sono lieto di vivere in una nazione che si assume il carico morale, politico e pratico, di sollevare i propri cittadini da certi impegni gravosi che condizionerebbero negativamente il resto della loro vita" (Schneider, 1998).
libro di Alice Ricciardi von Platen documenta in modo molto accurato su quale terreno culturale sia sorto il programma di eutanasia, in un primo momento previsto solo per i neonati malformati e successivamente esteso anche ai malati psichiatrici ospiti dei manicomi. Le convinzioni fatte proprie dal nazismo erano quelle espresse nel libro-programma di Binding e Hoche, apparso già nel 1922, il cui titolo suona ― tradotto letteralmente ― "L'autorizzazione all'eliminazione delle vite non degne di essere vissute": "Non c'è alcun dubbio che esistono uomini la cui morte è per loro stessi un sollievo, mentre per la società e lo Stato costituisce la liberazione da un peso, che non comporta la minima utilità se non quella di essere modello di grandissimo altruismo".
253
Il programma di eutanasia rivolto a sopprimere i cosiddetti "pesi morti" della nazione ― schizofrenici, epilettici, alcolizzati, malati in fase terminale e neonati con malformazioni genetiche ― era nobilitato in senso sociale. Veniva presentato dai burocrati incaricati di realizzarlo come un'operazione rivolta al bene comune, in particolare in quanto faceva posto negli ospedali e nelle istituzioni sanitarie ai soldati feriti in guerra. Il popolo tedesco veniva così grossolanamente diviso in soggetti "utili" e "non utili" ai fini del nazionalsocialismo. Tra i medici che collaborarono al programma ce ne furono alcuni che dovremmo annoverare tra gli "idealisti", per i quali si trattava di anteporre il bene della società al bene individuale. Come affermò il dottor Karl Brandt deponendo durante il processo di Norimberga: "La vicenda, così come il mio operato di medico, resta incomprensibile per l'individuo che si limiti a considerarla isolatamente. Il senso va cercato più in profondità: qui è in gioco la società. Se mi assumo un impegno verso la società, ne sarò responsabile per il suo bene" (Ricciardi, 2000).
Nella ricostruzione di tutta la vicenda fatta da Alice Ricciardi von Platen risulta che uniche forme di resistenza all'esecuzione del programma di eutanasia furono quelle di istituzioni psichiatriche gestite dalla Chiesa, sia evangelica che cattolica. Il numero dei medici che si opposero attivamente non fu elevato, così come furono relativamente pochi i convinti sostenitori del programma. La grande massa, sia dei medici che della popolazione, si lasciò guidare con inerzia. Purtroppo la popolazione non aveva compreso quale pressione avrebbe potuto esercitare con la propria opinione anche nello Stato nazionalsocialista, e come la strategia del terrore non potesse averla vinta di fronte a una protesta insistente. Ma la protesta, se si eccettua quella della Chiesa, non venne.
Il clima culturale e politico che aleggia oggi sulla nostra società non è quello totalitario. Coloro che ai nostri giorni sollevano il dibattito dell'eutanasia non hanno in mente le rozze argomentazioni dei biologi che consideravano i malati mentali come "psichicamente morti" e dei sociologi che li qualificavano come "pesi morti" e "parassiti". Oggi l'eutanasia viene rivendicata dai suoi paladini come un diritto, che fa capo all'autodeterminazione delle persone. Sarà bene non confondere i due problemi sotto un’unica etichetta, che mal si presta a includere gli uni e gli altri. Così appartiene più alla retorica che all'argomentare proprio dell'etica accusare i disegni legislativi finalizzati a regolamentare l'eutanasia di essere una riproposta dei metodi nazisti.
Una considerazione particolare merita il cammino fatto dall'Olanda nell'ambito del riconoscimento di una certa legittimità sociale all'eutanasia. L'Olanda ha una connaturata vocazione al pluralismo, al dibattito e alla tolleranza. Le tematiche bioetiche sono diventate un banco di prova per la capacità di questo paese di coniugare il non conformismo con la solidità sociale. Il rispetto per l'autonomia della coscienza si estende coerentemente alle scelte che dipendono da una definizione soggettiva di "vita eticamente buona". L'Olanda è stata una delle poche nazioni europee che ha decriminalizzato il suicidio e i tentativi di suicidio. Anche le comunità religiose hanno per lo più abbandonato il loro pubblico antagonismo in materia di prescrizione e di comportamenti morali, esercitando una pratica tolleranza di opinioni e di stili di vita divergenti. Pratiche quali l'aborto e la riproduzione artificiale hanno potuto essere difese alla luce del sole. Così è avvenuto per l'eutanasia. In Olanda tutto sembra possibile. O quantomeno tutto può essere detto, se non fatto.
La linea della tolleranza, del pluralismo e del rispetto di tutte le posizioni argomentate è stata messa a dura prova dalla questione dell'eutanasia. In Olanda sono emerse le tendenze più esplicite a far entrare l'aiuto attivo a porre termine a una vita che il soggetto ritiene non più desiderabile tra i comportamenti legalmente permessi. La pratica è relativamente diffusa tra i malati terminali, specialmente di AIDS. Tuttavia le informazioni relative a questa pratica spesso non sono attendibili. Nell'opinione pubblica mondiale sono diffuse semplificazioni sbrigative che presentano
254
l'Olanda come un Paese dove l'interruzione della vita su richiesta sarebbe praticata dai medici senza la minima esitazione morale. Ciò non corrisponde a verità.
In Olanda l'eutanasia su richiesta è diventato un intervento medico tollerato a partire da un caso giuridico del 1974, con cui un medico-figlia mise fine alla vita di sua madre, settantottenne e malata, iniettandole una dose letale di morfina. La tesi che le sofferenze dell'anziana signora fossero insopportabili fu accolta dal tribunale. Tra le autorità giudiziarie e la categoria professionale dei medici fu raggiunto un consenso circa le condizioni che assicurano una "prassi prudente" (presenza di una richiesta volontaria e persistente; sofferenze persistenti, insopportabili e irreversibili; consultazione con un collega medico; disponibilità di cartelle cliniche complete). Un regolamento amministrativo, entrato in vigore nel 1994, ha disposto una procedura di controllo di tutte le interruzioni di vita realizzate dai medici.
Gli sviluppi giuridici negli anni successivi e il raffinamento della regole che sovraintendono i comportamenti pratici ― due richieste su tre di morte mente assistita non vengono accolte ― hanno portato il Parlamento olandese ad approvare un Legge sull’eutanasia (novembre 2000), che integra le procedure e le norme in un quadro organico. La legge che l'eutanasia e la morte assistita vengano trattate in una sezione speciale del Codice Penale; i medici che osservano le norme di "prassi prudente" non commettono reato e non possono venire incriminati.
LA VOLONTÀ DI MORIRE
La principale spinta a voler legalizzare l'eutanasia, dandole una rilevanza giuridica alla volontà del malato di mettere dei limiti a quanto viene fatto per tenerlo in vita, è la paura di diventare vittima dell'ostinazione medica. È entrato nell'uso parlare a tale proposito di "accanimento terapeutico". La parola "accanimento" si rivela inappropriata per un duplice motivo. Nel suo significato peggiorativo (ancora una questione semantica sul nostro cammino...), evoca l'infierire sadico su di una vittima inerme. Con ragione i sanitari si ribellano al discredito che tale termine riversa sulla loro azione. D'altra parte, una certa forma di accanimento può positivamente essere richiesto e giustificato dalle esigenze terapeutiche: la vittoria sulla malattia domanda talvolta una lotta indefessa, con tutte le energie dell'intelligenza e della volontà. Forse è opportuno distinguere l'accanimento dall'ostinazione terapeutica, da considerare invece una deformazione del sano accanirsi a voler guarire.
Il medico che soggiace all'ostinazione considera come suo dovere esclusivamente quello di prolungare il più possibile il funzionamento dell'organismo del paziente, in qualsiasi condizione ciò avvenga, e ignorando ogni altra dimensione della vita umana che non sia quella biologica; trascurando soprattutto la qualità della vita che in tal modo ottiene e la volontà, esplicita o presunta, del paziente. Nei casi di ostinazione terapeutica, tenere in vita per qualche giorno o per qualche ora in più un paziente terminale diventa per il medico quasi un punto di onore. Il prezzo dell'ostinazione è una somma inenarrabile di sofferenze gratuite, tanto per il morente quanto per i suoi familiari. Questa situazione nuova del morire ha indotto a coniare un neologismo per qualificarla: distanasia, cioè una deformazione violenta e strutturale del processo naturale del morire, una volta che sia stato intensivamente medicalizzato.
Il fantasma del medico ostinato a prolungare la vita vegetativa induce alcuni a contrapporgli la rivendicazione di un "diritto a morire", che viene spesso interpretato come rivendicazione di un procedimento di eutanasia. Il dibattito sull'eutanasia non può che uscirne ulteriormente carico di equivoci. Il diritto a morire è in realtà una barriera frapposta al medico che soggiace alla libido sanandi e che non accetta la morte del paziente, in quanto vi vede la smentita delle sue fantasie inconsce di onnipotenza. Se non vogliamo trovarci costretti a difenderci dai medici,
255
bisogna che venga assimilato il principio che l'accresciuta disponibilità di mezzi terapeutici non crea con ciò stesso l'obbligo morale di utilizzarli.
Non sempre in medicina è lecito fare tutto quello che si è in grado di fare. Il ricorso all'etica si giustifica precisamente come una ricerca di aiuto per stabilire dei criteri di discernimento tra le diverse azioni possibili. Per cominciare dalla questione più fondamentale: affinché l'azione del sanitario sia moralmente buona, in quale considerazione deve tenere il desiderio soggettivo del paziente? Cercando di aprirci un sentiero tra gli equivoci terminologici e i fantasmi collegati all'eutanasia, ci imbattiamo nell'inequivocabile problema etico maggiore della vita a termine: la volontà di morire. Non sempre infatti la volontà intende ciò che le parole esprimono. Sollecitare la morte può significare un rimprovero rivolto a familiari e sanitari, o un disperato richiamo ad aspetti della propria situazione, come dolore fisico persistente o solitudine, che vengono disattesi. Ma non possiamo escludere che la volontà di morire possa essere anche una ricerca determinata di porre fine alla propria vita, che si manifesta nel modo più chiaro nella volontà di suicidarsi.
L'etica è chiamata in causa per chiarire l'obbligo di prevenire il suicidio. Esiste il dovere morale di salvare la vita di un altro essere umano contro la sua volontà? In questo caso entrano in conflitto due specie di obblighi: quello di difendere la vita e quello di rispettare la libertà, secondo il principio dell'autonomia personale; mentre il primo giustifica l'intervento, il secondo richiede la non interferenza (nel caso in cui si sia moralmente certi che la decisione suicidiaria è stata presa in effettiva libertà, e non sotto costrizione). Pensiamo, in concreto, al conflitto in cui viene a trovarsi un medico chiamato a fornire l'alimentazione forzata a un detenuto politico che abbia deciso lo sciopero della fame a oltranza, facendo così fallire la deliberata intenzione del suo gesto.
Solo poche voci isolate propongono il rispetto assoluto della volontà di suicidarsi come condizione per salvaguardare la dignità umana. Più generalmente, l'Occidente ha dato la preferenza all'obbligo di salvare la vita del suicida: in passato ricorrendo per lo più alle argomentazioni religiose che riferiscono il comandamento "non uccidere" anche alla vita del soggetto stesso; oggi prevalentemente con motivazioni secolari, ivi compreso il principio giuridico secondo cui il diritto alla vita va inteso come un diritto "assolutamente indisponibile", tutelato dallo Stato anche contro la volontà dell'individuo.
Con particolare mitezza si tende oggi a valutare i tentativi di porre fine alla propria vita da parte di persone che intendono sfuggire ai dolori intollerabili e ai trattamenti disumani nella fase terminale della malattia. Anche in questi casi non sussiste, almeno dal punto di vista dell'etica di ispirazione religiosa, alcun valido motivo per riformulare il giudizio morale che ritiene illecito ogni attentato contro la propria vita. Ma non dovremmo sentirci dispensati dal riflettere sul significato profondo di tali gesti suicidi, nei quali molto spesso si riversa una vibrata protesta contro le condizioni di vita a cui sono costretti i malati terminali. La prevenzione del suicidio non può ridursi allora alle misure coercitive. Deve estendersi piuttosto alla modifica di quelle forme più generali di malessere, le cui radici vanno fatte risalire all'organizzazione sanitaria del morire. Quando una persona giudica la propria vita come invivibile, non basta impedirgli di porvi fine: bisogna offrirgli l'aiuto necessario perché la sua vita ritrovi la qualità umana.
Appurato che si tratti di un vera volontà di morire, un'altra opera di discernimento è affidata all'etica: la distinzione tra la volontà sana e quella patologica. Non tutti accettano che possa esistere una sana volontà di morire. Per lungo tempo qualsiasi progetto autodistruttivo nei confronti della propria vita è stato etichettato come moralmente perverso. I comportamenti sociali verso i suicidi, comprendenti persino il rifiuto di esequie religiose, avevano una funzione prevalente di deterrente, affinché non si innescasse il fenomeno dell'imitazione; la valutazione morale era, in ogni caso, di condanna. A questo atteggiamento ha fatto seguito l'epoca dell'indulgenza, ma solo perché al gesto di chi si toglie la vita è stato conferito un carattere patologico. La conoscenza delle radici socio-psicologiche del comportamento suicida ha aperto la strada a
256
un atteggiamento di maggior comprensione. Peccato... depressione...: la volontà di morire non può essere coniugata anche con la salute, sia morale che mentale?
L’istinto naturale per la vita e l’obbligo morale di preservarla sono indubbiamente il punto di partenza dell’etica della vita fisica. Ma la volontà di morire non può essere esclusa in assoluto dal progetto di vita umano. Essa può esprimere la positiva accettazione della propria umanità, come essenzialmente limitata nel tempo. La fantasia dell’immortalità è legata all’io; talvolta ne esprime l’ipertrofia: in questo caso, è la fantasia di immortalità, non la volontà di morire, ad avere carattere patologico. Quando l’individuo lascia che si sviluppi anche la dimensione transpersonale, che trascende l’orizzonte dell’io, l’abbarbicamento alla vita corporea viene superato. A un certo livello di autorealizzazione la persona si apre a un'aspirazione mistico-unitiva con il lutto, anche al di fuori dell'esperienza formalmente religiosa.
La volontà di morire può avere anche un risvolto di ribellione all'idolatria della vita, caratteristica della cultura immanentista nella quale siamo immersi. Quando la vita fisica è considerata il bene sommo e assoluto, al di sopra della libertà e della dignità, l'amore naturale per la vita si tramuta appunto in idolatria. La medicina implicitamente promuove tale culto, organizzando la fase terminale come una lotta a oltranza contro la morte. Ribellarsi a tale organizzazione ― che per lo più espropria il malato di ogni autonomia, sottoponendolo ai rituali chirurgici e rianimatori dell'ostinazione terapeutica ― può essere anche un gesto di disobbedienza, mentalmente e moralmente sano. Dovremmo aspettarcelo soprattutto dal credente, che la fede ha reso libero dai miti (l'immortalità) e dagli idoli (la vita corporea sopra ogni altro valore).
SCEGLIERE UN MODELLO DI MORTE
Per dare forma al morire, più che di leggi e di norme etiche abbiamo bisogno di modelli. In misura maggiore di quanto amino ammettere i giuristi e gli esperti di etica, la vita morale delle persone si struttura modellandosi. Per quanto riguarda la morte, la varietà dei comportamenti che possono fungere da modello è enorme. Una raccolta di biografie curata da H.J. Schultz si limita a raccontare gli ultimi giorni di una quindicina di personaggi diversi, rappresentativi di varie culture ed epoche storiche: da Albert Schweitzer a Mozart, da Pascal a Seneca (Letzte Tage, 1983). Anche se in numero ridotto, questi racconti sono sufficienti a darci la misura della molteplicità di stili di morte esemplari. Forse nessuno di questi resoconti degli ultimi giorni interpella i nostri contemporanei come quello che riguarda Sigmund Freud. È noto che Freud morì per un cancro che gli fu diagnosticato nel 1923, a sessantasette anni. Sostenuto nelle sue decisioni da Max Schnur, il suo medico di fiducia, Freud affrontò con coraggio la lotta contro la malattia: fino al 1939, l’anno della sua morte, subì trentatré interventi chirurgici per far fronte alla devastazione progressiva causata da quello che egli chiamava "das Ungeheuer", cioè "il mostro". Sedici anni di lotta continua; finché il 21 settembre 1939, Freud convoca il dottor Schnur per dirgli: "Caro Schnur, lei si ricorda del nostro primo colloquio? allora mi ha promesso che non mi avrebbe lasciato in asso quando sarebbe giunto il momento. Ora è solo tormento e non ha più alcun senso". Lo stesso giorno, il 21 settembre, il dottor Schnur somministra al suo paziente, che finora ha sempre rifiutato ogni calmante, una forte dose di morfina e due giorni dopo Freud, senza svegliarsi, muore.
È una narrazione di morte che si colloca con naturalezza nel grande filone dello stoicismo, insieme a Seneca, Marco Aurelio, Epitteto (nonché di altri stoici nostri contemporanei). L'autodeterminazione della persona è il centro di gravità di questo modello. Freud mette in atto una strategia a lungo termine per attuare quello che ritiene un suo diritto: strutturare la propria morte. Dare alla propria vita e alla propria morte la forma e i limiti ritenuti più opportuni non
257
è una benevola concessione, ma un diritto del paziente, che equivale alla sua rivendicazione a essere soggetto. Ciò permette la personalizzazione della morte e del morire. La struttura della morte di Freud risponde ai suoi valori, in particolare a quello centrale della sua vita: la razionalità, il giudizio chiaro. Scriveva al fratello: "La vita non mi dà più gioia, da diversi punti di vista sono un relitto, ma sono in possesso delle mie facoltà intellettuali, lavoro ancora". E al dottor Schnur ha comunicato di non volere i calmanti affermando: "Preferisco pensare tra i tormenti che non pensare". La sua morte è stata coerente con la sua gerarchia di valori.
Può darsi che per un altro il valore dominante non sia quello di conservare l'uso della ragione, la lucidità fino alla fine, ma piuttosto di essere libero dal dolore. Per questo le morti, quando sono personalizzate, non si assomigliano le une alle altre. Un altro elemento importante che troviamo nel racconto della morte di Freud è la negoziazione con il medico. Il medico e il malato non sono due nemici, non prevaricano l'uno sull'altro; il medico non impone la sua etica, il malato non fa prevalere il suo punto di vista, ma si confrontano e trovano insieme, in maniera dialogica e negoziale, la giusta soluzione. Due posizioni diverse, ma non one up e one down: sono tutt'e due sullo stesso piano.
Nel sottofondo di questo modello riconosciamo i tratti caratteristici della modernità: il valore dell'individuo, la soggettività, il diritto all'autodeterminazione; in una parola l'Illuminismo. Può essere istruttivo confrontarci con la morte dell'"eroe culturale" dell'Illuminismo: Immanuel Kant. Lo scrittore inglese Thomas de Quincey, che aveva un’ammirazione sviscerata per Kant, ne ha lasciato una relazione accurata: Gli ultimi giorni di Immanuel Kant (1983). De Quincey ha scritto questa relazione nel 1827, quindi appena una ventina d'anni dopo la morte di Kant, che è avvenuta nel 1804, basandosi sulle relazioni di Vasiansky che aveva assistito Kant in tutta la fase terminale della sua vita. Anche qui troviamo il modello di una vita e di una morte dignitosa. Sono altamente rappresentati l'autodeterminazione individuale e lo stile di vita conforme ai valori personali.
Il racconto presenta anche un episodio singolare. Il vecchio Kant, che aveva anche enormi difficoltà a esprimersi ― Vasiansky interpretava le parole che Kant balbettava ― riceve il suo medico; questi vorrebbe che Kant si sedesse, ma il filosofo rimane in piedi. Racconta de Quincey, con le parole di Vasiansky: "Intanto continuava a tenersi in piedi, ma si vedeva che era sul punto di cadere a terra. Allora avvertii il medico, e ne ero ben convinto, che Kant non si sarebbe seduto, per quanto potesse soffrire rimanendo in piedi, finché non si fossero seduti i suoi ospiti. Il dottore sembrava dubbioso, ma Kant, che aveva udito quel che avevo detto, con uno sforzo prodigioso confermò la mia spiegazione del suo comportamento e pronunciò distintamente queste parole: 'Dio non voglia che io cada così in basso da dimenticare i doveri dell'umanità"'.
Certamente nel termine Humanität usato da Kant c’è il significato arcaico di "cortesia", "gentilezza"; ma non soltanto questo. C’è un riferimento ai doveri dell'umanità, doveri verso se stessi, ma anche doveri verso gli altri: esistono i doveri della co-umanità. La strutturazione della propria fine non è soltanto un diritto, ma comporta diritti e doveri. Per dirla con il vecchio Kant: Dio non voglia che noi strutturiamo la nostra vita ― e le decisioni di fine vita ― soltanto sul diritto, anche se sappiamo che il diritto di dare una forma personale alla vita e alla morte è stato acquisito dalla nostra cultura. Vorrebbe dire che saremmo caduti tanto in basso da dimenticare anche i nostri doveri nei confronti dell’umanità.
258
259
Siena, Santa Maria della Scala: Pellegrinaio
Domenico di Bartolo: Scena di morte
Già nel Trecento sembra che ci siano stati due pellegrinai: uno per gli uomini e uno per le donne. La scena di morte qui riprodotta è un particolare tratto dall'affresco Cura e governo degli infermi, della corsia degli uomini. Costituisce la fine del percorso della composizione ― da leggere da sinistra verso destra ― che raffigura i diversi trattamenti che fanno parte della cura dei malati. A sinistra è rappresentata l'accettazione di un nuovo paziente; al centro la diagnosi medica e un ferito, al quale il cerusico stesso lava i piedi; all'estremità destra dell'affresco troviamo la scena del morente, che riceve conforto ed esortazioni.
Il malato giace sotto una coperta, che gli lascia fuori solo la testa. È leggermente rivolto di lato e si rivolge a un monaco corpulento a lato del letto, con il desiderio di dire ancora qualcosa. Il monaco ha posto il piede sinistro sulla pedana, per avvicinarsi ancora di più al paziente. Appoggia il gomito sul ginocchio e sostiene il capo con la mano sinistra, mentre ascolta con il viso teso le ultime parole del morente.
Da sinistra due uomini stanno già portando una bara con un drappo nero, sul quale spicca il segno della Scala in oro. Quello che precede, un giovane dai riccioli biondi, distoglie lo sguardo dal capezzale e prende contatto visivo con l'osservatore. Questo espediente stilistico, spesso utilizzato nei cicli di affreschi del Rinascimento, permette all'osservatore di partecipare direttamente all'evento, in modo più immediato, poiché attraverso lo sguardo può entrare direttamente nella scena. Tuttavia per evitare un'associazione troppo stretta tra vita ospedaliera e morte, l'artista ha collocato la scena sullo sfondo, mentre in primo piano ha posto accessori narrativi, quali una lotta tra un cane e un gatto e un bacile di rame su un treppiedi con una brocca d'acqua e un asciugamano, con una precisione di dettagli che ricorda una natura morta. Lo stesso si può dire per gli oggetti allineati al capezzale del letto: due caraffe, una melagrana aperta, una scatola rotonda e un oggetto contenuto in una carta piegata, tutti rappresentati con le loro ombre.
Christina Riebesell
260
261
capitolo
22
RICERCA E TERAPIE SPERIMENTALI
NUOVE REGOLE PER LA RICERCA
Nessun argomento che si voglia portare contro la ricerca nella pratica medica può essere di tanto peso da delegittimarla e da indurci a bandirla dai nostri comportamenti. La ricerca può essere pericolosa ― sia per la salute del paziente che per i suoi diritti ma procedere senza alcuna ricerca è ancora più pericoloso. Anzi, propriamente una medicina che non si fondi sulla ricerca è irresponsabile.
Ciò non equivale, tuttavia, a un semaforo verde per qualsiasi tipo di ricerca. Consideriamo legittima solo quella che rispetta vincoli e procedure stabilite dalla comunità scientifica. A queste condizioni si aggiungono quelle di natura morale. Anche l'etica ha una voce in capitolo nell'ambito della regolazione della ricerca biomedica. Questa dimensione negli ultimi anni è diventata sempre più importante, fino quasi a monopolizzare il controllo della ricerca.
In occasione del dibattito pubblico relativo alla sperimentazione della "multiterapia Di Bella" anche le persone più estranee a protocolli, procedure, linee guida, norme deontologiche e comitati etici sono state confrontate ad alcuni aspetti vincolanti che ha oggi la ricerca in ambito biomedico. Nel decreto che autorizzava la sperimentazione veniva esplicitamente richiesto il "consenso informato" dei pazienti coinvolti e in occasione di un primo bilancio provvisorio ― quello relativo alla sperimentazione condotta in Lombardia su 300 pazienti ― venivano ufficialmente comunicati i costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale. Sono due dimensioni importanti della ricerca scientifica contemporanea, che meritano una considerazione attenta per le ripercussioni che hanno nei rapporti tra tutti gli attori coinvolti, in quanto innovano l'orizzonte tradizionale dei vincoli posti alla ricerca.
Gli scienziati hanno abitualmente amato sottolineare che la ricerca è un'attività che nasce e prospera nella libertà e ha come suo vincolo intrinseco il riferimento alla verità. La prima legittimazione della ricerca non sono le ricadute utili che ne possono derivare, bensì il suo orientamento al vero. Per questo la ricerca è per natura autonoma. Il che non vuol dire arbitraria; seguendo la traccia offerta dall'etimo di autonomia, la libertà da vincoli ("auto") è appaiata con la volontaria soggezione a leggi e regole ("nomos") e quindi con la possibilità e la necessità di confrontarsi con l'empiria. Il non dover rispondere a nessuno della propria ricerca va di pari passo con l'esigenza di rendere conto di essa alla comunità scientifica.
Le regole relative alla ricerca biomedica sono state elaborate soprattutto dall'Associazione medica mondiale, che è ritornata più e più volte sul tema con formulazione successive ("Dichiarazione sulle ricerche bio-mediche": Helsinki 1962; Helsinki 1964; Tokyo 1975), regolamentando
262
soprattutto la ricerca con gli esseri umani, più che la ricerca di base. La prima regola fondamentale alla quale è tenuta una sperimentazione è quella di avere il carattere di una vera ricerca scientifica: "La ricerca biomedica relativa agli esseri umani deve essere in conformità ai principi scientifici generalmente riconosciuti e deve essere basata sia su esami eseguiti in laboratorio o su animali in modo adeguato, sia su una conoscenza appropriata della letteratura scientifica". Viene così delegittimata una quantità di sperimentazioni semplicemente irrilevanti o inutili, per la buona ragione che sono già state fatte da altri. Purtroppo molte ricerche sono condotte senza obbedire a un progetto di conoscenza, ma semplicemente in ossequio alla legge che vige nel mondo accademico: to publish or to perish ("Pubblicare o soccombere"...). Per accumulare pubblicazioni, ai fini di carriera, si fanno ricerche che implicano disagio, sofferenze inutili e rischi per la salute di altri esseri umani.
Se confrontata con la prima regola a cui deve adeguarsi la ricerca biomedica, la sperimentazione della terapia Di Bella fa sorgere gravi perplessità. La sperimentazione è stata voluta dalla "piazza", sotto la pressione di una opinione pubblica abilmente surriscaldata dai mass media e guidata da un progetto politico. Per questo sono state scavalcate tutte le tappe abitualmente previste per avviare una sperimentazione. La stessa analisi dei risultati di efficacia, sulla base della documentazione clinica fornita dalle cartelle dei casi trattati con la cura sperimentata, è stata disponibile solo quando la sperimentazione ufficiale era stata avviata da alcuni mesi. La comunicazione di quei dati, fortemente negativi, rispondeva a un'esigenza etica di correttezza nei confronti dei malati che avevano scelto di seguire questa cura alternativa, ma era una chiara infrazione della metodologia stessa della ricerca. È vero che non tutto ciò che è utile è scientifico; ma attenersi alla scienza e al suo metodo può prevenire danni sicuri, che sopravvengono quando si tralascia una terapia di efficacia provata ― ancorché limitata ― per un trattamento di efficacia nulla.
Dopo la regola del controllo scientifico, la seconda restrizione alla libertà di ricerca riguarda il rapporto costi-benefici. Il primo costo da considerare è quello di un possibile danno alla vita, alla salute o al benessere del soggetto su cui avviene la sperimentazione. In linea teorica, i benefici di una ricerca sull'uomo devono essere proporzionali al rischio del danno che può essere inferto. Il codice di Norimberga (1946), sotto l'impressione traumatica delle sperimentazioni condotte durante il regime nazista, ha esplicitato il livello massimo di danno: nessun esperimento deve essere condotto quando può sopravvenire la morte o un'infermità invalidante. Ma anche il beneficio che ci si aspetta dalla sperimentazione pone dei limiti: non si dovrebbero fare esperimenti sull'uomo, il cui risultato prevedibile sia così piccolo da risultare banale. Sullo stesso tema rischi-benefici l'Associazione medica mondiale aggiunge due altre opportune indicazioni: "gli interessi del soggetto devono sempre prevalere su quelli della scienza e della società" e "il medico non deve intraprendere un progetto di ricerca, se non è possibile prevederne i rischi potenziali". Viene così contraddetta quella logica che ha condotto i ricercatori del passato a passare sopra ai diritti individuali, specialmente se si trattava di persone che si erano messe fiiori delle legge (il celebre scienziato e filosofo illuminista Pierre Louis Moreau de Maupertuis, nella sua Lettre sur le progrès de la science, del 1752, dichiarava: "Un essere umano è niente in confronto alla specie umana; un delinquente è meno di niente").
Il rapporto costi-benefici ai nostri giorni va considerato anche sotto l'aspetto dei costi economici. La ricerca biomedica impegna cifre considerevoli. Il rapporto ufficiale della Regione Lombardia relativamente ai 300 casi trattati sperimentalmente con il metodo Di Bella ha fornito la cifra di nove miliardi, a carico del Servizio sanitario nazionale. Il costo diventa un problema etico, oltre che economico, quando si consideri che tutti i sistemi sanitari pubblici si sono andati orientando negli ultimi anni verso la logica del budget. Ciò significa che la sanità è finanziata non sulla base della spesa effettiva ― programmata o reale, quale risultato dello splafonamento del tetto di spesa prevista ―
263
ma in base a un fondo negoziato in precedenza. Quanto viene fornito ai cittadini deve rigorosamente rientrare nella spesa preventivata, dal momento che non sono più previsti dei ripiani di bilancio a carico della collettività. Questo è il disegno della sanità pubblica, emerso dai Dlgs 502 del 1992 e 517 del 1993, che ha cominciato a entrare a regime dalla metà degli anni Novanta.
Questa prospettiva fa cadere una forte esigenza di rigore economico sulle sperimentazioni intraprese. Non si tratta di considerare se una vita ― qualsiasi vita ― valga o no una certa cifra di denaro, ma se la sperimentazione è stata intrapresa valutando che venivano impiegate risorse comuni e che quanto veniva utilizzato per questo uso era automaticamente sottratto ad altri usi. In parole povere, la sperimentazione è stata fatta togliendo qualcosa ad altri malati (se l’affermazione può sembrare grossolana, si consideri che il personale e le apparecchiature impiegate per seguire un progetto sperimentale non sono disponibili per altri malati, con il risultato di allungare le liste di attesa e di bloccare altri progetti di ricerca). I benefici sperati devono compensare i costi anche economici, se la ricerca vuol essere legittima dal punto vista dell'etica che sottostà alla vita civile.
IL CONSENSO DEL SOGGETTO ALLA SPERIMENTAZIONE
I due criteri che abbiamo finora valorizzato come guida per la ricerca non eccedono il livello dell'autoreferenzialità. La responsabilità nei confronti della scienza rimanda a un complesso di conoscenze metodologiche ― biostatistica, procedura sperimentale, criteri di randomizzazione, doppio cieco... ― che soltanto chi ha ricevuto la formazione necessaria per fare il ricercatore può possedere. È il motivo per cui nei comitati etici istituiti per valutare le ricerche i "laici" (rappresentanti, cioè, di altri saperi, senza essere essi stessi ricercatori biomedici) si trovano a svolgere un ruolo marginale o solo pleonastico, fino a che non pochi abbandonano volontariamente la frequenza a sedute di comitato in cui collezionano solo frustrazioni. Gli scienziati tollerano mal volentieri che la ricerca sia controllata da non scienziati. Il vincolo di un passaggio attraverso un comitato apposito per la ricerca (in inglese si chiama Institutional Review Board: è un organismo che esprime pareri sulla conformità delle ricerche programmate con le regole che tutelano i cittadini dalla possibilità di abuso e sfruttamento) contrasta con l'autoreferenzialità della scienza.
Una commissione creata negli Stati Uniti per analizzare il tristemente celebre Tuskegee Syphilis Study ― dal 1932 al 1973,600 braccianti negri dell'Alabama sono stati sottoposti a una ricerca per determinare gli effetti del corso naturale della sifilide, quando non venga curata ― ha formulato in modo tagliente questa regola: "La società non può permettere che l'equilibrio fra i diritti individuali e il progresso scientifico venga determinato unicamente dalla comunità scientifica". Anche l'Italia si è adeguata all'esigenza che la scienza non sia sottratta a forme di controllo della ricerca biomedica: in tal senso si muovono le "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici", emanate dal ministero della Sanità (G.U. n. 122, 28.5.1998). Tra le figure di non ricercatori di professione che vengono previste nei comitati che sopraintendono alla ricerca del decreto ministeriale c'è anche l’infermiere. La presenza di questa figura professionale è molto appropriata per garantire che si tengano in considerazione anche i valori e il punto di vista del soggetto sperimentale. Tuttavia l'effettiva traduzione in atto di tali comitati presuppone una tradizione di confronto democratico che è poco familiare alla cultura italiana e del tutto estranea al mondo medico.
Anche il secondo criterio ― il rapporto costi-benefici ― non arriva a costituire un limite estrinseco alla valutazione del ricercatore. È vero che oggi la ricerca biomedica è sempre meno rivestita di un'aura sacrale ed è soggetta a critiche animose. Ma continua a essere circondata da attese messianiche: quelli stessi che esprimono timori per le nuove conquiste, non esitano a invocare
264
più ricerca e progressi medici per combattere vecchie e nuove malattie. Non è, dunque, da questo orizzonte che poteva spuntare una vera limitazione alle attività di ricerca.
Nell'impianto regolativo della sperimentazione con gli esseri umani, elaborato nell'ultimo mezzo secolo, esiste in verità un terzo principio capace di limitare il potere del ricercatore: è quello che richiede il consenso di chi si sottopone alla sperimentazione. Il codice di Norimberga, essendo nato da una reazione a sperimentazioni effettuate su prigionieri, metteva fortemente l'accento sulla condizione del consenso. Si apre infatti con la dichiarazione: "il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale"; specifica poi tale volontarietà come capacità legale di dare il consenso e assenza di "elementi coercitivi, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione e violenza". In seguito la riflessione etica mise maggiormente in evidenza la necessità di comunicare tutti i fatti importanti al soggetto sperimentale, affinché questo possa prendere una decisione libera. Si venne così a parlare correntemente di consenso informato, considerato come una barriera invalicabile contro coloro che vorrebbero giustificare qualsiasi ricerca condotta sull'uomo su una base puramente utilitaristica, considerando i benefici che la ricerca può arrecare.
Il consenso informato si è andato sempre più accreditando come la principale legittimazione etica della ricerca biomedica. Le normative succedutesi nel tempo non hanno fatto che concedergli sempre maggiore rilievo. Così è ― per menzionare i due documenti di maggior rilievo a livello europeo ― nelle norme note come "Good clinical practice" ("Norme di buona pratica clinica nei trial su prodotti farmaceutici condotti nella Comunità europea", 1990; l’Italia ha recepito il documento della CEE con un decreto del ministero della Sanità del 1992; le norme sono state aggiornate nel 1997 e l'Italia le ha recepite con decreto del ministero della Sanità del 15.7.1997: "Recepimento delle linee-guida dell'unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali") e nella "Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina", nota come Convenzione europea sulla bioetica. Quest’ultima è stata approvata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea il 19 novembre 1997 e successivamente sottoposta alla firma degli stati membri del Consiglio d'Europa. La regola generale, relativa al consenso, formulata dell'art. 5, suona: "Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzi tutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".
Si deve tuttavia riconoscere che la rilevanza del consenso informato nella ricerca biomedica è più formale che sostanziale. Quantomeno ciò è vero nei Paesi e nelle aeree culturali nelle quali non è avvenuta una parallela rivoluzione che ha introdotto il consenso informato anche nella clinica. La clinica, infatti, è stata regolata per secoli da rapporti modellati in senso paternalistico: era il medico che decideva "per il bene del paziente", senza che esistesse un obbligo, né morale, né deontologico, di informare il paziente e di elaborare le scelte insieme a lui. Quando anche in medicina viene introdotta quella che è stata chiamata la "rivoluzione liberale", con il pieno riconoscimento dei diritti del soggetto, ivi compreso il diritto di fare scelte in medicina in conformità con i propri valori personali, l'informazione che passa tra gli attori sociali di un rapporto terapeutico diventa il pilastro centrale di una buona medicina. È illusorio pensare che si possa avere una ricerca ispirata al principio moderno e liberale del consenso informato, parallelamente a una clinica condotta in base a criteri premodemi di gestione paternalistica del rapporto. Un esempio può illustrare l'assunto.
Ce lo fornisce un articolo apparso nella Rivista italiana di psicologia oncologica nel 1991. Si tratta di una ricerca, condotta in un ospedale di Roma, su 50 pazienti affetti da carcinoma polmonare
265
inoperabile, sottoposti a chemioterapia antiblastica. La ricerca intendeva stabilire se i tre diversi regimi chemioterapici seguiti avessero una incidenza sulla qualità della vita dei pazienti. Attira l'attenzione l'annotazione relativa alla procedura seguita dallo studio: "La raccolta dei dati anagrafici e l'indagine psicodiagnostica sono state effettuate per tutti i pazienti prima dell'inizio della chemioterapia nei locali del Day hospital oncologico. Nessun paziente era a conoscenza della diagnosi né al momento della prima somministrazione, né al momento del follow up. I pazienti erano stati informati di avere una malattia grave di tipo infiammatorio che necessitava di cure intensive ed efficaci". Si può dire ― semplificando un po', ma senza allontanarci dal quadro realistico dell'informazione intercorsa tra sanitari e pazienti ― che a persone affette da una malattia a prognosi infausta, con scarse possibilità terapeutiche, era stata data la stessa informazione che giustificherebbe la somministrazione di un antibiotico a un malato di polmonite... L'impianto della ricerca ― lodevolmente attenta ai problemi non solo della quantità della vita che l'uno o l'altro protocollo terapeutico può assicurare, ma della qualità della vita guadagnata ― si scontra con il fatto macroscopico dell'esclusione dei pazienti da quella informazione sul loro stato che può renderli soggetti responsabili delle scelte.
Alcuni anni sono trascorsi dall'esecuzione di quella ricerca, che rispecchiava la cultura del rapporto medico-paziente e dell'informazione propria della tradizione, al decreto ministeriale che ha autorizzato la sperimentazione della "multiterapia Di Bella". Se per i primi due criteri di legittimità di una ricerca ― la sua conformità con la metodologia scientifica e la considerazione del rapporto costi-benefici ― abbiamo dovuto fare delle riserve critiche, possiamo invece registrare con soddisfazione l'esplicita richiesta del consenso informato contenuta nel decreto. Almeno formalmente, è stata recepita l'esigenza di rispettare la volontà del soggetto, informandolo della natura e dei limiti della sperimentazione. La garanzia che gli aspetti formali siano accompagnati da una partecipazione sostanziale la fornisce solo l'informazione che precede il consenso. Se le scelte avvengono nel clima emotivo ― sarebbe più appropriato chiamarlo isterico ― che ha accompagnato l'avvio della sperimentazione della terapia alternativa nella cura del cancro proposta da Di Bella, c'è motivo di credere che la razionalità dell'informazione data e di quella recepita sarà molto carente. Il consenso da solo, se non è abbinato a una informazione ragionata e ragionevole, è una ben fragile tutela del miglior interesse del soggetto sperimentale.
IL CONTROLLO SOCIALE
Nel giro di pochi anni è avvenuta una rapida crescita di consapevolezza che ha portato la società a chiedere trasparenza nell'ambito della sperimentazione di farmaci e procedure. La delega implicita che affidava ai terapeuti stessi il controllo della ricerca è stata revocata. Il dibattito sul carattere etico della ricerca, sottratto al monopolio della professione medica, ha coinvolto altri professionisti ― in primo luogo giuristi ed esperti di etica ― e progressivamente settori sempre più ampi della società. È iniziata così l'epoca ― per dirla con lo storico della medicina David Rothman ― che vede sempre più "estranei al letto del malato". Gli estranei diventano una piccola folla quando al letto del malato si fa della ricerca biomedica.
Un'eloquente esemplificazione della tendenza a porre dei limiti alla discrezionalità dei ricercatori è offerta dal dibattito intorno alla ricerca nota come Willowbrook Study. La prima menzione la troviamo in un articolo apparso nel 1966 nel New England Journal of Medicine, a firma di Henry Beecher. Questi era un anestesista di Harvard e del Massachusetts General Hospital; conosceva di prima mano la ricerca in medicina ed era paladino della sua importanza a servizio della società. Fu tra i primi a insistere sulla necessità di protocolli nella sperimentazione dei farmaci. Tuttavia, a metà degli anni Sessanta aveva cominciato a preoccuparsi per l'eticità del
266
modo in cui la ricerca clinica veniva abitualmente condotta. Temeva che una ricerca dubbiosa dal punto di vista etico avrebbe potuto far impugnare la legittimità della sperimentazione, portando così discredito al principale elemento di progresso in medicina. Gli stava a cuore che una cattiva etica non compromettesse il perseguimento di una buona scienza.
Beecher aveva cominciato a raccogliere esempi di quelle che considerava ricerche di dubbia eticità, traendole da specifici protocolli di ricerca pubblicati nelle riviste mediche. Nell'articolo pubblicato nel "NEJM" ne elencava 22. Era una selezione impressionistica, addirittura arbitraria, non derivante da un'indagine sistematica. Aveva però il vantaggio di riprodurre tipici protocolli di ricerca di punta in istituzioni che avevano la leadership nella ricerca biomedica nel ventennio che va dal 1945 al 1965, un periodo in cui i ricercatori hanno esercitato la più ampia discrezionalità.
In tutte le ricerche riportate da Beecher la salute e il benessere dei soggetti sperimentali erano messe in pericolo, senza che essi ne fossero a conoscenza e dessero la loro approvazione. Risultava che i pazienti ordinari non conoscevano i rischi per la loro salute, e talvolta per la loro stessa vita, a cui erano sottoposti per il bene della "scienza". Nell'elenco redatto da Beecher spiccava, al sedicesimo posto, la ricerca pediatrica condotta dal dottor Saul Krugman: il Willowbrook Study. Si trattava di un'infezione di epatite deliberatamente prodotta sui bambini che venivano ammessi nella scuola statale di Willobrook per bambini ritardati mentali, alla periferia di New York. Nella istituzione una forma blanda di epatite era endemica. Il dottor Krugman aveva disegnato una ricerca finalizzata a determinare il periodo di infettività dell'epatite e a studiare le risposte immunitarie spontanee. Per questo la induceva artificialmente su un gruppo di nuovi arrivati nell’istituto.
Va aggiunto che il dottor Krugman era un ricercatore che godeva di alto credito. Dopo le ricerche condotte a Willowbrook, dal 1956 al 1972, fu eletto presidente del Dipartimento di Pediatria della New York University. Nel 1972 ottenne un premio dalla Markle Foundation, con una citazione che lo elogiava per aver mostrato come una ricerca clinica deve essere condotta. Nel 1983 gli fu conferita anche l'alta onoreficenza del Lasker Prize.
L'intervento di Beecher fu mal recepito dalla comunità scientifica. Anche se egli aveva cercato di attenuare il tono del suo articolo, questo costituiva la rivelazione, portata davanti al grande pubblico, di procedure contestabili dal punto di vista morale seguite nelle ricerche con soggetti umani. Era quanto avveniva in vari ambiti della medicina, non esclusa la pediatria. Per un intervento censorio di questo genere l'americano usa l'espressione del linguaggio sportivo "blow whistler", che equivale al fischio con cui l'arbitro blocca un intervento falloso. Solo che in questo caso il dito veniva puntato non su procedure che avvenivano contro le regole del gioco, ma su un gioco che si svolgeva in assoluta mancanza di regole.
Per non demonizzare la sperimentazione di Willowbrook e non considerarla come frutto di cinismo e di insensibilità etica, bisogna ricollocarla nel contesto della ricerca scientifica nel periodo postbellico. La ricerca clinica è uscita dall'infanzia ed è entrata nell'adolescenza quando il progresso medico godeva di un primato assoluto. La generazione dei ricercatori che aveva operato durante la Seconda guerra mondiale era circondata di grande prestigio. I ricercatori erano considerati eroi nel laboratorio, così come i soldati lo erano sul campo di battaglia. La ricerca creava vaccini efficaci, test diagnostici, medicine miracolose come la penicillina. Nessuno avanzava dubbi o riserve sui metodi usati.
Dopo la guerra continuò la stagione d'oro della medicina. I ricercatori fornivano prodotti straordinari: una serie di antibiotici, che assicuravano anche una cura per la tubercolosi; vari farmaci che curavano le anomalie cardiache; una nuova comprensione dell'epatite. Nessuno sognava di mettere un freno a tanta genialità e creatività, intromettendosi nei laboratori per regolare i comportamenti dei ricercatori. L'orientamento era quello di dar fiducia ai ricercatori, attendendosi da loro in cambio un successo dopo l'altro. Se vogliamo nobilitare in senso filosofico tale orientamento, lo potremmo qualificare come "utilitarista": si trattava di promuovere il
267
maggior bene per il più grande numero di persone. Nessuno si poneva il problema dei costi, tanto meno di quelli etici.
È l'atteggiamento che intravediamo anche dietro la ricerca di Krugman. Egli era animato dalla convinzione che, se avesse potuto vincere l'epatite, avrebbe procurato il bene di un maggior numero di persone. Quello che faceva, provocando l'epatite, non lo sentiva come un abuso dei bambini. Non si sentiva certo affine agli sperimentatori nazisti, ma aspirava piuttosto a diventare un grande benefattore dell'umanità.
La ricerca era saldamente in mano ai ricercatori, i quali non ritenevano necessario chiedere il consenso ai soggetti sperimentali. Il fatto che molti di questi fossero incapaci di intendere e di volere ― come per definizione avviene nel caso dei bambini ― non cambiava la valutazione. Era solo un'ulteriore sottolineatura del diritto dei ricercatori di far valere il loro discernimento e di sostituire il loro giudizio a quello dei soggetti sperimentali. Questo è il contesto in cui negli anni Sessanta si cominciò a porre interrogativi sulla ricerca clinica, con alcuni ricercatori nel ruolo di "blow whistler".
La fondamentale modifica della situazione è costituita dall'entrata in scena della società. L'aspetto più vistoso della svolta è stata la creazione della Commissione nazionale (National Commission for the protection of human subject of biomedical and behavioral sciences), che ha lavorato dal 1974 al 1978. L'attività della Commissione è culminata nel Rapporto Belmont, che ha definito le linee fondamentali dell'etica della ricerca relativamente ai quattro nodi principali: i confini tra la ricerca biomedica e la pratica della medicina generalmente accettata; la valutazione del criterio rischi-benefici nel determinare quanto sia corretta la ricerca che utilizza soggetti umani; le linee-guida appropriate per la selezione dei soggetti sperimentali che partecipano a tali ricerche; la natura e la definizione del "consenso informato" nei vari ambiti della medicina.
La ricerca di linee-guida è stata proseguita ulteriormente dalla Commissione presidenziale, che è rimasta in carica dal 1980 al 1983. Il punto di arrivo è costituito da due importanti documenti: Protecting human subjects e Implementmg human research regulations. La sfida che ambedue le commissioni hanno assunto ― sintetizzata dallo storico della medicina Albert Jonsen nell'innovativo programma di "fare etica in pubblico" ― è stata vinta. È stato definito il terreno comune che meglio esprime la visione morale e i valori comuni delle società americana di oggi e sono state individuate le regole minime che vanno rispettate nella ricerca, affinché questa sia in armonia con la tutela dei soggetti, in particolare i soggetti deboli, e con la promozione dei diritti umani.
Nasce così ufficialmente la bioetica, quale lingua franca che permette di articolare un’etica razionale in una società laica e pluralista. La nuova disciplina non sostituisce l'etica medica, bensì si affianca a essa. Il suo punto di vista non si identifica con quello della professione medica e non si limita ai soli problemi che la pratica clinica può presentare alla coscienza del medico. Soprattutto la regolamentazione della ricerca è stato l'ambito in cui la bioetica ha dato le migliori prove di sé.
Un'altra acquisizione di questo periodo di riflessione etica è la distinzione tra la sperimentazione e la terapia. Viene messa in discussione l'equiparazione, fatta per lo più implicitamente, tra il medico e il ricercatore. Conseguenza pericolosa di tale equiparazione è che la fiducia che il paziente ha nei confronti del medico tende a essere estesa anche al ricercatore, per il fatto che si tratta della stessa persona. Terapia e ricerca sono invece da considerare come due attività differenti nei loro procedimenti, nei loro scopi e nei loro fini immediati. Per il medico in quanto terapeuta l'interesse immediato è costituito dal bene del paziente e gli obblighi etici ruotano attorno al bene del paziente, da favorire in ogni modo. Il ricercatore ha invece come fine quello di far avanzare la scienza, a beneficio della società. I suoi obblighi lo vincolano al protocollo, piuttosto che verso i singoli soggetti del protocollo.
Si è così evidenziata la tendenza ad accettare un "doppio standard" etico: uno per l'intervento
268
curativo (che include, eventualmente, la ricerca terapeutica) e uno per la ricerca non terapeutica. Nel primo caso prevalgono i valori promossi dalla tradizione ippocratica, che è sostanzialmente autoritaria e paternalistica. Essa riserva al medico la tutela del bene del paziente (il medico agisce per il bene del paziente, secondo la formulazione classica che ne hanno dato Pellegrino e Thomasma, 1992). L"'alleanza terapeutica" che si stabilisce tra il medico e il paziente è per lo più implicita; grazie a essa, il medico è autorizzato dal paziente a intraprendere qualsiasi cosa egli ritenga possa risolversi nel bene del paziente.
Relativamente alla ricerca non terapeutica (non intesa, cioè, a portare beneficio al singolo individuo che è oggetto della sperimentazione), la riflessione etica dell'ultimo ventennio ha portato a un consenso sulla necessità che venga soggetta a restrizioni. Tra queste la principale è la clausola del rispetto dell'autonomia del paziente. Il soggetto sperimentale deve essere messo in grado, tramite un'informazione appropriata, di decidere se partecipare o no alla ricerca.
Questa prospettiva rende evidente che la ricerca non debba essere considerata come "implicita" nella domanda iniziale con cui il malato cerca l'aiuto del medico. Secondo la ricostruzione storica che Michel Foucault fa della nascita della clinica, avvenuta a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, la ricerca era invece tacitamente contenuta nella istituzione stessa dell'ospedale: questo permetteva alle classi meno abbienti di beneficiare dei progressi della medicina, ma domandava loro in cambio di contribuire al progresso della scienza offrendosi come oggetti di ricerca nelle istituzioni cliniche (Foucault, I960). La bioetica contemporanea, invece, promuovendo la pratica del "consenso informato", richiede una nuova formulazione del contratto terapeutico, mediante cui il "consenso sociale" sull'utilità della ricerca non terapeutica si traduca in un esplicito "consenso individuale". Per esprimerci con le parole di Giulio Maccanaro: "La scienza e la medicina non hanno diritto di scegliere i martiri della società. Ma nemmeno la società ha diritto di scegliere i martiri della scienza".
LA RICERCA CON I BAMBINI
Le linee-guida che, sotto la spinta del movimento bioetico, si sono andate imponendo non sono, di per sé, modellate sui bambini quali soggetti sperimentali. Presuppongono dei soggetti adulti, con normali capacità mentali, informati e consapevoli. Dalle ricerche vengono esplicitamente escluse donne incinte e persone la cui libertà sia compromessa (malati gravi, reclusi, persone in disperato bisogno di denaro). E naturalmente i minori.
L'argomentazione per giustificare ricerche biomediche condotte sui bambini è che, dal punto di vista fisiologico, i bambini non sono puramente dei "piccoli adulti". Molti farmaci, per esempio, producono effetti completamente diversi negli adulti e nei bambini. Se non sono condotte ricerche accurate sulle reazioni pediatriche a tali farmaci, i bambini rischiano di ricevere dosi troppo basse (e quindi inefficaci) o troppo alte (e quindi tossiche). Inoltre la ricerca si deve occupare anche di bambini non affetti da patologie, al fine di accrescere le conoscenze sullo sviluppo normale (in riferimento ― per fare qualche esempio ― alla resistenza alle malattie, oppure ai bisogni nutrizionali).
Riferendoci alla distinzione tra ricerca terapeutica e non terapeutica, la particolare condizione dei bambini fa sorgere problemi etici peculiari. Mentre per la ricerca terapeutica ― quella cioè condotta avendo di mira il beneficio del bambino che vi partecipa ― è facile presumere che i genitori siano autorizzati a dare il loro "consenso informato" al posto del bambino (così come avviene per i trattamenti curativi: la ricerca terapeutica, infatti, può essere sostanzialmente assimilata alla terapia), interrogativi notevoli sorgono per la ricerca non terapeutica. È accettabile che i genitori diano il consenso anche per questo tipo di ricerca?
269
Due posizioni contrapposte si sono evidenziate tra gli esperti di bioetica. Una risposta negativa è stata data da Paul Ramsey. A suo avviso, la ricerca pediatrica non terapeutica non può essere giustificata eticamente, in quanto nessuna sperimentazione può essere fatta senza il consenso del soggetto sperimentale, e i genitori non possono prendere decisioni che non siano direttamente finalizzate al bene del figlio, di cui hanno la cura e la responsabilità.
Sul polo opposto si colloca invece Richard McCormick. Quando la ricerca pediatrica non terapeutica comporta rischi minimi, mentre promette un beneficio sostanziale a molti altri bambini, può essere autorizzata. Il fondamento di tale tesi McCormick lo cerca non nell'utilitarismo, ma in una visione sociale della natura umana. Tutti i membri della società sono interdipendenti e hanno perciò un minimo di doveri morali gli uni nei confronti degli altri. Anche i bambini, come membri della società, hanno un tale obbligo e, analogamente agli adulti, devono promuovere il bene sociale. Ciò legittima i genitori a dare un consenso (proxy consent) perché partecipino a ricerche che includano un rischio minimo.
Le due posizioni possono essere esemplificate prendendo in considerazione un caso ipotetico. Immaginiamo che un ricercatore progetti di prelevare piccoli campioni di sangue da neonati per cercare di capire perché tali bambini sono naturalmente immuni da certe malattie. Supponiamo anche che lo scopo del ricercatore sia quello di sviluppare, a lungo termine, un vaccino contro la polmonite da utilizzare a vantaggio dei neonati. Dal momento che la ricerca non è diretta a procurare il beneficio immediato dei neonati a cui viene prelevato il sangue, non sarebbe moralmente accettabile, secondo la prospettiva di Ramsey. Dal punto di vista di McCornick, invece, la ricerca ricadrebbe entro l'ambito di ciò che i neonati sono "tenuti" a fornire alla società, cosicché la ricerca potrebbe essere considerata moralmente corretta.
Come si intuisce, una posizione è più sensibile alla protezione del bambino da ogni possibile prevaricazione, mentre l'altra è più rivolta alla promozione della ricerca scientifica, necessaria per una medicina di qualità. Le linee-guida pratiche devono cercare di integrare le due preoccupazioni. Una solida base di consenso è possibile. Lo dimostrano le linee-guida elaborate dall'Associazione pediatrica britannica (1980).
Può essere utile, a conclusione, riportare le quattro premesse che, secondo tale documento, possono essere accettate universalmente come base per elaborare regole più dettagliate:
― la ricerca che implica i bambini apporta importanti benefici a tutti i bambini; deve essere sostenuta e incoraggiata, e condotta in modo etico;
― la ricerca non deve mai essere fatta sui bambini se la stessa ricerca può essere fatta su adulti;
― la ricerca che implica un bambino e non porta un beneficio a questo bambino (ricerca non terapeutica) non è necessariamente contraria all'etica o alla legge;
― il grado di beneficio che risulta dalla ricerca deve essere stabilito in rapporto al rischio di disturbo, disagio o dolore (rapporto rischio-beneficio).
270
271
quarta parte
LE RISORSE PER LO STUDIO DELLA BIOETICA
272
273
Siena, Santa Maria della Scala: Pellegrinaio
Lorenzo di Pietro: Sogno della madre del beato Sorore
Non siamo in grado di dare una risposta univoca alla questione dell'origine del nome di Santa Maria della Scala per l'ospedale di Siena. Sono stati fatti diversi tentativi per risalire alla sua genesi. Uno di questi fa riferimento al luogo in cui si trova: la piazza davanti ai gradini che conducono al duomo.
Un'altra spiegazione fa risalire il nome alla leggenda della fondazione. Essa racconta di un sogno fatto dalla madre del leggendario fondatore, il beato Sorore. Nel sogno appariva una scala che il figlio che ella stava per partorire avrebbe salito fino al cielo, per arrivare alla Madonna. Questo figlio, cresciuto nella devozione, cominciò ad aprire la sua capanna ai pellegrini che andavano a Roma e ad altri bisognosi. In questa attività ricevette l'aiuto dei canonici, così che l'ospizio cominciò a crescere rapidamente. Presto ci fu la necessità di una nuova costruzione. Nello scavarne le fondamenta furono trovati tre bellissimi gradini di marmo, che il beato Sorore interpretò come simbolo della Trinità e scelse come emblema della sua istituzione. Abbiamo così una terza spiegazione del nome della Scala. Infine Sorore, ciabattino di professione, indossò l'abito degli agostiniani e visse come devoto religioso.
Come avviene in molte leggende di fondazioni e di vite di santi, anche qui si rimanda a un sogno, quello della madre prima della nascita. La leggenda sembra risalire alla fine del XIV secolo. Nel Quattrocento essa venne perfezionata e ampliata: la vita del ciabattino Sorore, la cui morte sarebbe avvenuta nell'anno 898, venne inventata fin nei dettagli più pittoreschi. La sua immagine viene creata in quadri e statue e si fece perfino redigere la sua biografia ufficiale da fra' Gregorio Lombardelli. In questo modo la confraternita ebbe ciò di cui aveva più urgente bisogno: un fondatore laico indipendente dai canonici. Essa legittimava così la sua pretesa di dirigere e amministrare l'ospedale.
La scena qui rappresentata modifica tuttavia la leggenda. Non è il fondatore che sale la scala celeste, bensì i nudi trovatelli, che vengono accolti dalla Madonna, in segno della loro salvezza. La raffigurazione del sogno è collocata all'interno di una basilica a tre navate e avviene alla presenza di molti religiosi e notabili laici, pieni di stupore. Il sogno miracoloso della madre del leggendario fondatore diventa così il miracolo della salvezza dei trovatelli, attribuito alla benefica istituzione. Il fondatore Sorore non è però scomparso dalla raffigurazione: egli è inginocchiato davanti alla scala e racconta il sogno ai convenuti. Con l'indice destro si tocca la fronte, facendo così intendere che la scena della scala è una visione.
Christina Riebesell
274
275
I COMITATI NAZIONALI PER LA BIOETICA
La necessità di approfondire il dibattito sui problemi etici suscitati dai progressi delle scienze biomediche ha da tempo suggerito ai governi delle singole nazioni, così come alle più importanti istituzioni sovranazionali, la creazione di comitati per la bioetica. La tipologia di tali comitati ― definiti di primo livello o, a seconda delle realtà in cui si costituiscono, centrali, nazionali, federali o sovranazionali ― è duplice:
1. possono essere comitati permanenti (come, per esempio, il Comitato nazionale per la bioetica in Italia, i cui componenti e le cui cariche subiscono periodici rinnovamenti ma la cui esistenza è costante). La loro funzione è di supporto alle decisioni dei legislatori attraverso l'elaborazione di pareri o linee-guida sui più diversi argomenti che la realtà della biomedicina pone all'attenzione della comunità e al vaglio della bioetica;
2. la seconda modalità di organizzare un tavolo di esperti intorno a problemi di bioetica è rappresentata dall’istituzione dei cosiddetti comitati ad hoc.
Come appare dalla loro stessa denominazione, i comitati del secondo tipo vengono istituiti con uno specifico mandato, allo scopo di approfondire i dilemmi etici su specifiche questioni; permangono in attività a tempo determinato, sino cioè al momento dell'elaborazione di un documento che esprima il parere del comitato sul problema che è all'origine della discussione (e per il quale il comitato stesso è stato costituito). Questi comitati "a tempo" hanno fornito in passato grandi contributi al dibattito bioetico su svariati temi e molti di essi hanno svolto un ruolo fondamentale nella produzione normativa di diversi Paesi.
Sebbene la tendenza attuale sia quella di creare comitati permanenti, non possiamo trascurare il ruolo svolto da alcuni comitati ad hoc, tra i quali ricordiamo in particolare la Commissione nazionale statunitense (1974-1978), creata su decisione del Congresso presso il Dipartimento federale per la salute, l'educazione e il benessere con la denominazione ufficiale di National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Sciences. La Commissione era chiamata a pronunciarsi su quali fossero i principi etici fondamentali che devono regolare le ricerche biomediche e quelle relative all'ambito delle scienze comportamentali. La riflessione doveva avere quale naturale punto d'arrivo l'elaborazione di linee-guida in grado di concretizzare e quindi rendere applicabili, per gli operatori impegnati nella pratica quotidiana della ricerca, gli orientamenti etici affermatisi nel corso del lavoro della Commissione.
L'importanza di tale lavoro è oggi universalmente riconosciuta: la riflessione intorno ai quattro temi intorno ai quali si è sviluppata l'attività degli esperti (confini tra ricerca biomedica e pratica
276
della medicina comunemente accettata; valutazione del criterio rischi-benefici per la valutazione di correttezza delle ricerche che includano soggetti umani; linee-guida per la selezione dei soggetti che partecipano a ricerche sperimentali; natura e definizione del consenso informato nei vari ambiti della ricerca) ha portato alla redazione del documento ― punto di riferimento anche oggi obbligato per la bioetica ― meglio conosciuto come Belmont Report (dal Belmont Conference Center della Smithsonian Institution, dove del documento vennero presentate le linee fondamentali, in attesa della definitiva pubblicazione, nel 1978).
Un altro esempio di lavoro importante e proficuo realizzato da un comitato ad hoc è rappresentato dalla Commissione presidenziale nominata dal presidente Ronald Reagan e attiva dal 1980 al 1983. Come per la precedente commissione, i suoi compiti erano essenzialmente di consulenza per l'attività legislativa e amministrativa. Ben più larghi, tuttavia, gli ambiti di interesse: dalla ricerca alla bioetica clinica, dalla definizione di morte alle fasi di inizio della vita, sino alle questioni etiche legate alla genetica. Il risultato dell'attività della Commissione presidenziale si è tradotto in una imponente mole di pubblicazioni che occupano un intero ripiano dello scaffale di una biblioteca e che sono ancora oggi considerate un punto di riferimento insostituibile per i cultori della bioetica.
In Europa si segnala l'attività della Commissione Warnock, istituito in Gran Bretagna dal Parlamento e incaricata di approfondire i problemi della fertilizzazione in vitro (1984). Proprio all'attività della Commissione britannica si deve la proposta del limite di 14 giorni per fare ricerca sull'embrione, da cui la disputa ancora oggi accesissima sulla definizione, per tale embrione, di pre-embrione (con tutto ciò che ne consegue riguardo al suo statuto e alla sperimentazione cui può essere sottoposto).
I comitati nazionali, invece, pur nelle molteplici diversità che li contraddistinguono, presentano la comune caratteristica di appartenere al novero dei cosiddetti comitati permanenti. Tra questi, in Europa, si distingue ― per prestigio, anzianità di istituzione ed efficacia organizzativa ―, il Comitato francese.
Dal dicembre 1983, quando è stato insediato, a oggi, il Comitato consultivo nazionale di etica per le scienze della vita e della salute ha elaborato "pareri" (avis) proposti con analoga efficacia e autorevolezza sia alle autorità deputate a legiferare, sia alla popolazione. La finalità esplicita del lavoro del Comité è rivolta ai problemi morali correlati alla ricerca negli ambiti della biologia e della medicina. La pratica medica al di fuori della ricerca ne è esclusa, ma ciò non limita la ricchezza e la varietà degli argomenti approfonditi nei diversi avis.
Il modello di elaborazione del parere è costante: inventario degli aspetti scientifici; analisi delle opinioni etiche e degli aspetti giuridici; considerazioni sulle conseguenze; direttive proposte. I criteri di rinnovamento dei 36 membri del Comité sono stati previsti sin dal momento della sua istituzione: metà dei membri è sostituita ogni due anni, in modo che la totalità dei componenti è completamente rinnovata ogni quattro. La "freschezza" che ne deriva è accentuata dalla vitalità di un dibattito alimentato dalla rappresentanza istituzionalizzata delle principali "famiglie spirituali" presenti nella società francese: cattolici, musulmani, ebrei e marxisti.
Circa la capacità di diffondere il risultato del proprio lavoro, basti considerare le iniziative che il Comité ha intrapreso in tal senso: attraverso l'attività di un centro di documentazione vengono pubblicate una lettera di informazione trimestrale sulle attività del Comitato; una bibliografia semestrale su etica e scienze della vita; la rassegna stampa mensile "Éthique". Sempre da parte del Centro di documentazione, viene messa a disposizione la banca-dati informatizzata dei dati bibliografici.
Ma ancor più efficace, per la diffusione tra la popolazione dei risultati del lavoro del Comitato francese, appare l'organizzazione contemporanea in'diverse città delle Giornate annuali di etica, ove la cittadinanza è invitata a partecipare a dibattiti pubblici sui temi oggetto di riflessione
277
e di pareri da parte del Comitato stesso. Appare un modo incisivo di adempiere a una delle funzioni istituzionali del Comitato: contribuire a una presa di coscienza da parte della società intera circa i problemi della bioetica.
Non solo in Francia hanno trovato vita comitati permanenti nazionali di bioetica. Non sempre tuttavia negli altri paesi d’Europa essi sono sorti con analoghe finalità, modalità organizzative e sfere d’azione. Un esempio di tale diversità viene dalla Gran Bretagna, dove l’iniziativa di dar vita a un Comitato nazionale non è partita da organi politici ma dalla British Medical Association, in particolare dal suo Comitato di etica medica, successivamente denominato National Ethical Research Committee, che ha sancito con due deliberazioni del 1984 e del 1986 la costituzione del vero e proprio Comitato nazionale di bioetica, prevalentemente impegnato sul fronte dei problemi etici legati alla ricerca clinica biomedica.
In Portogallo esiste un Consiglio nazionale di etica e di deontologia medica, strettamente legato a un Centro di bioetica portoghese, entrambi riconosciuti dal governo. Dal 1990, tuttavia, il governo ha istituito un Consiglio nazionale di etica per le scienze della vita che, per organigramma, modalità di elezione del presidente e dei membri e numero di partecipanti, appare più simile ai Comitati nazionali di stampo francese.
Sorprende, in un paese ricco di prestigiosi studiosi e di rinomati centri di bioetica come la Spagna, l’assenza di un Comitato nazionale istituito dal governo. Numerose sono tuttavia le commissioni ad hoc che provvedono a supportare con pareri qualificati l’attività di normazione giuridica.
Lo stesso non si può dire per la Danimarca, che vanta un Comitato nazionale sin dal 1979 (Central Research Ethics Committee), dapprima organizzato su base volontaristica, successivamente (dal 1992) provvisto di statuto e autorità specifici, con il compito di coordinare i comitati etici locali e fornire supporti decisionali in casi dubbi. Non solo: dal 1988 è sorto un secondo Comitato nazionale (Danish Council of Ethics), il cui lavoro è dedicato ai problemi etici inerenti le attività dei servizi sanitari e le ricerche biomediche su soggetti umani.
Comitato nazionale per la bioetica
Via Veneto 56 ― Roma
telefono 06/481611 (centralino), 06/48161490-91-92, 06/4819944, 06/4819946
fax 06/48161493
e-mail cnbioetica@palazzochigi.it
In Italia la nascita del Comitato nazionale per la bioetica ha rappresentato un'occasione di conflitto tra la bioetica cattolica e quella laica. Questa ipoteca storica, che rimanda il pensiero alle dispute accanite che già secoli or sono dividevano il campo in guelfi e ghibellini, non ha mancato di far sentire i propri dannosi effetti sul dibattito etico, spesso paralizzato da una contrapposizione "muro contro muro" tra i due schieramenti, che ha portato a frequenti e prolungate fasi di paralisi legislativa su argomenti anche molto importanti. Nell'ambito specifico della storia del Comitato nazionale italiano, si possono riconoscere i segni della stessa conflittualità sin dai primi vagiti del neonato, primo Comitato (costituito presso il ministero della Sanità nel 1989): nei pochi mesi di vita successivi all'insediamento, la composizione, ritenuta troppo sbilanciata sul versante "confessionale", fu capace di suscitare una reazione così energica da favorire l'immediata costituzione di un contraltare laico al Comitato: la Consulta di bioetica.
Si considera come convenzionale data di nascita dell'attuale Comitato nazionale per la bioetica il 28 marzo 1990. Il relativo decreto del presidente del Consiglio gli conferiva i caratteri di uno strumento pre-legislativo a disposizione della presidenza del Consiglio, costituito da 40 membri, esperti in diverse discipline (biologiche, giuridiche, medico-legali, filosofiche), che restano
278
in carica per tre anni. Il suo ruolo è quello di dibattere pubblicamente i problemi etici che nascono dalla pratica delle scienze biomediche, alla ricerca di una base di consenso per le normative che devono regolare la materia.
Tra i suoi compiti istituzionali: elaborare un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo delle scienze della vita e della salute dell'uomo; formulare pareri e indicare soluzioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi etici e giuridici che emergono con il progredire delle ricerche; prospettare soluzioni per le funzioni di controllo volte alla tutela della sicurezza dell'uomo e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico; promuovere la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati; favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica.
Appare evidente, quindi, un orientamento che privilegia la valutazione dei problemi etici nella ricerca medica e nelle pratiche sperimentali della biologia e della genetica. Si delinea tuttavia il rischio di sconfinamento nel campo della deontologia professionale e il limite rappresentato da un pluralismo ideologico non pienamente realizzato per assenza di regole istituzionalmente definite al riguardo. La scarsa leggibilità dei documenti e la loro insufficiente diffusione rappresentano altri aspetti su cui si potrebbe efficacemente lavorare in senso migliorativo.
Ciò non ha impedito, tuttavia, ai Comitati che si sono succeduti sino a oggi ― sotto le presidenze di Adriano Bompiani, Adriano Ossicini, Francesco D'Agostino e Giovanni Berlinguer ― di impegnarsi a fondo nella produzione di documenti su un'ampia area di argomenti. I titoli dei documenti prodotti in dieci anni di attività lo dimostrano, testimoniando, con la vastità degli ambiti raggiunti, quello che può essere considerato un punto di forza della bioetica italiana.
Documenti pubblicati dal Comitato nazionale per la bioetica
Terapia genica (15 febbraio 1991)
Definizione e accertamento della morte nell'uomo (15 febbraio 1991)
Problemi della raccolta e trattamento del liquido seminale umano per finalità diagnostiche (5 maggio 1991)
Documento sulla sicurezza delle biotecnologie (28 maggio 1991)
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali (6 settembre 1991)
Bioetica e formazione nel sistema sanitario (7 settembre 1991)
Donazione d'organo a fini di trapianto (7 ottobre 1991)
Comitati Etici (27 febbraio 1992)
Informazione e consenso all'atto medico (20 giugno 1992)
Diagnosi prenatali (18 luglio 1992)
Rapporto al presidente del Consiglio sui primi due anni di attività del Comitato nazionale per la bioetica (18 luglio 1992)
La legislazione straniera sulla procreazione assistita (18 luglio 1992)
La sperimentazione dei farmaci (7 novembre 1992)
Rapporto sulla brevettabilità degli organismi viventi (19 novembre 1993)
Trapianti di organi nell'infanzia (21 gennaio 1994)
Bioetica con l'infanzia (22 gennaio 1994)
Progetto Genoma Umano (18 marzo 1994)
Parere del CNB sulle tecniche di procreazione assistita ― Sintesi e conclusioni (17 giugno 1994)
La fecondazione assistita ― Documenti del Comitato nazionale per la bioetica (17 febbraio 1995)
Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana (14 luglio 1995)
Bioetica e ambiente (21 settembre 1995)
Le vaccinazioni (22 settembre 1995)
Parere del CNB sull'eticità della terapia elettroconvulsivante (22 settembre 1995)
279
Bioetiche a confronto ― Atti del seminario di studio (20 ottobre 1995)
Venire al mondo (15 dicembre 1995)
Il neonato anencefalico e la donazione di organi (21 giugno 1996)
Identità e statuto dell'embrione umano (22 giugno 1996)
Pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica su "Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina" e "Bozza preliminare di dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani" (21 febbraio 1997)
Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi (8 luglio 1997)
Infanzia e ambiente (18 luglio 1997)
Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente non consanguineo (17 ottobre 1997)
La clonazione (17 ottobre 1997)
La gravidanza e il parto sotto il profilo bioetico (17 aprile 1998)
Il suicidio degli adolescenti come problema bioetico (17 luglio 1998)
Etica, sistema sanitario e risorse (17 luglio 1998)
La circoncisione: profili bioetici (25 settembre 1998)
Il problema bioetico della sterilizzazione non volontaria (20 novembre 1998)
Dichiarazione per il diritto del bambino a un ambiente non inquinato (24 settembre 1999)
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla proposta di moratoria per la sperimentazione umana di Xenotrapianti (19 novembre 1999)
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sul protocollo europeo sulla ricerca biomedica (19 novembre 1999)
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sul Libro Bianco del Consiglio d'Europa dedicato al trattamento dei pazienti psichiatrici (19 novembre 1999)
Orientamenti bioetici per i test genetici (19 novembre 1999)
Dichiarazione del CNB sulla possibilità di brevettare cellule di origine embrionale umana (25 febbraio 2000)
Protezione dell'embrione e del feto umani. Parere del CNB sul progetto di protocollo del Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa (31 marzo 2000)
Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sull'impiego terapeutico delle cellule staminali (27 ottobre 2000)
Psichiatria e salute mentale: orientamenti bioetici (24 novembre 2000)
Da segnalare l'iniziativa di istituzionalizzare l'insegnamento della bioetica nelle scuole attraverso una convenzione con il ministero della Pubblica istruzione. Un gruppo paritetico, costituito da quattro esponenti del ministero e quattro rappresentanti del CNB, è al lavoro a tale scopo. Il gruppo, aperto ai contributi del Forum della associazioni dei familiari e degli stessi insegnanti e alunni, dovrà individuare argomenti, contenuti e modalità dell'insegnamento. L'iniziativa, pur difficile per la molteplicità di voci e interessi culturali coinvolti, promette di rappresentare una svolta nell'impegno comune a promuovere presso le nuove generazioni l'interesse verso il dibattito sui temi della bioetica.
Anche con il ministero della Sanità il CNB ha stipulato una convenzione per sviluppare iniziative comuni a favore degli operatori del Servizio sanitario nazionale, volte a promuovere la conoscenza dei problemi etici che scaturiscono dai progressi della medicina. Le aree di intervento sono:
― ricerca didattica sulle modalità di approccio alle problematiche bioetiche;
― introduzione delle questioni afferenti alla bioetica nella promozione continua degli operatori sanitari;
― produzione di materiali per la formazione a distanza degli operatori.
280
281
capitolo
4
I CENTRI DI BIOETICA IN ITALIA
istituto di bioetica dell'università cattolica del sacro cuore
Largo F. Vito 1 ― 00168 Roma
telefono 06/30154960, 06/30154205, 06/30155861
fax 06/3051149
e-mail cdb@uni.net
sito internet: www.uni.net/cdb
Ispirato al "personalismo ontologicamente fondato", che trae origine dal pensiero del teologo medievale Tommaso d'Aquino, rappresenta il centro di riferimento della bioetica cattolica. Le sue finalità istituzionali sono di ricerca (approfondire l’attività di ricerca a livello interdisciplinare ― scientifico, filosofico, giuridico ecc. ― sui problemi etici suscitati dai progressi della medicina), di didattica (insegnamento della bioetica nel corso di laurea in medicina nell'università Cattolica, dal 1984 come esame complementare, dal 1992 come esame fondamentale, nonché come esame in alcune delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina stessa, nel diploma universitario della sanità, nella Scuola per dirigenti dell'assistenza infermieristica, nella Scuola di ostetricia e in quella diretta a fini speciali per tecnici cosmetologi). Altre attività didattiche organizzate dall'istituto consistono in: corsi specializzati presso istituzioni universitarie e no; corso di perfezionamento post-laurea; corsi monografici di aggiornamento, seminari, cicli di conferenze. L'Istituto ha anche istituito un dottorato di ricerca in bioetica.
Particolare attenzione viene dedicata dall'istituto allo statuto dell'embrione umano, all'ingegneria genetica, ai comitati di etica e ai problemi dell'anziano.
Tra le pubblicazioni curate dall'istituto: Medicina e morale (rivista bimestrale) e la collana "Scienza medicina etica", tra i cui volumi, pubblicati dalla casa editrice Vita e Pensiero, segnaliamo:
Accanto al morente. Prospettive etiche e pastorali, di Massimo Petrini, 1990
Lineamenti di etica nella sperimentazione clinica, a cura di Antonio G. Spagnolo ed Elio Sgreccia, 1994
Rilevanza dei fattori etici e sociali nella prevenzione delle malattie professionali, a cura di Elio Sgreccia e Vincenza Mele
Etica e allocazione delle risorse in sanità, a cura di Elio Sgreccia e Antonio C. Spagnolo, 1996
Fabbricare bambini? La questione dell'embrione tra nuova medicina e genetica, di Mariella Lombardi Ricci, 1996
Evangelium Vitae e bioetica. Un approccio interdisciplinare, a cura di Elio Sgreccia e Dario Sacchini, 1996
282
Accanto all'istituto di bioetica permane il Centro di bioetica dell'Università Cattolica, costituito nel 1985 e che ha rinnovato il proprio statuto nel 1992. Il Centro promuove e organizza le attività di formazione all'esterno della Facoltà mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati sui temi della bioetica e dell'etica medica. Il Centro cura inoltre collegamenti, scambi culturali e collaborazioni in tema di formazione con altri centri e istituzioni, in Italia e all'estero.
fondazione lanza
Via Dante 55 ― 35139 Padova
telefono 049/8756008, 049/8756788
fax 049/8756788
e-mail lanza@ux1.unipd.it
La Fondazione Lanza ha sviluppato uno specifico "Progetto etica e medicina", finalizzato alla gestione responsabile delle nuove tecnologie biomediche e all'esigenza di umanizzare la medicina.
Tra le sue realizzazioni: una ricognizione delle tendenze e degli orientamenti della bioetica contemporanea, l'attivazione di un laboratorio di bioetica per la formazione permanente (seminari interdisciplinari di etica e medicina, i cui risultati sono riprodotti nei "Quaderni di etica e medicina", a cura di P. Benciolini e C. Viafora, Ed. Gregoriana, Padova). Aree di impegno specifico sono inoltre rappresentate dalla ricerca di una nuova professionalità in campo sanitario ("tra professionalità e dedizione"); dall'elaborazione di modelli argomentativi capaci di rendere operativi i principi etici di riferimento ("rispetto di tutto l'uomo e di tutti gli uomini"); dall'attivazione di processi formativi più strutturati sia a livello di formazione di base che di formazione permanente; dall'attenzione alle valenze etiche della prevenzione.
Tra i "Quaderni di etica e medicina", nuova serie, tutti a cura di P. Benciolini e C. Viafora ed editi da CIC Edizioni internazionali, Roma, segnaliamo:
Etica e geriatria. L'anziano cronico non autosufficiente, 1996
Etica e terapia intensiva. Il problema del limite, 1997
Etica e ostetricia. Diagnosi prenatale, 1997
Etica e cure palliative. La fase terminale, 1998
Etica e ostetricia. Il triplo test, 1998
Etica e psichiatria. Dal manicomio al territorio, 1999
Etica e medicina generale. Il rapporto medico-paziente, 1999
Nell'ambito dell'attività formativa, il "Progetto etica e medicina" ha operato una scelta precisa, concentrando la sua attenzione sui comitati etici e sulla loro progressiva istituzionalizzazione nel mondo sanitario italiano. L'interesse si è concretizzato in corsi di formazione, concepiti sia nell'ottica delle tematiche inerenti l'attività dei comitati etici per la sperimentazione, sia in quella delle problematiche dell'etica clinica. La Fondazione Lanza ha motivato questa scelta con la convinzione che i comitati etici sono in grado di svolgere funzioni differenziate, quali: elevare il livello di comprensione e di analisi dei problemi etici connessi con le pratiche sanitarie; integrare le voci delle professioni coinvolte nel sistema delle cure; promuovere il dibattito sulle questioni etiche relative alla gestione dei nuovi poteri biomedici attraverso iniziative di comunicazione tra istituzione sanitaria e società; gestire il crescente divario tra il progresso biomedico e la sua assimilazione normativa da parte della società.
Altre attività della Fondazione: gli Incontri intemazionali di bioetica, per la ricognizione delle
283
tendenze e il legame costante con la ricerca internazionale; le Giornate di studio sulla bioetica, in collaborazione con gli altri centri italiani; i Seminari interdisciplinari di etica e medicina, espressione di un laboratorio di bioetica clinica per la formazione permanente.
Si segnala inoltre, tra i più recenti successi della Fondazione, la nascita (1999) della rivista quadrimestrale Etica per le professioni, tesa a dibattere argomenti di etica applicata (tra le sezioni della rivista, oltre all'editoriale e al forum, si nota la presenza di "Applicazioni", mentre le stesse rubriche sono orientate ad ambiti professionali: ambiente, economia, formazione, sanità.
centro internazionale studi famiglia
Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 Milano
telefono: 02/48012040
fax 02/48009938
e-mail cisf@stpauls.it
La sua prospettiva specifica consiste nell'affrontare i problemi della bioetica articolandoli intorno alla prospettiva della famiglia. L'approccio alla bioetica del centro può essere riassunto in una frase chiave di Sandro Spinsanti, che ne è stato direttore: ''Senza la prospettiva della reciprocità, che la famiglia rende possibile e garantisce, la vita umana perde il carattere di qualità che la rende appetibile".
Un evento programmatico, che illustra il particolare approccio del Centro ai problemi della bioetica, è stato l'organizzazione del convegno "Nascere, amare, morire ― Etica della vita e della famiglia" (atti a cura di S. Spinsanti, Ed. Paoline, Milano, 1989). L'elemento innovativo introdotto dal CISF nella problematica della bioetica in occasione del convegno è stata proprio la famiglia, intesa come miglior luogo possibile ove i desideri, e con essi i conflitti, si possano comporre, perdendo la loro carica distruttrice anarchica: la famiglia considerata come un buon luogo per nascere, amare, morire. E anche un buon luogo per risolvere i dilemmi etici che pone oggi l'applicazione della tecnologia a tutto l'arco della vita umana, dalla nascita alla morte. L'introduzione della famiglia nel dibattito sulla bioetica ha inoltre il vantaggio di contrastare la tendenza a cercare la sicurezza nei ridotti dell'ideologia, nella situazione di crisi provocata dalla transizione culturale e dal cambiamento dei parametri di comportamento etico tradizionale.
Il CISF ha organizzato numerosi convegni a carattere bioetico, tra i quali ricordiamo:
Gli ultimi giorni del malato di cancro (14 dicembre 1990)
Anoressia e bulimia (3 dicembre 1992)
Esigenze e diritti di gestanti, madri e neonati in difficoltà: aspetti etico-giuridici e ruolo delle istituzioni, degli operatori e del volontariato (27-28 aprile 1995)
Minori a rischio e interventi di tutela (21 novembre 1996)
Fecondazione artificiale: subito la legge, prima di tutto il bambino (24 ottobre 1999)
Famiglia e Alzheimer (31 maggio 2000)
Nell'attività editoriale del centro è compresa anche la pubblicazione di monografie, tra cui ricordiamo:
Pedofilia: come proteggere l'infanzia da vecchi e nuovi abusi, 1998
La malattia di Alzheimer: un ladro di cuori, di anime e di memorie, 2000
Il Centro cura la pubblicazione del bollettino bibliografico "Famiglia oggi ― News" (bibliografia sistematica sulla bioetica) che offre un servizio di documentazione e informazione sulle novità in bioetica, segnalando libri, articoli di riviste e documenti di organismi ufficiali che riguardano la bioetica, in particolare nella sua articolazione con la famiglia.
284
politeia
Via Cosimo Del Fante 13 ― 20122 Milano
telefono 02/58313988
fax 02/58314072
e-mail politeia@fildir.unimi.it
È un'associazione privata senza fini di lucro, costituita a Roma nel 1983, finanziata dai soci e da attività di ricerca e formazione. Le sue finalità sono: contribuire a sviluppare una cultura pubblica orientata ai criteri dell'efficienza, efficacia, equità; elaborare modelli di politiche pubbliche e assetti istituzionali capaci di espandere le opportunità di vita individuali e affermare, nei loro esiti, il benessere collettivo. La sua attività, di fatto, mira a favorire uno scambio continuo, di informazioni e analisi tra studiosi e "decisori" pubblici. Politeia si propone anche di rappresentare un supporto tecnico e scientifico al settore economico e imprenditoriale, attraverso un'attività basata su approfondimenti teorici (ricerche) e promozione culturale (convegni, seminari, diffusione editoriale), su temi di economia, etica, scienze politiche, nella costante ricerca di compatibilità e complementarietà tra apporti disciplinari differenti.
La rivista (trimestrale) del Centro è Notizie di Politeia. Altre pubblicazioni a cura di Politeia sono gli atti dei convegni organizzati dal centro. Tra questi ricordiamo:
Un'etica pubblica per la società aperta, a cura di Politeia, Bibliotechne, Milano, 1987
La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell'uomo, a cura di Maurizio Mori, Bibliotechne, Milano, 1991
Quale statuto per l'embrione umano. Problemi e prospettive, a cura di Maurizio Mori, Bibliotechne, Milano, 1992
Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana e l'autonomia degli individui, a cura di Paolo Cattorini, Emilio D'Orazio, Valerio Pocar, Zadig, Milano, 1999
Nell'ambito della collana "Politeia ricerche" ricordiamo:
La tutela dell'ambiente
Qualità della vita e morte individuale: una nuova cultura del morire?
Valutazione di impatto ambientale, analisi costi-benefici e premesse etico-politiche
Problemi etico-giuridici della fecondazione artificiale umana
Il problema dell'insegnamento dell'etica nella scuola secondaria superiore
Tra le più importanti ricerche pubblicate da "Notizie di Politeia" ricordiamo:
Gli scopi della medicina: nuove priorità, rapporto dello Hastings Center, "Notizie di Politeia", n° 45,1977.
Codice etico nei servizi pubblici, a cura di Emilio D'Orazio e Sebastiano Maffettone, "Notizie di Politeia", n° 51,1998.
società italiana di bioetica
Istituto di Antropologia dell'università degli studi di Firenze
Via del Proconsolo 12 ― 50122 Firenze
telefono 055/2398065
fax 055/283358
e-mail antropos@unifi.it
Istituita presso la Cattedra di antropologia dell'università di Firenze, ha per finalità la fondazione dell'etica su basi naturali, mirando alla comprensione del fatto etico attraverso la valorizzazione dell'etologia, dell'antropologia e della sociologia. In tale contesto la bioetica si pone come patto
285
tra uomo e natura per rendere ancora possibile la nostra esistenza sul nostro pianeta, come scienza biologica e naturalistica con rilevanze ecologiche.
La rivista ufficiale della Società è Problemi di bioetica, pubblicazione trimestrale.
istituto italiano di bioetica
Sede nazionale
Piazza Verdi 4/4 ― 16121 Genova
Responsabile: Luisella Battaglia
Centri collegati
Bari
Presso Dipartimento di Bioetica Università degli studi
Piazza Umberto I ― Palazzo Ateneo ― 70121 Bari
Responsabile: Francesco Bellino
Bologna
Centro studi di bioetica e pedagogia della complessità
Via Magli, 4 ― 40018 San Pietro in Casale (Bo)
telefono e fax 051/810387
Responsabile: Roberto Marchesini
Trieste
Associazione per lo studio e la divulgazione dei problemi di bioetica
Via del Veltro, 83 ― 34100
Responsabile: Margherita Hack
L'Istituto italiano di bioetica è stato creato a Genova nel 1993 da scienziati e umanisti provenienti da diverse università italiane, nonché da personaggi di rilievo della cultura del nostro Paese. L’Istituto ha sede centrale a Genova ed è collegato a sezioni appartenenti a diverse regioni italiane, che realizzano a livello locale sinergie e iniziative necessarie a conseguire gli obiettivi statutari. Tali obiettivi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali e scientifiche nei settori della bioetica medica (studiando il rapporto tra vita e valori etici nel campo dell'attività medica, in riferimento alla nascita, alla salute e alla morte dell'uomo); della bioetica ambientale (con un marcato interesse alle questioni di valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono ai comportamenti umani nei confronti dell'ambiente naturale) e della bioetica animalista (che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti alle relazioni tra l'uomo e le altre specie animali).
L'Istituto italiano di bioetica realizza: seminari destinati a fornire orientamenti ai cultori della bioetica e a favorire la formazione di gruppi stabili di ricerca attraverso il contatto tra studiosi di varie discipline; corsi di formazione rivolti in particolare a medici, veterinari, ricercatori, operatori sanitari e ambientali, tesi a fornire elementi di formazione sia generale sui fondamenti teorici e sulle nozioni di base della bioetica, sia una preparazione specifica, mirata ai diversi campi d'attività degli iscritti; convegni di studio, pubblicazioni varie e collane editoriali sui temi che sono oggetto della sua attività; ricerche e indagini conoscitive, anche attraverso il conferimento di borse di studio, i cui materiali documentativi siano in grado di alimentare un'apposita banca dati. L’Istituto pubblica la collana editoriale "Quaderni di bioetica" (diretta da Roberto Marchesini),
286
che diventerà una rivista e verrà pubblicata con la casa editrice Apèiron. I "Quaderni di bioetica" sono nati per lanciare un dibattito che veda coinvolte diverse discipline intorno ai grandi problemi legati all'impatto dell'uomo sul mondo esterno, allo sviluppo tecnologico, alle accresciute possibilità d'intervenire sul vivente con metodiche sempre più sofisticate. "Quaderni di bioetica" ha realizzato studi monografici dedicati ad argomenti in genere poco indagati, affrontati con un taglio interdisciplinare. La collana si è posta come obiettivo editoriale la realizzazione di itinerari di pronta consultazione che riportino i pareri dei massimi esperti sui temi affrontati.
I titoli pubblicati (Macro edizioni) sono:
Bioetica, ricerca e società
L'albero, tra uomo e ambiente
Bioetica e scelta terapeutica
Bioetica delle virtù
Una città da vivere
La tolleranza e le sue ragioni
Le creature dimenticate
Bioetica e professione medico veterinaria
Il rito alimentare
Bioetica e cultura della complessità
Un’altra proposta editoriale dell'istituto italiano di bioetica è rappresentata dalla collana "Questioni di bioetica", diretta da Raffaele Prodomo (Apèiron editoria e comunicazione, Bologna) che ha l'obiettivo di portare in Italia alcuni tra i più importanti saggi stranieri sui temi del rapporto medico-malato, del concetto di salute e benessere, dei dilemmi etici aperti da alcune pratiche biomediche. Tra le novità di questa collana: Il consenso informato. Un nuovo rapporto fra medico e paziente, di Stephen Wear, Il medico e il malato, di Pedro Laín Entralgo, Medicina e multiculturalismo. Dilemmi epistemologici ed etici nelle politiche sanitarie (AA.VV.).
istituto giano
Via Buonarroti 7 ― 00185 Roma
telefono: 06/77250540
fax 06/77077875
e-mail gianorom@tin.it
sito internet httpv/giano.hws.nu/
Il progetto culturale dell'istituto Giano, fondato e diretto da Sandro Spinsanti, si sviluppa all’insegna della figura mitologica di Giano. Giano, divinità ricchissima di spessore simbolico ― tanto da essere tradizionalmente utilizzata anche per visualizzare la condizione della medicina, chiamata a guardare contemporaneamente nelle opposte direzioni delle scienze della natura e delle scienze dell'uomo, abbinando sapere scientifico e arte del guarire ― nell’antichità romana era preposto alle transizioni e ai cambiamenti. Particolare è quindi l'attenzione che l'istituto nutre per le medical humanities, così come per la sanità, il cui travagliato cambiamento richiede la saggia coniugazione dell'innovazione con la conservazione dei valori che, nell'erogazione delle cure, hanno tradizionalmente costituito una dimensione essenziale della nuova medicina.
L'Istituto Giano organizza corsi di formazione e aggiornamento per operatori delle Aziende sanitarie locali e scuole di perfezionamento in bioetica rivolte a diverse professioni. In particolare
287
l’istituto Giano dedica una specifica attenzione alla qualificazione in bioetica di operatori di una professione emergente, come quella degli infermieri, attraverso l’organizzazione in collaborazione con l'università di Roma "Tor Vergata" di un corso biennale: Bioetica nella professione infermieristica, per promuovere una sanità che tuteli i valori umani dell'alleanza terapeutica.
Inoltre l'istituto Giano organizza annualmente, in collaborazione con la Cittadella di Assisi, un incontro rivolto a operatori della salute, con diverse qualificazioni professionali: medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, cappellani. L'intento degli incontri è di ricostruire, su problemi concreti, l'intreccio delle cure e di favorire il dialogo e l'integrazione tra i diversi professionisti. Si sono tenuti incontri su:
Le trame del corpo (1997)
Curare con i cinque sensi (1998)
Il gioco delle libertà in medicina (1999)
La ricerca della salute: con la medicina, nonostante la medicina, oltre la medicina (2000)
Guaritori da guarire (2001)
Tra le pubblicazioni: la rivista trimestrale Janus. Medicina: cultura, culture (ed. Zadig); la collana: "Management della salute" edita dalla EdiSES, Napoli, con l’obiettivo di bilanciare il management sanitario con le medical humanities e dare nel contempo a queste la salda concretezza della cultura manageriale. Si tratta di manuali pratici, che mirano a promuovere il cambiamento in sanità sotto il duplice segno dell'efficienza e delle qualità. Volumi già pubblicati:
La qualità nel servizio sanitario, di John Ovretveit, 1996
Management per la nuova sanità, a cura di Sandro Spinsanti, 1997
I sistemi premianti nei servizi sanitari pubblici, di Vincenzo e Francesco Lorenzini, 1997
Altra proposta editoriale a cura dell'istituto Giano è la collana "La biblioteca di Giano", pubblicata dalle edizioni Cidas, Roma; propone opere che si ispirano al movimento delle medical humanities e mirano alla ricomposizione dell'unità del campo terapeutico, favorendo un dialogo fra le diverse professioni della salute. Senza trascurare opere dedicate ai problemi più attuali della sanità, privilegia la riflessione sulle questioni fondamentali dell'antropologia medica. Sono usciti nella collana i seguenti volumi:
Curare e prendersi cura, di Sandro Spinsanti, 1998
Le ragioni della bioetica, di Sandro Spinsanti, 1999
Conoscere la nuova sanità, a cura di Sandro Spinsanti, 1999.
consulta di bioetica
Via Cosimo del Fante 13 ― 20122 Milano
telefono e fax 02.58300423
e-mail cbioetica@tin.it
sito internet http://www.syrnbolic.parma.it/bertolin/consulta.htm
La Consulta di bioetica esordisce nel panorama della bioetica nazionale successivamente all'annuncio dell'istituzione del Comitato nazionale per la bioetica, nel 1988. A tale momento l'esordio sembra polemicamente collegato: la scelta dei membri del primo CNB appariva infatti condizionata da orientamenti di parte e in esso gli esponenti della cosiddetta bioetica laica non si sentivano
288
sufficientemente rappresentati. Una crisi di governo impedirà a quel CNB, costituito presso il ministero della Sanità, di muovere i primi passi. Solo nel 1990 nascerà, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale che oggi conosciamo. Nel frattempo, tuttavia, si costituisce ugualmente a Milano (1989) la sua "controparte laica", la Consulta di bioetica.
Ne è fondatore il neurologo Renato Boeri, e come manifesto programmatico si può fare riferimento a una frase di Ugo Scarpelli: "Guardando alla diversità delle etiche e delle bioetiche non siamo autorizzati a considerarle come una molteplicità di etiche false al cospetto di un'etica vera, bensì come una varietà di risposte cui esseri umani sono pervenuti circa le proprie domande esistenziali". In effetti la Consulta si presenta come "un'associazione di cittadini che si propone di diffondere un atteggiamento aperto e libero da pregiudiziali dogmatiche nella ricerca di soluzioni ai problemi morali posti dallo sviluppo della medicina e delle scienze biologiche". Dibattito, dunque, sui temi della bioetica nel rispetto delle diverse concezioni di valore presenti nella società. La Consulta di bioetica ha prodotto a tutt'oggi i seguenti documenti ufficiali:
Accertamento di morte
Carta di autodeterminazione ― Biocard
Eutanasia
Per una difesa del diritto di aborto
Bambini e autodeterminazione
I comitati etici per la sperimentazione clinica
Osservazioni sulla recente legge sulla sperimentazione animale
Il progetto Zadig (assistenza agli anziani)
La fecondazione assistita
Etica e ricerca sperimentale nei soggetti umani Principi bioetici e screening
Principi etici per una legislazione sulla procreazione assistita
Proposta di legge sul consenso informato e sulle direttive anticipate
Organo d'informazione della Consulta di bioetica è Bioetica, rivista interdisciplinare (ed. Zadig), diretta da Maurizio Mori e Demetrio Neri. La rivista ha periodicità trimestrale.
Numerosi sono stati anche i convegni organizzati dalla Consulta di bioetica. Ricordiamo, tra quelli degli ultimi anni:
La nozione di dignità della vita umana (1997)
Per la libertà di procreare: opinioni a confronto (1998)
Verso il riconoscimento giuridico della Carta di autodeterminazione del malato (1999)
Etica laica e valori (1999)
Da ricordare anche i seminari "I diritti dei morenti" (1997-1998).
289
capitolo
25
CORSI, SCUOLE, DIPLOMI
L'Istituto di bioetica dell'università Cattolica del Sacro Cuore organizza corsi specializzati presso istituzioni universitarie e no, due corsi annuali di perfezionamento post-laurea (di base e avanzato), corsi di aggiornamento, seminari, cicli di conferenze. È inoltre attivo, presso il medesimo Istituto, un posto per dottorato di ricerca in bioetica.
Il corso di perfezionamento post-laurea, in particolare, costituisce uno degli impegni principali dell'istituto. In 130 ore di insegnamento, distribuite in tre settimane intensive, i 60 candidati ammessi approfondiscono temi che spaziano in molti ambiti: bioetica generale, etica generale, argomenti di storia della filosofia, fondamenti di teologia morale, antropologia filosofica, deontologia medica, fondamenti di diritto, bioetica clinica e altri temi più specifici (sessualità, vita nascente, fase terminale della vita, sperimentazione sull'uomo, genetica, comportamenti a rischio, psichiatria, comitati di etica, relazione medico-paziente, economia sanitaria). A completamento dell'offerta di formazione proposta dall'istituto, è stato recentemente istituito un corso di perfezione di livello avanzato, destinato a quanti abbiano già frequentato il corso di base. Articolato in tre settimane intensive per complessive 105 ore di lezione, il corso consente ai 50 candidati ammessi di approfondire le conoscenze già acquisite attraverso un programma che prevede lezioni ed esercitazioni interattive.
La Fondazione Lanza ha promosso l'attivazione di un laboratorio di bioetica per la formazione permanente (i Seminari interdisciplinari di etica e medicina) e ha soprattutto centrato la sua attività di formazione su corsi dedicati al tema dei comitati di bioetica, articolati su due livelli: di base (50 iscritti) e avanzato (30 iscritti). Tra il 1994 e il 1998 sono stati realizzati tre cicli completi. La metodologia formativa si basa sui momenti del confronto e del dibattito tra voci differenti, espressione delle diverse sensibilità morali presenti nella società; alla dinamica dei gruppi di lavoro è affidato un ruolo importante per lo sviluppo della capacità di applicare regole a casi concreti, nonché per lo sviluppo delle attitudini necessarie a sviluppare la dialogicità, condizione necessaria per il buon funzionamento di un comitato di bioetica.
La Fondazione Internazionale Fatebenefratelli (tel. 06/5818895) organizza annualmente un corso di bioetica clinica (presso l'Ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina, Piazza Fatebenefratelli 2, 00186 Roma, e-mail fbfisola@tin.it) destinato a operatori della sanità, di tutte le professioni, che intendano approfondire le motivazioni delle loro scelte etico-professionali, sia nel rapporto con i malati che nell'organizzazione dei servizi.
Lo spirito del corso, analogamente a tutte le iniziative della FIF (scuole, seminari, giornate di studio), è quello di trasfondere quella "cultura dell'ospitalità" che deve caratterizzare le strutture sanitarie, definendo un modello di umanizzazione e uno stile di rapporto professionale rispettoso
290
della globalità della persona malata, intesa non solo come affetta da problemi e malattie, ma anche come sorgente di risorse e potenzialità da valorizzare. Il corso è finalizzato a disegnare un modello formativo che integri la conoscenza dei valori professionali con la maturazione della coscienza personale nell'esercizio delle virtù e nella coerenza dei comportamenti. Attraverso due settimane intensive (10 giorni suddivisi in due moduli di 5 giorni ciascuno) il corso offre ai trenta candidati ammessi un quadro delle questioni dibattute nella bioetica a partire dai principi classici rivisti alla luce del personalismo cristiano, passando attraverso la discussione del tema centrale della responsabilità personale e delle virtù etiche.
L'Istituto Giano, è impegnato attivamente nell'organizzazione in collaborazione con l'università di Roma ― Tor Vergata di un corso biennale, "Bioetica nella professione infermieristica", e di corsi di formazione etico-economica per medici e personale sanitario. Il corso Bioetica nella professione infermieristica, in particolare, è rivolto a un numero ristretto di partecipanti con responsabilità di insegnamento, di formazione continua e di animazione di comitati di bioetica negli ospedali; è centrato su tre tematiche: bioetica sistematica, bioetica clinica e medical humanities. Il primo anno del corso prevede la partecipazione a sette seminari mensili (venerdì e sabato), da gennaio a ottobre, organizzati a Roma. II secondo anno, non residenziale, è dedicato alla ricerca, all'elaborazione di due lavori scritti e alla preparazione dell'esame orale (sono previste due sessioni annuali: in primavera e in autunno). Il diploma finale conclude un itinerario arricchito dalla possibilità di partecipare, sempre nel secondo anno, a seminari didattici, rivolti all'apprendimento della didattica della bioetica, per il secondo anno di corso è assicurata un'attività tutoriale per guidare la ricerca e la redazione degli elaborati scritti.
L'Università di Roma "La Sapienza" organizza un corso annuale di perfezionamento post-laurea diretto da Eugenio Lecaldano. Titoli di ammissione sono le lauree in scienze biomediche, lettere e filosofia, diritto, teologia ed equipollenti. Il corso dura quattro mesi e si propone di aggiornare i laureati delle varie discipline sui rapporti fra gli sviluppi delle scienze biologiche, le loro applicazioni tecnologiche e i problemi etici che sorgono sia nelle aree più avanzate della ricerca, sia nella pratica quotidiana. Il corso si svolge presso l'istituto di antropologia, dipartimento di biologia dell'animale e dell'uomo, Piazzale A. Moro 5, Roma, tel. 06/49912346.
In programma, approfondimenti su: storia e analisi delle principali correnti bioetiche, bioetica e regole giuridiche, aspetti antropologici e psicologici della bioetica e le basi scientifiche e le implicazioni di temi fondamentali (riproduzione, vita nascente, fine della vita, salute e sanità, mercificazione del corpo ecc.), informazione, insegnamento e organizzazione (comitati etici) nel campo bioetico. Il corso è aperto agli infermieri DAI della stessa università, mentre infermieri di altra provenienza sono ammessi come uditori e possono ricevere un attestato di partecipazione.
Il corso è anche dotato di sito internet (http://www.uniroma1.it/bioetica/bio.htm), dove la rivista mensile telematica Bioethics rende disponibili i testi delle lezioni e altri contributi scientifici. Per comunicare con la redazione esiste anche un indirizzo e-mail (spazio.libero@agora.stm.it).
Un Master in bioetica è organizzato dall'Università degli Studi del Sannio, di Benevento e l'istituto per la formazione e la ricerca sociosanitaria (IFoS) quest'ultimo è nato dalla collaborazione tra lo stesso ateneo beneventano e l'istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma. Sotto la direzione scientifica di S. Gindro e P. Perlingieri, il Master è diretto a laureati in medicina, filosofia, teologia, giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, nonché a operatori con incarichi dirigenziali in ASL, ospedali e assessorati alla sanità. Il Master ha durata di un anno, con moduli di una giornata per 2-3 moduli al mese. Previsto per 30 discenti, garantisce, attraverso l'attività tutoriale, percorsi di formazione individualizzati e flessibilità di strutturazione dei moduli. Coordinamento scientifico: A. Casoni (tel. 06/32652401, e-mail iprs@mclink.it). Segreteria didattica tel. 0824/21219; segreteria amministrativa tel. 0824/25405. Sede: Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento.
291
Da ormai cinque anni, presso l'Istituto nazionale tumori di Napoli (Via M. Semmola, 80131 — Napoli), viene organizzato a cura di Raffaele Prodomo e Armando Tripodi, in collaborazione con l'Istituto italiano di bioetica, un corso di perfezionamento in bioetica (tel. 081 /5903211,081 /5903286).
Il requisito della laurea è necessario, ma parte significativa dei frequentatori è costituita da infermieri, ammessi come uditori e attratti sia dall'elevato livello scientifico dei docenti, sia dalle tematiche individuate ogni anno come filo conduttore del corso. Tra le tematiche approfondite nelle versioni più recenti di Corso:
Il rapporto tra etica e clinica nelle professioni sanitarie
Le nuove dimensioni della relazione terapeutica
Le metamorfosi della salute. Dilemmi epistemologici ed etici nelle politiche sanitarie
La medicina tra razionalità scientifica e ragioni storico-sociali
292
293
capitolo
26
ENCICLOPEDIE E MANUALI DI BIOETICA
Un posto d'eccezione nell'ambito della trattatistica enciclopedica in bioetica deve essere assegnato alla Enciclopedia di bioetica (Enciclopedia of Bioethics), opera che ha visto la luce nel 1978. Esempio pressoché unico per una enciclopedia, anziché limitarsi a raccogliere e organizzare le conoscenze di un sapere consolidato e organizzato accademicamente, l'Enciclopedia di bioetica, fiore all'occhiello tra le attività editoriali del Kennedy Institute di Washington, ha contribuito a fondare concettualmente la materia che descrive e approfondisce. Basti pensare che proprio in questa prima edizione è stata coniata una definizione di bioetica che è stata in seguito ampiamente condivisa: "studio sistematico della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della sanità in quanto questa condotta è esaminata alla luce dei valori e dei principi morali".
La scelta di tempo non è casuale, ma frutto dell'intuito del suo "architetto", Warren Reich, coordinatore di un'imponente massa critica di pensatori impegnati a produrre un'opera costituita da 4 volumi, 1990 pagine, 315 articoli di 285 autori. In essa sono descritti i diversi sistemi etici e i principi ai quali si riferiscono; la storia dell'etica medica nei diversi Paesi, culture, epoche; le discipline differenza: biologia e medicina, psicologia e sociologia, scienze politiche e diritto, antropologia e storia, teologia (posizione delle grandi religioni mondiali circa l'etica delle scienze e della medicina); le teorie filosofiche; i concetti antropologici fondamentali (salute, guarigione, normalità ecc.). La prima edizione dell'Enciclopedia ha quindi svolto un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo della bioetica e nell'ampliarne la conoscenza e la diffusione nel mondo.
La seconda edizione (primavera del 1995), costituita da cinque volumi, ha tenuto conto dei fattori scientifici, intellettuali, culturali e legali che hanno inciso sui mutamenti della bioetica negli ultimi vent'anni. Nuovi argomenti sono stati pertanto approfonditi: le terapie genetiche; le tecniche di riproduzione; i grandi mutamenti di scenario della sanità; i problemi legati alla difesa dell'ecosfera; i nuovi trend anagrafici della popolazione; il tema dell'allocazione delle risorse. Inoltre hanno trovato ampio spazio gli sviluppi più recenti del dibattito bioetico, quali l’etica delle virtù, l'approccio esperienziale, l'apporto delle donne, il dibattito internazionale.
Nel panorama italiano spicca un’opera a carattere enciclopedico generale: il Dizionario di bioetica curato da S. Leone e S. Privitera (Dehoniane, Bologna, 1994). Strutturato in 350 voci per 1068 pagine, affianca all'esplicazione di termini inerenti i grandi temi della bioetica (aborto, eutanasia, ingegneria genetica, trapianti, sperimentazione, fecondazione in vitro ecc.) la definizione di espressioni riguardanti temi inusuali (codice della strada, cosmetici, fumo, malattie iatrogene ecc.). Presenta inoltre un glossario su alcuni concetti di etica fondamentale, allo scopo di rendere più comprensibili le trattazioni sulla bioetica speciale.
294
Altra caratteristica del Dizionario è la piena accettazione del concetto di "salute spirituale" come categoria facente parte a pieno titolo della sfera della salute globale della persona. In questa ottica trovano posto riferimenti a temi ― i Padri della Chiesa, conversione, superstizione, virtù teologali ecc. ― che in sé non sono strettamente inerenti la bioetica. Tra i 176 autori, accanto a teologi, filosofi e bioeticisti, anche professionisti quali medici, avvocati, giornalisti ecc., a portare il contributo delle professioni nelle voci in cui il rapporto professione-bioetica e le relative riflessioni trovano frequente se non quotidiana occasione di esercizio. L'orientamento dell'opera è quello del personalismo cattolico, anche se sono presenti contributi di autori appartenenti a diverse impostazioni culturali.
Il Manuale di bioetica di Elio Sgreccia rappresenta il testo di riferimento della bioetica personalista cattolica. Edito dapprima in un solo volume nel 1986, dedicato ai "Fondamenti di etica biomedica", è stato integrato nel 1991 dal secondo, sugli aspetti medico-sociali. Proprio quest'ultimo, alla luce della rapida evoluzione dei problemi in ambito sociale, economico e demografico, è stato aggiornato con una più recente edizione (Manuale di bioetica II. Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano, 1996). Sono stati approfonditi i temi riguardanti la politica sanitaria, i problemi correlati a comportamenti che il manuale definisce "devianti" (psichiatria, disfunzioni sessuali, tossicodipendenza, AIDS), aspetti assistenziali (handicap, terza età) e attività sociali (medicina del lavoro, sport, medicina delle catastrofi ecc.).
Tre capitoli, in particolare, sono stati rivisti, riorganizzati e ampliati: Bioetica e infezione da Hiv; Bioetica anzianità e invecchiamento della popolazione; Bioetica, economia e salute, con sviluppo di interi paragrafi autonomi per istanze che nella precedente edizione erano state solo fugacemente accennate. Per quanto riguarda l'infezione da HIV, tra le questioni affrontate si segnalano: la posizione del medico di fronte al dilemma del rispetto o meno del segreto professionale nelle situazioni in cui la sieropositività per AIDS mette in pericolo la vita del partner; gli aspetti particolari legati alla sperimentazione di nuovi farmaci, la formazione etica degli operatori sanitari; il consenso al test per l'HIV; lo screening dei pazienti; le strategie di prevenzione; le discriminazioni in ambito lavorativo che colpiscono i sieropositivi.
Nel capitolo Bioetica anzianità e invecchiamento della popolazione sono stati approfonditi i problemi etici riguardanti l'assistenza all'anziano non autosufficiente e al malato grave. Aggiornata anche la trattazione delle problematiche riguardanti la gestione economica della salute, in particolare il dibattito etico sulla limitazione e razionalizzazione della spesa sanitaria e sui criteri di distribuzione delle risorse disponibili. I temi trattati nel primo volume (Bioetica speciale ed etica medica), che ha avuto tre successive edizioni, sono: statuto dell'embrione, fecondazione in vitro, sessualità, ingegneria genetica, sperimentazione, trapianti.
Etica bio-medica (Paoline, Milano, 1987); Bioetica in sanità (La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993) e Bioetica nella professione infermieristica (EdiSES, Napoli, 1995) rappresentano il contributo di Sandro Spinsanti alla manualistica bioetica italiana. Tra gli aspetti più rilevanti che si colgono nell'opera di Spinsanti c'è l'apertura della riflessione bioetica al confronto con gli stimolanti approcci dell'impostazione antropologica della medicina e l'attenzione costante alle medical humanities. Un originale approccio alla bioetica proposto dallo stesso autore è quello che privilegia la biografia degli studiosi che hanno svolto il ruolo di pionieri della bioetica: Bioetica. Biografie per una disciplina, F. Angeli, Milano, (1995), offre un ritratto del pensiero e dell'opera dei più importanti bioeticisti a livello mondiale.
Contributi alla manualistica bioetica italiana sono venuti anche da Corrado Viafora, Salvino Leone, Francesco Bellino e Adriano Bompiani. Di Corrado Viafora ricordiamo due importanti contributi editoriali: il manuale Fondamenti di bioetica (Cea, Milano, 1989) e la rassegna Centri di bioetica in Italia (Gregoriana, Padova 1993), della quale è stato coordinatore. La collocazione di Viafora nel dibattito bioetico è tra gli esponenti del personalismo di ispirazione cristiana, con un
295
particolare impegno nello sviluppo dei principi fondamentali della letteratura bioetica ― autonomia, beneficità, giustizia ― alla luce del paradigma antropologico fornito dal cristianesimo, nella prospettiva dello sviluppo dei principi di dignità dell'uomo, globalità della cura, solidarietà.
Salvino Leone è l'autore di un manuale, Lineamenti di bioetica (Medical books, Padova, 1987), che rappresenta un apporto alla bioetica proveniente dalla cultura cattolica del nostro Paese. Ha contribuito alla trattatistica bioetica anche Francesco Bellino con il volume da lui curato: Trattato di bioetica (Levante ed., Bari, 1992). In esso l'autore sviluppa sia gli aspetti fondativi della bioetica, approfondendone i presupposti teoretici e i fondamenti epistemologici, antropologici, etici, giuridici e deontologici, sia i problemi specifici, tra i quali alcuni di recente individuazione (bioetica e medicina estetica, etica dello sport ecc.).
Vanno ricordate anche alcune opere di autori stranieri, a carattere manualistico o saggistico, che hanno avuto la possibilità, peraltro rara, di essere tradotte e proposte alla lettura dei cultori italiani della bioetica. Tra queste, il Manuale di bioetica di Tristam Engelhardt Jr. (Il Saggiatore, Milano, 1991, nuova edizione, 1999). L'opera propone le controverse teorie dell'autore americano sull'applicazione estensiva di un contrattualismo radicale, fortemente avversato da studiosi di bioetica sia di orientamento cattolico, sia di ispirazione laica.
Di Adriano Bompiani segnaliamo Bioetica in Italia. Lineamenti e tendenze (Edizioni Dehoniane, Bologna, 1992), che descrive l'apporto degli autori italiani allo sviluppo della bioetica prendendo spunto dai problemi più rilevanti affiorati nel dibattito italiano e il contesto culturale in cui tale dibattito si è svolto. Particolarmente approfondite le tematiche dell'evoluzione dell'etica medica, dello sviluppo del concetto di corporeità con relative applicazione al campo bioetico, della responsabilità morale degli scienziati e del rapporto uomo-ambiente e uomo-animale. Il secondo volume Bioetica dalla parte dei deboli (Edizioni Dehoniane, Bologna, 1995) rappresenta la continuazione del primo, secondo un filo conduttore rappresentato dall'impegno della bioetica nelle questioni "sociali", con riferimento ai problemi legati agli embrioni, ai bambini che crescono in famiglie inadeguate, ai malati mentali, ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai sofferenti cronici, agli anziani esclusi e non autosufficienti, ai malati terminali.
Con il trattato Fondamenti di bioetica, sviluppo storico e metodo (San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993) Diego Gracia offre, attraverso la suggestiva chiave di un itinerario storico e filosofico di ampio spessore, una proposta metodologica che rappresenta uno degli sforzi di concettualizzazione di più ampio respiro che siano stati finora tentati in campo bioetico.
A uno degli esponenti di primo piano della bioetica europea, Patrick Verspieren, si deve Biologia, medicina ed etica (Queriniana, Brescia, 1990), una raccolta di testi del magistero cattolico riguardanti tre grandi aree tematiche: l'inizio della vita; salute, malattia, medicina e rispetto dell'uomo; la prossimità della morte. Dal pontificato di Pio XII, e più precisamente dall'anno 1949, sino all'appendice rappresentata dal documento della Conferènza episcopale italiana su Evangelizzazione e cultura della vita umana, del 1989 Verspieren presenta e commenta i documenti valorizzandone la portata e il significato ma rinunciando ― come abitualmente è dato riscontrare nelle sue opere ― a tentare di costruirvi sopra un sistema di tipo manualistico.
296
297
capitolo
27
RIVISTE DI BIOETICA
In Italia non mancano possibilità di aggiornamento culturale sui temi di bioetica, grazie al significativo impegno editoriale dei principali centri e alla conseguente fioritura di riviste di bioetica.
L'Istituto di bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore affida le proprie proposte editoriali alla rivista bimestrale Medicina e Morale, una pubblicazione che esiste da quasi mezzo secolo e che si articola in testi e rubriche, tra le quali particolare spazio è dedicato a una ricca sezione dedicata alla documentazione. In essa vengono pubblicati integralmente documenti di rilievo bioetico provenienti dal magistero pontificio, ma anche dei principali organismi internazionali. Merita anche di essere citata una rubrica fissa su Etica e ambiente, dove trovano posto recensioni di numerose opere della letteratura internazionale su questo tema.
Dall'aprile 1994 Medicina e Morale è disponibile su internet (www.uni.net/cdb/) e dalla fine del 1995 alla rivista si affianca un foglio bimestrale (Centro di bioetica newsletter) che aggiorna sulle iniziative nel campo della bioetica e offre uno spazio all'aggiornamento sulla letteratura specifica, rimandando alla rivista per approfondimenti delle fonti citate.
Il centro Politeia presenta, tra i propri riferimenti editoriali, la rivista trimestrale Notizie di Politeia, cui è affidato, dal 1985, il compito di diffondere e commentare iniziative culturali e di studio e fornire servizi per la ricerca. È una rivista aperta a raccogliere contributi di diversa e varia provenienza, con una marcata preferenza per l'impostazione utilitarista che è a fondamento di tutto il lavoro di ricerca organizzato nel centro. Per la qualità dei contributi italiani e stranieri rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama scientifico e culturale italiano, contribuendo a rinnovarne i contenuti e a introdurre uno stile rigoroso nell'analisi dei problemi.
L'organo ufficiale della Società italiana di bioetica è Problemi di bioetica, pubblicazione trimestrale nella cui impostazione si riflette la fisionomia della società. La rivista si propone infatti come punto d'incontro, riflessione e dibattito per tutte le questioni inerenti l'ambito generalmente definito come "bioetico": etica medica ed etica ambientale. Esplicito proposito della rivista è quello di integrare approcci diversi in questo campo del sapere, senza presupposti ideologici e metodologici.
Bioetica è la rivista ufficiale della Consulta di bioetica. È una rivista interdisciplinare, nata nel 1993, che promuove la riflessione teorica e approfondita dei vari problemi della bioetica, con connotazione apertamente pluralista. Intento della rivista è anche l'apertura del dibattito italiano su scenari più ampi, attraverso un diretto contatto con le fonti più autorevoli del letteratura internazionale. Tra le sezioni attive nella rivista: Studi e saggi; Interventi; Documenti; Osservatorio sui comitati etici; una rubrica (Cronache di bioetica) passa in rassegna cronologicamente tutti gli eventi di rilevanza bioetica proposti dai media italiani e stranieri.
298
Il periodico Bioetica e cultura è l'organo ufficiale dell'istituto siciliano di bioetica (Corso V. Emanuele 463 ― 90134 Palermo, tel. 091/331648), costituito nel 1990 e diretto da Salvatore Privitera. La rivista, semestrale, pubblica gli atti dell'annuale Meeting mediterraneo di bioetica e dei diversi incontri programmati dal centro. Ospita, inoltre, numerosi contributi di studiosi amici dell'istituto. Riflette l'orientamento del centro, che si propone di promuovere l'etica come punto d'incontro fra popoli, culture e religioni del Mediterraneo, accettando tuttavia come vincolo l'insegnamento sociale del magistero della Chiesa cattolica.
Janus, la rivista trimestrale dell'istituto Giano, presenta in ogni fascicolo una suddivisione in due parti: la prima in cui gli interventi sono rivolti a considerare e a riflettere su temi legati all'attualità, ma di cui è già fin d'ora possibile prevedere l'influenza sul futuro. La seconda in cui sono affrontati i temi del "passato vitale".
Nella prima sezione della rivista vengono proposti brevi interventi di commento a fatti di attualità che hanno interessato il panorama medico scientifico e le sue implicazioni nelle medical humanities. Segue una parte che costituisce il corpo centrale della rivista, monografico, con interventi convergenti su uno stesso tema e che dà il titolo al volume. La prima sezione contiene anche un osservatorio internazionale, che presenta fatti e commenti concernenti le medical humanities nel mondo, affidato ai centri internazionali che afferiscono alla rivista. La sezione contiene, oltre a schede sui libri più recenti, la recensione di un libro di particolare significato a opera di diversi esperti che lo affrontano dal proprio peculiare punto di vista.
La seconda parte presenta articoli in cui si dà conto dell'evoluzione di una pratica medica, attraverso le controversie e i consensi che ha suscitato. Segue un saggio in cui si sviscera un argomento di stretta natura filosofica, ma di attualità pratica. Conclude la rivista, infine, un articolo su un testo letterario, classico e no, affidato a un critico letterario.
Nata nel 1996, Qualità Equità, la rivista diretta da Giovanni Berlinguer si definisce "rivista del welfare futuro". Il suo impegno equivale a una scommessa sulla trasformazione anziché sul lento, inesorabile deperimento del welfare. Una trasformazione che richiede però (come scrive nella presentazione del primo numero lo stesso Berlinguer) una critica esplicita: verso le tendenze dello Stato a invadere tutto il campo, e dei cittadini a chiedere tutto dallo Stato; verso la sottrazione di responsabilità alla società civile, ai suoi corpi intermedi e ai singoli cittadini; verso il prevalere del clientelismo sull’equità e del burocratismo sullo spirito di servizio; verso il pervertimento dei diritti conquistati in privilegi consolidati e irremovibili; verso le inefficienze che divengono la peggior forma d'ingiustizia, perché illudono sull'eguaglianza alimentando invece le più odiose discriminazioni. La rivista, trimestrale, si rivolge ai dirigenti delle associazioni sindacali e del terzo settore, a coloro che operano professionalmente o volontariamente nel campo dell'assistenza, della sanità, della previdenza e dell'elevamento culturale della popolazione, agli studiosi che lavorano nelle università e nei centri di ricerca.
Kéiron è il nome greco di Chirone, il più saggio dei centauri. È anche il nome della rivista quadrimestrale diretta da Ivan Cavicchi ed edita da Farmindustria. La rivista è impegnata in un percorso di approfondimento su temi di etica, scienza ed economia. La scelta del nome non è casuale: Chirone è un eroe riparatore di colpe (riparazione etica), di malattie (terapeutica), ma non solo. Rappresenta la grande ambivalenza oggi smarrita ― l'ammalato guaritore e il guaritore ammalato ―, un'ambivalenza che media le diverse condizioni dell'uomo. La rivista intende rispondere all'unanime convinzione che, per governare le nuove e vecchie complessità dei nostri giorni e soprattutto i difficili rapporti tra i mondi degli interessi, dei diritti e dei valori sociali, ci sia un grande bisogno di cultura. E ciò è ancor più vero per il campo della salute. La rivista si rivolge quindi a quanti operano nei vari ambiti della salute e del benessere e condividono analoghe necessità di modernizzazione.
Per quanti nutrano un interesse specifico nei riguardi della bioetica applicata alla quotidianità
299
dei problemi al letto dell'ammalato, si segnala la rivista quadrimestrale Bioetica clinica, diretta da Sandro Gindro, che accompagna la descrizione di casi specifici ― ma di largo riscontro nella pratica clinica ― ad analisi approfondite curate da esperti qualificati del mondo della bioetica.
Il tradizionale interesse per la bioetica maturato nel corso degli anni presso l'Università Scienza e Vita dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha un preciso riferimento editoriale nelle riviste Kos, mensile di scienza ed etica, e Sanare Infirmos, quadrimestrale, entrambe attente a coniugare gli approfondimenti tecnici sulle realtà sanitarie con l'impegno costituito, nella pratica sanitaria, da un moderno rilancio del concetto cristiano di assistenza e ospitalità.
300
301
BIBLIOGRAFIA
AA. VV., L'ascolto che guarisce, Cittadella, Assisi, 1989.
Abbot E.A., Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni, Adelphi, Milano, 1966.
Atighetchi D., La mutilazione genitale femminile come problema di sanità pubblica, in "L'Arco di Giano", n. 13,1997.
Associazione Pediatrica Britannica, Guidelines to aid ethical Committees considering research involving children, in "Archives of Disease in Childrood", 55,1980.
Benci L., La nuova legge: molte luci e qualche ombra, in "Janus", n. 1,2001.
Bernardi B., "Salute per tutti": prospettiva XXI secolo, in "L'Arco di Giano", n. 16, 1998.
Bernardi B., Multiculturalità ed interculturalità: l'apporto delle ricerche antropologiche, da "Annali della Pubblica Istruzione", XXXIX, n. 5, 1993.
Berne E., A che gioco giochiamo, Bompiani, Milano, 1967.
Brodkey A., Questo buio feroce. Storia della mia morte, Rizzoli, Milano, 1999.
Bucci R., Etica e mercato della sanità, Ediesse, Roma, 1996.
Butler S., Erewhon, Adelphi, Milano, 1975.
Callahan D., La medicina impossibile. Le utopie egli errori della medicina moderna, Baldini e Castoldi, Milano, 2000.
Cavana E., Dalla routine assistenziale all'Evidence Based Nursing, in "Tendenze nuove", aprile-giugno 1996.
Cechov A., Racconti, Garzanti, Milano, 1983.
Commissione nazionale olandese, Choices in health care, 1992.
Ciminelli M.L., Le mutilazioni genitali femminili: equivoci etnografici e distorsioni antropologiche, in "L'Arco di Giano", n. 26,2000.
Colombo F., Gli italiani scoprono la "privacy" ma pochi sanno bene cosa sia, in "Telèma", n. 15,1998.
Commissione del parlamento svedese, Priorità nell'assistenza sanitaria. Premesse di ordine etico ed economico ed attuazione pratica, in "Bioetica. Rivista interdisciplinare", 5, n. 1,1977.
Commissione ministeriale olandese, Le scelte in sanità, in "L'Arco di Giano", n. 5, 1994.
Corbellini G., Contare replicare-misurare-correlare determinare-modulare, in "Kéiron", n. 3, 2000.
Cosmacini G., Medicina e inguaribilità. Una prospettiva storica, in "L'Arco di Giano", n. 16, 1998.
Crichton M., Casi di emergenza, Rizzoli, Milano, 1995.
D’Agata G., Il medico della mutua, Tasc. Econ. Newton, Milano, 1993 (1 ed. 1964).
Deming W. E., Out of crisis, Mit, Cambridge Mass., 1986.
Di Nicola P., Equivalenza, uguaglianza, debito: tre forme di circolazione di beni e servizi nella società moderna, in "L’Arco di Giano", n. 6,1994, pp. 179-184.
Domenighetti G., Il conflitto originale: attese versus realtà, in "L'Arco di Giano", n. 23,2000, pp. 31-40.
Donne J., Poesie amorose, poesie teologiche, tr. di Cristina Campo, Einaudi, Torino, 1971.
302
Engelhíardt H.T., Manuale di bioetica, Il Saggiatore, Torino, 1991.
Foucault M., La nascita della clinica, Einaudi, Torino, 1969.
Galgano A., La Qualità Totale, Il Sole-24 Ore, Milano, 1990.
Galimberti U., Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 1999.
Gilligan C., Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano, 1987.
Godbout J.T., Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
Gordon D., Paci E., Parlare o tacere? Narrazioni culturali e cancro, in "L'Arco di Giano", n. 14, 1997.
Gracia D., Fondamenti di bioetica, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993.
Grmek M., Aids. Storia di una epidemia attuale, Laterza, Bari, 1989.
Grmek M., La terza rivoluzione biomedica, in "Il Sole-24 Ore", 5 marzo 2000.
Grof S., Oltre il cervello, Cittadella, Assisi, 1988.
Groopman J., Second opinions, Viking, New York, 2000.
Guimarães Rosa J., Miguilim, Feltrinelli, Milano, 1999.
Hall E.T., Il linguaggio silenzioso, tr.it., Bompiani, Milano, 1968.
Hastings Center, Gli scopi della medicina: nuove priorità, in "Notizie di Politeia", n. 45, 1997.
Hors J., Les trois temps de la transplantation d'organes, in "Journal international de bioéthique", 6, n. 2, 1995.
Iandolo C., Il paziente inosservante, Armando, Roma, 1985.
Illich I., Nemesi medica, Mondadori, Milano, 1976, Ed. Red, Como, 1991.
Jonas H., Il principio di responsabilità, Einaudi, Torino, 1990.
Jonsen A., Introduzione a G. J. Agich, Ch. E. Begley, The price of health, Reidel, Dordrecht, 1986.
Jung C.G., I rapporti della psicoterapia con la cura d’anime, in "Opere", vol. XI, Bollati Boringhieri, Torino, 1969-1992.
Kant I., Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo?, in "Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto", Utet, Torino, 1975.
Kübler Ross E., La morte e il morire, Cittadella, Assisi, 1976.
Laing R.D., Nodi. Paradigmi di rapporti intrapsichici e interpersonali, Einaudi, Torino, 1969.
Le donne raccontano il parto, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona, 1999.
Luzzatto A., L'uomo a fronte della sofferenza nella tradizione ebraica, in AA. W., "Schmerz in Wissenschaft, Kunst und Literatur", Guido Pressler Verlag, Hürtgenwald, 2000.
Maciocco G., La Banca Mondiale da Adam Smith ad Amartya Sen, in "Salute e Sviluppo", n. 3, 1999.
Maciocco G., La salute e il mercato, in "L'Arco di Giano", n. 6, 1994.
Malthus R., Saggio sul Principio di popolazione, Einaudi, Torino, 1977.
Mann Th., Kay K., SIDA, discrimination et santé publique, Comunicazione dalla IV Conferenza internazionale sull’AIDS, 13-16 giugno 1988, Stoccolma.
Mann Th., La montagna incantata, ed. Corbaccio, Milano, 1992.
Mann Th., I Buddenbrook, ed. Corbaccio, Milano, 1992.
Mauss M., Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, in "Année sociologique", serie II, 1923-24; tr. it. Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, in Mauss M., Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino, 1965.
Maynard A., Bloor K., Health Care Reform: informing difficult choises, London, John Wiley, 1995.
Mazzetti M., Il dialogo transculturale in medicina, in "L'Arco di Giano", n. 22, 1999.
McLoskey E.L., The patient self ― determination Act, in "Kennedy Institute of Ethics journal", 1, 1991.
Meneghello L., Libera nos a malo, Rizzoli, Milano, 2000.
Migley M., Perché gli animali, Feltrinelli, Milano, 1985.
Morosini P.L., Perraro F., Enciclopedia della gestione di qualità in sanità, Centro Scientifico Editore, Torino, 1999.
Morrein H., Cost containment: Issues of moral confict and iustice for physicians, in "Theoretical Medicine", 6, 1985.
Morrein H., The MG and the Drg, in "Hastings Center Report", n. 3, 1985.
303
Munson R., Davis L.H., Germ-line gene therapy and the medical imperative, in "Kennedy Institute of Ethics Journal", n. 2,1992.
Orzalesi M., De Caro B., L'alba dei sensi, in "L'Arco di Giano" n. 17, 1998.
Osbome D., Gaebler T., Dirigere e governare. Una proposta per reinventare la pubblica amministrazione, Garzanti, Milano, 1995.
Ovretveit, La qualità del servizio sanitario, EdiSES, Napoli, 1996.
Padiglione P., Pontalti C., "Fra le generazioni modelli di connessione simbolica", in Donati P. (a cura di), Quarto rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995, pp. 187-220.
Padiglione V. et al., Intercultura e servizi alla persona, in "L'Arco di Giano", n. 22, 1999.
Pellegrino E., Thomasma D., Per il bene del paziente. Tradizione e innovazione nell'etica medica, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1992.
Piaget J., Inhelder B., La représentation de l'espace chez l'enfant, PUF, Paris, 1947.
Relman A.S., Assessment and accountability. The third revolution in medical care, "The New England Journal of Medicine", n. 319, 1988.
Ricciardi von Platen A., Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente, Le Lettere, Firenze, 2000.
Rifkin J., L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori, Milano, 2000.
Rilke R.M., Il libro d'ore, tr. di P. De Nicola, Morcelliana, Brescia, 1950.
Roberts M., Breast screening: timefor a rethink?, in "BMJ", vol. 299,1991.
Rose G., The strategy of preventive medicine, Oxford UP, Cambridge (Mass.), 1992.
Rushdie S., I figli della mezzanotte, Garzanti, Milano, 1984.
Sacks O., Risvegli, Adelphi, Milano, 1987.
Sankar A., Patients, Physicians and the contest: medical care in the home, in Lock M. e Gordon D. (a cura di), "Biomedicine examined", Kluwer Ac. Pubbl., Dordreelit, 1988.
Satolli R., Screening HCV: ritirata dopo la grancassa, "Occhio clinico", n. 5 maggio 1997.
Satolli R., Tutto quello che nessuno vi ha mai detto su...: un programma di ricerca, in "Janus", n. 1, 2001.
Savater F., Etica per un figlio, Laterza, Roma-Bari, 2000.
Schneider H., Il piccolo Adolf non aveva le ciglia, Rizzoli, Milano, 1998.
Singer P., Liberazione animale, Mondadori, Milano, 1991.
Slaytor E.K., Ward J.E., How risks of breast cancer and benefits of screening are communicated to women: analysis of 58 pamphlets, in "BMJ", vol. 317, 1998.
Smith A., Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni, tr.it., Einaudi, Torino, 1965 (ed. orig. 1776).
Sontag S., La malattia come metafora, Einaudi, Torino, 1981.
Sontag S., L'AIDS e le sue metafore, Einaudi, Torino, 1989.
Titmus R.M., The gift relationship. From human blood to social policy, Pantheon Books, New York, 1971.
Vegetti Finzi S., Il parto raccontato: pensieri ed emozioni per una società diversa, in "L'Arco di Giano", n. 23,1999.
Visentin M., Verso un ospedale senza dolore, in "L'Arco di Giano", n. 23, 2000.
Vitale A., Le regole del passato per il futuro della ricerca con gli animali, in "L'Arco di Giano", n. 23, V, 2000.
Waitzkin H., Stoeckle J., Information control and micropolitics of health care: Summary of ongoing research project, in "Social Science and Medicine", 10, 1976, pp. 263-276.
Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971.
Weber M., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino, 1948.
WilberK., Grazia e grinta. La malattia mortale come occasione di crescita, Cittadella, Assisi, 1995.
1 Autorefenzialità: “Il concetto si applica a organizzazioni che prendono le loro decisioni consultandosi solo al proprio interno e leggendo solo la letteratura prodotta da argomenti della propria disciplina e/o dal proprio indirizzo culturale. Un esempio clamoroso di autoreferenzialità è rappresentato dalle scuole di psicoterapia, anche se la situazione sta migliorando. Tutte le specialità hanno comunque la tendenza all'autoreferenzialità" (Morosini P.L., Perraro F., Enciclopedia della gestione di qualità in sanità, 1999).
2 "La traduzione esatta della parola privacy (riservatezza? discrezione? tutela della vita privata?) in italiano non esiste. Non credo che sia un caso. La privacy è un bene dell'individuo, ed è un bene valorizzato dove l'individuo è forte e centrale e lo Stato è descritto, per prima cosa, a partire dai limiti che deve avere. La privacy si riferisce a ogni singola vita. Presuppone dunque un ambiente culturale, tradizionale, psicologico in cui una singola vita conti di più dell'insieme collettivo e della società. Privacy implica anche un concetto di solitudine necessaria, in cui il cittadino, in cambio della non ingerenza dello Stato, si impegna alla tutela e alla protezione di se stesso. Il cittadino non chiede e non permette interferenze. Sua è la vita nel bene e nel male" (Colombo, 1998).
3 Una presentazione sintetica della psicologia della Gestalt aperta alla possibile applicazione di questo approccio ad altri campi di interesse, e quindi anche alla bioetica, è quella offerta da F. Perls, R. Hefferline, P. Goodman, Teoria e pratica della teoria della Gestalt, Ubaldini, Roma, 1971, specialmente pp. 42-47.
4 Con il parere: Problemi della raccolta e trattamento del liquido seminale umano per finalità diagnostiche (5-5-1991) il Comitato nazionale per la bioetica ha preso atto della diversità di opinioni morali circa la modalità di raccolta del seme e ha indicato l'opportunità di offrire alternative alla procedura corrente:
"Consapevole del fatto che la raccolta del liquido seminale per masturbazione può comportare ― per una parte dei medici e dei pazienti interessati ― problemi e perplessità di ordine psicologico e di morale personale, oltre che religiosi, il CNB ritiene che:
― esista di fatto una estraneità dell'operatore sanitario in merito al problema morale della raccolta del seme;
― tuttavia deve essere in ogni caso strettamente salvaguardato, nel rapporto medico-paziente, il pieno rispetto delle convinzioni religiose e culturali e della dignità personale del paziente in merito alla raccolta del seme;
― deve essere altresì garantita al paziente la piena informazione su eventuali metodiche alternative scientificamente valide e alle quali egli deve comunque dare il proprio assenso".