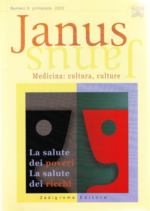
Sandro Spinsanti
La salute dei poveri, la salute dei ricchi
Editoriale Janus 9 - Primavera 2003
«I poveri muoiono prima»: questo slogan sintetico esprimeva, in uno scritto di Giovanni Berlinguer del 1968, la consapevolezza di una situazione di iniquità, sulla quale il partito comunista di allora fondava il suo impegno per la riforma sanitaria. Dieci anni dopo il Servizio sanitario nazionale, a base universalista, sarebbe diventato realtà. Nel frattempo abbiamo avuto anche la riforma della riforma, ma i poveri continuano a morire prima. Non solo i poveri che abitano nelle aree che, ottimisticamente, eravamo soliti chiamare in via di sviluppo, mentre ora dobbiamo qualificarle con realismo come aree del sottosviluppo endemico e irredimibile: anche a casa nostra la divaricazione tra ricchi e poveri si ripercuote sulla possibilità di un reale accesso ai servizi sanitari. Nella prospettiva del decentramento e del federalismo crescono le preoccupazioni per la capacità della sanità italiana di continuare a essere pensata in chiave universalistica. Quanto mai opportuna appare quindi la creazione di un Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane a opera dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica (www.osservasalute.it), al fine di monitorare il delicato passaggio a un’organizzazione sanitaria a base regionale, perché non avvenga a spese del diritto di tutti ad accedere ai servizi sanitari, indipendentemente dal reddito.
Una generosa utopia ha guidato i sistemi sanitari che, pur con tutte le differenze, i Paesi dell’area economicamente sviluppata sono andati costruendo. La ricerca di una società con minori disuguaglianze si è illusa di aver prodotto almeno un risultato concreto: una specie di “socialismo delle casse mutue”. La teoria poteva essere racchiusa in un assioma: nessuno si ammala perché è povero - nessuno diventa povero perché è malato. In teoria; in pratica, la tendenza verso una medicina a due livelli è sempre più marcata: chi ha soldi si può curare meglio. E questo anche nei sistemi sanitari che hanno optato per l’universalismo, come il nostro Ssn. Se un giorno il dolore dei poveri e il dolore dei ricchi dovessero essere trattati diversamente (anche semplicemente per una distribuzione disequilibrata di centri di terapia del dolore nel territorio, con maggiori possibilità per coloro che possono accedere alla medicina privata) dovremmo dichiarare fallito un progetto di più alta civiltà.
Ma che dire delle macro iniquità che si stanno consolidando a livello planetario? I nostri tentativi - pur doverosi dal punto di vista umano e giustificabili secondo il principio etico di giustizia - di assicurare un equo accesso alle opportunità di salute a tutti i nostri cittadini ci appaiono come uno sforzo di “essere morali in un luogo immorale”. Perché insanabilmente immorale è la distribuzione di beni sul pianeta. Abbiamo progressivamente perso la fiducia nella capacità del sistema mondiale di giungere spontaneamente a un riequilibrio. Le disparità non ci appaiono più congiunturali, ma strutturali. Anche le più accurate analisi demografiche ed economiche sono inadeguate a descrivere la realtà che si va imponendo al nostro sguardo. Leggiamo continuamente statistiche che misurano la distanza che separa il mondo dei ricchi da quello dei poveri: la speranza di vita in rapporto al reddito, la mortalità perinatale, il numero giornaliero di bambini che muoiono per infezioni da acqua non potabile… Dopo pochi minuti abbiamo già dimenticato quelle cifre, forse per un inconscio processo di autodifesa che ci impedisce di vedere come la povertà degli uni sia legata alla ricchezza degli altri, la salute dei ricchi alla malattia dei poveri. Sarebbero più appropriati altri approcci e altri linguaggi, per aggirare le barriere della coscienza. Il linguaggio dell’utopia negativa, per esempio. Il mondo nuovo di Aldous Huxley - di cui in questo fascicolo proponiamo la lettura, guidata da un saggio di Dietrich von Engelhardt - prevedeva le disuguaglianze nei confronti della salute non come eventi incidentali, dovuti al gioco delle combinazioni genetiche, ma come una scelta deliberata di politica sanitaria complessiva: mentre gli esseri umani Alfa e le classi dirigenti vengono dotate fin dalla vita in provetta delle migliori opportunità di salute, gli Epsilon e chi dovrà svolgere lavori monotoni e ripetitivi sono irrorati d’alcool quando sono ancora allo stato d’embrione, così da impedire uno sviluppo in pienezza: anche la salute, come l’intelligenza e le altre facoltà superiori, è dosata, concessa in proporzione del posto che si è destinati a occupare in una società ordinata gerarchicamente.
O forse bisognerà rovesciare anche la parvenza stessa di ragionevolezza e ripiegare sulla satira urticante di Jonathan Swift. Per portare allo scoperto le implicazioni della politica e dell’economia della Gran Bretagna nei confronti dell’Irlanda nel XVIII secolo il celebre polemista formulava la sua «Modesta proposta per impedire ai bimbi della povera gente d’essere un peso per i genitori e per il Paese, facendoli invece servire alla pubblica utilità» (1729). Prendendo alla lettera gli economisti che definivano la popolazione «a most precious commodity», Swift propone di utilizzare i bambini in eccesso come nutrimento per i ricchi («Un bambino di un anno, sano e ben nutrito, è il piatto più delizioso, nutriente e salubre, sia stufato che arrosto o al forno o allesso; ed io son certo che andrebbe ugualmente bene in fricassea o in ragù… Voglio ammettere che questo cibo sarà alquanto caro, e perciò molto adatto ai Signori, i quali avendo già divorato molti dei genitori, paiono avere il miglior titolo a divorare i figli»). Solo immagini violente e metafore sgradevoli - una parte dell’umanità che cannibalizza l’altra; la disuguaglianza come progetto deliberato e programmato - hanno la possibilità di aprire uno spiraglio nella nostra coscienza, portandoci a vedere quegli aspetti della realtà che i discorsi razionali ci mascherano.
Pur senza percorrere le strade della satira e del paradosso, questo fascicolo di Janus mette al centro delle riflessioni convergenti sul nostro Obiettivo la divaricazione crescente tra la salute dei poveri e la salute dei ricchi. I poveri - i poveri di salute, oltre che di beni economici - non sono un fenomeno accidentale e marginale nell’organizzazione della convivenza umana: sono un prodotto. Gli articoli che ospitiamo non si limitano a descrivere il fenomeno, ma cercano anche di mettere a fuoco il processo attraverso il quale vengono costruite le condizioni di povertà di salute. Naturalmente il presupposto è che non si assuma, come posizione di partenza, un atteggiamento rassegnato e impotente nei confronti delle ingiuste ineguaglianze. “I poveri li avrete sempre con voi”: questa sentenza evangelica (Matteo, 26,11) può essere vissuta come un alibi per il disimpegno. I contributi di Giovanni Berlinguer e Fabrizio Simonelli ci invitano invece a coniugare l’esercizio di una professione sanitaria con l’impegno a combattere le ingiustizie (nell’orizzonte del movimento per la bioetica) e a rimuovere le condizioni che minacciano la salute, in senso ampio, non solo a combattere le patologie (è l’ideologia fatta propria dall’Oms, tradotta nelle iniziative riconducibili alla Health promotion). Il contributo di Gavino Maciocco illustra ulteriormente le differenze nei confronti della salute che si possono ricondurre alla deprivazione materiale, e che possono essere contrastate con adeguate misure di welfare. Anche chi si occupa di finanziamento sanitario deve convenire che la salute dei cittadini non è correlata a quanto si spende, ma alle scelte che si fanno. La conclusione cui giungiamo, seguendo le argomentazioni proposte da Gino Tosolini, è che la sanità deve essere saldamente guidata dalla politica, intesa nel senso di un orientamento al bene comune: agli economisti che teorizzano il razionamento va contrapposta la saggia politica delle spese giuste, misurate dai livelli di salute prodotti.
La crescita della salute si può favorire spendendo in ambiti non direttamente sanitari. In istruzione, per esempio. Roberto Bucci ci fornisce un’ampia rassegna di studi che documentano come lo studio faccia bene alla salute. Non solo perché l’istruzione fornisce più opportunità di lavoro, e quindi di benessere, ma per l’empowerment che produce nei cittadini. La possibilità di acquisire direttamente informazioni e conoscenze contrasta la dipendenza dalla medicina professionalizzata che Ivan Illich in Nemesi medica (1976) aveva denunciato come una causa della “espropriazione della salute”.
La dipendenza dalle cure professionali e dall’organizzazione sociale dei servizi corre parallelamente all’impoverimento delle relazioni primarie, in particolare quelle che si esprimono nei legami familiari. Tra le diverse forme di povertà, quella della risorsa costituita dai rapporti di cura che hanno luogo nella famiglia è tra le più drammatiche. Almeno nelle società che, come la nostra, si sono incamminate verso la struttura familiare nucleare e hanno ridotto vistosamente il proprio potenziale demografico. Giovanna Vicarelli ci invita a rimettere la famiglia al centro delle nostre considerazioni: non come un surrogato alle carenze dell’organizzazione sociale, ma come un soggetto destinato a gestire in proprio la salute come un capitale comune ai suoi membri. Questo capitale va amministrato con oculatezza, lungimiranza e senso di responsabilità. Nella famiglia l’aspetto della solidarietà perde la connotazione vagamente predicatoria che l’accompagna, per acquisire una configurazione antropologica. La famiglia - in tutte le sue varianti - è ancora la creazione umana meno inadeguata che ci permette di far fronte alle sfide che ci pone la vita, dal suo inizio alla sua fine. Quando la cura si sposta dalla famiglia alle istituzioni, soprattutto nelle condizioni di fragilità che conoscono i disabili, gli anziani e i non autosufficienti, si presentano le situazioni di carenza che descrive Katia Cragnolini. La destinazione del personale sanitario non è solo una questione organizzativa: ancora una volta è l’approccio intellettuale alla disabilità e alla salute che determina le scelte.
Il nostro dossier non trascura, infine, una delle cause meno visibili di povertà: la povertà di potere, in particolare quella che determina le condizioni di lavoro. Mentre Gianfranco Domenighetti indirizza la nostra attenzione allo scenario macrosociale, dove il modello di sviluppo neo-liberista è il principale fattore di insicurezza e precarietà, Francesco Calamo-Specchia affronta quelle prevaricazioni che hanno luogo negli ambienti di lavoro, genericamente chiamate mobbing. Anche queste danneggiano la salute, non solo psichica. Una linea di continuità collega la mancanza di potere con l’impoverimento delle risorse, per concludersi con la perdita della motivazione al lavoro, di cui hanno soprattutto bisogno coloro che esercitano una professione sanitaria. La linea di separazione tra i ricchi e i poveri nei confronti della salute ci appare così molto frastagliata: anche tra i ricchi dei paesi ricchi individuiamo sacche di povertà. Tutte le forme di povertà, comunque si presentino, sfidano il nostro sentire etico e ci provocano per cercare una risposta adeguata.
È contro la povertà che i professionisti della salute si sentono mobilitati, in stato permanente di guerra. Ne siamo dolorosamente consapevoli ora che le porte del tempio di Giano si sono riaperte. La guerra che la medicina ama combattere si fa con i farmaci, non con le bombe. La sua utopia si chiama salute da far crescere, anche se il compito che prevalentemente le viene assegnato è quello di correre dietro alla distruzione, per riparare almeno qualcuna delle tante ferite che vengono deliberatamente inferte ai corpi e alle anime.