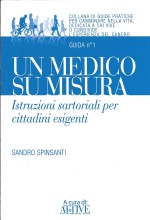
Sandro Spinsanti
UN MEDICO SU MISURA
Istruzioni sartoriali per cittadini esigenti
a cura di Attivecomeprima Onlus
Milano
3
Avere un buon medico, a cui affidarsi, sul quale confidare: per molti è un capitale più prezioso di un conto in banca. Come assicurarselo? Bisogna attribuirlo a un colpo di fortuna? C'è una ricetta più sicura: datti da fare per costruirtelo! Perché il medico ideale al quale aspiri non te lo garantisce il Servizio sanitario nazionale; né cade dal cielo inaspettatamente, come un dono della Provvidenza, che ti fa sentire un privilegiato. Il medico su misura ― "sartoriale", appunto, come un abito fatto si di te e per te ― è il prodotto di un serio lavoro, come ti richiede un grande impegno. Certo, non è vero che ognuno ha il medico che si merita: un dottore indegno di essere chiamato tale ti può capitare in sorte, quando entri negli ingranaggi non sempre controllabili delle strutture sanitarie. Ma qui stiamo parlando del medico che è nella nostra facoltà scegliere. Possiamo fare di più per avere un medico tagliato su misura per le nostre esigenze.
Prima di tutto ti devi prendere le misure. A seconda di cosa intendi per cura, qualche medico ti starà largo, qualche altro stretto... Tu invece aspiri ad avere un medico proprio della tua taglia! Prima di tutto domandati: che cosa ti aspetti dal medico?
Quando la guarigione è... "tornare come prima"
Il medico ti serve per stare bene, d'accordo; ma tu che idea di salute hai in mente? Potresti far parte di coloro che intendono l'opera di cura come il ristabilimento dello stato che precede la malattia. Prima stavi bene, eri sano; poi è sopravvenuta la malattia, con il suo sciame di dolori, sintomi, sofferenze. Non aspiri ad altro che ad abbandonare il tuo stato di malato, a recuperare quello stato felice dal quale sei stato cacciato. La guarigione è per te ― per usare un'espressione latina, che ci dice quanto sia antico e radicato questo atteggiamento ― "restitutio ad integrum", ovvero recuperare lo stato precedente.
4
"La malattia ti ha "de localizzato" e tu non vedi l'ora di poter tornare là dove ti senti a casa. La metafora spaziale è stata utilizzata efficacemente dalla scrittrice Susan Sontag nel libro in cui ha descritto la sua esperienza di cancro del seno:
"Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza, nel regno dello star bene e in quello dello star male. Preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto buono, ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, a riconoscersi cittadino di quell'altro paese "
(Susan Sontag, La malattia come metafora, Einaudi 1979)
Il sogno di chi emigra nel regno della malattia è che la parentesi prima o poi si chiuda, così da poter ritornare dall'esilio. Prima sano, poi malato, poi di nuovo finalmente sano. Grazie all'opera competente dei professionisti della cura.
La malattia, ovvero il sintomo
Una variante di questo atteggiamento di fondo nei confronti della guarigione è il concentrarsi sul sintomo. La guarigione è allora equivalente alla scomparsa del sintomo doloroso. Una illustrazione convincente di questo orientamento verso una guarigione sintomatica è offerta dal film di Mike Leigh Another year, presentato con successo al festival di Cannes del 2010. Il film si apre con una scena che si svolge in un ambulatorio medico. Gerri, la protagonista, è una psicologa del servizio pubblico. Le si presenta una paziente che ha la depressione e l'infelicità scritte in faccia. Soffre d'insonnia e chiede un farmaco per dormire. La psicologa si dice disposta a inviarla a uno psichiatra che può prescriverglielo, ma allo stesso tempo le propone di fare dei colloqui. Fanno parte del trattamento e sono coperti dal servizio sanitario. La paziente è riluttante e solo con grande difficoltà la psicologa riesce a convincerla a presentarsi all'appuntamento. L'incontro ha luogo, ma si conclude con un fallimento: la signora non è disposta a sciogliere nessuno dei nodi con cui è stretta all'angustia familiare e personale che la psicologa ― e noi spettatori con lei ― indovina dietro le occhiaie dell'insonnia: la paziente si dice convinta che, se riuscirà ad avere un sonno regolare per un mese, tutto sarà sistemato. Insiste
5
quindi nella richiesta delle pillole. All psicologa non resta che una ritirata con discrezione.
Qual è la malattia? E quale il rimedio? La paziente e la professionista sanitaria hanno due concezioni diverse della patologia e della cura adeguata; immaginano due diversi percorsi verso la guarigione. Per la signora che ricorre all'aiuto professionale della psicologa il problema si chiama insonnia; quando non avrà più questo sintomo fastidioso, si considererà guarita. La professionista ― in questo caso la psicologa ― ha una diversa rappresentazione della malattia: per lei il male parla attraverso il sintomo, ma non si identifica con il sintomo stesso. Va scoperto e stanato nella profondità dove si nasconde, affinché la persona possa camminare verso la guarigione. Dissente dalle categoria di patologo/terapeutico che il paziente si è costruito, perché vuol portarlo a un modello più alto di salute.
Il medico sotto il segno di efficacia ed efficienza
Se ti sei preso le misure e hai riconosciuto che la tua idea di guarigione equivale a una RIPARAZIONE ― come ritorno allo stato precedente alla malattia o come semplice eliminazione del sintomo― il "medico su misura" per te avrà soprattutto le caratteristiche di competenza ed efficacia. Non c'è da perder tempo. Qualche volta perché il trattamento è efficace solo se tempestivo (quante volte ci rammarichiamo di aver rimandato una visita di controllo o di aver trascurato un sintomo...!); in ogni caso perché il soggiorno nel regno della malattia è spiacevole. Nel medico apprezzi la capacità di eliminare i tempi morti, di saltare gli estenuanti passaggi burocratici (vorrei vedere...!), di accelerare il processo di cura che porta alla guarigione.
Il medico giusto è per te il medico competente: non ti rivolgerai a un oculista per una frattura al piede!
Non è necessario che qualcuno ti raccomandi di evitare gli incompetenti; sai che ne esistono, in medicina come in qualsiasi altra attività umana, e cerchi di evitarli. Ti informi presso amici e conoscenti. Oggi, poi, hai la possibilità di sfruttare la miniera di informazioni offerte da internet. Se sei abbastanza accorto da evitare le trappole (anche via internet va sottoposto a un controllo di qualità!), sei in grado di sceglierti il professionista che ha la maggiore esperienza nel problema specifico che è il tuo, e il più alto
6
numero di successi. In breve, ti sei fatto il medico su misura delle tue esigenze, che sono quelle della più rapida ed efficace scomparsa di ciò che per te merita il nome di malattia.
E se il medico al quale ti affidi fosse un discepolo del Dottor House? Beh, non sarebbe un dramma. Forse hai maturato una certa insofferenza per molti discorsi che circolano sulla "umanizzazione" della medicina... Non ti interessa il medico buono, ma il buon medico! E non escludi a priori dal novero dei buoni medici coloro che, come di Dottor House, proclamano di essere diventati medici per curare le malattie, non i malati... Perché, posto di fronte alla sua alternativa: "Preferiresti un medico compassionevole che ti tiene la mano ma ti lascia morire, o uno che ti tratta male, ma ti salva la via?", sceglieresti senz'altro la seconda ipotesi. Certo, non senza osservare che si tratta di falsi dilemmi: ciò che è auspicabile è un buon medico che sia anche buono! Tuttavia non puoi che sottoscrivere l'affermazione di Alexandre Dumas figlio: "Il buon chirurgo opera con le mani, non con il cuore".
Se la malattia è cronica
Supponiamo ora che l’auspicato ritorno alla salute, intesa come recupero del felice stato precedente alla malattia, non sia possibile. È un'ipotesi fondata non sulla malevolenza, né su una sfiducia nelle capacità terapeutiche della medicina, ma sul realismo: le malattie croniche sono sempre più numerose.
Già sul finire del XX sec. una ricerca internazionale coordinata dal prestigioso Hastings Center americano indicava, tra le priorità della medicina nel nuovo secolo che era alle porte, l'assistenza ai malati per i quali non è prevista la guarigione:
Nelle società sempre più vecchie del nostro tempo, dove le malattie croniche sono la causa più comune di dolore, di sofferenza e di morte ― dove, in altre parole, le infermità sono destinate a continuare indipendentemente da quello che fanno i medici ― l'assistenza alla persona, il prendersi cura di lei, diventa ancora più importante, riacquistando un primato dopo un'epoca in cui è apparsa una seconda scelta. Nei casi di infermità cronica i pazienti devono essere aiutati a dare un senso personale alla propria
7
condizione, ad affrontarla e a conviverci, magari in permanenza. A sessant'anni hanno per lo più una malattia cronica, e a ottanta ne hanno tre o più. Dopo gli ottanta almeno nella metà dei casi hanno bisogno di un aiuto significativo per far fronte alle comuni attività della vita quotidiana. Nei confronti dei malati cronici, che devono imparare ad adattarsi ad un sé nuovo e alterato, il lavoro del personale medico dovrà concentrarsi non già sulla terapia, ma sulla gestione della malattia ― dove per "gestione" si intende l'assistenza psicologica empatetica e continua a una persona che, in un modo o nell'altro, deve accettare la realtà della malattia e conviverci. Qualcuno ha osservato che la medicina a volte deve aiutare il malato cronico a forgiarsi una nuova identità
(Hastings Center, Gli scopi della medicina, 1997)
In parole semplici, la guarigione in questo scenario equivale a una MANUTENZIONE della salute: si tratta di continuare a vivere con la patologia e nonostante essa, proseguendo la propria parabola esistenziale.
Il modello "manutenzione della salute" si realizza al massimo grado nelle malattie croniche. Ma non solo: anche nel caso di patologia per le quali ci si aspetta una risposta risolutiva da parte della medicina la partecipazione attiva da parte del paziente è auspicabile. Ha fatto il suo tempo quel modello di relazione con i professionisti della salute nel quale questi si rapportavano con il malato come i genitori con i bambini piccoli: tutto quello che era richiesto al malato era di mettersi nella mani dell'esperto e seguire le sue indicazioni. Le domande da parte del malato ― sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle alternative terapeutiche ― erano considerate fuori luogo ("Lei è in ospedale per guarire, non deve fare domande", era solito dire un primario ai pazienti che gli chiedevano spiegazioni...). Il paziente ideale era, per definizione, sottomesso e obbediente.
Il buon paziente dell'epoca moderna: adulto e responsabile
Questo modo di praticare la medicina è stato delegittimato dal cambiamento culturale che riconosce e favorisce "l'autonomia" del cittadino nelle scelte sanitarie che lo riguardavano. La traduzione pratica di questa rivoluzione si chiama "consenso informato": il medico non è autorizzato
8
a intraprendere nessun intervento diagnostico o terapeutico sul paziente, anche se quello che intende fare apporta un indiscusso beneficio, se prima non lo ha chiaramente informato e non ha ottenuto un suo esplicito consenso. Un documento elaborato dal Comitato Nazionale per la Bioetica ha fotografato il cambiamento intervenuto di recente nella nostra cultura in questi termini:
"Il consenso informato, che si traduce in una più ampia partecipazione del paziente alle decisioni che lo riguardano, è sempre più richiesto nelle nostre società: si ritiene tramontata la stagione del "paternalismo medico" in cui il sanitario si sentirà, in virtù del mandato da esplicare nell'esercizio della professione, legittimato a ignorare le scelte e le indicazioni del paziente, e a trasgredirle quando fossero in contrasto con l'indicazione clinica in senso stretto"
(Comitato Nazionale per la Bioetica,
Informazione e consenso all’atto medico, 1992)
Una illustrazione convincente del cambiamento avvenuto in questi anni è offerta dal progetto elaborato dall’AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici), finalizzato a diffondere la cultura dell’umanizzazione delle cure oncologiche in Italia. Il progetto si chiama HUCARE, e sta per HUmanition of CAncer caRE. L’umanizzazione non è identificata con i buoni sentimenti, né con un atteggiamento accogliente ed empatico da parte del curante, ma ha il suo centro di gravità nell’informazione. Solo se questa è corretta ed esaustiva, così da mettere il malato in grado di partecipare attivamente al processo decisionale, si può qualificare come "buona" la cura fornita. Per questo le domande da parte del paziente vengono non solo tollerate, ma favorite. Nel sito internet del progetto ― avviato nel 2008; nel frattempo più di 30 centri oncologici in Italia sono stati coinvolti ― si trova l’invito ad andare preparati agli incontri con il medico: "Hai domande da fare al tuo oncologo? Scarica la lista".
Ecco un chiaro indicatore per sapere se sei di fronte a un medico che fa per te: valutare se e quanto favorisce le domande; se ti fa cadere dall'alto il suo sapere o cerca di condividerlo; se sollecita l'espressione delle tue emozioni e delle tue preferenze, oppure ti fa ammutolire trascinandoti nell'ambito del linguaggio tecnico e delle statistiche.
9
Quando la malattia è occasione di crescita
"Tornare come prima"; "continuare la propria vita"...: sono concezioni della salute molto diffuse, che richiedono una adeguato rapporto con chi eroga servizi di cura. Ma l'esperienza ti ha forse portato a riflettere che c’è anche un altro modo di mettere in rapporto salute e malattia. Possono essere concepite non solo come territori separati da un netto confine, ma anche come stati interconnessi, così che uno confluisce nell’altro. Non solo anche la malattia può essere più o meno grave, ma anche la guarigione può realizzarsi in modi e gradi diversi. Soprattutto la salute può essere intesa come uno stato che si estende dal ristabilimento dell’equilibrio fisico precedente alla malattia a una nuova condizione, che riguarda la persona nella sua totalità. Il filosofo Friedrich Nietzsche per questo nuovo stato ha coniato l'espressione "Grande Salute". Dopo la RIPARAZIONE e la MANUTENZIONE, troviamo una tersa accezione di salute, intesa come CRESCITA.
La crescita personale non equivale a un processo lineare-cronologico: si può essere vecchi senza essere mai cresciuti, così come è possibile che dei minori ― e anche dei bambini! ― abbiano già realizzato una grande crescita personale. Per descrivere la maturità, possiamo far ricorso alla metafora dei piani superiori di una casa proposta da Kierkegaard
"Pensiamo a una casa, composta di scantinato, pianterreno e primo piano, abitata o adibita in modo tale che ci sia una differenza di ceto tra gli inquilini di ciascun piano; e confrontiamo l'essere umano con una simile casa: è tanto doloroso e ridicolo il caso della maggior parte degli uomini che, nella loro casa, preferiscono vivere nel sottosuolo... E non solo preferisce vivere nel sottosuolo, no ma lo ama a tal punto che si adire se qualcuno gli propone di occupare il piano buono che sta lì a vuoto a sua disposizione perché è pur sempre a casa sua che vive"
(Soeren Kierkegaard, La malattia mortale, in Opere, Sansoni 1962)
In questa prospettiva i limiti che la malattia e la stessa decadenza fisica connessa alla corporeità ci costringono ad attraversare ci appaiono come soglie che si aprono su nuovi territori. Le limitazioni nella vita ― e il "pathos" che le accompagna ― sono opportunità di maturazione della persona. Ovvero un’occasione, che si può cogliere o no, di diventare l'essere
10
pieno che potenzialmente siamo: quell'uomo e quella donna, cresciuti nella piena misura della propria umanità,che siamo chiamati a essere. In questo territorio non si può essere introdotti a forza (così come non si può far crescere una pianta tirandola su dal terreno...].
In termini più colloquiali, possiamo dire che la condizione di malattia e i processi di cura che si mettono in atto contro di essa si aprono su scenari molto diversi. Alcune persone passandovi attraverso diventano migliori: il crogiolo della sofferenza la purifica, così che la "Grande Salute" a cui pervengono è anche la realizzazione di un essere umano nelle sue più alte potenzialità. Altre, invece, nella malattia rivelano lati oscuri: lottando per la sopravvivenza fanno ricorso a qualsiasi risorsa, non esitando a prevaricare sugli altri, ricorrendo a comportamenti tirannici e facendo scelte che non tengono in minima considerazione i bisogni altrui.
Una storia esemplare
Il racconto di un medico, che ha accompagnato le decisioni cliniche di una paziente confrontata con scelte cliniche che incidevano profondamente nella vita sua e dei suoi familiari, ci aiuta a dare concretezza al legame che intravediamo tra la cura e l'autorealizzazione della persona. È la storia personale della signora Rosa. Che è una paziente indecisa. Lei, sempre così combattiva contro la malattia ― la Sclerosi Laterale Amiotrofica, che le è stata diagnosticata due anni fa ― e così collaborativa con i medici. Ora il pneumologo che la segue l'ha informata che la malattia è progredita: è urgente procedere alla tracheotomia e alla ventilazione meccanica.
La signora Rosa, ricoverata per la dispnea ingravescente in un reparto per insufficienti respiratori cronici, è stata informata sulle sue condizioni cliniche, sul loro sviluppo e sulle scelte che le si prospettano. Lei stessa ha insistito per conoscere il decorso della malattia; e il medico l'ha incoraggiata a porre tutte le domande che riteneva opportune. Tutt'e due, il medico e la paziente, si sono incontrati nel terreno che meglio esprime la medicina dell'epoca moderna, rispettosa dell'autonomia del malato: domande e risposte, disponibilità a condividere conoscenze, perplessità, incertezze nel corso del tempo. Il medico ha spiegato alla signora Rosa che per la sua malattia non esiste una cura efficace e risolutiva: l'insufficienza respiratoria è progressiva; tuttavia la ventilazione meccanica le permetterebbe
11
di sopravvivere. Dovrebbe farsi tracheotomizzare ed attaccare a un ventilatore meccanico. Da un punto di vista clinico sarebbe dimissibile dopo qualche settimana e potrebbe andare a casa. Assistenza domiciliare? Beh, ci saranno da affrontare difficoltà burocratiche per ottenerla, ma non sarà impossibile. Solo che l'assistenza, nelle sue condizioni, sarà complessa e il servizio pubblico, anche se disponibile, richiederà di essere supportato e integrato da altre forme di assistenza che la famiglia dovrà assicurare. La signora Rosa sa anche che la progressione della malattia neurologica di base porterà alla tetraplegia, cioè alla immobilità totale. Naturalmente saranno necessari tutti i presidi necessari per farvi fronte e prevenire piaghe da decubito, polmoniti ecc... Inoltre le sue secrezioni dovranno essere aspirate e dovrà essere alimentata artificialmente con la PEG. Sarà, insomma, un malato molto complesso, gravemente compromesso, dipendente in ogni sua funzione vitale da aiuti altrui. Potrà sopravvivere, persino a lungo, tenendo conto della ingravescente immobilità anche del viso, che alla fine renderà impossibile lo stesso movimento degli occhi, ultima modalità di comunicazione rimasta, nonostante l'aiuto del computer.
La signora Rosa ha una figlia. È molto affezionata e disposta a fare tutto per far sopravvivere la madre. Ma ciò che l'aspetta è pesante: dovrà forse abbandonare il lavoro o cercare ― con estrema difficoltà ― di ottenere un part-time. Ha anche due bambini piccoli, che hanno bisogno di accudimento. L'assistenza da fornire alla madre di ripercuoterà pesantemente sulla sua famiglia.
Ecco il motivo dell’indecisione della signora Rosa. Apprezza la vita, non vuol morire; ma la sua sopravvivenza sarebbe pagata a un prezzo altissimo da sua figlia: non in denaro, ma in termini di opportunità esistenziali. Non sappiamo come sta formulando dentro di sé il dilemma che la blocca, di fronte alle benevole pressioni del medico che sollecita la sua decisione a sottoporsi alla tracheotomia. Potremmo anche immaginare che Rosa sia stata professoressa di letteratura americana. In questo frangente le torna in mente il verso con cui Edgar Lee Masters conclude, nell'Antologia di Spoon River, la poesia dedicata a Lucinda Matlock: "It takes life to love life". Ecco: lei ama la vita, ma per proseguirla dovrebbe prendere un pezzo della vita di sua figlia e della sua famiglia. Solo nelle affermazioni retoriche di chi proclama la santità ― e quindi l'intangibilità ― della vita,
12
questa non costa niente: la vita ha un prezzo, cioè la vita stessa di qualcun altro. La signora Rosa, che ha una rigorosa vita morale, non se la sente di chiedere questo sacrificio a sua figlia (che pur la ama, e sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa per impedire che la madre muoia).
Dopo una notte insonne, la malata chiama il medico e gli comunica che ha deciso: non si farà tracheotomizzare. E il medico le assicura la sua assistenza per accompagnarla sino alla fine, contrastando i sintomi e impedendole di soffrire mediante l'impiego delle migliori risorse della medicina palliativa.
La vicenda della signora Rosa ci fa conoscere una persona che ― per utilizzare la metafora di Kierkegaard ― dalla cantina è salita ai piani alti della casa: le sue decisioni non esprimono solo la ricerca di un prolungamento della propria vita, ma tengono conto anche degli altri. E arrivano a un'autolimitazione nella quale si traduce un'alta personalità morale.
Il medico che ha a cuore e rispetta la vita morale del malato
Nella ricerca della salute gli esseri umani possono dar corpo al meglio e al peggio della sostanza morale di cui sono fatti. Quale tipo di medico può accompagnarci in questa terra incognita dell'autorealizzazione personale? Non è certo compito del medico far di noi degli esseri umani migliori. Lo afferma in modo pungente il dottor Gillespie, nella storica serie televisiva Il Dottor Kildare: "Il nostro lavoro consiste nel tener viva la gente, non nell'insegnargli come vivere". D'accordo; ed è bene non confondere i ruoli. Tuttavia, se siamo consapevoli che nelle nostre scelte di salute stiamo scrivendo anche la nostra storia in senso più alto, ci appoggeremo piuttosto a professionisti che hanno antenne per questa dimensione. Utilizzeremo al meglio, quando si tratta di sconfiggere la malattia, la competenza di quei professionisti che Tiziano Terzani chiama, con ruvida bonomia, medici-aggiustatori: "Gli aggiustatori curavano il cancro, non il mio cancro". Ma come compagni di viaggio, sensibili ed empatici, preferiremo medici come quello che ha accompagnato e favorito le scelte della signora Rosa: che non decide per lei, ma con lei; che le offre informazioni e sostegno affinché le sue decisioni siano il coronamento, non la caricatura della sua esistenza.
13
Epilogo
TRA MEDICO E PAZIENTE:
NUOVI DIRITTI, NUOVI DOVERI
Il nuovo profilo della pratica medica non richiede solo un professionista sanitario diverso, ma anche la formazione di un paziente più consapevole del compito che incombe su di lui nel cercare la giusta risposta ai problemi di salute in collaborazione con il professionista sanitario. Il "buon paziente" dei nostri tempi non è colui che tace, si sottomette e segue alla lettera le prescrizioni. Essere un buon paziente oggi richiede intelligenza, volontà e un certo numero di virtù. Per questo, se sei malato, devi ricordare che:
● un buon medico non esiste senza un buon paziente. Si può fare molto, in quanto pazienti, per migliorare lo stato della medicina, cominciando a disporsi a essere un buon paziente. Gli orientali dicono: "Quando il discepolo è pronto, arriva il maestro'"
● il dottore non sceglie i suoi pazienti: è il paziente che sceglie il dottore. È un potere che chiede di essere esercitato con senso di responsabilità. Mettere tutto l’impegno per trovare il medico adatto è una delle forme più produttive di investimento: "Un buon medico salva, se non sempre dalla malattia, almeno dai cattivi medici" (Jean Paul)
● il buon paziente non è quello che sopporta e tace. Parlare della propria malattia non è soltanto un diritto, ma un dovere
● non lasciarti intimidire dalle apparecchiature diagnostiche e dai macchinari sofisticati. Anche il medico più orientato in senso tecnologico ha bisogno del racconto del paziente per capire che cosa la malattia significa per lui
● la medicina non è una scienza esatta. Anche il medico più competente non può escludere un margine di errore o una zona di incertezza. Il medico che ti consiglia di acquisire un parere complementare (o "second opinion") non è meno bravo di altri: dimostra invece alta professionalità
● il medico non è né un padrone, né un robot. Lui non può esigere da te un atteggiamento servile; tu non devi cercare di ridurlo a puro esecutore dei tuoi desideri
14
● "non fare del tuo medico il complice per piccole frodi (certificati compiacenti, ricette "facili" ecc.): quello che potresti guadagnare su un piano, lo perdesti su quello della stima reciproca e della qualità del rapporto
● diffida di un medico che ti chiede di sottoscrivere un modulo senza offriti un'esauriente spiegazione di che cosa ti stia proponendo. Lui sta forse eseguendo quella che ritiene una semplice procedura burocratica, ma per te capire è essenziale per poter dare un consenso vero, che ti permetta di partecipare alle decisioni cliniche
● dopo la prestazione, tu hai pagato il medico; o il medico riceve lo stipendio dal SSN. Bene: si tratta infatti di un'opera professionale, non di un'azione caritativa. Ciò non ti impedisce, però, di mostrare la tua gratitudine a chi si è occupato della tua salute e l'apprezzamento per il suo lavoro. Questa piccola "gratuità" può avere effetti preziosi sulla relazione
● la medicina, oggi, può fare molto. Qualche volta può fare perfino troppo, per esempio prolungando la vita in condizioni che il paziente considera indegne. Per prevenire queste situazioni, fai conoscere al medico qual è per te il confine accettabile tra la buona terapia e l'accanimento terapeutico
● tra il paziente e il medico ci possono esser divergenze insanabili in mate"ria di scelte etiche. Il medico non deve fare violenza alla tua coscienza; ma neppure tu devi farla alla coscienza del medico. Esaurite tutte le possibilità del dialogo, non ti resta che cambiare medico.
MODELLI DI BUONA CURA
|
|
LA RIPARAZIONE
|
LA MANUTENZIONE |
LA GRANDE SALUTE |
|
OBIETTIVO SALUTE
|
"tornare come prima" |
continuare a vivere, malgrado la malattia, con la malattia
|
diventare un essere umano completo (la salute come autorealizzazione) |
|
LA PATOLOGIA TIPICA
|
malattie acute e reversibili |
malattie croniche |
qualsiasi malattia |
|
I VALORI PERSONALI DEL PAZIENTE
|
irrilevanti |
importanti |
essenziali |
|
IL BUON MEDICO
|
competente e autorevole |
dialogante e affidabile |
disponibile e rispettoso |
|
IL BUON PAZIENTE
|
docile e obbediente (compliant) |
informato e collaboratore |
protagonista consapevole |
|
CHI PRENDE LE DECISIONI
|
il medico "in scienza e coscienza" |
il medico e il malato insieme (consenso informato)
|
la persona malata con autonomia e responsabilità |