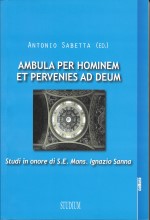
- Critica della ragione medica
- Lo schermo di Ippocrate
- Arte Terapia
- L'occhio clinico e l'occhio dell'artista
- La narrazione in medicina
- Il corpo nella medicina contemporanea
- Nostalgia dei maestri
- Medicina narrativa
- Volontariato medico in Africa: una cura per la demotivazione?
- La sociologia della salute nell'orizzonte delle medical humanities
- Due settimane ancora
- Provocato rispondo
- Schede bibliografiche
Sandro Spinsanti
IL CORPO NELLA MEDICINA CONTEMPORANEA: IL CONTRIBU-TO DELLE MEDICAL HUMANITIES
in Antonio Sabetta (ed.), Ambula per hominem et pervenies ad Deum, Studi in onore di Mons. Ignazio Sanna
Edizioni Studium, Roma 2012
pp. 177-187
177
Un’antropologia del corpo è implicita in qualsiasi pratica della medicina. Costituisce, allo stesso tempo, un criterio per valutarne la qualità etica: a seconda che tratti o non tratti adeguatamente il corpo, avremo il crinale che distingue la buona dalla cattiva medicina. Raramente, tuttavia, il corpo viene tematizzato quale pietra di paragone della qualità dei processi di cura. In primo piano nel dibattito pubblico emergono altre categorie, come la richiesta di “umanizzare” la medicina e di dare al paziente la “centralità” nel trattamento medico; ovvero dalla rivolta contro il “riduzionismo” in medicina. Da queste tematiche dobbiamo farci guidare, cercando di rendere esplicita la valutazione del corpo che tali progetti di intervento sulla pratica della medicina veicolano.
1. La richiesta di “umanizzazione” della medicina
Il tema di maggior successo mediatico nella valutazione dei servizi sanitari è quello diffuso dallo slogan della “umanizzazione”. Più esattamente, dal dittico costituito dall’accusa di “disumanizzazione”, da una parte, e dalla richiesta di “riumanizzazione”, dall’altra. Sia l’accusa che la richiesta hanno diversi significati. Quello più corrente ha a che fare con la sensazione che, parallelamente all’accrescersi delle potenzialità terapeutiche della medicina, si è andata atrofizzando la capacità degli operatori sanitari di essere presenti, in quanto esseri umani dotati di sensibilità ed emozioni, alla persona del malato. In breve, si rimprovera
178
ai professionisti della sanità di saper “curare”, ma di non saper o voler “prendersi cura”.
Questo discorso sulla disumanizzazione/umanizzazione della medicina tende a declinarsi sul piano della “morale”. Nel linguaggio comune con questo termine non si intende la disciplina filosofica che considera il comportamento umano alla luce dei valori (bene/male, giusto/ingiusto, utile/dannoso), bensì, in senso più riduttivo, quell’atteggiamento che porta a giudicare il comportamento altrui in base a determinate attese. Accusando medici e infermieri di disumanizzazione, in pratica “si fa loro la morale”. Si rimprovera al personale sanitario di non ispirarsi agli ideali filantropici tradizionalmente connessi con le professioni terapeutiche. Anche l’esaltazione della professione del medico e dell’infermiere come “missione” conduce allo stesso risultato: il sanitario, confrontato con un modello troppo idealizzato ― qualcuno si spinge fino a considerare le professioni sanitarie come una specie di sacerdozio della salute, e quindi si aspetta da chi le esercita la stessa dedizione altruistica propria dei sacerdoti ― tende a ripiegare sulla rassegnazione o sul cinismo.
Simili campagne di moralizzazione, che accompagnano oggi come un controcanto l’enfatizzazione delle notizie di “malasanità”, non danno i risultati attesi da chi le conduce. Rischiano invece di essere controproducenti: i sanitari, sentendosi sotto accusa, si chiudono in se stessi corporativisticamente, oppure rispondono alle critiche, percepite come aggressioni ostili, con altrettanta ostilità, riversando sui pazienti la responsabilità per il degrado dei rapporti. Sulla base di tale reciproca incomprensione non si può costruire nessun progetto per innalzare la qualità della pratica medica. Si scava, piuttosto, un fossato sempre più ampio di diffidenza, proprio in un ambito in cui la fiducia è il valore principale.
Per una questione di giustizia, e non per una tattica di captatio benevolentiae, a coloro che lavorano nell’ambito della sanità bisogna anzitutto tributare il riconoscimento che non svolgono un lavoro come gli altri: per la particolare situazione del malato ― talvolta in lotta drammatica per la vita e la salute, in stato di particolare tensione emotiva sempre ― i sanitari sono coinvolti e sollecitati a una partecipazione umana che supera quella di qualsiasi altro lavoro. Quando i discorsi sull’umanizzazione della medicina pigiano esclusivamente sul pedale dei sentimenti, colpevolizzando al tempo stesso i sanitari di non mettere abbastanza cuore in quello che
179
fanno, la morale, da terreno saldo di consenso sulla base della condivisione degli stessi valori, rischia di tramutarsi in sabbie mobili.
Una particolare insidia è insita nelle argomentazioni moraleggianti di tipo religioso. Quando, ad esempio, si presenta unilateralmente il lavoro sanitario sotto la metafora del buon samaritano e a medici e infermieri viene richiesto un comportamento tutto modulato sull'oblatività, l’abnegazione e l’amore per il prossimo, si incrementa inevitabilmente il senso di inadeguatezza. Di qui è poi facile scivolare in cronici sensi di colpa. Ciò che ne consegue è per lo più una brusca interruzione di contatto con la proposta di un ideale così manifestamente lontano dal poter essere tradotto in atto. Da questo punto di vista, gli operatori che non vogliono più sentir parlare di “umanizzazione” esprimono piuttosto un giustificato rifiuto delle “prediche”, nel senso angustiarne e oppressivo del termine.
Un altro portale d’ingresso alla richiesta di “umanizzazione” della medicina è costituito dalle accuse di distanza dai bisogni emotivi del malato a causa della crescente tecnicizzazione degli interventi diagnostico/terapeutici. E diventato un luogo comune contrapporre la medicina altamente tecnologica (high tech) a quella con contenuti molto umani e coinvolgenti (high touch).
La risposta alle nuove tecnologie biomediche, con il loro pericolo intrinseco di freddo distacco, viene individuata in una vicinanza che ha funzione di compensazione. Il ruolo di “contatto” è affidato per lo più alla professione infermieristica, con il risultato globale di una maggiore concentrazione del medico sulle dimensioni tecniche della cura. La pratica medica, tutta rivolta all’efficacia della prestazione, si sente autorizzata in tal modo a essere sempre più fredda, in quanto ci si aspetta che la calda presenza dell’infermiere compensi le sue carenze. Tra curare e prendersi cura viene così a instaurarsi una dicotomia, che giunge a immaginare un “curare” (come impresa eroica, hard) dispensato dal “prendersi cura” (attività lasciata a professioni più soft, dedite alla dimensione relazionale). Anche l’umanizzazione della medicina che accettasse la separazione sistematica tra l'high tech e l'high touch, puntando solo su quest’ultimo per rispondere al senso di estraneità crescente dei pazienti, finirebbe per costituire un tradimento della causa. L’affermazione antropologica forte, secondo cui il corpo è la persona e non una parte di essa, delegittima una pratica della medicina modellata implicitamente
180
su una forma di dualismo, quand’anche al corpo venissero riservati i trattamenti più efficaci di cui la scienza medica dispone.
Un’efficace descrizione del malessere che suscita nei nostri contemporanei una pratica della medicina che consideri il corpo da curare semplicemente come “oggetto” da curare è stata fornita dal racconto autobiografico di Tiziano Terzani: Un altro giro di giostra. Il celebre giornalista sviluppa una polemica benevola nei confronti dei medici dell’efficientissimo ospedale americano nel quale si è sottoposto alle cure per il cancro. Li chiama “aggiustatori”, per il rapporto che instaurano con il corpo staccato dalla persona: «Io ero un corpo: un corpo ammalato da guarire. E avevo un bel dire: ma io sono anche una mente, forse anche uno spirito e certo sono un cumulo di storie, di sentimenti, di pensieri ed emozioni che con la mia malattia hanno probabilmente avuto un sacco a che fare! Nessuno sembrava volere o poterne tenere conto. Neppure nella terapia. Quel che veniva attaccato era il cancro, un cancro ben descritto nei manuali, con le sue caratteristiche di incidenza e di sopravvivenza, il cancro che può essere di tutti. Ma non il mio! A me come persona i bravi medici ― aggiustatori chiedevano poco o nulla. Bastava che il mio corpo fosse presente agli appuntamenti che loro gli fissavano per sottoporlo ai vari “trattamenti”» 1.
La personalizzazione della cura, che ai nostri giorni viene richiesta come correttivo della pratica medica corrente, è l’esigenza avanzata dal movimento per l’“umanizzazione” della medicina, liberato dalle sue ambiguità moralistiche. Nella sua essenza, richiede un rapporto diverso con il corpo malato.
2. Il recupero antropologico del soggetto
La richiesta di “umanizzazione della medicina” può essere intesa, in un’accezione più radicale rispetto a quella che abbiamo finora considerato, come la richiesta di un punto di vista sull’uomo, sano o malato, diverso da quello proprio delle scienze naturali, che la medicina ha assunto da quando si è andata strutturando come scienza, a partire dalla
181
metà del XIX secolo. Il ripensamento della medicina è legato al superamento del positivismo come modello più alto del sapere.
Il positivismo è una teoria filosofica elaborata nel XIX secolo, ma che ha influenzato anche il secolo successivo. Inteso come rispetto dei fatti osservati, il positivismo costituisce una delle acquisizioni della filosofia della scienza a cui non si può rinunciare. Ma l’uomo di scienza, legandosi al positivismo, aveva creato situazioni parziali e tendenziose, illudendosi sulla professata obiettività impersonale dei fatti. Ciò si verifica soprattutto quando l’oggetto della scienza è l’uomo.
Lo spirito del positivismo è reso letterariamente dalla dichiarazione di fede che Charles Dickens nel romanzo Tempi moderni mette in bocca a un personaggio, Thomas Gradgrind, un direttore di scuola che si compiace di essere un uomo “eminentemente pratico”. Il romanziere immagina che, rivolgendosi a un gruppo di signore presenti in una scuola, il personaggio, campione del positivismo, rivolga loro questo discorsetto:
Ora quello che voglio sono Fatti. Insegnate a questi ragazzi e a queste ragazze Fatti e niente altro. Solo di Fatti abbiamo bisogno nella vita. Non piantate altro e sradicate tutto il resto. Solo coi Fatti si può plasmare la mente degli animali che ragionano: il resto non servirà mai loro assolutamente nulla. Questo è il principio su cui ho allevato i miei figli, e questo è il principio su cui ho allevato questi fanciulli. Tenetevi ai Fatti, signore! 2
Applicato alla medicina, il positivismo tendeva a concepirla come scienza pura, fondata su fatti, su nudi fatti. La medicina si proponeva di essere neutra o indifferente rispetto alle questioni collegate ai valori; la scienza medica, nella sua purezza, si riteneva collocata al di là del bene e del male.
Assumendo il modo di conoscere proprio delle scienze naturali, la medicina ha cercato di adeguarsi a quella forma particolare di conoscenza che è fondata sulla razionalità e si acquisisce con l’osservazione e l’esperimento, secondo una particolare metodologia “critica”. In quanto scienza naturale, la medicina procede empiricamente. La sua base è costituita da fisiologia e patologia; disfunzione e malattia sono considerate come conseguenze di disturbi di processi materiali-organici. In
182
questa prospettiva, la malattia non è più qualcosa che capita all’uomo nel suo insieme, ma qualcosa che succede ai suoi organi. Lo studio delle cause della malattia si restringe alla ricerca di mutamenti locali nei tessuti, nelle strutture cellulari e nella stessa costituzione delle molecole biochimiche fondamentali. Il fatto morboso si ritiene compreso quando si può spiegare stabilendo il rapporto causa-effetto, sulla base delle leggi che regolano i fatti fisico-chimici.
Da quando la medicina si è organizzata come scienza della natura, è cominciato per l’arte di guarire un periodo di splendore, sotto l’egida dell’efficacia e di realizzazioni mai raggiunte in precedenza. I progressi della chirurgia, della batteriologia, della farmacologia non sarebbero stati ottenuti, se la medicina non si fosse allineata tra le scienze della natura. Proprio questi successi, fungendo da rinforzo positivo, hanno portato a consolidare la convinzione che la strada imboccata fosse quella giusta, impedendo di rendersi conto dei pericoli insiti in essa. Senza misconoscere i momenti positivi della concezione natural-scientifica (in particolare il principio della ricerca empirica esatta e il significato fondamentale del lavoro di indagine di tipo fisiologico e biochimico), si deve però convenire che, quando l’uomo è considerato semplicemente come un pezzo di natura tra gli altri, si opera una violenta mutilazione antropologica.
La crisi nella medicina non sarà superata finché non avremo rifiutato di considerare come esclusivo il punto di vista delle scienze della natura. L’“umanizzazione” da introdurre nella pratica dell’arte sanitaria è più radicale del semplice recupero degli aspetti filantropici o umanitari ― nel senso che abbiamo analizzato sopra ― da includere, oltre a quelli di competenza professionale, nel rapporto con il malato. La disposizione interiore dell’oblatività e le virtù personali sono ovviamente necessarie per l’esercizio dell’arte sanitaria: vir bonus, sanandi peritus, definiva il medico la tradizione ippocratica (dove “bonus” indica una costellazione di qualità che si aggiungono alla perizia professionale). Le stesse esigenze valgono per chiunque ― infermiere, tecnico, ausiliare ― avvicini il malato. Ma la “bontà” dell’operatore non basta, da sola, a umanizzare la medicina, se questa non recupera la prospettiva della totalità dell’essere umano.
Ciò vuol dire, in pratica, che il sapere mutuato dalle scienze della natura deve essere abbinato a quello che è specifico delle cosiddette
183
“scienze umane”: la storia, la sociologia, la psicologia, l’antropologia culturale, il diritto, la filosofia, la teologia, solo per menzionare le più importanti. Esse meritano il nome di “umane” perché considerano nell’uomo la formalità che lo specifica, ciò per cui l’uomo si differenzia dagli altri esseri animati: la sua storicità, interiorità, individualità, spiritualità. In una parola, l’uomo come soggetto. Mentre invece è procedimento tipico delle scienze della natura evacuare il soggetto, per considerare l’uomo come un pezzo di natura tra gli altri.
Questo è un esito particolarmente infausto in medicina, dove si fa più evidente che l’uomo considerato in questo modo diventa una caricatura. Nel suo linguaggio codificato, il malato scompare; la sua presenza è puramente oggettuale. Com’è stato detto efficacemente, per essere più scienza, la medicina perde il malato. Con altra formula a effetto, qualcuno ha denunciato che la medicina rischia di morire di obesità scientifica...
Finché l’uomo malato non sarà considerato anche secondo il punto di vista delle scienze umane, sarà sempre “mal-trattato”, anche se, per ipotesi, il trattamento fosse irreprensibile dal punto di vista di ciò che prescrive la scienza medica. La congiuntura culturale sembra oggi favorevole a una medicina che voglia ricucire lo strappo creatosi tra scienza della natura e scienze umane, le quali non danno più segno di nutrire quel complesso di inferiorità che le ha tradizionalmente caratterizzate nei riguardi delle prime.
Un secondo elemento congiunturale è la crisi in atto nelle scienze naturali: crisi non di disgregazione, ma di crescita. Secondo l’analisi di Thomas Kuhn, si sta registrando nelle scienze un tipico periodo di transizione dalla “scienza normale” al caos che precede il cambiamento di paradigma. La filosofia della scienza contemporanea ci ha reso consapevoli che le scienze non procedono per accumulo lineare di conoscenze, ma per rivoluzioni, nel corso delle quali ha luogo un cambiamento di paradigma. Si pensi al passaggio dalla fisica di Aristotele a quella di Newton, e da questa alla fisica di Einstein; al passaggio dal sistema geocentrico di Tolomeo all’astronomia di Copernico e di Galileo; alla transizione dalla teoria del flogisto alla chimica di Lavoisier: sono tutti esempi di una ristrutturazione del sapere sulla base di un “nuovo paradigma” che emerge dal caos. Lo stesso clima si può cogliere oggi nelle
184
scienze biomediche. E questo è, per l’appunto, il progetto che identifica le Medical Humanities.
È legittimo attendersi che nel nuovo paradigma emerga un’antropologia diversa da quella implicita nella medicina scientifica finora invalsa. Ciò comporta una rottura con il naturalismo, che considera l’uomo come un essere vivente in tutto e per tutto simile agli altri esseri viventi, e si attiene a una metodologia che esclude sistematicamente gli aspetti psichici, spirituali, storico-biografici e sociali dell’esistenza umana (o quanto meno non li ritiene rilevanti per il processo patologico e per quello terapeutico). Il paziente lavoro di ricostruzione dell’immagine completa dell’uomo malato, compito delle scienze dell’uomo abbinate a quelle della natura, si completa con la riconquista del soggetto, che è il vero regista dei sintomi e il protagonista del processo di guarigione. È questo l’obiettivo della “medicina antropologica” di Viktor von Weizsäcker, per menzionare uno tra i numerosi progetti di rinnovamento della medicina proposti nel XX secolo 3.
3. La corporeità nell’orizzonte transpersonale
Il progetto promosso dalle Medical Humanities che abbiamo finora considerato può essere descritto come un recupero di quelle dimensioni della persona che sono sistematicamente ignorate dalla medicina in quanto si basa sui saperi bio-logici, mentre vengono coltivate e valorizzate dai saperi antropo-logici. Come un Giano bifronte, la medicina per curare l’uomo deve guardare contemporaneamente nelle due opposte direzioni. Ma c’è un’altra dimensione che fa parte essenziale del percorso di malattia e di cura: quella transpersonale. Anche questa fa parte dei “riduzionismi necessari” della medicina. Nella pratica della cura i professionisti sanitari sono tenuti a ignorare sistematicamente ciò che rende una persona diversa dalle altre dal punto di vista morale e spirituale. Vizi e virtù, meriti e demeriti, credenze e convinzioni: tutto è rigorosamente messo tra parentesi e considerato irrilevante rispetto ai bisogni della persona malata, così come il professionista deve opporsi
185
alla categorizzazione più fondamentale della convivenza umana, rinunciando a suddividere i malati tra amici e nemici (e ovviamente tra queste persone gradevoli e sgradevoli, meritevoli o no di trattamenti, quando questi sono richiesti dalle condizioni di salute).
La cura si differenzia anche da un rapporto riconducibile alla categoria di “pastorale”. Come afferma in modo tranciante il dott. Gillespie ― protagonista della celebre serie televisiva Il dottor Kildare ― «il nostro lavoro consiste nel tener viva la gente, non nell’insegnargli come vivere». È il “riduzionismo necessario” con cui, storicamente e culturalmente, la medicina ha preso le distanze dalla religione. E dalla filosofia. Le questioni metafisiche non sono ritenute di competenza della medicina.
Non possiamo ignorare, tuttavia, che tali questioni, anche se “scomunicate” (nel senso letterale, cioè tagliate fuori dalla comunicazione) dalla pratica medica, tendono a permanere anche nel contesto secolarizzato in cui si pratica la cura. I movimenti delle Medical Humanities e quello della bioetica hanno ampiamente beneficiato della categoria di “persona” per il recupero delle dimensioni antropologiche del corpo e per tracciare una linea di demarcazione tra gli interventi accettabili e quelli non accettabili nei segmenti di inizio e di fine della vita; il loro compito, tuttavia, non sembra completo, finché la vicenda del corpo non sarà considerata anche in una dimensione che trascende la persona. In altri termini, in un orizzonte transpersonale.
Adottare la prospettiva transpersonale in medicina implica una radicale correzione dell’antropocentrismo (la bio-etica è già per sua naturale vocazione correlata alla biosfera) e l’accesso a quell’atteggiamento verso la vita che è tipico della tradizione religiosa-sapienziale. La vita si presenta allora essenzialmente come un dono, a cui si partecipa mediante la modalità della comunione. Questo, che è lo stato di coscienza tipico dell’uomo spirituale, è anche l’ideale di una coscienza critica che non voglia semplicemente limitarsi a registrare il consenso sociale sulla normatività riferita ai nuovi interventi in campo biologico-medico.
L’ampliamento della coscienza reso possibile dalla dimensione transpersonale trasforma la categoria del pathos. Lo stato di coscienza transpersonale ci indica un atteggiamento verso la vita che non sia modulato esclusivamente sulle categorie dell’azione (anche se si tratta di un’azione che accetta di lasciarsi confrontare con i limiti posti dall’etica). La bioetica si trova molto impegnata a mettere dei confini al desiderio: al desiderio di
186
generare, di generare figli con certe caratteristiche e a certe condizioni, di prolungare la vita o di abbreviarla, di modificare il patrimonio genetico ecc. In breve, la bioetica è confrontata con le mille trasformazioni dell'eros, cioè del desiderio e del potere dell’uomo sulla vita.
Nelle sue infinite espressioni, l'eros ci presenta la vita, propria e altrui, come un campo di intervento illimitato, grazie all’aumento di possibilità dovuto al progresso scientifico e tecnologico. L’ebbrezza di interventismo attivo sulla vita, tipica della cultura occidentale, è tutta centrata sulle possibilità di tutto conoscere e tutto cambiare. Ma anche il pathos, cioè quella modalità di esistenza che dipende non da ciò che facciamo ma da ciò che subiamo, è una dimensione costitutiva della vita.
La determinazione volontaria è entrata pesantemente anche in dimensioni dell’esistenza che prima venivano fatte dipendere dal caso o dalla provvidenza: come il numero e la temporalità delle nascite e anche il momento di arrendersi alla morte. Tutto ciò ora tende a dipendere dall’azione dell’uomo. Questo sbilanciamento unilaterale verso l’azione produce una deformazione antropologica: l’uomo che aumenta il potere arbitrario su se stesso non diventa ancor più uomo, ma una caricatura d’uomo.
Abbiamo bisogno di integrare la modalità “patica” dell’esistenza nel repertorio dei comportamenti che costituiscono l’umano autentico. La “passione”, infatti, e non solo l’azione, costituisce una possibilità di crescita. Anzi, la pazienza ― intesa in senso etimologico, come virtù correlata ai comportamenti che dipendono dal pathos ― ci può far arrivare là dove l’azione non ci può portare. Teilhard de Chardin ha chiamato “passività di crescita” questi eventi dell’esistenza che richiedono la pazienza come risposta comportamentale 4. La passività costituisce, rispetto all’azione, l’altro braccio con cui Dio ci attira a sé; la pazienza è la virtù che si appropria di queste possibilità di crescita.
La riflessione etica non ha il compito, come un gendarme, di mettere dei limiti e delle scadenze al desiderio. Il suo obiettivo, espresso positivamente, è quello di far emergere l’interpellazione presente in ciò che la vita ci fa subire. Deve educare il desiderio a riconoscere la voce
187
del pathos, ad aprirsi a questo «Tu» che ci viene incontro nella durezza di ciò su cui non abbiamo potere.
Anche questo atteggiamento recettivo verso la vita ― che possiamo qualificare come spirituale, anche senza essere necessariamente vissuto entro una religione costituita ― ha bisogno di essere incluso nella saggezza che ci è richiesta dal confronto con la pratica attuale della medicina. Anche la riflessione maturata nell’ambito religioso finora si è prevalentemente occupata di contrastare le inclinazioni faustiane del progresso biomedico, mediante accurate valutazioni del lecito e dell’illecito nell’ambito della genetica, della biologia e della nuova pratica della medicina. Per essere completa, la sapienza ha bisogno di integrare anche quanto la vita, come festoso-tragico gioco dell'Essere, veicola attraverso il pathos, inducendoci al trascendimento. Ed è compito di chi promuove quello stato di coscienza che nasce dalla esperienza della vita come dono a cui si partecipa, quale è concettualizzato all’interno del movimento transpersonale, stimolare la riflessione a confrontarsi anche con questo ultimo orizzonte.
NOTE
1 T. Terzani, Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo, Longanesi, Milano 2004.
2 C. Dickens, Tempi difficili, tr. it. Gianna Lonza, introduzione di Piergiorgio Bellocchio, Garzanti, Milano 1988.
3 Cfr. S. Spinsanti, Guarire tutto l’uomo. La medicina antropologica di Viktor von Weizsäcker, Paoline, Cinisello Balsamo 1988.
4 Cfr. P. Teilhard de Chardin, Le milieu divin, Seuil, Parigi 1957, in particolare il capitolo dedicato alla “divinizzazione delle passività”, pp. 71-80, dove le “passività” formano la metà dell’esistenza umana, in quanto noi subiamo la vita in misura analoga, se non di più, di quanto subiamo la morte.