
- Interessi plurali, interessi in conflitto nella pratica clinica
- Conflitto di interessi
- L'alleanza terapeutica
- Chi ha potere sul mio corpo?
- Curare e prendersi cura
- Il medico e il paziente, una relazione complessa
- Le mani sulla vita
- Come riconoscere il medico giusto
- Cambiamenti nella relazione tra medico e paziente
- L'educazione come terapia
- «Dottore, sto male» - «Mi racconti»
- Narrative based medicine
- We have a dream
- L'ascolto che guarisce
- La comunicazione medico-paziente
- La gestione dei conflitti in ambito sanitario
- Ripensare la cura nel contesto di una società conflittuale
- La necessità di porre limiti alla medicina
- Parlare o tacere?
- Il rapporto medico-paziente
- Il recupero del soggetto
- Etica della vita e intervento sanitario
- Elogio della indecisione
- Comunicare e informare: quale empowerment per il cittadino?
- L'ascolto che guarisce: conclusioni
- Dignità del malato e dignità del medico
- Aspetti etici della relazione medico-paziente
- La decisione cardiochirurgica: aspetti etici
- Il segreto nel rapporto con il paziente sieropositivo
- Il rapporto medico-paziente: modello in transizione
- La formazione culturale del curante
- Le professioni della salute si incontrano
- Le separazioni nella vita
- Quando inizia l'accanimento diagnostico e terapeutico?
- L'accanimento diagnostico e terapeutico
- La persona è al centro della comunicazione
- Il medico impari a non «scomunicare»
- Ma il malato deve o vuole sapere?
- Il dottor Knock si aggiorna
- Il tempo come cura
- A una donna come me
- La difficile virtù di saper ascoltare
- Dottore, ma l'operazione s'ha proprio da fare?
Sandro Spinsanti - Vito Pappalepore
IL MEDICO E IL PAZIENTE, UNA RELAZIONE COMPLESSA
Dall'educazione sanitaria al consenso informato
Presentazione di Antonio Panti
Mediamix Edizioni Scientifiche, Milano 1995
pp. 220
5
INDICE
pg
9 Presentazione
13 Autori
PARTE GENERALE
IL CONSENSO INFORMATO NELLA SOCIETÀ MODERNA
19 I - Cosa si intende per “consenso informato”
19 Introduzione
21 La ricerca biomedica con soggetti umani
25 Trattamenti invasivi e procedure potenzialmente pericolose
27 Il coinvolgimento del paziente nelle scelte terapeutiche
31 II - La normativa
31 La “Legge dell’autodeterminazione” (USA, 1991)
34 Il consenso informato nella legislazione italiana
37 “Informazione e consenso all’atto medico” (Comitato nazionale per la bioetica, 1992)
40 Codici deontologici dei medici italiani (1978, 1989, 1995)
44 Leggi di riordino della disciplina in materia sanitaria
45 Parlamento europeo
49 III - Consenso informato e bioetica
49 L'evoluzione dell’etica in medicina
49 L’etica medica come etica dei medici
53 La stagione della bioetica
56 L’ospedale come azienda di servizi
60 Consenso informato e buona medicina
60 L’ “alleanza terapeutica”
62 Terapie e diritti della persona
67 La responsabilità per la propria salute
72 I limiti alle terapie: problemi antropologici ed etici
76 Il paziente è “un cliente che ha sempre ragione”?
81 IV - Consenso informato tra comunicazione e informazione
81 Comunicare senza informare
86 Informare senza comunicare
89 Come utilizzare il consenso scritto
93 Epilogo - Tra medico e paziente, nuovi diritti, nuovi doveri
93 Riferimenti bibliografici
7
PARTE SPECIALE
IL CONSENSO NELLA PRATICA CLINICA
Vito Pappalepore
V - Apparato cardiovascolare
103 1. Cardiopatia ischemica
107 2. Ipertensione arteriosa
111 3. Scompenso cardiaco
115 4. Varici
VI - Apparato respiratorio
121 5. Bronchite cronica ed enfisema polmonare
125 6. Asma e rinite allergici
129 7. Malattie infettive delle vie respiratorie
VII - Apparato osteoarticolare
135 8. Mal di schiena
139 9. Artrosi
VIII - Apparato digerente
145 10. Ulcera gastroduodenale
149 11. Ernia iatale e reflusso gastro-esofageo
153 12. Epatite acuta e cronica, cirrosi epatica
157 13. Colelitiasi
IX - Apparato urogenitale
163 14. Ipertrofia prostatica
167 15. Carcinoma della prostata
171 16. Prostatiti
175 17. Nefrolitiasi
X - Apparato genitale femminile
181 18. Contraccezione
185 19. Menopausa
189 20. Diagnostica strumentale in ginecologia e ostetricia
193 21. Infezioni ginecologiche
XI - Sistema nervoso
199 22. Depressione
203 23. Cefalea
X - Metabolismo
209 24. Obesità
213 25. Diabete mellito
217 26. Dislipidemia
9
PRESENTAZIONE
Forse qualche medico di medicina generale pensa ancora, o è tentato di pensare, che il problema del consenso informato, che sta diventando uno dei temi più impegnativi nella revisione odierna del rapporto tra medico e paziente, sia esterno o almeno ininfluente sul suo agire quotidiano.
Il consenso informato è infatti invocato nella ricerca clinica che utilizza soggetti umani e, sempre di più, quando si eseguono procedure che comportano rischi per il paziente e, di conseguenza, anche per il medico. Un rischio di diversa natura ma di quasi identica frequenza, o forse, di questi tempi, quasi più probabile per il medico, è la cosiddetta “malpractice”: il paziente rischia danni o, talora, la vita; il medico rischia denunce civili e penali. Il medico deve imparare meglio a tutelarsi, perché la pratica del consenso informato soltanto marginalmente ha un siffatto valore.
Ma tutto ciò non è ancora troppo lontano dalla pratica del medico di medicina generale?
Non lo credo affatto. Il medico di medicina generale non può sottrarsi a quel cambiamento di fondo che Sandro Spinsanti descrive come “l'entrata della medicina nella modernità”. Ciò significa un diverso rapporto col paziente, divenuto cittadino e soggetto di diritti, all'interno di una cultura complessiva che ha cominciato a coniugare le cure con i precetti costituzionali, abbandonando la carità per la giustizia e la filantropia per la solidarietà.
Il medico di medicina generale, ancor più dello specialista, è nella condizione ideale per vivere, recepire e condividere tali mutamenti.
“L'aria della città rende liberi”, si declamava all'inizio dell'epoca che, con l’inurbamento e la fine (a volte più presunta che reale) del paternalismo e della sudditanza, ha favorito la nascita di nuovi rapporti sociali. Ora l'aria della “cittadinanza” circola anche nella sanità, per quanto a fatica o talora con qualche intralcio o incomprensione.
10
Un'aria siffatta si insinua persino negli studi dei medici di famiglia. E sono proprio i cittadini nel ruolo di malati, consapevoli dei loro doveri, propensi a ricorrere alla medicina quasi come a una panacea del benessere, e poco disposti ad adottare stili di vita sani, sono ormai questi i pazienti che quotidianamente affollano gli studi dei medici di medicina generale.
Il medico di medicina generale, nella sua posizione di tramite rispetto alla medicina di livello specialistico, tanto sofisticata sul piano tecnologico quanto fredda sul piano umano, occupa un posto strategico rispetto a un consenso informato che si colloca quasi come il paradigma di una medicina inscritta nell'orizzonte del moderno concetto di persona.
Anche se le procedure di traduzione pratica dell'informazione data al malato e di raccolta del consenso, scritto o verbale che sia, poco coinvolgono il medico di medicina generale perché attengono all'attività specialistica, tuttavia ben sappiamo come il vero, concreto consenso informato si avvia nel suo studio, nel rapporto che egli instaura col paziente. Anzi, allo specialista che oggi, volente o nolente, non può sottrarsi dall'introdurre sistematicamente il consenso informato nella sua pratica diagnostica e terapeutica, il medico di medicina generale può apportare un notevole contributo: quello della sua frequentazione quotidiana col paziente di oggi e quello della sua relazione fiduciaria e personale col singolo cittadino.
La fiducia è, infatti, il valore fondante e permanente nel rapporto di cura, tra chi presta la sua opera e chi la riceve. Nella sua specificità ― riconosciuta anche dall'ordinamento ― di medico di fiducia, il medico di medicina generale può promuovere un'informazione che sintetizza il rispetto nei confronti del cittadino con la scelta professionale della cura e che comporta, in pari misura, l'affidamento da parte del paziente e la disponibilità del medico; l'alleanza terapeutica di cui parlano Pellegrino e Thomasma (Per il bene del paziente, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993).
Se la prospettiva giuridica, infatti, pone l'accento sul consenso (non è privo di ragione se nell'espressione corrente consenso è il sostantivo e informato l'aggettivo qualificativo), il medico di fiducia sa, tuttavia, che centrale è l'informazione quale espressione del livello di comunicazione tra medico e paziente, e quindi di lealtà e di rispetto reciproci. Il consenso è, quindi, conseguente all'informazione, che, se manipolata, non avrebbe né dignità morale né validità giuridica.
Ne deriva che l'informazione non è uno dei tanti atti medici, ma l'atto medico per eccellenza, perché rappresenta il processo evolutivo del rapporto
11
fiduciario, base e fondamento della relazione terapeutica.
L'informazione avviene in tempi e per gradi successivi e susseguenti nasce dalla collaborazione di più attori: il paziente e tutti i medici che intorno a lui prestano la loro opera. Perché il processo sia significativo, cioè esprima il livello di comprensione, di adesione, di partecipazione e quindi di convincimento del malato, con le conseguenze positive che tutti conoscono, centrale è il ruolo del medico di famiglia.
Quante volte il medico di medicina generale vede tornare il paziente in studio, dopo una visita specialistica, per sentirsi chiedere consiglio sulle prescrizioni dello specialista? E non solo nei casi, ovvi, di intervento chirurgico o di accertamenti con qualche rischio, ma di fronte a terapie anche banali. Alla fiducia del paziente il medico deve rispondere con la propria lealtà e correttezza, consapevole del dovere di non far mai perdere la speranza.
Ciò significa che anche in una società come la nostra, propensa a comportamenti collettivi e a stereotipi televisivi, ciascun individuo vuole il riconoscimento della propria peculiarità.
Protocolli e linee guida, auspicabili per evitare l'eccessiva dispersione delle decisioni cliniche, non possono far dimenticare l'individualità del malato che ci sta di fronte. Una società multietnica e capace di far convivere diverse culture e comportamenti, di tollerare devianze e di aiutare disabilità, non consente l'adozione di modelli standardizzati. Per questo siamo lontani dalla culture nordamericana del consenso scritto a ogni costo, estranea com'è questa pratica a una cultura che diffida ancora di ogni scritto come di un imbroglio. Ma dobbiamo comprendere che il ruolo di medici di medicina generale si gioca anche nel contribuire alla crescita nei nostri pazienti della consapevolezza dell'essere cittadini, e, nei medici stessi, del rispetto per l'autonomia della persona.
Antonio Panti
Segretario Nazionale Fimmg
Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze
12
13
AUTORI
Antonio Panti
Laureato in medicina a Firenze, è stato assistente in semeiotica e in cardiologia, ma ha sempre svolto l’attività di medico di medicina generale, che tuttora svolge a tempo pieno. Da molti anni si occupa di organizzazione sanitaria, sia attraverso il sindacalismo ― è segretario nazionale della FIMMG, il sindacato dei medici di medicina generale ― sia attraverso gli organismi professionali ― è presidente dell’Ordine di Firenze e della Federazione toscana degli Ordini. La Federazione nazionale degli Ordini lo ha delegato a presiedere la Commissione nazionale VRQ, la Commissione per i problemi delle tossicodipendenze e a far parte della Commissione per la stesura del Codice deontologico e per il rinnovo della legge istitutiva degli Ordini. Giornalista pubblicista, collabora a riviste mediche e dirige Toscana Medica, organo della Federazione toscana degli Ordini dei medici.
Sandro Spinsanti
Ha insegnato Etica medica presso l’Università Cattolica del S. Cuore e Bioetica nella Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze. Ha diretto il Centro internazionale di studi sulla famiglia (Milano) e il Dipartimento di scienze umane dell'Ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina (Roma). È direttore scientifico dell'Istituto per l'analisi dello stato sociale e coordinatore della ricerca presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. È membro della Commissione ministeriale di studio per la procreazione medico-assistita e del Comitato nazionale per la valutazione tecnico-scientifica e umana dei servizi e degli interventi sanitari. Tra le sue opere più recenti, Bioetica in sanità. Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993; La Bioetica, Biografie per una disciplina, Ed. Franco Angeli, 1995. Ha fondato e dirige la rivista di “medical humanities” L’Arco di Giano.
Vito Pappalepore
Ha manifestato la sua vocazione fin dall’inizio della carriera, lasciando l’incarico di assistente in ospedale per dedicarsi alla medicina generale. Fondatore e responsabile della sezione provinciale milanese della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), dal 1990 è segretario provinciale della sezione di Milano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. È direttore responsabile del periodico Medici a Milano.
Hanno collaborato:
Marco Sghirinzetti
Nicoletta Monferroni
Anna Fantini
Medici di medicina generale
14
15
PARTE GENERALE
IL CONSENSO INFORMATO
NELLA SOCIETÀ MODERNA
16
17
SOMMARIO
PARTE GENERALE
IL CONSENSO INFORMATO NELLA SOCIETÀ MODERNA
Sandro Spinsanti
19 I. - Cosa si intende per “consenso informato”
31 II. - La normativa
49 III. - Consenso informato e bioetica
81 IV. - Consenso informato tra comunicazione e informazione
93 Epilogo - Tra medico e paziente, nuovi diritti, nuovi doveri
95 Riferimenti bibliografici
18
19
COSA SI INTENDE PER CONSENSO INFORMATO
INTRODUZIONE
La relazione che si instaura tra chi presta cure mediche e chi le riceve cambia a un ritmo diverso dal sapere terapeutico. Nel giro di appena un paio di secoli abbiamo visto passare la medicina dal ricorso a salassi e clisteri alla somministrazione di antibiotici, per puntare ormai all’ingegneria genetica. Eppure il rapporto di fondo tra terapeuta e malato potrebbe teoricamente essere lo stesso. Su quella che Edward Shorter ha chiamato "la tormentata storia del rapporto medico-paziente" (Shorter, 1986) influiscono più i cambiamenti nell’organizzazione sociale delle cure che i progressi scientifici della medicina. Soprattutto incide quella realtà impalpabile ma reale costituita dalla cultura del tempo.
Il cambiamento culturale che sta avendo luogo sullo scorcio del XX secolo ― a partire dagli anni '70 nei Paesi anglosassoni e solo molto più di recente da noi ― ha trovato un punto di riferimento nel “consenso informato”, quale condizione di esercizio della medicina in un contesto in cui prevalgono modelli ideali diversi rispetto al passato. Ma è possibile dare al “consenso” lo stesso significato in tutta l’ampia gamma di interventi che costituiscono una terapia?
Pretendere che colui che viene sottoposto a un trattamento terapeutico dia un consenso dello stesso tipo, quando i trattamenti sono così
20
diversi, non rischia di creare intorno al consenso informato un alone insanabile di ambiguità?
Ciò a cui si consente è profondamente diverso ― per prendere le due situazioni estreme dello spettro ― in psicoterapia e in chirurgia estetica. Quando si inizia una terapia psicologica, né il terapeuta né il paziente sanno con esattezza dove la terapia li condurrà. Il paziente ricorre allo psicoterapeuta perché ― mettiamo il caso ― è afflitto da un bisogno compulsivo di bere alcolici, che non riesce a frenare con il semplice esercizio della volontà.
Chiede di essere aiutato a liberarsi dal sintomo. Insieme al terapeuta inizia un percorso che lo porterà a rimettere in discussione comportamenti e motivazioni in aree anche molto lontane da quelle in cui il sintomo si esprime (la sua autorealizzazione nel lavoro o nei legami affettivi, per esempio, oppure il rapporto con la madre, per giungere magari ad affrontare una tendenza omosessuale repressa...). Evidentemente sarebbe irrealistico pensare che, prima di iniziare il trattamento, il terapeuta sia in grado di dare al paziente un’informazione precisa dei cambiamenti che sarà necessario introdurre nella sua vita per ottenere il risultato previsto e, ottenuto il suo consenso, dare avvio alla terapia!
Situazione opposta si configura in chirurgia estetica. In questo caso il terapeuta è tenuto non solo a mettere in atto gli interventi terapeutici appropriati per ottenere il risultato atteso, ma ha l’obbligo del risultato stesso. Lo ha sancito giuridicamente il Tribunale di Milano (sentenza 04394 dell’8 agosto 1985), chiamato a dirimere una curiosa causa legale: una ballerina e spogliarellista ha citato per danni un chirurgo estetico che, nel rifarle il seno, ha prodotto delle cicatrici, della cui presenza la paziente non era stata avvertita. Il Tribunale ha accolto le sue richieste, in forza dell’obbligo di risultato che incombe sulla chirurgia estetica. Nella massima della sentenza si legge che il dovere di informazione che grava sul professionista in questo caso non riguarda solo le potenziali cause di invalidità o di inefficacia della prestazione professionale, “ma anche le ragioni che questa rendano inutile in rapporto al risultato sperato dal cliente”.
Il chirurgo estetico, in altre parole, non può limitarsi a prospettare i possibili rischi del trattamento suggerito, ma deve anche informare il cliente se il miglioramento estetico da questi perseguito è conseguibile o meno. Nel caso in questione il chirurgo avrebbe dovuto sottoporre alla spogliarellista delle foto relative al residuato di cicatrici prodotte da interventi di analoga natura.
È ovvio che il chirurgo, in questi casi, sarà obbligato a fare ricorso a
21
un’informazione la più accurata possibile, a ottenere il consenso e a documentarlo in modo inoppugnabile.
Nell’infinita gamma di situazioni terapeutiche che si presentano tra i due casi estremi della psicoterapia e della chirurgia estetica, variano sia il grado di informazione appropriata, sia la possibilità del paziente di dare il suo consenso all’intervento terapeutico, sia, infine, la modalità del consenso stesso (tacito o esplicito, verbale o per iscritto, personale o per interposta persona). Possiamo fare una prima opera di chiarificazione identificando alcune situazioni tipiche in cui viene invocato il consenso informato.
La ricerca biomedica con soggetti umani
Nell’elenco dei casi in cui è richiesto il consenso informato, il primo posto spetta agli interventi che devono essere qualificati come ricerca biomedica. La priorità è anzitutto quella cronologica, in quanto il problema del consenso è stato sollevato originariamente in rapporto agli interventi finalizzati non a ottenere una guarigione, ma a perseguire una conoscenza, eventualmente utilizzabile a fini terapeutici.
La società, nel suo insieme, accettando l’introduzione del metodo scientifico in medicina, ha implicitamente avallato la sperimentazione come via per la crescita del sapere.
I primi seri interrogativi sulla liceità della ricerca biomedica risalgono a quando si è venuti a conoscenza, all’indomani della seconda guerra mondiale, delle sperimentazioni ciniche e insensate, espressione di sadismo più che di amore per la scienza, eseguite dai medici nazisti su prigionieri nei lager. La fiducia incondizionata nell’ethos professionale dei medici, come garante contro la possibilità di abusi, è stata messa a dura prova. Sull’onda dell’emozione e nel ricordo dell’orrore, si è fatta strada la convinzione che fosse necessario procedere a una severa regolamentazione in questo ambito.
Frutto di questa presa di coscienza è stato il cosiddetto Codice di Norimberga, elaborato nel 1946: un documento in dieci punti inteso a limitare le possibili sperimentazioni mediche su soggetti umani.
Come condizioni necessarie per giustificare moralmente un esperimento con esseri umani, il Codice di Norimberga prevede esplicitamente, oltre all’utilità e all’innocuità dell’esperimento, il consenso del
22
soggetto sottoposto a sperimentazione. Il consenso è, precisamente, il primo dei dieci punti che costituiscono il documento:
“Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare il consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata”.
Successivamente l’Associazione Medica Mondiale si è occupata a più riprese di dare norme deontologiche ai medici che fanno ricerche con soggetti umani. La Dichiarazione sulle ricerche bio-mediche (nota come Dichiarazione di Helsinki, promulgata nel 1964, rivista poi a Tokyo nel 1975, a Venezia nel 1983 e a Hong Kong nel 1989) è più analitica del Codice di Norimberga. Tra le regole più significative troviamo ancora quella del consenso:
Art. 9
“Al momento di ogni ricerca sull’uomo, l’eventuale soggetto sarà informato in modo adeguato sugli obiettivi, i metodi, i benefici previsti e sui rischi potenziali e sugli svantaggi che potrebbero derivargliene.
Egli (ella) dovrà anche essere informato (a) che è libero (a) di disimpegnarsi in qualsiasi momento. Il medico dovrà ottenere il consenso libero e cosciente del soggetto, preferibilmente per iscritto”.
Nei vari sviluppi della normativa ― dichiarazioni internazionali e linee guida ― risulta evidente che l’interesse è rivolto alla protezione del soggetto soprattutto sul versante della sua libera partecipazione alla sperimentazione. Quello che si vuol prevenire è l’arruolamento di soggetti mediante la costrizione, l’inganno, le intimidazioni o le incentivazioni che utilizzano la debolezza di persone che si trovano in posizione di vulnerabilità
23
(detenuti, militari, persone che versano in condizioni di estrema indigenza ecc...).
Progressivamente l’accento si è spostato dalla libertà del consenso alla qualità dell’informazione che lo precede. È evidente, infatti, che lo scienziato e il soggetto sottoposto a sperimentazione non si trovano su due posizioni equiparabili, quanto a conoscenze e a potere decisionale. È facile estorcere un consenso, sottraendo o manipolando le informazioni. L’autonomia dell’individuo è rispettata solo se, prima di acconsentire a essere arruolato nell’esperimento, egli ha ricevuto le informazioni necessarie, le ha comprese e ha valutato tutta la portata della sua partecipazione alla ricerca. Questo insieme di condizioni viene per lo più evocato dalla dizione abbreviata “consenso informato”.
È questa l’espressione che troviamo, per esempio, in una delle normative di ultima generazione: le Linee guida etiche internazionali per la ricerca biomedica sui soggetti umani, pubblicate nel 1993 dal CIOMS (Consiglio per le Organizzazioni Internazionali delle Scienze Biomediche), in accordo con l’OMS.
La prima linea-guida riguarda, appunto, il “consenso informato individuale”:
“Per ogni ricerca biomedica sulla specie umana il ricercatore deve ottenere il consenso informato del soggetto che potrebbe essere incluso nella sperimentazione o, nel caso di individui non in grado di fornire il consenso informato, il consenso surrogato da parte di un rappresentante ”.
Lo scenario concreto in cui il medico attualmente ha la maggiore probabilità di venire a contatto con la ricerca biomedica è quello dei trial clinici, condotti per lo più in modo multicentrico, con la sponsorizzazione da parte di industrie farmaceutiche. La necessità di adottare regole comuni, almeno all’interno della Comunità Economica Europea, ha portato all’elaborazione di norme molto dettagliate, note come Good Clinical Practice.
Fin dal 1985 la Comunità Economica Europea ha elaborato un documento destinato a essere il naturale punto di riferimento per il mercato unico europeo dei farmaci. Il documento ― Norme di buona pratica clinica nei trial su prodotti farmaceutici condotti nella Comunità Europea, in sigla GCP (Good Clinical Practice) ― dopo diverse revisioni, è stato pubblicato nella sua forma definitiva l’11 luglio 1990.
24
Il documento fornisce una descrizione approfondita di quali siano le regole da seguire, e di come applicarle dal punto di vista operativo per la preparazione; conduzione e analisi dei dati di uno studio clinico su prodotti farmaceutici.
Il documento CEE:
― contiene indicazioni su come “salvaguardare” il soggetto che venga arruolato in uno studio clinico;
― descrive i compiti e le competenze del comitato etico (per esempio la verifica dell’eticità del protocollo e dell’opportunità o meno che lo stesso venga svolto);
― illustra le responsabilità delle persone coinvolte nello studio (medico sperimentatore, personale dell’azienda sponsor e monitor dello studio).
L’Italia ha recepito il documento della CEE con un decreto del Ministero della Sanità (27 aprile 1992): Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all’ammissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in attuazione della direttiva n° 91/507/CEE.
“L’obiettivo di queste linee guida è di stabilire i princìpi dello standard delle norme di buona pratica clinica (GCP) per la sperimentazione nell’uomo di medicinali nell’ambito della CEE.
... I documenti, riguardanti lo studio clinico (che devono essere archiviati dallo sperimentatore e poi conservati per almeno 10 anni dopo il termine dello stesso), includono il protocollo, copie delle richieste di autorizzazione e delle approvazioni da parte delle autorità ministeriali, locali e del comitato etico, il curriculum vitae di tutti i medici e del personale (infermieri, biologici, ecc...) coinvolti nella sperimentazione, il modulo del consenso informato, i rapporti di monitoraggio, i certificati di audit, la corrispondenza relativa allo studio, i valori normali di riferimento, i dati grezzi, una copia delle schede raccolta dati compilate e il rapporto finale.
Capitolo 1: Salvaguardia dei soggetti partecipanti allo studio e consultazione dei comitati etici.
L’integrità personale e il benessere dei soggetti coinvolti in uno studio è responsabilità primaria dello sperimentatore in rapporto allo studio; ma una garanzia indipendente che i soggetti sono tutelati è fornita da un comitato etico e dal consenso informato liberamente ottenuto.
25
Nessun soggetto può essere obbligato a partecipare a uno studio. Ai soggetti e ai loro parenti o, se necessario, rappresentanti legali deve essere data ampia opportunità di informarsi sui dettagli dello studio. L’informazione deve chiarire che il rifiuto di partecipare allo studio o l’abbandono dello stesso in qualsiasi momento non andrà a scapito delle successive cure che il soggetto continuerà comunque a ricevere. Ai soggetti dovrà essere dato tempo sufficiente per decidere se vogliono o meno partecipare allo studio.
Se un soggetto, dopo una completa ed esauriente esposizione dello studio (che includa i suoi scopi, i benefici attesi per i soggetti o altre persone, i trattamenti di confronto ― costituiti da principi attivi e/o placebo ― rischi e inconvenienti e, quando appropriato, un’illustrazione della terapia medica alternativa standard riconosciuta), acconsente a partecipare allo stesso, il consenso deve essere registrato in modo appropriato.
Il modulo del consenso deve pertanto essere firmato e datato dal partecipante alla ricerca (consenso informato scritto) oppure deve essere firmato e datato da un testimone non coinvolto nella ricerca in atto che attesti il fatto che il soggetto abbia, a suo parere, perfettamente compreso quanto contenuto nel testo del consenso e che acconsenta a partecipare allo studio (consenso informato testimoniato).
Il consenso deve sempre essere firmato dal soggetto nel caso di studio non terapeutico, cioè quando non sia previsto beneficio clinico diretto per il soggetto.
Capitolo 2.5: Responsabilità dello sperimentatore... (punto h): fornire informazioni a tutto il personale coinvolto nello studio o in altri aspetti correlati al trattamento del paziente”.
Trattamenti invasivi e procedure potenzialmente pericolose
Seppure inserita in un contesto terapeutico, una situazione diversa viene a crearsi nell’ambito di procedure diagnostiche e di trattamenti a carattere non sperimentale che comportano un certo grado di pericolosità e la possibilità di comparsa di eventi avversi di una certa gravità.
Una trasfusione di sangue, per esempio, è quanto di più standardizzato
26
si possa immaginare in medicina, eppure non è esente da rischi. Ci rendiamo sempre più conto che, pur avendo il medico la delega sociale a fare per il paziente ciò che secondo lo stato dell’arte medica risulta appropriato, e magari anche la richiesta esplicita da parte del paziente a fare tutto il possibile per raggiungere il risultato terapeutico, non sarebbe corretto nei confronti del paziente stesso nascondergli i potenziali rischi.
Per alcune di queste procedure esiste un vero e proprio obbligo formale di informare il soggetto e di chiedergli il consenso alle procedure (come per esempio in caso di trasfusioni di sangue: vedremo in seguito le norme di riferimento). Inoltre, per tutte le procedure terapeutiche possiamo perlomeno parlare di obbligo morale all’informazione.
Indipendentemente dall’intenzione ― più che legittima ― del medico di mettersi al riparo da future possibili rivendicazioni del paziente che possono, a volte, arrivare fino alle aule giudiziarie, non è accettabile che egli si assuma in prima persona la responsabilità di decidere un intervento che potrebbe essere dannoso per il paziente.
Anche se, per esempio, è una procedura ormai standardizzata sottoporre le gestanti quarantenni alla diagnosi prenatale, non sarebbe corretto da parte del medico ― dal punto di vista morale, indipendentemente da qualsiasi obbligo giuridico ― non informare la donna della percentuale di rischio per la vita del feto insita nell'intervento diagnostico dell’amniocentesi. Allo stesso modo in cui non sarebbe corretto non informare la paziente della probabilità di avere un bambino malformato.
Talvolta il tentare “il tutto per tutto”, anche in condizioni di incertezza sull’esito, può essere sollecitato dal paziente stesso, indotto dalla situazione a giocare anche la carta della disperazione. Ma il consenso del paziente a sperimentazioni terapeutiche non può essere semplicemente presunto.
Le differenze da persona a persona possono essere molto marcate; inoltre, per la stessa persona, la volontà di sottoporsi a terapie sperimentali può variare nelle diverse fasi del decorso della malattia. Non si può assumere che “tutto il possibile” sia la misura giusta per tutti. Il consenso esplicito del paziente a ciò che gli viene proposto è la condizione che rende umanamente e moralmente giustificabile gli interventi terapeutici di questo genere.
Un’illustrazione chiara di quest’accezione di consenso informato si può trovare in alcune pubblicazioni concepite a uso degli specialisti, per fornire loro sussidi didattici nelle procedure diagnostiche e negli interventi terapeutici di loro competenza. Citiamo, per esemplificare, Il consenso
27
informato in cardiologia (Antonio Lotto et al., Mediamix Edizioni Scientifiche, 1995). Ognuna delle procedure diagnostiche (test ergometrici da sforzo, test farmacologici nel contesto di procedure diagnostiche ecografiche e scintigrafiche, pericardiocentesi, biopsia endomiocardica, coronarografia, angiografia) e degli interventi terapeutici (cardioversione elettrica, impianto di pace-maker, angioplastica coronarica, by-pass aorto-coronarico, sostituzione valvolare, fino al trapianto cardiaco) sono analizzati sia dal punto di vista strettamente medico, sia in modo da poter essere descritti, anche con l’aiuto di appropriate figure, in maniera comprensibile al paziente. Al medico vengono ricordate le indicazioni e controindicazioni di ciascuna procedura o intervento, compresi i rischi connessi e le eventuali alternative. Si tratta, in pratica, di ciò che il clinico deve sapere, in base allo stato attuale delle conoscenze specifiche. Il paziente riceve un’informazione precisa riguardo alla finalità della procedura diagnostica o terapeutica e alla modalità di esecuzione, ai rischi e alle alternative, agli effetti collaterali e alle conseguenze della non esecuzione dell’indagine o dell’intervento. La firma posta in calce a un modulo, accanto a quella del medico che ha fornito l’informazione, è il momento conclusivo di tutto il processo informativo.
Per quanto riguarda l’impianto di pace-maker ― per fare un esempio ― è corretto informare il paziente della possibilità, che varia dallo 0,1% allo 0,6%, dell’insorgenza di complicanze e di rischi correlati alle varie metodiche d’intervento, ma anche che attualmente non ci sono alternative specifiche al pace-maker: il paziente che rifiuta di sottoporsi all’intervento mantiene, perciò, un alto rischio di mortalità altrimenti non controllabile. Se consideriamo l’angiografia in generale, bisognerà informare il paziente che esistono valide alternative all’angiografia classica, che permettono di acquisire immagini delle cavità cardiache e dei vasi in modo meno invasivo e con minori rischi.
Il coinvolgimento del paziente nelle scelte terapeutiche
L’ultimo scenario del consenso informato si apre sulla situazione in cui esistono alternative terapeutiche con diversa ricaduta sull’aspettativa e sulla qualità di vita del paziente. La nuova frontiera del consenso informato non è, infatti, l’autorizzazione data dal paziente ai trattamenti che lo
28
riguardano, ma la sua partecipazione attiva nella scelta delle alternative possibili.
Sempre più spesso, infatti, le scelte terapeutiche si divaricano in diverse direzioni. Per fare un esempio, prendiamo il trattamento del cancro alla mammella. I più accreditati specialisti nell’ambito specifico ammettono oggi che la malattia si può aggredire con almeno una dozzina di strategie terapeutiche. Ognuno di questi protocolli di trattamento ha delle ripercussioni di grande portata sia sulle aspettative di sopravvivenza, sia sulla qualità della vita (in quanto più o meno mutilanti, più o meno invasivi o provanti per l’organismo). La partecipazione attiva del paziente a scelte di così grande importanza non è un “optional”: è indispensabile dal punto di vista non di una medicina difensiva, ma di una medicina rispettosa dei valori personali dell’individuo.
Se si vuole assicurare la partecipazione del paziente, in quanto protagonista delle scelte che lo riguardano, il baricentro si sposta sull’informazione, più che sul consenso. Mentre il consenso a un trattamento non è difficile da ottenere ― specialmente se il medico sa far buon uso delle emozioni del paziente ― dare le informazioni utili e necessarie perché il paziente possa essere il regista delle decisioni che lo riguardano è molto arduo. Ci rendiamo conto che la dizione di “consenso informato”, con tutte le sue ambiguità e inadeguatezze, ci sta portando a una strutturazione nuova del rapporto tra medico e paziente, che, pur conservando i tratti essenziali di ciò che ci ha trasmesso il passato, è sostanzialmente da inventare.
In base alla nuova concezione di consenso informato, il ruolo del medico di medicina generale diviene cruciale. In merito a questa affermazione, qualcuno potrebbe obiettare che il medico di medicina generale non è chiamato direttamente in causa nell’ottenere il consenso informato legato alla ricerca e alla sperimentazione; si potrebbe inoltre obiettare che anche le procedure diagnostiche invasive e pericolose non sono, sostanzialmente, di sua competenza. Si potrebbe sostenere che i problemi legati alle alternative terapeutiche, che hanno una diversa incidenza sull’aspettativa di vita e sulla sua qualità, vengono per lo più discussi nell’ambito della medicina specialistica, e non nello studio del medico di medicina generale. Ma il consenso informato in quanto partecipazione attiva del paziente alle decisioni che lo riguardano è sicuramente un processo, più che un atto isolato.
Se questo processo non viene ben avviato, attraverso la comunicazione che si instaura con il medico di medicina generale, e ben proseguito, anche dopo l’intervento del presidio ospedaliero e del singolo
29
medico specialista, è possibile che i problemi di rapporto con il paziente vengano a trovarsi su un binario morto, in una situazione che li rende insolubili.
La comunicazione con il paziente, che rende possibile quel modello di medicina in cui la giusta decisione va presa in due, deve incominciare a monte. Essa dipende in modo determinante dal rapporto che si instaura con il medico di medicina generale, in una situazione che ha fondamentalmente un valore educativo. Dato che il modello di buona medicina a cui ci avvia il consenso informato è un modello inedito, che nessuno degli interlocutori possiede in proprio, si tratterà di una co-educazione: medico e paziente dovranno educarsi insieme.
30
31
II
LA NORMATIVA
La “Legge dell’autodeterminazione” (USA, 1991)
Iniziamo la presentazione di una serie di normative che regolano il consenso all’atto medico riportandone una che è molto lontana dalla pratica dei medici italiani: la “Legge dell’autodeterminazione” (Self Determination Act) americana.
È bene tenerla presente non perché costituisca di fatto un vincolo o un punto di riferimento obbligante per il medico italiano, ma per il suo valore esemplare, in quanto fornisce l’illustrazione estrema degli sviluppi e della teorizzazione della posizione di privilegio che deve avere l’autonomia del paziente.
La legge, entrata in vigore il 1° dicembre 1991, stabilisce che ogni istituzione sanitaria che riceve pazienti assistiti dai due programmi federali “Medicare” e “Medicaid” è tenuta a fornire ai pazienti in modo sistematico, al momento della loro ammissione in ospedale, informazioni riguardo alle leggi statali relative alle “advance directives” (vale a dire le disposizioni previe che la persona impartisce per il caso in cui non sia più in grado di intendere e di volere) e a sollecitare l’autodeterminazione del paziente.
Il senatore Dandforth, proponente della legge e suo accanito difensore durante il travagliato iter parlamentare e l’acceso dibattito che l’ha accompagnata, l’ha giustificata sostenendo: “Per la prima volta ai pazienti adulti viene fornita la conoscenza dei loro diritti legali per prendere le decisioni relative ai trattamenti sanitari”.
La legge dell’autodeterminazione obbliga, infatti, gli ospedali e le case di riposo per anziani a istituire dei meccanismi per rendere edotti i
32
pazienti dei loro diritti legali, che prevedono la facoltà di accettare o rifiutare il trattamento medico; qualora diventassero incapaci di prendere le decisioni che li riguardano, sono state approvate dai diversi stati americani procedure giuridiche volte a individuare in modo chiaro chi sia autorizzato a parlare in nome del paziente e a prendere le decisioni al posto suo (come il “living will” ― noto in Europa come “testamento biologico” ― le “advance directives”, il “durable power of attorney” ecc...).
Sullo sfondo della legge americana, che obbliga le istituzioni sanitarie a sollecitare l’autodeterminazione del malato, sta la necessità di avere delle indicazioni chiare circa la volontà del paziente, qualora questi non sia più in grado di esprimerla.
Il dato con cui bisogna fare i conti è la statistica fornita dall’American Medicai Association: negli Stati Uniti ormai il 70 per cento delle morti sopravviene dopo la decisione di rinunciare a un possibile trattamento medico o di interrompere quello in corso.
È facile immaginare i dilemmi e le angosce che questo tipo di decisione suscita nei sanitari e nei familiari, nonché i possibili risvolti legali, in un Paese, come appunto gli Stati Uniti, in cui la litigiosità giudiziaria in campo sanitario raggiunge livelli per noi impensabili e, vista la nostra "ossequiosità" nei confronti della classe medica, inconcepibili. Periodicamente, l’opinione pubblica americana si appassiona o per un caso in cui i familiari vogliono interrompere un trattamento che prolunga la vita, ritenendo di esprimere o interpretare la volontà del proprio congiunto (famosi i casi di Karen Ann Quinlan e di Nancy Cruzan), o per un caso di segno opposto: lo scontro tra i medici che vorrebbero interrompere un trattamento ormai divenuto “futile” (oltre che inutilmente costoso), mentre i congiunti si oppongono, adducendo la volontà del congiunto, a qualunque procedura che potrebbe abbreviare la vita.
La legislazione americana relativa all’autodeterminazione non è solo una risposta alla diffusione di cause per “malpractice” o una misura per prevenirle: alla base è chiaramente avvertibile anche una preoccupazione etica. Soprattutto in America il movimento della bioetica ha operato uno spostamento d’accento dalla prospettiva centrata sulla professione (autorizzata a valutare il “bene del paziente” e a perseguirlo con ogni mezzo appropriato) a una tutela della volontà del malato, dei suoi valori e delle sue preferenze. Da questo punto di vista, la “Legge dell’autodeterminazione” può essere considerata uno dei frutti tardivi del movimento per i diritti civili, che tante innovazioni ha portato nella vita civile del Paese nelle ultime due decadi.
Il consenso informato svolge nella pratica medica lo stesso ruolo che
33
il richiamo alla libertà ha avuto nel movimento dei diritti civili.
Esso è costituito da tre importanti elementi:
― l’informazione (con il problema connesso della capacità del soggetto di comprendere l’informazione medica);
― la libertà da coercizioni o da pressioni nelle scelte, con i due corollari dell’autonomia del paziente e del paternalismo professionale dei medici
― la capacità del paziente di prendere una decisione in modo competente.
La scelta americana di imporre il consenso informato per legge (con il rinforzo di un meccanismo economico: le istituzioni sanitarie non sono rimborsate se non dimostrano di aver ottemperato alle procedure previste dalla “Legge dell’autodeterminazione”) ha suscitato molti contrasti.
L’aspetto più preoccupante è il fatto che l’attenzione alla volontà e ai valori del paziente in questo modo slitta dal piano dell’etica ― o magari della “parenetica”, cioè dell'esortazione ― a quello della legge. Il consenso informato diventa un documento legalmente vincolante.
I fautori della legge hanno voluto vedervi il punto di arrivo di due decenni di bioetica, tesa a portare dentro la pratica della medicina i valori dell’autonomia e dell’autodeterminazione, in accordo con l’aspirazione tipicamente americana a salvaguardare in ogni caso la libertà individuale.
Ma è sufficiente che un’idea sia buona, perché lo diventi anche la legge che la traduce in pratica? Un consenso legalmente valido può non coincidere con uno moralmente valido. Lo strumento legislativo è troppo grossolano per cogliere tutte quelle sfumature intermedie della capacità di intendere e di volere, e quindi di prendere delle decisioni relative alla vita e alla salute, che si collocano tra due estremi: quello del paziente riconosciuto ufficialmente incapace e quello che abbia, invece, il pieno possesso delle sue facoltà. I casi quotidiani più numerosi e problematici con cui si confronta il medico sono invece quelli che prevedono una capacità di autodeterminarsi che può rivelarsi dubbia o mutevole.
Il rischio peggiore è che il consenso informato imposto per legge si traduca in un ulteriore atto burocratico. E facile fare dell’ironia in proposito
Conosciamo tutti, per averla ripetutamente vista al cinema, la procedura della polizia americana che consiste nel leggere al cittadino che viene arrestato la lista dei sui diritti. Nel gergo della polizia, l’arrestato viene “mirandizzato” (dal nome della "Legge Miranda"), che ha introdotto la tutela di questo tipo di diritti). Sappiamo che si tratta di una procedura: è importante eseguirla (altrimenti qualsiasi avvocato può contestare l’arresto, per vizio di forma), non che la persona interessata vi prenda parte in modo consapevole. Si può ipotizzare che, in modo analogo, per la burocrazia
34
ospedaliera possa diventare rilevante solo sapere se il paziente è stato debitamente “danforthizzato” (il senatore del Missouri Danfoth ha legato, come abbiamo menzionato, il suo nome alla legge dell’autodeterminazione), senza curarsi del senso e del modo in cui la procedura viene realizzata... Il rischio che si profila è quello di un ulteriore impoverimento del tessuto relazionale che costituisce la dimensione umana della professione medica.
Il consenso informato nella legislazione italiana
Niente di analogo esiste in Italia. L’attività medica viene tendenzialmente vista come un’area in cui le normative giuridiche sono inappropriate, in quanto la medicina è in grado di regolare i rapporti tra terapeuti e pazienti in modo autonomo.
Sullo sfondo possiamo leggere il rapporto conflittuale tra medicina e diritto, che è stato tratteggiato in modo eloquente da Francesco D’Agostino, filosofo del diritto e attuale presidente del Comitato nazionale per la bioetica:
“I medici non amano i giuristi. I giuristi sospettano dei medici. Il problema del rapporto tra medicina e diritto, che in sé non è mai stato facile, sembra poi essere divenuto particolarmente difficile oggi, per il suo intrecciarsi con le più complesse questioni bioetiche. Il diritto vede nella medicina un’attività benefica sì, ma pericolosamente suscettibile di rovesciarsi in una minaccia per l’uomo: e cerca di approntare tutte le tecniche a sua disposizione per garantire il paziente contro il medico. La medicina, a sua volta, tende a vedere nel diritto un ossessivo e formalistico sistema di norme generali e astratte, incapaci di adattarsi alle molteplici e imprevedibili esigenze dei casi concreti, e che impongono al terapeuta il rispetto di procedure spesso burocratiche e antiquate, e in definitiva irrilevanti per gli interessi dei pazienti" (D’Agostino, 1993, p. 51).
35
In Italia, forse a causa di questa tensione di fondo, l’ambito della pratica medica si è sviluppato senza specifiche normative giuridiche. La legge regola attualmente solo alcune pratiche tra quelle che creano perplessità etiche e giuridiche.
Si tratta:
― della donazione di organi (la legge n. 458/1967 ha disciplinato il prelievo e il trapianto del rene tra viventi; la legge n. 644/1975 a proposito di espianto di organi da cadavere ha disposto che, in assenza di un’esplicita dichiarazione di donazione in vita, il coniuge non separato o i figli maggiorenni possano dissentire all’espianto);
― del transessualismo (legge n. 164/1982, che permette la modificazione del sesso fenotipico);
― della sterilizzazione volontaria (che risulta in pratica legalizzata dall’abolizione, da parte della legge n. 194/1978, degli articoli del codice che la proibivano);
― dell’interruzione di gravidanza (regolamentata dalla legge n. 194/1978).
In tutte queste leggi c’è una considerazione più o meno rilevante dell’autodeterminazione del cittadino, al quale viene riconosciuto il diritto di influenzare con la propria volontà le scelte che vengono fatte in medicina sulla sua salute e sul suo corpo.
Il concetto di consenso informato entra, invece, esplicitamente nella legislazione italiana solo con la legge n. 107/1990 sulle trasfusioni di sangue. Per la prima volta nelle norme che disciplinano le trasfusioni di sangue umano e dei suoi componenti per la produzione di plasmaderivati viene previsto il consenso informato:
Art. 3
“Per donazione di sangue e di emocomponenti sì intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma o piastrine o leucociti previo ‘consenso informato’ e la verifica dell’ idoneità fisica del donatore”.
Il D.M. del 15 gennaio 1991 specifica che il motivo per cui la trasfusione di sangue necessita del consenso informato del ricevente è che costituisce “una pratica terapeutica non esente da rischio”. Lo stesso D.M. specifica ulteriormente che il consenso del candidato donatore
36
“deve essere dato per iscritto, dopo che la procedura è stata spiegata in modo comprensibile per il donatore, ponendolo in condizioni di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso” (art. 26).
Più di recente il consenso informato è stato previsto, in uno dei decreti del ministro della Sanità per disinnescare l’emergenza sangue, prima della trasfusione o del trattamento con emoderivati.
Il decreto (Gazzetta Ufficiale n. 240, 13 ottobre 1995) riporta anche un modello previsto per il consenso informato.
|
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………… il ……………………………………………… sono stato informato dal dott. ……………………………………………………………………… che per le mie condizioni cliniche potrebbe essere necessario ricevere trasfusioni di sangue omologo/emocomponenti*, che tale pratica terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa, la trasmissione di virus dell’immunodeficienza, dell’epatite ecc). Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott. ……………………………………………………………… sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli che potrebbero derivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione. Quindi acconsento/non acconsento* a essere sottoposto presso codesta struttura al trattamento trasfusionale necessario per tutto il decorso della mia malattia. Data …………………………………………… Firma ………………………………………… * Cancellare quanto non interessa
|
37
“Informazione e consenso all’atto medico”
(Comitato nazionale per la bioetica, 1992)
Passando dal versante della legge a quello dell’etica, troviamo un importante documento prodotto dal Comitato nazionale per la bioetica: “Informazione e consenso all’atto medico” (20 giugno 1992).
Il Comitato affronta il problema del consenso agli atti medici di diagnosi e cura, portando l’attenzione sulla quantità e qualità dell’informazione necessaria affinché il consenso sia moralmente valido.
Il documento vero e proprio è accompagnato da un’ampia relazione, che tocca i più diversi aspetti del tema: i modelli di medicina a cui il binomio informazione/consenso può essere riferito; l’esperienza clinica relativa al consenso informato; la giustificazione dell’atto medico dal punto di vista dei fondamenti giuridici; la posizione dei codici deontologici dei vari Paesi circa l’informazione e il consenso; l’applicazione di queste tematiche all’età pediatrica.
Il solido impianto di documentazione sembra essere una tacita manovra di supporto per far passare una concezione del rapporto medico-paziente molto innovativa rispetto a quella trasmessaci dalla tradizione. Il documento constata che, sotto il profilo sociologico, il nuovo contesto culturale, di cui la bioetica è espressione, richiede non tanto l’aggiunta di qualche nuova procedura, quanto la rimessa in discussione dei presupposti stessi dell’atto medico:
“Il consenso informato, che si traduce in una più ampia partecipazione del paziente alle decisioni che lo riguardano, è sempre più richiesto nelle nostre società; si ritiene tramontata la stagione del 'paternalismo medico' in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell'esercizio della professione, legittimato nell’ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente, e a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto”.
L’informazione che il Comitato vuol promuovere “è finalizzata non a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra medico e paziente, ma a porre un soggetto (il paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia
38
effettivamente tale; in altri termini, porlo in condizione di scegliere.
Un’informazione corretta è perciò soprattutto chiara nell’indicare i passaggi decisionali fondamentali in una direzione o in un’altra, e cioè le alternative che si presentano: spetterà al curante presentare le ragioni per le quali viene consigliato un determinato provvedimento piuttosto che un altro”.
Dai passaggi citati risulta evidente che la proposta del Comitato non si identifica con la sostituzione dell’impianto paternalistico tradizionale a vantaggio di un modello di rapporto di tipo contrattuale-autonomistico. Al contrario, il documento mette in guardia dalle interpretazioni burocratiche del principio di autonomia applicato al rapporto tra medico e paziente:
“Nella ricerca sistematica, e quasi ossessiva, di un’adesione a ogni atto medico si può giungere a un ricorso indiscriminato a ‘moduli’ in cui raccogliere 'il consenso informato scritto': una modulistica del genere, pure se redatta con diligenza, non copre tutte le imprevedibili situazioni della realtà clinica e rischia di burocratizzare e di distorcere il peculiare carattere della fiducia a cui è improntato il rapporto”.
Al Comitato sta a cuore la difesa dell’alleanza terapeutica e l’ideale di piena umanizzazione dei rapporti in sanità, cui aspira la società attuale. L’informazione necessaria per garantire al consenso il suo carattere etico, e non soltanto giuridico, è quella che passa attraverso una comunicazione interpersonale (“Non basta una informazione fredda e distaccata, pur se legalisticamente precisa”).
Malgrado la continuità sostanziale di quanto proposto dal documento del Comitato per la bioetica con le esigenze di sempre associate a una “buona medicina”, il modello soggiacente a informazione e consenso all’atto medico si distacca da quello abitualmente coltivato dai medici. La diversità si rivela in alcuni snodi fondamentali, come quello del rapporto con i familiari. Il documento è esplicito al riguardo:
“È indiscutibile che un paziente adulto e in condizioni diintendere e di volere sia l’interlocutore vero (e talvolta l’unico) del medico”.
Il rapporto con i familiari o fiduciari è importante per acquisire elementi
39
utili a comprendere la psicologia del paziente e a inquadrare la situazione personale; non può essere invece il foro dove si prendono le decisioni “per il bene” del malato, a sua insaputa. Quando il medico viene invitato dai familiari a non fornire informazioni veritiere o complete al malato, non deve accondiscendere al loro desiderio. Secondo il Comitato, il medico è tenuto a fornire al paziente le informazioni che lo riguardano, seppur nelle modalità suggerite dalla prudenza:
“Notizie esatte ma prive di drammaticità, caratterizzate dal corredo di elementi che facciano intravvedere al paziente qualche speranza nel futuro che sarebbe disumano negare ”.
In occasione della pubblicazione del documento è insorta una divergenza di vedute tra il presidente del Comitato, Adriano Bompiani, e il presidente della FNOMCeO, Danilo Poggiolini, in merito alla competenza del Comitato nazionale per la bioetica a intervenire sul tema.
Il punto centrale della discussione può essere ricondotto alla domanda:
"L’etica medica è competenza esclusiva degli Ordini professionali, oppure anche altre istituzioni sono legittimate a prendere posizione in merito?"
Il punto di vista del presidente della Federazione degli Ordini tendeva a proporre l’autonomia della professione, attraverso la deontologia e la medicina legale, ogni volta che si renda necessario dare nuove norme o rivedere quelle vecchie relative al comportamento professionale dei sanitari.
L’intervento del Comitato in tema di informazione e consenso è stato quindi recepito come un’indebita intrusione. Attraverso il suo presidente, il Comitato per la bioetica ha ribadito che i suoi pareri hanno un valore solo consultivo, non normativo: il rilievo e l’autorevolezza che tali pareri potranno acquisire presso il potere legislativo e in genere nella società civile dipenderanno essenzialmente dal loro rigore e dalla loro coerenza intrinseca.
Tuttavia il Comitato non esclude che i suoi interventi, provenendo da un organismo interdisciplinare, possano toccare ambiti limitrofi a quelli della bioetica: questa eventualità deve essere intesa “come riprova e conferma del carattere ultimativamente unitario dei problemi della medicina contemporanea”.
40
Codici deontologici dei medici italiani
(1978, 1989, 1995)
La reazione dei vertici degli Ordini dei medici al documento del Comitato per la bioetica è più comprensibile se si pone la proposta del Comitato in rapporto con le posizioni proprie dei medici, riflesse nei loro codici deontologici.
Questi, nelle successive modifiche, documentano un progressivo avvicinamento al modello di rapporto medico-paziente proprio della concezione moderna di consenso informato. Tuttavia questo sviluppo ha comportato un parallelo distacco dal modello tradizionale, che viene designato con l’espressione “paternalismo medico”. L’informazione in tale modello è in funzione della finalità propria dell’atto medico, rivolto al bene del malato. Il medico deve gestirla tenendo presente la propria valutazione di ciò che reca beneficio o danno al malato, ed eventualmente la valutazione della famiglia; il malato, in quanto parte in causa, è per lo più ritenuto incapace di valutare quanta e quale informazione sia benefica per il suo stato.
Quando la prognosi è infausta o senza speranze di guarigione, l’impostazione paternalista tende a vedere come dovere del medico fare di tutto per proteggere il malato, non facendogli pervenire l’informazione. È coerente con questa posizione il coinvolgimento della famiglia, chiedendo ai familiari di condividere le decisioni del medico e di dare il consenso alla linea terapeutica proposta.
Tale concezione è rispecchiata nella sentenza della Corte d’Appello di Milano che in data 16.10.1964 rovesciava la decisione di primo grado del Tribunale di Milano, secondo la quale doveva ritenersi “irrilevante, dal punto di vista giuridico, il consenso prestato dal padre di un maggiorenne non interdetto”.
Secondo la Corte d’Appello, al comportamento del medico volto a nascondere la verità può corrispondere un alto valore morale: “Risponde ai criteri di ragionevolezza che devono caratterizzare la valutazione dei fatti umani oltre l’astrattezza e il formalismo delle norme, che il chirurgo taccia al malato la gravità del suo male e il rischio che un’operazione comporta, criterio sanzionato da una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi e consacrata nei princìpi deontologici secondo cui il celare all’ammalato la nuda verità è precipuo dovere, forse il più nobile, del medico cui spetta di vagliare ciò che il paziente debba sapere e quanto debba essergli nascosto”.
41
Non stupisce perciò trovare nel Codice deontologico medico del 1978, tra le regole generali di comportamento che esprimono i doveri del medico nei confronti del paziente:
Art. 30
“Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non alla famiglia. In ogni caso la volontà del paziente, liberamente espressa, deve rappresentare per il medico un elemento al quale egli ispirerà il suo comportamento".
Un articolo successivo (art. 39) prevede il consenso del paziente per atti medici che “comportino un rischio”. Tale consenso è richiesto in modo personale e non delegabile.
Nella revisione del codice approvata nel 1989, la posizione dei medici italiani relativamente al problema se comunicare una diagnosi infausta al paziente o alla famiglia rimane sostanzialmente immutata. La nuova formulazione suona:
“Il medico potrà valutare l’opportunità di tenere nascosta al malato e di attenuare una prognosi grave o infausta, la quale dovrà essere comunque comunicata ai congiunti”.
La seconda parte dell’articolo, relativa alla volontà del paziente come guida all’operato del medico, viene poi ripresa letteralmente. Oltre a un’attenuazione nella forma (“il medico potrà valutare”...), l’unica modifica di rilievo è la sostituzione del riferimento alla “famiglia” con quello di “congiunti”. Evidentemente anche in Italia l’immagine tradizionale di famiglia, in cui le relazioni esistenti di fatto rispecchiano sostanzialmente ciò che risulta all’anagrafe, cede il passo a situazioni più mobili e “irregolari”.
La nuova formulazione permette di equiparare alla famiglia del malato anche un convivente, ovvero chiunque di fatto abbia un rapporto significativo con il malato stesso. Al di là di questo ampliamento nel numero e nelle caratteristiche degli interlocutori del medico, l’impianto della deontologia resta immutato: il medico è tenuto a rispettare la
42
volontà del malato, ma si riserva la valutazione delle informazioni che è opportuno dare allo stesso.
La spinta culturale al cambiamento deve essere notevole, se nel giro di poco più di un lustro l’Ordine dei medici ha sentito la necessità di varare una nuova versione del codice di comportamento dei professionisti (giugno 1995). Hanno fatto notizia soprattutto le prese di posizione restrittive dei medici italiani nei confronti delle procedure di riproduzione medicalmente assistita.
Molto più carichi di conseguenza nella pratica quotidiana della medicina sono invece gli articoli (artt. 29-31) dedicati al consenso agli atti medici. Il principio secondo cui al paziente devono essere date le informazioni necessarie per essere messo in grado di essere il protagonista delle decisioni che lo riguardano è accettato senza esitazioni.
La posizione è tanto più meritevole di attenzione, in quanto i medici italiani nel 1995 vengono ad allinearsi con quanto auspicato dal documento “Informazione e consenso all’atto medico” nel 1992, e allora respinto dai supremi organismi rappresentativi dell’Ordine.
Riportiamo, per facilitare la documentazione, gli articoli del nuovo codice relativi a “Informazione e consenso del paziente” (Capo IV).
Art. 29
“Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, la prognosi, le prospettive terapeutiche e le loro conseguenze, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche .
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta.
Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici.
43
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza.
La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale.
Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione ai pazienti in condizione di degenza, in accordo e collaborazione con il medico curante”.
Art. 30
“Il medico è tenuto a informare i congiunti del paziente che non sia in grado di comprendere le informazioni relative al suo stato di salute o che esprima il desiderio di rendere i suddetti partecipi delle sue condizioni”.
Art. 31
“Il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato.
Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta in tutti i casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sull'integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente.
Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possono comportare grave rischio per l’incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque,
44
solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito un’opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 33”.
Leggi di riordino della disciplina in materia sanitaria
Dall’insieme dei provvedimenti legislativi che costituiscono il nuovo volto che la sanità italiana degli anni ’90 si sta dando, risultano delle indicazioni autorevoli nella direzione generale di una cultura del consenso informato.
Nel disegno generale dei decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 l’opinione pubblica ha colto soprattutto gli aspetti relativi alla “aziendalizzazione” delle USL, ai diversi sistemi di finanziamento, finalizzati a dare al sistema una forte spinta in direzione dell’efficienza, e agli elementi di competitività introdotti tra le strutture erogatrici di servizi sanitari. Non sono questi gli unici elementi di novità nel riordino del sistema.
Ancor più innovativa è la funzione di guida attribuita ai cittadini nell’orientare il Servizio sanitario nazionale verso livelli di qualità. I DD.LL. sviluppano questa prospettiva nel Titolo IV: “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini”, in particolare nell'art. 14. Sarà compito del ministro della Sanità definire degli “indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie” relativamente, in particolare, alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza e al diritto all’informazione. Nella prospettiva che attribuisce una centralità strategica al cittadino-utente dei servizi l’informazione appare come un valore cruciale per valutare la qualità della prestazione.
È appropriato invocare a questo proposito lo spirito aziendale, non in una prospettiva economicistica, bensì come uno stile diverso di rapporti, di cui hanno bisogno tutte le amministrazioni e i servizi del settore pubblico (Cassese, 1994; Osborne, Gaebler, 1992).
45
Un’indicazione ancor più esplicita in questo senso viene dalla Carta dei servizi pubblici sanitari, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della sanità (2 maggio 1995).
Al cittadino viene attribuito un “potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati”. Non si tratta ― precisa la Carta ― di una tutela dei diritti degli utenti intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino. Il ruolo forte assegnato ai cittadini nell’orientare l’attività dei pubblici servizi deriva direttamente dall’idea di azienda di pubblico servizio, la cui “missione” è quella di fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-utenti. Non potrà espletare il suo compito se non metterà gli utenti dei servizi in condizione di pilotare la ricerca della qualità.
Il consenso informato, in questa prospettiva, ci appare non tanto come condizione di legittimità degli interventi, per il rispetto formale dei diritti individuali, quanto piuttosto come una strategia di buona conduzione aziendale di una struttura di servizi destinati alla persona.
Parlamento europeo
Il consenso informato ha trovato anche un’esplicita collocazione nelle normative che l’Europa, che si va faticosamente costruendo come realtà culturale e politica omogenea, si è data in materia di bioetica.
Il punto culminante è costituito dalla Convenzione sulla bioetica (per la precisione: “Progetto di convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”), approvata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sessione 30 gennaio ― 3 febbraio 1995.
Per comprendere quale immenso sforzo di accordo la Convenzione comporti, è opportuno collocarla sullo sfondo del travagliato cammino che ha dovuto percorrere l’Europa per giungere a una normativa vincolante per tutti i Paesi che la costituiscono.
Ancor prima che i più recenti progressi nella biologia e nella medicina richiamassero l’attenzione sulle possibilità di abusi e di azioni contrarie alla dignità umana, l’Europa ha dovuto confrontarsi con
46
scandalose violazioni del “minimo morale”, avvenute sotto il segno delle politiche eugenetiche e delle sperimentazioni con esseri umani di marca “nazista”. Una delle barriere innalzate per prevenire quelle ricadute nella barbarie è stata la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, approvata nel 1950 dai 23 Stati membri del Consiglio d’Europa.
La Convenzione vuol essere una garanzia collettiva sul piano europeo di alcuni dei princìpi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, rafforzata da un controllo internazionale giudiziario, le cui decisioni devono essere rispettate da tutti gli Stati. Gli organi di controllo sono la Commissione europea dei diritti dell’uomo e il Tribunale europeo dei diritti dell’uomo, che hanno la loro sede a Strasburgo.
Tuttavia, le nuove pratiche biomediche rischiano di infrangere tali diritti, pur senza superare il livello di guardia costituito dalla Convenzione. Il Tribunale europeo dei diritti dell’uomo è stato chiamato negli ultimi anni a intervenire su questioni che esulano completamente dal quadro problematico per il quale è stato istituito e per le quali i suoi strumenti giuridici appaiono quantomeno inadeguati.
Per esemplificare: una signora danese nel 1983 è ricorsa al Tribunale dichiarando di essere stata sottoposta a “tortura” perché l’uso di un nuovo strumento, in un’operazione volontaria di sterilizzazione che non aveva avuto successo, aveva costituito un esperimento senza il suo consenso.
Un altro caso riguarda il ricorso al Tribunale per la condanna da parte del governo francese delle organizzazioni che aiutano le coppie a cercare madri “gestazionali” (altrimenti dette “uteri in affitto”). Il Tribunale è stato chiamato anche a deliberare circa i diritti di un donatore di seme olandese, il quale chiedeva che gli fosse concesso il diritto di visita nei confronti di un bambino nato dalla sua donazione.
Dalla metà degli anni ’ 80 si è incominciato a sentire in maniera acuta in Europa la carenza di una riflessione adeguata nell’ambito bioetico, come supporto per normative omogenee. Nel 1985 i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa si dichiaravano per un fronte comune, affermando che le leggi nazionali sarebbero state inefficaci se non ci fosse stato un allineamento dei Paesi vicini. Il diffondersi delle nuove pratiche scuote la società nelle sue convinzioni più profonde. Anche chi non sia turbato dalle questioni metafisiche o dai dubbi etici, non può comunque non vedere almeno la dimensione economica dei problemi. In Europa ci stiamo avvicinando inesorabilmente al “grande mercato”, che si aprirà con la caduta delle barriere nazionali. Poiché la pratiche biomediche hanno una ricaduta economica di enorme importanza, quando gli
47
investimenti privati potranno circolare liberamente si rischierà di vederli risucchiati da Paesi con una legislazione più tollerante, a danno di quelli che pongono ai propri ricercatori limitazioni più severe in nome della sicurezza e dell’etica. È una prospettiva che diventa inquietante quando si prende in considerazione la commercializzazione del corpo umano.
Le iniziative per creare una legislazione comune in materia di bioetica hanno dovuto affrontare il dibattito se, in linea di principio, tale unificazione sia possibile o auspicabile. Coloro che sono contrari a una legiferazione in questo ambito adducono come argomento l’insufficiente consenso che esiste attualmente su alcune questioni antropologiche cruciali, come l’inizio e la fine della vita, lo status giuridico deH’embrione, l’impatto delle tecnologie riproduttive e della genetica. L’impegno comune, per esempio, a rispettare la vita umana ha poco senso quando gli stati divergono radicalmente in questioni come l’aborto o l’uso di embrioni nella ricerca.
Coloro, peraltro, che sollecitano misure di regolazione giuridica, considerano i benefici di una legislazione a diversi livelli. La legge da sola non modifica le convinzioni morali delle persone, tuttavia ne può influenzare il comportamento dal punto di vista della morale comune. Non avere nessuna legge equivale all’anarchia. Tra una legge inefficace e un’abdicazione di responsabilità da parte dello stato, è meglio correre il rischio di un’eventuale inefficacia. Una legislazione anche imperfetta, inoltre, avrebbe effetti contagiosi positivi su altri Paesi, che potrebbero ispirarvisi e migliorarla.
In una situazione di incertezza diffusa sulle questioni di fondo, la linea di accordo è passata attraverso un progetto di Convenzione sulla bioetica. I progetti per una bioetica europea sembrano troppo ambiziosi, se si considerano tutte le diversità di cui si deve tener conto. L’Europa è infatti un mosaico di realtà culturali, che si estende dall'Irlanda alla Turchia: dal Paese ― per intenderci ― che ha introdotto l’illegittimità dell’aborto nella costituzione e ha discusso a lungo se togliere il passaporto a una minorenne che intendeva recarsi all’estero per interrompere una gravidanza frutto di un incesto, al Paese che considera per motivi religiosi l’integrità del corpo come inviolabile e si oppone perciò a qualsiasi pratica di trapianto di organi.
Con differenze culturali e religiose così radicali, è difficile immaginare un cammino europeo verso la bioetica che proceda allo stesso passo. Un nuovo insieme di regole, che sappia combinare norme giuridiche, morali e diritti dell’uomo per tutelare i valori minacciati dalle pratiche biomediche, è ancora lontano. Tanto più significativo è il fatto, perciò, che uno dei
48
punti di accordo ottenuti con maggiore facilità nella Convenzione sulla bioetica del 1995 riguardi la necessità di ottenere il consenso per ogni intervento su una persona in ambito sanitario, sia per diagnosi, prevenzione, terapia, riabilitazione o ricerca. Il documento, infatti, prevede che:
“Nessun intervento in materia di salute può essere effettuato su una persona senza il suo consenso informato, libero, esplicito e specifico”.
49
III
CONSENSO INFORMATO E BIOETICA
L’evoluzione dell’etica in medicina
L’etica medica come etica dei medici
Oggi, alla fine del XX secolo, cerchiamo una “buona” medicina per rispondere ai nostri problemi di salute, non meno di quanto abbiano fatto i nostri antenati o i nostri padri, soltanto una generazione fa. Ma la nostra idea di ciò che corrisponde a buona o cattiva medicina è cambiata, così come sono cambiate le nostre attese nei confronti di un ospedale o del servizio sanitario pubblico. Più precisamente, possiamo dire che ci troviamo presi in un processo storico che ha visto il susseguirsi di almeno tre grandi modelli di buona medicina, ognuno dei quali prospetta in modo coerente come si devono comportare i diversi protagonisti del sistema delle cure: i medici, i malati, le varie professioni sanitarie, la società nel suo insieme. Ogni modello che si sussegue nel tempo ci obbliga a ripensare ogni volta la medicina intera sotto una diversa luce per quello che riguarda la qualità.
Per illustrare i cambiamenti di tutto ciò che associamo all’idea di “buona” medicina, ci serviremo di uno schema riportato nella tabella successiva. Come ogni schema, introduce una certa semplificazione nella realtà delle cose, ma ha il vantaggio di concentrare l’attenzione sui punti nevralgici del cambiamento.
Il primo modello presentato dallo schema può essere chiamato premoderno. Ha caratteristiche di grande antichità e di forte tenuta nel tempo. La sua antichità è indiscussa, in quanto in Occidente risale almeno
50
STAGIONI DELL'ETICA IN MEDICINA
|
|
Epoca premoderna Etica medica
|
Epoca moderna Bioetica |
Epoca postmoderna Etica dell'organizzazione
|
|
La buona medicina |
Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente? |
Quale trattamento rispetta il malato nei suoi valori e nell’autonomia delle sue scelte
|
Quale trattamento ottimizza l’uso delle risorse e produce un paziente/cliente soddisfatto? |
|
L’ideale medico
|
Paternalismo benevolo (scienza e coscienza) |
Autorità democraticamente condivisa
|
Leadership morale, scientifica, organizzativa |
|
Il buon paziente
|
Obbediente (compliance) |
Partecipante (consenso informato) |
Cliente giustamente soddisfatto e consolidato |
|
Il buon rapporto |
Alleanza terapeutica (il dottore con il suo paziente) |
Partnership (professionista- utente)
|
Stewardship (fornitore di servizi-cliente) Contratto di assistenza: azienda/popolazione
|
a Ippocrate. Ma anche la sua forza è notevole, in quanto non esiste in tutta la tradizione occidentale un modello culturale che abbia resistito tanto a lungo. L’Occidente ― dall’antichità greco-romana a oggi ― ha cambiato una quantità di cose nell’organizzazione sociale: l’economia, la famiglia, la religione, il diritto, la politica. La medicina stessa si è profondamente modificata nel corso del tempo, sia nei modelli teorici che nel modo di fornire aiuto ai malati. Tra il medico seguace di Galeno ― che interpreta le malattie secondo la teoria degli umori ― il medico scienziato dell’Ottocento ― che ricorre al metodo della scienza sperimentale per spiegare come funziona l’organismo sano o malato ― e il medico della nostra epoca ― che è capace di ricondurre le malattie a un difetto del corredo genetico ed è in grado di prevederne l’insorgenza con anni di anticipo ― le differenze sono enormi. La stessa cosa si può dire riguardo al ricorso ai salassi, ai vaccini e all’ingegneria genetica. La diversità tra questi mezzi terapeutici, quanto a efficacia ed efficienza, è incolmabile.
51
Per l’etica, invece, non è avvenuto così. Le convinzioni su ciò che è bene o male fare in medicina, sui comportamenti giusti o ingiusti nei confronti del malato, sono rimaste relativamente stabili per secoli. Praticamente si tratta di una tradizione ininterrotta che in Occidente è durata per più di 25 secoli, dall’epoca di Ippocrate fino ai nostri giorni: in tutto questo tempo non abbiamo mai sentito il bisogno di modificare il concetto, condiviso dai medici e dai pazienti, di quelle pratiche di cura della salute a cui attribuire un valore morale positivo.
Ci possiamo riferire a quest’epoca come alla stagione premoderna dell'etica in medicina. Sinteticamente la denominiamo etica medica. L’aggettivo è giustificato. L’etica a cui ci riferiamo, infatti, è sostanzialmente l’etica “del medico”. È il medico che la determina ed è la professione medica che se ne fa garante. In quest’etica sono prescritti comportamenti per i malati, per i familiari, per le professioni che collaborano con il medico; tutti svolgono, tuttavia, funzioni subordinate e sono chiamati a modellarsi sulle richieste che provengono dai medici, i quali hanno un ruolo decisivo nello stabilire che cosa sia “buona” medicina. La qualifica di “paramedici”, data a coloro che esercitano professioni sanitarie non mediche, rispecchia bene questa situazione di centralità del medico. Anche l’etica dei non medici in questa stagione è un’etica “paramedica”.
La domanda fondamentale a cui risponde la medicina di qualità dell’epoca premoderna è: “Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente?”. Troviamo questa preoccupazione già nel giuramento di Ippocrate, nella cosiddetta clausola terapeutica:
“Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa”.
Tutta l’azione del medico è diretta a procurare il bene del paziente, identificato con la risoluzione dei problemi posti dalla patologia.
Le risorse che il medico utilizzerà sono ovviamente quelle che la scienza del tempo gli mette a disposizione: per il medico dell’antichità era la “dieta” (cioè il regime terapeutico che tendeva a ristabilire nella vita del malato l’equilibrio turbato); per il medico dei nostri giorni i trattamenti appropriati potranno essere, per esempio, gli antibiotici o i trapianti di organo. Qualunque sia la scienza di riferimento, il modello
52
rimane tuttavia lo stesso: il medico si impegna a fare il bene del paziente.
Quest’accentuazione è presente anche in altre tradizioni mediche che afferiscono al filone ippocratico. Pensiamo, per esempio, alla medicina omeopatica. Il libro fondamentale di Samuel Hahnemann, l'Organon dell’arte di guarire, inizia con una frase programmatica, che circoscrive il dovere del medico in un perimetro molto preciso: “L’unico compito del medico è guarire presto, dolcemente, durevolmente”. Tutto il resto dell’opera è dedicato al “come” ottenere la guarigione, vale a dire ai rimedi appropriati alle patologie. La prima frase compendia il fondamento etico di tutta l’impresa terapeutica, ricondotta alla volontà di procurare la guarigione del paziente. Finché un medico può rispondere alla domanda “perché fa quello che fa”, dicendo che lo fa per il bene del paziente, sa che ha dietro di sé il sostegno dell’etica medica a legittimare il suo operato.
I principi fondamentali di questa etica, riconducibili all'imperativo di fare il bene del paziente, presuppongono un modello ideale del medico fondamentalmente paternalista: il medico è colui che sa qual è il bene del paziente e vuole realizzarlo, mettendovi tutto il suo impegno e tutta la dedizione. È la scienza in continuo progresso che lo guida nel percorso della terapia, mentre la coscienza gli impedisce di trarre profitto dalla debolezza del paziente (per esempio, strumentalizzandolo ai fini di ingiusto lucro o di fama). Questa duplice guida è riassunta da una formuletta, molto amata e citata dai medici, quando rivendicano a se stessi l’obbligo di prendere le decisioni “in scienza e coscienza”. Nel linguaggio della bioetica americana, si parla a questo proposito di una medicina ispirata al principio della “beneficence”, ovvero di “beneficio per il paziente”.
Il malato contribuisce alla buona medicina impegnandosi a essere docile e osservante delle prescrizioni, in un rapporto di affidamento fiduciale. Egli non ha, di per sé, nulla da dire in merito all’atto terapeutico, che rimane affidato a quanto il medico stabilisce .per il suo bene. Tutto quello che il malato deve fare, è di diventare “paziènte”, ni tutti i significati del termine (anche in senso morale, in quanto la pazienza è la principale virtù che è chiamato a esercitare). Il buon paziente è il paziente “osservante”. A lui si richiede di entrare nel trattamento mediante la “compliance”. Come affermava l’illustre spagnolo Gregorio Marañon, che ha rappresentato nella prima metà del secolo il permanere dell’ideale ippocratico: “Il malato che non sa essere paziente diminuisce le sue possibilità di guarire. Obbedire al medico è incominciare a guarire”.
53
In questo modello il buon rapporto è l'alleanza terapeutica tra colui che si dedica all’opera della guarigione e chi riceve questo servizio. Il termine “alleanza” fa parte della tradizione religiosa. Il rapporto medico-paziente ha, di fatto, una connotazione fortemente religiosa in senso ampio, in quanto, allo stesso modo dell'alleanza che è il pilastro centrale della religione ebraico-cristiana, mette in relazione due fondamentali diseguaglianze. Nell’alleanza religiosa si tratta del legame che si instaura tra la potenza della divinità, in quanto fonte di forza e di salvezza, e la situazione di necessità propria del popolo che ha bisogno di redenzione. L’unione dei due mediante l’alleanza fa salvezza. Analogamente, la guarigione in medicina, nel modello tradizionale, si ottiene mediante l’unione tra scienza e coscienza del medico (unione che include il suo sapere, la filantropia, la volontà di fare il bene del paziente) e la volontà del paziente di mantenersi dentro questo rapporto di alleanza.
Il seguire la prescrizione medica è la condizione essenziale perché l’alleanza possa esplicare i suoi effetti benefici, e quindi procurare la guarigione. Il contraente dell’alleanza, che è il malato, si deve affidare al terapeuta e accettare le condizioni che gli vengono poste per la guarigione; il medico, che concede l’alleanza, lo guida verso il suo proprio bene.
Questo modello continua ancora a strutturare i nostri comportamenti sociali, sia come medici che come pazienti. Soltanto quando diventiamo “moderni” il modello entra in crisi.
La stagione della bioetica
Quando comincia l’epoca moderna? I manuali di filosofia e di storia generalmente fanno iniziare la modernità con l’Illuminismo, nel XVIII secolo. Ci dicono che nella storia è avvenuto un cambiamento profondo, una di quelle fratture che hanno ripercussioni generalizzate su tutta la struttura dell’esistenza. L’Illuminismo ha progressivamente modificato l’insieme della vita politica e sociale; solo in un ambito non è entrato: in medicina.
Nei rapporti sociali che si stringono attorno a chi somministra e a chi riceve le cure sanitarie, l’epoca moderna non è incominciata fino a pochissimo tempo fa. Soltanto da una ventina di anni sono diventati visibili i segni di una frattura che indica che la medicina è entrata nell’epoca moderna. Di conseguenza, cambiano tutti i parametri che costituiscono il modello di “buona medicina” caratteristico dell’epoca premoderna.
54
Rinunciando a una descrizione approfondita, ci limitiamo, seguendo lo schema fin qui adottato, a mettere delle parole chiave attorno a questi cambiamenti. Lo scopo generale della medicina non è più soltanto quello di portare il maggior beneficio al paziente: perché un trattamento medico abbia un carattere di qualità, ci dobbiamo anche domandare se tratta il malato da adulto, rispettandolo nei suoi valori e nell’autonomia delle sue scelte.
Nell’epoca moderna, infatti, il malato va fondamentalmente considerato come una persona autonoma, capace di autodeterminare le proprie scelte.
L’autonomia della persona è basilare nell’epoca moderna. Così lo ha espresso Immanuel Kant nel famoso saggio “Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?”. L’Illuminismo comincia quando si decide di uscire dallo stato di minorità dovuta all’uomo stesso, intendendo per minorità “l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”. Il primo paragrafo dello scritto, che sintetizza il programma di vita dell’uomo moderno, termina con l’esortazione: “Sapere aude”, abbi il coraggio di servirti dell’intelletto come guida. L’epoca moderna in medicina comincia quando il programma generale dell’emancipazione si estende anche a quella “minorità non dovuta” che vige tra il medico e il paziente.
Il malato dell’epoca moderna è quello che ha la capacità e il coraggio di non farsi trattare come una persona eterodeterminata, ma assume il peso e la responsabilità delle decisioni che lo riguardano. Ciò mette in crisi il modello secondo cui nella medicina tradizionale il malato è per definizione uno che non può determinare se stesso. Riconosciamo l’influenza di concezioni antiche, come quelle che ha espresso Aristotele affermando che il malato, proprio per la sua condizione, non è capace di dare giudizi razionali, in quanto è turbato dalle passioni, come per esempio la paura per la propria vita; nello stato di malattia deve quindi subentrare la struttura paternalistica di contenimento: qualcun altro prende le decisioni per il bene del malato, dal momento che questi non lo può fare. Dire che la medicina entra nell’epoca moderna significa prima di tutto rimettere in discussione questo paradigma profondo, che presuppone una fondamentale diseguaglianza tra le persone autonome e quelle che non lo sono (le scelte di queste ultime essendo determinate dalle prime).
Nell’epoca moderna i valori del malato, intesi come quadro di riferimento che guida l’autonomia delle sue scelte, diventano un momento
55
fondamentale del fare “buona” medicina. La potente ed efficace medicina che la scienza, abbinata alla tecnologia, ci mette oggi a disposizione si apre su scenari diversi. L’arsenale medico è potente e vario, e ci mette di fronte ad alternative create dai diversi valori soggettivi. A seconda del concetto soggettivo di buona vita, ovvero di ciò che vogliamo fare della nostra vita, un intervento medico può essere appropriato o no.
Perché si abbia buona medicina non ci si può limitare a rispondere alla domanda: “Questo intervento porta oggettivamente un beneficio al paziente?”. Non basta stabilire ― per esempio ― che l’atto medico ha di fatto prolungato la vita del paziente. Se quanto il medico intraprende va contro i suoi valori e le sue decisioni, non possiamo parlare di buona medicina. L’autodeterminazione del paziente, in quanto articolazione fondamentale dei suoi diritti (per capire la differenza del paradigma, basti pensare che nel modello tradizionale si parla solo di doveri del medico e non di diritti del paziente), diventa un criterio di qualità. L’intervento sanitario non può essere più deciso unilateralmente dal medico che si basa sul sapere della sua professione, ma deve essere individuato insieme al paziente, spesso con un faticoso processo di contrattazione.
Superato il paternalismo benevolo, l’ideale medico in questo modello diventa un’autorità democraticamente condivisa; il buon paziente è un paziente partecipante alla decisione. Il cardine di questa strutturazione concettuale è il “consenso informato”, secondo l’ultima delle diverse accezioni che abbiamo esaminato precedentemente. L’idea di qualità dell’atto medico si arricchisce di una nuova componente: è buono l’intervento sanitario che ha anche una correttezza formale, vale a dire il rispetto delle procedure volte a far partecipare il paziente alle scelte diagnostiche e terapeutiche che lo riguardano. Questa specificazione ci permette di dissociarci dall’uso del consenso informato che si va diffondendo anche in Italia, concepito per lo più in funzione difensiva del medico, non finalizzato a promuovere l’autonomia del paziente.
Nella prospettiva che abbiamo adottato, il paziente non ha più solo diritti ma anche dei doveri. La sua posizione non è solo di privilegio, ma anche di scomoda responsabilità, in quanto deve partecipare al processo decisionale. Non possiamo escludere che talvolta il paziente potrebbe preferire di delegare la decisione e di demandarla al medico (“Faccia quello che è necessario: il dottore è lei, non io!”).
Il paziente partecipante nelle scelte ha il compito di diventare un buon paziente. Per diventarlo non basta che si limiti a non far storie, non porre troppe domande, essere docile e seguire le prescrizioni mediche; il
56
buon paziente ha anche un compito etico: deve realizzare tutto quello che è necessario per essere un buon paziente. Il buon rapporto è una partnership, che si instaura tra professionista e utente.
Il termine “utente” può suscitare delle associazioni che sembrano fuori luogo in sanità. Per ricondurlo entro l’ambito appropriato, basta pensare al senso etimologico della parola. L’utente è colui che “usa” la competenza del medico; in quanto utente, ha il dovere di usarla bene, responsabilmente, per fare insieme al professionista le scelte appropriate.
L’idea di qualità, dunque, include il concetto di partecipazione. Il termine bioetica, usato per designare questo modello di qualità dell’atto medico, è un neologismo, appropriato per un modello di qualità in medicina veramente inedito. È la buona medicina appropriata per la stagione dell’etica in medicina che abbiamo chiamato “moderna”.
Sentiamo il bisogno di cambiare etichetta anche perché non ci troviamo più nell’ambito dell’etica medica, cioè del medico, concentrata sul medico, elaborata dalla professione medica a beneficio anche del malato. La bioetica implica uno spostamento dell’accento, per cui la qualità non è più determinata in maniera unica ed esclusiva dal sapere e dal potere del medico, ma viene stabilita in modo dialogico, insieme al paziente, il quale deve partecipare alle decisioni con i suoi valori, nell’ambito del consenso sociale. Nella bioetica, quindi, entra la società, l’etica civile, l’accordo ottenuto trasversalmente alle diverse comunità morali di appartenenza, includendo anche gli “stranieri morali”.
Questo modello di qualità, che nella nostra cultura non abbiamo nemmeno ben cominciato ad articolare, si diffonde con estrema difficoltà. Lo contrasta una profonda resistenza, sia da parte del mondo medico, sia da parte dei cittadini. Si avverte che è necessario accrescere le conoscenze e mobilitare tutte le energie concettuali e morali, al fine di entrare in questo modello. Tanto i professionisti della sanità quanto i pazienti sono obbligati a cambiare modelli di riferimento che hanno una lunghissima tradizione. E un passaggio epocale; spostandosi da un modello all’altro i valori si modificano, possiamo dire che stiamo assistendo all’inaugurazione di una nuova epoca della qualità e dell’etica nella medicina.
L’ospedale come azienda di servizi
Mentre proviamo ancora tanta difficoltà a entrare nella stagione della medicina moderna, forti spinte ci stanno già indirizzando verso l’epoca postmoderna. Ci stiamo muovendo, infatti, secondo quanto prescrivono
57
sia lo spirito che la lettera della più recente riforma sanitaria, verso l’introduzione dello “stile azienda” in sanità. Il modello di qualità comporta un rapporto nuovo con il paziente. Sommariamente possiamo dire che non solo il paziente deve essere informato e responsabilizzato per partecipare in modo autonomo alle decisioni terapeutiche, ma deve essere considerato come un “cliente". Oltre ad avere diritti da rivendicare, vuole anche essere soddisfatto.
Questa prospettiva caratterizza quel tipo di organizzazione sanitaria che è stata messa in moto con la riforma della riforma e che si sintetizza nel concetto di azienda sanitaria. Soddisfare i pazienti diventa un’esigenza strategica per la sopravvivenza dell’azienda stessa. Il paziente, infatti, spostandosi da una struttura all’altra, si porta dietro la sua capacità di spesa, rappresentata dalla sua quota capitaria. E importante, quindi. una gestione oculata dell’azienda: se perde i pazienti, perché questi preferiscono un’altra struttura, l’azienda esce dal mercato. Se i sanitari non trattano bene i pazienti per la ragione che è loro diritto in quanto cittadini avere una buona assistenza, devono farlo almeno per l’interesse dell'azienda.
Il modello di qualità postmoderno comporta delle variazioni anche in tutte le altre articolazioni fondamentali del sistema di rapporti entro cui si svolge l’azione sanitaria. Innanzi tutto l'interrogativo fondamentale che dovrà porsi chiunque abbia delle responsabilità nelle scelte ruoterà intorno a elementi di carattere gestionale: quale trattamento ottimizzerà l’uso delle risorse e produrrà un paziente-cliente soddisfatto? La fisionomia stessa dell’interrogativo etico viene modificata.
Nell’etica medica il registro per valutare la qualità è quello della bontà (l'azione è buona in quanto porta il beneficio della guarigione, lenisce i sintomi dolorosi); la bioetica si colloca entro la tradizione etica coltivata nel mondo anglosassone, che valuta se l’azione sia giusta o ingiusta, in rapporto ai diritti e nel rispetto delle procedure. La nuova stagione che si è aperta ci obbliga a interrogarci se l’azione sia appropriata rispetto ai fini da conseguire, che comportano sia una più acuta sensibilità per il bene comune e l’equità sociale, sia l’acquisizione di un atteggiamento che abbini la soddisfazione del cittadino/cliente con l’attenzione agli interessi dell’azienda.
La qualità, ovvero il valore etico di un intervento sanitario, oggi è molto più complessa. I criteri più recenti non devono sostituire quelli precedenti, ma integrarsi con essi. La “buona” medicina è quella che, come diceva Hahnemann, deve mirare a guarire in maniera rapida, efficace e duratura. Ma questo non basta: deve anche preoccuparsi di essere
58
“giusta”, rispettando i diritti del malato e promuovendo la sua autonomia. A queste considerazioni si aggiungono poi anche quelle relative a ciò che si dimostra appropriato nell’orizzonte della giustizia in considerazione dell’accesso ai servizi e dell’equa distribuzione delle risorse.
La buona medicina, quella dotata di qualità, è quella risultante dall’integrazione delle esigenze che nascono dall’etica medica, da quelle della bioetica, e delle esigenze, infine, di quella nuova stagione dell’etica in medicina che sentiamo incombere, sotto la spinta delle nuove condizioni sociali e della pressione dell’economia, e che possiamo chiamare etica dell’organizzazione. Per la precisione, da tutt’e tre contemporaneamente. Le stagioni dell’etica in medicina, con le rispettive esigenze riguardo a ciò che è giusto e appropriato nell’assistenza sanitaria, non vanno viste come modelli conclusi che si succedono nel tempo, ma come esigenze contemporanee e contestuali.
Lo schema seguente, che pone le scelte in uno spazio tridimensionale, può visualizzare la complessità della situazione attuale.
Finché la qualità dell’intervento sanitario sul paziente si misurava esclusivamente con il metro del beneficio del paziente (epoca premoderna), maggiore era il beneficio ― nello schema viene indicato simbolicamente con una retta numerata da 0 a 15 ― che il malato riceveva da quello che si poteva fare per lui, maggiore era la qualità, anche etica,
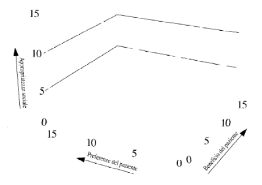
59
dell’atto medico. La modernità, con l’introduzione dell’autonomia del paziente, ha introdotto un altro parametro, indicato nello schema come asse delle preferenze. La buona scelta medica dovrà tener conto temporaneamente di due fattori: il beneficio da procurare al paziente e il suo consenso a ciò che il malato ha individuato e scelto come suo bene. La scelta si realizza sul piano orizzontale di una contrattazione, che spesso produce un compromesso (non è detto, infatti, che ciò che costituisce dal punto di vista clinico il maggior beneficio per il paziente corrisponda alle sue preferenze, o inversamente: ciò che il paziente informato vuole per sé può non coincidere con quanto la medicina sarebbe in grado di fare per lui).
A queste due dimensioni oggi dobbiamo aggiungere una terza, così che la decisione clinica ci appare collocata in uno spazio tridimensionale. Dobbiamo considerare, infatti, anche l’appropriatezza sociale degli interventi sanitari, in una prospettiva di uso ottimale di risorse limitate, solidarietà con i più fragili ed equità. Quello che possiamo fare per un malato, anche se valutabile con un punteggio alto sul parametro dell’appropriatezza clinica e su quello delle preferenze personali, potrebbe collocarsi molto in basso rispetto al criterio del buon uso delle risorse.
La buona medicina ci appare così come il frutto di una “contrattazione” molteplice, che deve tener conto di tre diversi parametri: l’indicazione clinica (il “bene” del paziente), le preferenze e i valori soggettivi del paziente (il “consenso informato”) e infine l’appropriatezza sociale. L’assistenza sanitaria, dovendo conciliare nelle sue scelte esigenze diverse e talvolta contrastanti, senza minimamente rinunciare alle esigenze della scienza, ci appare più che mai un’arte.
L’ideale medico dell’epoca postmoderna è una leadership morale. Il modello paternalista non funziona più là dove si assume lo stile dell’azienda postmoderna: è necessario dotarlo di autorevolezza. Non ci possiamo più basare su una divisione dei compiti di tipo burocratico. Soltanto chi ha quella che la cultura del management chiama la “vision”, cioè la visione strategica degli obiettivi e dei mezzi, sviluppa una forza morale capace di trascinare gli altri membri dell’équipe.
Il buon paziente è il cliente soddisfatto e consolidato; ma bisogna subito aggiungere che il nostro obiettivo non è il cliente in qualsiasi modo soddisfatto e consolidato, bensì il cliente giustamente soddisfatto. Il buon rapporto è la stewardship, che implica un atteggiamento non centrato sul professionista, ma sugli standard di qualità del servizio.
60
Consenso informato e buona medicina
L’alleanza terapeutica
Lo sviluppo dell’etica in medicina ha attraversato epoche diverse, ognuna delle quali ha comportato dei problemi particolari nei confronti del consenso informato, inteso come una modalità di esercizio della medicina che richiede la partecipazione attiva del paziente alle decisioni cliniche che lo riguardano.
Nel modello tradizionale, che abbiamo chiamato premoderno, il consenso informato non aveva né una collocazione teorica, né un’espressione pratica. Tutto quello che si richiedeva era l’assenso del paziente, che si traduceva nell’obbediente esecuzione delle prescrizioni mediche.
Non sarebbe giusto, però, valutare l’etica medica del passato a partire da ciò che in essa troviamo di carente. Essa è stata caratterizzata, invece, da grandi valori ideali, in un orizzonte di filantropia.
La pratica della medicina è stata sostanzialmente vincolata dalla volontà dei medici di mettere tutto il loro sapere al servizio della salute dei pazienti, cercando di tutelare al meglio lo stato di benessere nel soggetto. Comunque lo si voglia formulare, questo fondamentale dovere ha tradizionalmente improntato la professione medica.
Per verificare la sostanziale tenuta nei secoli di tale impegno, possiamo confrontare la “clausola terapeutica” del Giuramento di Ippocrate con una delle più recenti formulazioni dell’etica ippocratica. Essa risale al 1988. In tale data, il tradizionale incontro scientifico-commerciale di Milano-Medicina è stato inaugurato da un simbolico “processo a Ippocrate”: intellettuali e studiosi di diverse discipline sono stati mobilitati per un’analisi approfondita del celebre giuramento e dell’etica medica da esso rappresentata.
Valutati i pro e i contro di uno dei documenti fondamentali della tradizione culturale dell’occidente, considerate tutte le riserve, le condanne sommarie e le apologie d’ufficio, si è optato alla fine per la redazione di un nuovo testo del giuramento, elaborato da un comitato di esperti del Corriere medico.
Se raffrontiamo la nuova versione della clausola terapeutica con quella antica, possiamo constatare che lo spirito dello storico giuramento resta immutato:
61
“Accoglierò con umanità e sensibilità coloro che a me si affidano perché li curi, e parteciperò loro la mia dottrina affinché possano da uomini liberi trarre conforto e aiuto dall’arte medica, in salute e in malattia. E sarà mio impegno stare sempre vicino al paziente con pazienza pari alla sua. E stare sempre dalla sua parte, e soltanto dalla sua, con passione tutta mia.
Eserciterò la mia arte secondo un sapere che mi impegno ad accrescere costantemente, e prescriverò farmaci secondo un giudizio che manterrò puro e retto, e che sempre mi guiderà nello scegliere quei rimedi che sicuramente si siano dimostrati giovevoli. Non farò della mia arte ingiusto lucro, né anteporrò alcun interesse a quello del malato, nemmeno se richiesto dal potere di chi amministra e governa la cosa pubblica’’.
Al di sotto degli aggiornamenti, dei raffinamenti stilistici e degli ampliamenti retorici, è facilmente riconoscibile in filigrana l’antico testo. L’atteggiamento di fondo è il medesimo: il rispetto dell’etica medica è un dovere del sanitario, al quale non fa riscontro, però, un diritto giuridicamente rivendicabile da parte del malato.
L’elevatezza morale del modello a cui il medico cerca di adeguare il suo comportamento dà ancora più rilievo all’essenziale asimmetria del rapporto con il paziente. Il professionista sanitario è colui che sa qual è la scelta terapeutica ideale per ottenere il pieno benessere del malato e mette tutto il suo impegno per applicarla.
I medici cresciuti all’interno di questo modello mostrano notevoli resistenze ad abbandonarlo e hanno dalla loro parte delle buone ragioni. Innanzi tutto, una giustificata resistenza deriva dalla constatazione quotidiana di quanto sia illusorio un rapporto simmetrico tra sanitario e paziente: lo stato di malattia comporta naturalmente una condizione di bisogno, e quindi di fondamentale disparità. Qualcuno arriva a pensare che parlare di rapporto simmetrico tra chi fornisce le cure e chi le riceve sia un discorso puramente demagogico. L’autonomia del paziente, infatti, non può essere data per scontata, in quanto essa è più il risultato finale di un’educazione e di una crescita, che un pacifico punto di partenza.
Ma ci può essere anche una ragione di più alto profilo nell’aderire agli ideali veicolati per secoli dalla medicina ippocratica: per esempio il mondo non anglosassone, in particolare quello di tradizione latina, si
62
trova più a suo agio in una formulazione dell’etica che non sia centrata sull’individuo, autonomo e rivolto alla difesa dei propri diritti, ma si orienti piuttosto verso il “prendersi cura” reciproco, come struttura primordiale dell’esistenza umana (cfr. Rodotà, 1995).
Quest’ultimo è un punto di vista molto familiare a quelle professioni sanitarie, che in genere sentono come estraneo il linguaggio della bioetica elaborato a partire dalla prospettiva dei diritti individuali, della privacy, dell’autonomia. Nel mondo culturale latino, infatti, è più familiare l’etica della virtù, rispetto a quella dei diritti (Gracia, 1993); dall’etica ci si aspetta che guidi l’azione verso la qualità eccellente, piuttosto che si ponga a tutela dell’individuo, vigilando pertanto affinché non sia violato nella sua autodeterminazione.
Ogni medico coscienzioso sa, per esempio, che sarebbe irresponsabile da parte sua limitarsi a registrare richieste e rifiuti da parte dei pazienti. Le decisioni, infatti, sono spesso prese sotto l’influenza di stati d’animo turbati.
Un medico consapevole dei suoi doveri, e “alleato” con il paziente nella ricerca del miglior interesse dello stesso, non può rinunciare a esercitare l’arte della persuasione. Per esempio: un intervento demolitivo ― specie se devastante per l’immagine corporea, come la mastectomia per una donna ― potrebbe essere rifiutato di primo acchito, mentre la bilancia potrebbe, una volta valutato serenamente il rapporto rischio-beneficio, pendere dalla parte del beneficio procurato da tale scelta.
Il paternalismo non può essere rifiutato in blocco, quasi fosse uno stigma vergognoso di tutta la medicina premoderna.
C’è ancora e ci sarà sempre nella pratica della medicina un ampio spazio dove il medico può espletare quella funzione di sostegno che nella vita normale si identifica con ciò che fa un buon padre o una buona madre, è opportuno che il medico difenda, anche per la medicina del futuro, la convinzione che la buona cura comincia con il prendersi cura.
Terapie e diritti della persona
Il cambiamento nel rapporto tra medico e paziente, che nello schema generale di evoluzione dell’etica in medicina abbiamo sintetizzato come processo di “modernizzazione” (nel preciso senso culturale di passaggio all’epoca “moderna”, sinonimo di democrazia politica e di liberalismo economico, che ha progressivamente modificato tutte le
63
aree della vita sociale), comporta una trasformazione che si può paragonare a un radicale cambiamento delle “regole del gioco”. Le regole del gioco sono una cosa importante nella convivenza umana: che si tratti di sport o di sanità, di elezioni politiche o di accesso alle prestazioni erogate del Servizio sanitario nazionale. Chiunque ha a cuore che i cambiamenti avvengano in modo da non pregiudicare il pacifico svolgimento della vita sociale deve dare una priorità assoluta alle regole. Le modifiche delle regole vanno notificate a tutti, per tempo, ripetutamente, verificando che l’informazione arrivi a ognuna delle persone coinvolte e che ci sia un adeguato consenso al cambiamento.
Ebbene, in medicina, il passaggio all’epoca moderna comporta un cambiamento delle regole. Il primo sospetto che ci assale è che la trasformazione non sia accompagnata da un’informazione accurata, scrupolosa e capillare, come certamente accadrebbe se cambiassero le regole del gioco del calcio. A questo sospetto c’è da aggiungere la constatazione che, solitamente, al cambiamento delle regole viene opposta resistenza.
I comportamenti umani, infatti, sono vischiosi, tendono a resistere al cambiamento, in particolare quando la “perseverazione” è favorita da una coesione omogenea di tutto un gruppo professionale.
Nel caso particolare della professione medica, si tratta di comportamenti motivati in senso altamente etico e umanitario. I medici hanno di se stessi una comprensione centrata sul beneficio da arrecare alla salute dei pazienti; l’azione medica vuol essere intesa come rivolta al miglior interesse del malato. Dall’interno del mondo medico si sviluppa perciò una forte resistenza al cambiamento delle regole, proprio perché quelle precedentemente in vigore appaiono ispirate ai più alti ideali.
Le cure sanitarie oggi si devono ancor più armonizzare con il rispetto dei diritti della persona. Questa formulazione sintetica del cambiamento. che l’epoca moderna comporta, acquista contenuto quando consideriamo analiticamente tali diritti. Proviamo a prendere come punto di riferimento ùna delle formulazioni più note dei diritti umani: la dichiarazione di indipendenza degli Stati americani redatta da Thomas Jefferson nel 1776. Tra le verità che non hanno bisogno di essere dimostrate, in quello storico documento viene citato il fatto che tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti e che sono dotati di certi diritti innati, dei quali non possono essere privati a nessun patto: come il “diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità (“the pursuit of happiness”).
C’è inoltre da sottolineare che gli sviluppi biomedici più recenti
64
costringono la società a confrontarsi anche con il diritto alla vita, inteso come limite invalicabile. Le sicurezze che ci hanno accompagnato per secoli si incrinano di fronte a fatti nuovi. Chi va protetto, in nome del suo irrinunciabile diritto alla vita? Questo diritto si estende al feto, e a partire da quale fase dello sviluppo embrionale? è un diritto esclusivo degli esseri umani o si estende anche ad altre forme di vita animale? E ancora: fino a che punto va protetto il diritto alla vita? Il diritto alla vita va tutelato anche quando una vita ha perduto le qualità umane più fondamentali? Quelli sopraccitati sono altrettanti scottanti capitoli della bioetica contemporanea.
Tuttavia, a noi qui interessa soprattutto analizzare il nuovo rapporto con il secondo dei diritti dell’uomo menzionati nella dichiarazione di indipendenza americana: il diritto alla libertà. In termini sociali, tale diritto è stato fatto equivalere all’autonomia, intesa come capacità dell’individuo di autodeterminarsi nelle scelte, comprese quelle che vengono fatte nell’ambito delle cure sanitarie. Nel modello tradizionale le regole del gioco prevedevano una specie di sospensione dell’autonomia, quando l’individuo veniva a trovarsi nello stato di malattia: il medico ― spesso in collaborazione con la famiglia del malato ― è autorizzato a valutare quali informazioni fornirgli, a scegliere il trattamento appropriato e i percorsi da fargli seguire nell’accidentato camminò verso la salute (e ancor più in quello verso la morte).
Il diritto alla libertà, nella sua versione di diritto a scelte autonome, è apparso, sullo scenario della sanità, come un diritto di seconda generazione, rispetto ai diritti fondamentali che costituiscono il tessuto delle società democratiche, diritti per i quali sono state fatte le rivoluzioni liberali dell’epoca moderna. Secondo lo storico della medicina Diego Gracia, fino agli anni più recenti la rivoluzione liberale e democratica ha stentato a imporsi in medicina, nonostante avesse già modificato altri ambiti della vita sociale: “Nel mondo della salute la rivoluzione sociale ha preceduto in molti casi la rivoluzione liberale... Il liberalismo è sempre stato il grande ‘argomento in sospeso’ nella medicina occidentale” (Gracia, 1993, p.174).
La pratica del diritto alla libertà in medicina è stata coltivata soprattutto negli Stati Uniti, anche per la propensione degli americani a indulgere alla litigiosità giudiziale. L’impatto della prospettiva dei diritti sul modello tradizionalmente vigente in sanità, centrato sull’ideale umanitario e sul dovere del medico di orientare la sua azione al bene del malato, è stato dirompente.
65
Una delle prime formulazione del diritto del paziente al rispetto della propria autonomia anche in ambito sanitario è quella del giudice Benjamin Cardozo, in una sentenza del 1914: “Ogni essere umano adulto e capace di intendere e di volere ha diritto di decidere che cosa viene fatto al suo corpo” (Faden, Beauchamp. 1986). Come l’albero nel seme, in questa frase è contenuto tutto lo sviluppo, avvenuto negli ultimi due decenni, della regolamentazione del consenso informato e della tutela sempre più minuziosa del diritto del paziente a essere coinvolto nelle decisioni cliniche che lo riguardano. La “Legge dell’autodeterminazione’' del 1991, che abbiamo analizzato nei riferimenti normativi, può essere considerata come il punto di arrivo finale dell’intera parabola del diritto alla libertà applicato alla sanità.
Malgrado la sorda resistenza dei medici formati in una tradizione più ispirata al principio del beneficio per il paziente e al paternalismo che al rispetto dell’autonomia, il movimento della “modernizzazione” della pratica medica si è esteso a tutti i Paesi dell’area occidentale. L’informazione del paziente e l’acquisizione abituale del consenso non sono più un “optional”, ma tende a diventare un obbligo deontologico e, in alcuni casi, anche legale.
Questi sviluppi dell'autonomia del paziente e del suo diritto all’informazione, tuttavia, potrebbero evolvere anche verso un esito infausto, è possibile, infatti, immaginare che lo spostamento di accento dal beneficio per il paziente alla sua autonomia avvenga in un clima avvelenato dalla diffidenza e dal risentimento per il potere perduto, col triste risultato che il diritto alla libertà si possa tramutare nella sua caricatura. ossia nel “diritto” a essere lasciato solo, proprio nel momento in cui il malato ha maggior bisogno della presenza benevola ed efficace di un sanitario che lo assista, non solo con i mezzi che la scienza gli mette a disposizione, ma anche con la sua completa umanità. Lo sviluppo della richiesta di un consenso informato ― anche se redatto, per fini burocratici, su un modulo standard preconfezionato ― potrebbe risultare come un espediente per rifilare al malato la responsabilità per decisioni che andrebbero invece condivise.
L’integrazione tra il diritto all’informazione e il rispetto dell’autonomia personale nella pratica della medicina dovrebbe avvenire senza rinunciare ai valori che sono assolutamente impliciti nella medicina ispirata al bene del paziente. Se qualcosa deve finire, questo qualcosa non devono essere sicuramente gli ideali della medicina ippocratica, bensì la pratica della medicina “del silenzio”, ovvero di quella medicina muta ars che ritiene di poter fare a meno del dialogo col paziente.
66
Questo anche perché i veri benefici per il malato, quelli che rispettano i suoi valori e le sue scelte di vita ― quel beneficio che presuppone un’intelligente negoziazione tra le enormi potenzialità della medicina di oggi e le aspirazioni qualitative che reggono la vita di una persona ― non possono essere assolutamente individuate senza una vera comunicazione.
La formulazione dei diritti umani, dalla quale tutto il nostro argomentare ha preso le mosse, menzionava, tra le “verità che non hanno bisogno di essere dimostrate”, anche il diritto innato dell’uomo alla “ricerca della felicità”. Nei confronti di quest’ultimo diritto noi europei siamo stati sempre piuttosto scettici. La “ricerca della felicità” l’abbiamo lasciata all’iniziativa individuale del cittadino, chiedendo allo Stato di occuparsi solo di due “inviolabili” diritti: la protezione della vita e la tutela della libertà. La ricerca della felicità non l’abbiamo inclusa nell’elenco dei diritti costituzionali, e tanto meno abbiamo considerato un possibile legame tra essa e la pratica della medicina. Eppure niente sembra più attuale di questa nuova frontiera di diritti, che potremmo chiamare “diritti di terza generazione”. Essi emergono insieme a quello che è sicuramente una nuova richiesta di salute, non solo limitata alla lotta contro la malattia, ma identificata con il pieno benessere: fisico, psichico, sociale e spirituale.
Quella che si profila è una diversa fisionomia globale della medicina, per la quale è stata coniata l’espressione “medicina del desiderio”. Il modellamento del corpo sul desiderio diventa l’elemento trainante della ricerca di salute nella società ad alto sviluppo economico. Il ventaglio degli interventi richiesti a questo tipo di medicina è molto ampio. Comprende ― tanto per nominarne alcuni ― i trattamenti anti-stress ed estetici; la regolazione della fertilità (fecondazione in vitro, gravidanza dopo la menopausa, programmazione del sesso del nascituro, modifiche dell’eredità genetica) che va spesso oltre, e talvolta contro, i limiti posti dalla natura; la determinazione da parte del soggetto della quantità e qualità delle cure che determinano la lunghezza della vita giunta al termine (dai limiti posti all’accanimento terapeutico mediante disposizioni previe ― “living will” o testamento biologico ― alla richiesta di eutanasia, in condizioni di vita giudicate soggettivamente intollerabili).
Il nodo etico di questo tipo di domanda di salute, radicata nella personale “ricerca della felicità” concepita come un diritto, si stringe intorno all’espropriazione della tradizionale delega al medico di decidere, in “scienza e coscienza” che cosa dovesse essere fatto al malato. In una medicina di questo profilo al sanitario sembra sottratta qualsiasi facoltà di intervenire con un proprio giudizio etico in merito all’azione appropriata
67
da intraprendere. Quello che ci si attende da lui è solo una prestazione d’opera, finalizzata a realizzare degli obiettivi che gli vengono imposti da un paziente promosso ormai a “utente”, quando non addirittura a “cliente”.
L’obiezione di coscienza rimane un’estrema barriera contro l’avanzata del desiderio, spesso nel suo significato di componente irrazionale dell’agire umano, in medicina, che minaccia di travolgere il tradizionale modello di rapporto medico-paziente. Questa possibilità ha avuto un esplicito riconoscimento nel caso dell’interruzione di gravidanza (legge 194 del 1978). Più di recente, l’ultima revisione del codice deontologico dei medici italiani (1995) ha dichiarato incompatibili con la seria professionalità del medico le pratiche di fecondazione medicalmente assistita che più si allontanano dal profilo di intervento medico a un problema di sterilità della coppia. E forse opportuno prendere in considerazione la possibilità che la non disponibilità del medico, per ragioni di coscienza, possa essere invocata anche in altre circostanze create dalla medicina del desiderio, in modo da garantire al sanitario il pieno rispetto dell’autonomia della sua decisione etica, caratteristica che gli spetta in quanto singolo soggetto.
La responsabilità per la propria salute
Nel contesto culturale che abbiamo visto come tipico dell’epoca moderna, cambiano, in modo direttamente correlato, sia i diritti che i doveri del medico e del paziente. L’altra faccia del diritto del paziente a entrare attivamente nel processo decisionale che lo porterà, insieme al medico, alle scelte terapeutiche che meglio esprimono i suoi valori personali, è costituita dal suo dovere di rendersi responsabile per la propria salute e per la qualità della propria vita. La prima conseguenza concreta è che il paziente diventa compartecipe dell’incertezza del medico.
Nessuno ha contribuito in misura maggiore della sociologa americana Renée Fox a mettere a fuoco il posto che occupa l’incertezza nel sapere medico. Da più di un trentennio la studiosa si dedica a esplorare il ruolo che ha l’incertezza nella formazione dello studente di medicina, nella socializzazione del medico e nella condizione umana dei professionisti della salute; l’incertezza è il filo rosso che lega le ricerche, l’insegnamento, gli scritti della Fox. L’insieme della sua opera ci permette di registrare i profondi cambiamenti che il problema della certezza in
68
medicina ha subito nel giro di una generazione.
Discepola del sociologo Talcott Parsons, Renée Fox ha cominciato a occuparsi, fin dagli anni ’50, del modo in cui gli studenti di medicina vengono “socializzati” nella professione. Nel saggio che raccoglie la sua prima ricerca ― intitolato Training for uncertainty (Fox, 1957) ― giungeva alla conclusione che ciò che è specifico della formazione medica è di essere un itinerario finalizzato a fornire la capacità di gestire l’incertezza.
Nel corso del suo lungo allenamento il medico in formazione si può confrontare con tre tipi fondamentali di incertezza. Il primo è quello che deriva da un dominio incompleto o imperfetto del sapere disponibile: nessuno è in grado di possedere tutte le qualificazioni e tutte le conoscenze del sapere medico. Il secondo tipo di incertezza dipende dai limiti propri della conoscenza medica attuale (esistono immensi problemi ai quali nessun medico, per quanto esperto, può dare ancora una risposta, anche se è legittimo sperare che lo si possa fare in futuro). Una terza causa di incertezza è quella che consiste nella difficoltà di distinguere l’ignoranza o l’incapacità personale dai limiti specifici della conoscenza medica attuale; ovvero, in parole semplici, se l’eventuale fallimento vada imputato all’ignoranza del medico o a quella della scienza.
All’occhio dello studioso dei comportamenti sociali risulta agevole stabilire un rapporto tra l’incertezza del sapere medico e quella intrinseca alla condizione umana, nella quale i fatti relativi a salute, malattia, benessere, morte, sofferenza sono sempre problemi critici per quanto riguarda il loro stesso significato. Ma il sociologo è in grado di distinguere anche i meccanismi attraverso i quali gli studenti di medicina in formazione riescono ad adattarsi all’incertezza. Al termine dell'allenamento all’incertezza”, gli studenti diventano capaci di accettare l’incertezza come parte integrante della pratica professionale della medicina, di distinguere i limiti propri da quelli della scienza, di affrontare l’incertezza con un certo candore e una positiva filosofia venata di scetticismo.
Studiando l’evoluzione dell’incertezza medica, Renée Fox ha notato una marcata differenza tra quella degli studenti in medicina degli anni ‘50 e l’incertezza tipica dei decenni successivi (Fox, 1974 e 1980). La nuova e più forte sensibilizzazione all’incertezza medica, i cui inizi si possono far risalire alla metà degli anni ’70, presuppone l’affermarsi della nuova biomedicina e di quella riflessione critica che ha preso il nome di bioetica. Il contesto sociale è cambiato, e quindi è cambiato
69
anche il profilo dell’incertezza. Questa non si situa più solo all’interno della scienza medica, ma piuttosto alla frontiera tra la medicina, la politica e l’etica.
Le problematiche bioetiche danno all’incertezza connotazioni molto più ampie. Un significato emblematico assume in questo senso la perplessità relativa a un iter sperimentale che preveda la manipolazione del DNA. Il presentimento che la capacità di manipolare i geni potrebbe alla fine provocare una catastrofe si abbina a dubbi circa i limiti delle regolamentazioni relative alla ricerca scientifica (“Chi decide a chi competono le decisioni?”). Un discorso analogo si può fare circa gli effetti nocivi che prodotti chimici e farmaci possono determinare sull’ambiente e sulla salute dell’uomo (prodotti cancerogeni o mutageni). La stessa metodologia della ricerca ― per esempio, la validità dei test, riguardanti sostanze cancerogene, fatti sull’animale ― crea problemi notevoli di incertezza. La pratica di prescrivere delle norme e di tormentarsi su questa prescrizione (vedi il ricorso alle “moratorie” in vari ambiti: ingegneria genetica, trapianti sperimentali di organi, ricerca sull’embrione) lascia emergere una figura inedita di incertezza che potremmo chiamare “incertezza di secondo livello”, ovvero “incertezza dell’incertezza”.
La maggior parte dei problemi posti attualmente dall’incertezza e dal rischio non si può ridurre entro il quadro analitico di una sola disciplina o di una singola professione. Le incertezze associate ai progressi scientifici e tecnici più recenti (come il trapianto di organi, il depistaggio di malattie genetiche e la diagnosi prenatale, la chemioterapia per il cancro) sono legate a metaproblemi che eccedono l’ambito dell’incertezza medica. Sia che si parli di rischi potenziali paragonati ai vantaggi eventuali, di conseguenze aleatorie che determinati interventi terapeutici possono comportare per la salute e la sopravvivenza, di capacità predittiva di test diagnostici, oppure di qualità della vita, inevitabilmente si incontrano problemi fondamentali della società e della stessa condizione umana (cfr. Spinsanti, 1991).
Dall’analisi dell’evoluzione dell’incertezza medica nel corso di un trentennio, Renée Fox giunge alla conclusione che esiste almeno una coscienza collettiva latente del fatto che le nostre istanze politiche, legislative e professionali attuali non possono inglobare completamente, né risolvere convenientemente il senso profondo delle nostre questioni morali e metafisiche riguardanti l’incertezza relativa alla salute e alla medicina (Fox, 1980). Nella medicina attuale sembra giunta all’estrema maturazione quell’incertezza che già il primo, e il più celebre, degli Aforismi attribuiti a Ippocrate considerava come l’orizzonte naturale in cui si esercita l’arte medica:
70
“La vita è breve,
l’arte lunga,
l’occasione fuggevole,
l’esperienza fallace,
il giudizio difficile”.
L’incertezza è, dunque, con gli aspetti etici connessi, l’orizzonte connaturale alla decisione clinica. Il delicato equilibrio del sapere medico, perpetuamente oscillante tra la certezza e l’incertezza (ivi comprese le certezze autentiche e quelle ideologiche, che presuppongono una semplificazione deformante della realtà, le incertezze paralizzanti e quelle creative, perché si aprono su orizzonti di senso più ampio), è dovuto al fatto che oggetto della medicina non sono propriamente le malattie, ma uomini malati, è il soggetto umano il centro attorno al quale ruota il sapere medico. Ogni sapere relativo alla patologia che, per diventare certo, escluda il soggetto, si condanna con ciò stesso a fallire il suo obiettivo.
Senza il soggetto, non si capisce la malattia; senza il soggetto, non si realizza la guarigione. Forse si può avere la guarigione in senso riduttivo, intesa come restaurazione di uno “status quo ante”. Ma in senso antropologico pieno, la guarigione ― che differisce dal recupero dello stato di salute previo all’irrompere della malattia e comprende variabili quali l’aumento della consapevolezza, il cambiamento dello stile di vita, l’acquisizione di una conoscenza di sé che includa quella parte di ombra che probabilmente gioca un certo ruolo nella creazione della malattia ― non può essere raggiunta e considerata tale senza la partecipazione del soggetto.
Quello che osserviamo nella prassi medica quotidiana è, invece, proprio la sistematica esclusione del soggetto, inteso come momento fondamentale unificatore, in cui il biologico, lo psichico e il sociale si riuniscono sotto la categoria del biografico. Quando si pretende di dar ragione della malattia considerando come insignificante la dimensione soggettiva dell’uomo, si produce una dipendenza, che è allo stesso tempo psicologica e istituzionale, dall’apparato sanitario, cui corrisponde un’implicita delega agli “esperti” di attuare la guarigione.
Questo abbandonarsi passivo trova spesso riscontro nella volontà esplicita, proprio di coloro che rappresentano il sapere medico, di escludere le complicazioni che derivano da un coinvolgimento del soggetto. Il messaggio: “Tu non c’entri per niente con la tua malattia”, trasmesso,
71
almeno implicitamente, attraverso una gestione del tutto impersonale del fatto morboso, produce un irreparabile impoverimento antropologico della malattia, ma anche una semplificazione del processo terapeutico che può risultare allettante tanto per il sanitario, quanto per il malato.
La guarigione, intesa come evento sostanziale più pregnante, più globale del semplice recupero della salute, cioè come una possibilità di riappropriarsi di se stesso, non può avvenire soltanto adattandosi alle regole di comportamento che i rituali sanitari stabiliscono per il “buon” paziente. Nessuno può sapere, al posto del soggetto, qual è il cammino verso la guarigione, nel suo equilibrio assolutamente singolare di opposizione e resa, di male da combattere e male da accettare.
La resistenza dei sanitari ad accettare la partecipazione del soggetto ― che può sottointendere il significato personale della malattia e della guarigione nell’insieme del processo terapeutico ― è solo una parte della verità. L’altra metà del fallimento del programma di antropologizzare la malattia va attribuita ai malati stessi. Sono essi che vogliono semplicemente liberarsi di un sintomo e non scendere fino alle radici della malattia, là dove si incontra la propria partecipazione al fatto di essere malato e dove si è chiamati ad assumere la propria responsabilità per la guarigione.
Un approccio etico positivo, che rispetti il senso soggettivo della malattia e della guarigione e non deresponsabilizzi il malato ma lo guidi, piuttosto, a riprendersi la responsabilità della sua vita proprio attraverso la vicenda patologica che sta attraversando, ha un difficile compito davanti a sé. Il principale ostacolo è costituito dalla contrapposizione corrente tra due atteggiamenti di fondo nei confronti del sintomo morboso: comprendere ed eliminare.
L’approccio psicoterapeutico ha fatto proprio il primo. Per lo psicoterapeuta il sintomo va interrogato, affinché lasci trapelare il suo senso; la guarigione viene fatta coincidere non con la semplice eliminazione del sintomo, ma con l’appropriazione del suo significato da parte del soggetto. Tuttavia, questa concezione si è estesa tutt’al più alle somatizzazioni nevrotiche, ma non al resto delle malattie somatiche di competenza della medicina. La pratica terapeutica di quest’ultima si è sempre più identificata con l’approccio che si propone di eliminare il sintomo.
La clinica si può rinnovare solo se, senza ratificare questa contrapposizione tra il comprendere e l’eliminare, instaura una pace tra queste due dimensioni o concezioni dell’atto terapeutico. E necessario abolire
72
la distinzione artificiale, o soltanto di comodo, tra clinica delle malattie somatiche e clinica della patologia di tipo psicologico, che si basa su un dualismo che la medicina cosiddetta psicosomatica ha solo sfumato, senza riuscire ad abolirlo.
Il mettere pace inizia con il dissipare gli equivoci: coloro che sono tutti tesi verso la strategia dell’eliminazione sospettano coloro che inclinano verso il comprendere, quasi fossero alleati della malattia, conniventi con il male; per contro, coloro che si collocano sul versante del comprendere accusano pesantemente i sanitari che sono sul versante dell’eliminazione di praticare una specie di veterinaria applicata all’uomo, riducendo il proprio ruolo a quello di meccanici dell’organismo. Queste due modalità non vanno contrapposte, ma integrate.
Quando alla malattia si dà il permesso di parlare fino in fondo e si esercita verso di essa un ascolto totale, si può realizzare la chiusura del circolo ermeneutico, mediante un comprendere che non è antitetico ma complementare all’eliminare. Solo questo è un processo terapeutico completo, che comporta l’esigenza di dare alla malattia dell’uomo tutto lo spessore soggettivo che le compete.
I limiti alle terapie: problemi antropologici ed etici
Tra i comportamenti medici che suscitano con più forza il malessere dell’opinione pubblica, uno dei primi posti spetta all’accanimento terapeutico. Se ne discute molto, e con molta passione. Ciò, però, non significa che se ne parli con appropriatezza. Anzi, a ben vedere, l’uso corrente dell’espressione è viziato da un prevalere di “pathos” che ne fa uno dei cavalli di battaglia di chi accusa la medicina di “disumanizzazione”. In pratica, quando gli sforzi di salvare la vita a un malato non hanno risultato, vengono bollati come “accanimento terapeutico” e sui medici viene gettato il sospetto di comportarsi come tecnici disumani, che prolungano un’azione inutile mirando a fini personali, più che al bene del malato. Se invece l’intervento medico ha successo, i sanitari vengono lodati per la loro perizia e dedizione alla causa della guarigione del malato, vista come fine unico della medicina. Si tratta, quindi, di un giudizio “ex post”, e non di un’accurata descrizione del delicato processo di decisione clinica, dove al medico è richiesto di trovare “ex ante” la giusta misura per il suo intervento, in un precario equilibrio tra l’eccesso e la carenza, tra il “troppo” e il
73
"troppo poco”, tra l’ostinazione cieca e l’abbandono prematuro del paziente, in quella condizione di incertezza che è intrinseca a ogni decisione medica.
È comprensibile che i medici reagiscano per lo più con irritazione all'accusa approssimativa di accanimento terapeutico, soprattutto quando viene filtrata da un’informazione vorace e spettacolare, che deforma il contesto in cui vengono prese le decisioni. Basti pensare alla ridda di insinuazioni e accuse rivolte ai medici che hanno assistito Fellini negli ultimi giorni di vita. La facile etichettatura di accanimento terapeutico ferisce i medici che lottano per tenere in vita i malati perché misconosce il fatto che i risultati positivi in medicina sono il frutto di molta tenacia. Se, dopo aver mobilitato tutte le energie della mente e del corpo per contrastare la morte, il medico si sente rivolgere l’accusa di aver indulto all’accanimento terapeutico, è molto probabile che possa lasciarsi prendere dallo sconforto. È quell’alleanza tacita tra il terapista e il paziente, che costituisce tradizionalmente lo scheletro dell’arte terapeutica, viene ulteriormente scossa.
L’accanimento terapeutico è, dunque, solo il frutto di malintesi? Dipende esclusivamente dall’incompetenza degli informatori e dei cittadini, che equivocano sul significato degli sforzi medici per prolungare la vita dei malati? L’accanimento terapeutico va accantonato come un falso problema? Prima delle dovute risposte a questi interrogativi, esaminiamo che cosa avviene, sempre a livello di opinione pubblica, circa l’accanimento diagnostico. Qui lo scenario è completamente diverso. Non ci sono mobilitazione dei media, scambi di accuse e difese; l’argomento non viene problematizzato sotto la spinta di forti emozioni. Raramente capita che qualcuno si lamenti per troppe indagini diagnostiche. Semmai la categoria invocata per valutare eventuali abusi è quella dello spreco delle risorse, non quella dell’accanimento. Visto dalla parte del paziente, l’eccesso diagnostico non sembra un pericolo per la salute: meglio un test in più che uno in meno...
Registrate le differenze tra i due ordini di problemi e l’inadeguatezza del termine “accanimento” utilizzato per indicarli ― anche per la connotazione moralistica che lo accompagna e le reazioni che suscita in chi viene fatto oggetto di accusa ― resta tuttavia l’interesse per la ricerca della giusta misura tanto nell’ambito della terapia quanto in quello della diagnosi.
Un cambiamento strategico in questa direzione consiste nell’introduzione in medicina di un punto di vista che abitualmente non era tenuto in considerazione: quello del paziente stesso. Anche sotto questa prospettiva
74
vediamo l’utilità di promuovere il modello di rapporto incentrato sul consenso informato. Tradizionalmente, finché l’unico criterio sul quale doveva misurarsi la qualità morale dell’atto medico era la sua capacità di realizzare il “bene del paziente”, questo veniva praticamente a coincidere con l’ambito delle possibilità stesse della medicina (le quali, peraltro, erano molto più limitate di quanto i medici amassero concedere e far sapere ai pazienti...). La prima seria divaricazione tra il possibile e l’auspicabile è avvenuta, verso la metà del nostro secolo, con l’acquisizione della possibilità di mantenere in vita un paziente mediante le tecniche di respirazione artificiale.
Nel medesimo periodo anche nell’ambito dell’etica medica si sono registrati i primi tentativi di introdurre delle distinzioni che fossero d’aiuto ai medici nelle decisioni che erano costretti a prendere. Negli anni ‘50 fu molto apprezzata la distinzione, proposta da Pio XII, tra “mezzi ordinari” e “mezzi straordinari”. Secondo tale criterio, gli sforzi rivolti a salvare la vita o a prolungare uno stato di particolare sofferenza possono essere lecitamente tralasciati quando hanno un carattere di straordinarietà. La distinzione ha avuto molto successo ed è stata ampiamente adottata dall’etica sviluppatasi senza riferimenti religiosi. Mira a individuare gli interventi medici ritenuti obbligatori ― identificati con quelli ordinari ― distinguendoli da quelli che possono essere omessi senza colpa morale.
Nella pratica sanitaria il criterio della straordinarietà dei mezzi è di difficile utilizzazione, a meno che non sia abbinato a qualche altro criterio come, per esempio, valutare se l’intervento terapeutico previsto prolunghi la vita o soltanto il processo del morire. Progressivamente nell’ambito dell’etica medica si è avvertita l’inadeguatezza della distinzione tra mezzi ordinari e mezzi straordinari a guidare le decisioni in situazioni di conflitto. Nella stessa morale cattolica si è sentito il bisogno di un superamento di quella distinzione. La dichiarazione sull’eutanasia della pontificia Commissione per la dottrina della fede (1980) ha registrato e ratificato il cambiamento di parametro di valutazione: “Finora i moralisti rispondevano che non si è mai obbligati all’uso di mezzi ‘straordinari’. Oggi però tale risposta, sebbene valida in linea di principio, può forse sembrare meno chiara, sia per l’imprecisione del termine che per i rapidi progressi della terapia. Perciò alcuni preferiscono parlare di mezzi ‘proporzionati’ e ‘sproporzionati’ ”.
L’idea di proporzionalità rimanda necessariamente a un fine, a una gerarchia soggettiva di valori, a una valutazione del tipo di vita che la persona considera conciliabile o inconciliabile con il proprio modello di
75
“buona vita”. Siamo così rinviati a un giudizio di qualità di vita, che non può essere posto al di fuori dei valori di riferimento del soggetto. Muovendoci in questo orizzonte, siamo entrati nella prospettiva etica che abbiamo identificato come propria dell’epoca moderna, in quanto essa integra il valore dell’autonomia individuale nel disegnare ciò che è appropriato all’ideale personale del singolo.
L’autodeterminazione del paziente entra a far parte costitutivamente di quella ricerca della giusta misura ― che si colloca tra il troppo e il troppo poco ― che determina la qualità dell’atto medico.
In questa prospettiva diventa più comprensibile il fantasma dell’accanimento terapeutico, che turba tanti nostri contemporanei. Esso nasce dal timore che il proprio metro di valutazione dei trattamenti possibili venga disatteso da un mondo di professionisti sanitari sintonizzati unicamente sui valori del prolungamento della vita. Non è necessario immaginare chissà quale disumano infierire su un corpo incapace di difendersi per attivare la fantasia dell’accanimento: basta la preoccupazione di una decisione presa su di noi, invece che con noi. Conseguentemente, la risposta positiva alla possibile deriva della pratica medica verso questa violazione della persona e del rispetto che le è dovuto non si restringe a delle limitazioni nell’impiego dell’intero arsenale terapeutico quando il malato ha iniziato il processo irreversibile del morire, ma la risposta adeguata inizia prima, mediante l’accettazione della prospettiva teorica e pratica proposta dalle “cure palliative”.
Ciò implica la pari dignità tra la medicina finalizzata a invertire il corso della malattia o a contrastare la morte e quella che ha come obiettivo il prendersi cura del paziente e accompagnarlo nel cammino inevitabile, lenendo i sintomi e rendendo possibile la “buona morte”. La filosofia sottostante alle cure palliative è l’antidoto appropriato a quelle forme di abuso alle quali ci si riferisce quando si parla di accanimento terapeutico.
L’orizzonte generale della bioetica ci è d’ausilio anche nel collocare i problemi posti dal cosiddetto accanimento diagnostico. L’imputato qui non può essere il clinico nella sua volontà di stabilire una diagnosi. Questo resta il primo e ineliminabile passo per una corretta procedura medica. L’etica medica tradizionale ha anche curato che l’intenzione diagnostica fosse guidata dalla volontà di procurare il bene del malato. Nei confronti di questi, infatti, non è giustificabile un sapere per il sapere, ma solo quello che si apre su un’operatività terapeutica. Non è un buon diagnosta il clinico incompetente, che copre la propria ignoranza in fatto di diagnosi differenziale scandagliando alla cieca e moltiplicando
76
indagini diagnostiche a tappeto. Finché siamo guidati da queste preoccupazioni, ci muoviamo ancora nell’ambito dell’etica medica. Entriamo nell’ordine problematico che è tipico della bioetica quando chiediamo al medico di farsi carico anche della preoccupazione per l’efficienza dei servizi sanitari e per il contenimento delle spese per la salute sostenute dal sistema sanitario.
Oltre che il tradizionale principio del beneficio per il paziente e la comunità e quello moderno dell’autodeterminazione del paziente, sancito dal consenso informato, oggi il sanitario è chiamato in modo crescente a tener presente nelle sue scelte cliniche l’esigenza di ottimizzare l’uso delle risorse, che diventano sempre più scarse con il crescere della domanda.
Il medico, in epoca di sviluppo della medicina ― e di espansione economica ― poteva immaginare di lasciarsi guidare dalla domanda: "Che cosa posso fare di più per il malato che ho in cura?". Oggi sarebbe irresponsabile se ragionasse ancora in questi termini. Deve invece chiedersi: "Di che cosa posso fare a meno, pur ottenendo lo stesso risultato di qualità nella cura del paziente?". In altre parole, il criterio dell’economicità nell’uso delle risorse, a cominciare da quelle diagnostiche, deve entrare nel perimetro dei principi che circoscrivono la "buona medicina". Anche l’intenzione diagnostica deve proporsi la giusta misura: quella che si colloca dopo il "troppo poco" e prima del "troppo". In questo orizzonte il problema del consenso informato confluisce in quello della ricerca della giusta soddisfazione del paziente.
Il paziente è “un cliente che ha sempre ragione”?
Il modello della qualità della prestazione medica, che si impone in epoca di ottimizzazione nell’uso delle risorse che abbiamo chiamato “aziendale” o postmoderno, è particolarmente insidioso. Quando portiamo nella sanità lo stile azienda e consideriamo il rapporto con il paziente come cliente, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo anche messo le premesse per affossare valori importantissimi che ci sono stati trasmessi in 25 secoli di medicina, come l’orientamento al bene del paziente. Promuovendo il paziente-cliente, non dobbiamo dimenticare che la soddisfazione del paziente non è un imperativo assoluto, sciolto cioè da vincoli morali. Qualsiasi azienda, ma soprattutto l’azienda sanitaria, deve essere sottoposta alle esigenze dell’etica. Il paziente non va soddisfatto in qualsiasi modo, ma solo in modo giusto.
77
Un supporto sistematico per visualizzare i problemi della soddisfazione in rapporto con le esigenze dell’etica può essere fornito dallo schema riportato di seguito.
IL QUADRILATERO DELLA SODDISFAZIONE
-
giustamente soddisfatto
giustamente insoddisfatto
ingiustamente soddisfatto
ingiustamente insoddisfatto
Le ragioni dell’insoddisfazione sono diverse, è ovviamente insoddisfatto il paziente a cui, per incuria o incompetenza, non sia stato diagnosticato e trattato il suo male: egli ha diritto che, secondo il modello dell’etica medica, sia messo in atto tutto ciò che gli procura il beneficio che è autorizzato ad aspettarsi. Ma sarà insoddisfatto anche il paziente diabetico ― per fare un esempio ― che venga “messo a insulina” per decisione autoritaria del “professore”, senza che gli sia spiegato il significato e la necessità della decisione terapeutica, i vantaggi che ne ricava e le esigenze di “compliance”. La soddisfazione del paziente non può diventare un assoluto, ma va confrontata con alcune esigenze imprescindibili, in base alle quali possiamo dire che il paziente è giustamente soddisfatto. Per portare un esempio tratto dal “nursing”: come sanno gli infermieri che lavorano in ambito geriatrico, gli anziani spesso non sentono lo stimolo della sete e rifiutano di bere. Sarebbe soddisfatto, ma ingiustamente, l’anziano che fosse lasciato semplicemente alle sue preferenze e non trattato secondo le esigenze della scienza infermieristica. In questo caso ciò che determina se la soddisfazione soggettiva del paziente sia giusta o ingiusta è il sapere che è proprio del professionista. Il primo e fondamentale criterio con cui la soddisfazione del paziente si deve misurare, se vogliamo che si realizzi una giusta soddisfazione, è quello della scienza. La coscienza del sanitario deve vigilare perché sia
78
rispettata la prima e più fondamentale esigenza dell’arte medica: "Primum non nocere". Non si può e non si deve arrecare un danno, anche se questo, paradossalmente, comportasse la soddisfazione del paziente.
modi di ottenere una soddisfazione ingiusta possono essere molti. Alcuni a danno del paziente (si può arrivare anche a dargli delle informazioni inesatte, fino al vero e proprio imbroglio), altri a danno di terzi (è chiaro che il paziente a cui faccio, per un privilegio, saltare la lista i’attesa è soddisfatto, ma è ingiustamente soddisfatto se considero le esigenze di equità).
Se la soddisfazione non è l’ultimo criterio di qualità, ma va piuttosto misurata con le esigenze dell’etica, la stessa cosa possiamo dire dell’insoddisfazione. Ci sono casi in cui il paziente è ingiustamente insoddisfatto. Questo è il caso del paziente che va dal medico di medicina generale con la sua richiesta di un farmaco (magari quello che ha fatto tanto bene al vicino o di cui si parla di più...), oppure vuole un trattamento di compiacenza, come un certificato falso di malattia. Se questo paziente non viene soddisfatto, cioè gli si nega ciò che richiede in modo illegittimo, allora è ingiustamente insoddisfatto.
La prospettiva interessante che apre il “quadrilatero della soddisfazione” è quella di proporre una visione dinamica dell’etica. Troppo spesso identifichiamo l’etica con un’istanza che giudica i comportamenti ― buono o cattivo, giusto o ingiusto, appropriato o non appropriato ― ma meno adatta a ottenere delle trasformazioni significative dei comportamenti.
La prospettiva cambia se, tenendo a mente il quadrilatero della soddisfazione, ci domandiamo: quale intervento dobbiamo mettere in atto affinché un paziente, che nel grafico si trova in un quadrante inferiore, passi in uno superiore? L’obiettivo ideale è che si collochi nel primo a sinistra, tra coloro che sono giustamente soddisfatti; ma se ciò non è possibile, almeno nel secondo, vale a dire che il paziente sia giustamente insoddisfatto (questa possibilità di un’insoddisfazione insanabile ci ibera da un complesso di onnipotenza: non possiamo far sì che tutti siano soddisfatti, ma possiamo evitare almeno che lo siano ingiustamente...).
L’etica ci appare così uno strumento operativo: ci stimola a fare qualcosa per modificare una situazione. L’etica è essenzialmente un insieme di interventi dinamici, tesi a un risultato. La qualità dell’intervento sanitario, infine, sta nella sua capacità di integrare i diversi elementi,
79
ossia che la scienza medica ritiene assodato e raccomandabile (da questo punto di vista non si potrà mai accettare in medicina una logica del “cliente” che ha sempre ragione...), ciò che è conciliabile con le esigenze dei diritti umani e con l’autodeterminazione del paziente, ciò che promana dall’orizzonte dell’ottimizzazione delle risorse che inaugura l’era delle aziende sanitarie.
80
81
IV
CONSENSO INFORMATO TRA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Comunicare senza informare
La scena di un vecchio film ci permette di visualizzare, grazie a una situazione tipica, in che modo si realizza una comunicazione senza informazione. Si tratta del film Vivere di Akira Kurosawa, del 1952, un classico della storia del cinema. Il protagonista, un umile capufficio del catasto, va a farsi visitare da un medico per persistenti dolori allo stomaco. In sala di attesa ha un colloquio con un “veterano” degli ambulatori medici, il quale dapprima gli descrive esattamente i sintomi del cancro dello stomaco, poi passa a predirgli il comportamento del medico. Se questi, guardando la radiografia, minimizza, nega risolutamente che si tratti di cancro, scherza e gli dice che può mangiare tutto quello che vuole, si può essere certi: la diagnosi di cancro è confermata! Al malato restano solo pochi mesi di vita. E proprio in questo modo indiretto il nostro capufficio verrà a conoscere la sentenza che lo riguarda. Anche in assenza di una informazione veritiera, la comunicazione relativa al suo stato di salute è giunta fino a lui.
Il problema della comunicazione è diventato centrale nella medicina attuale. Questo fatto non depone a favore della comunicazione stessa. Quando, infatti, nei rapporti interpersonali la comunicazione si fa centrale, ci sentiamo legittimati a dedurre che siamo di fronte a un indice di relazione “malata”. Lo conferma autorevolmente Paul Waztlawick, uno dei maggiori esperti della comunicazione umana: “Quanto più una relazione è spontanea e ‘sana’, tanto più l’aspetto relazionale della comunicazione recede sullo sfondo. Viceversa, le relazioni ‘malate’ sono caratterizzate
82
da una lotta costante per definire la natura della relazione, mentre l’aspetto di contenuto della comunicazione diventa sempre meno riportante” (Watzlawick, 1971), è quanto possiamo verificare empiricamente nelle relazioni amorose: le coppie in crisi, invece di fare l’amore, imbastiscono eterni discorsi per definire il loro rapporto... Quando la comunicazione è inceppata, ci si accorge di essa, in quanto diventa un sintomo dolorante.
Qualcosa di analogo succede oggi in medicina. Si parla molto di comunicazione perché abbiamo l’impressione che siano sempre più frequenti e dolorosi i nodi della comunicazione. In particolare, la comunicazione si ingorga quando si decide, per motivi di diversa natura ― mancanza di tempo e di opportunità, o anche motivi etici ― di saltare il lomento dell’informazione, andando direttamente all’azione terapeutica. L’enfasi posta sul fare, piuttosto che sul parlare informativo, danneggia il processo della guarigione e si traduce in un saldo negativo sul piano della comunicazione.
Se la comunicazione non fluisce in modo sano, ristagna patologicamente, poiché, in ogni caso, non si può non comunicare. Questo è il primo assioma stabilito da Watzlawick nella sua Pragmatica della comunicazione umana. La comunicazione, infatti, è un comportamento; non esiste l’opposto del comportamento. Chi, per esempio, in una situazione di vicinanza fisica, si chiude nel mutismo, comunica che non vuol comunicare. Le parole e il silenzio, l’attività e l’inattività: tutto, nell’interazione, ha il valore di messaggio. La questione, quindi, diventa: che cosa comunica il comportamento del medico, quando rifiuta di informare il malato? (evidentemente quello che crea problemi è la comunicazione di una prognosi infausta: dare buone notizie è invece una delle opportunità più piacevoli che la vita ci riserva, dentro e fuori la medicina).
Una risposta alla domanda possiamo ricavarla dalla descrizione seguente, in cui l’oncologo francese Léon Schwarzenberg tratteggia la situazione che si crea quando l’ambiente che circonda il malato opta per i congiura del silenzio:
“È raro che i malati ripongano assoluta fiducia nel loro medico. Molti di essi credono che in questa valle di lacrime non esista bugiardo più grosso e patentato del medico, e che del resto egli eserciti l’unica professione nella quale la menzogna è d’obbligo. Inutile dire che a volte costoro hanno ragione. Ma dubbi e sospetti possono travalicare il medico stesso. Ve n’è che sospettano un complotto tra i loro stessi familiari o anche da parte dei loro amici. E, ancora una volta, spesso hanno ragione.
83
La moglie o il marito, a volte il figlio maggiore che svolge il ruolo di capofamiglia ha deciso che “non bisogna dirglielo. Non possiamo farlo. Significherebbe ammazzarlo”. E il medico dal canto suo non osa spingersi più in là e a sua volta si inchina alla volontà della famiglia. Purtroppo, però, accade che la maggior parte di noi medici si sia attori da quattro soldi, bugiardi da poco. Il malato avverte perfettamente che non tutti coloro che lo circondano sono sinceri con lui, lo legge loro in faccia, lo coglie dai loro silenzi più ancora che dalle loro parole, lo capisce dai loro errori, dai lapsus, dagli impappinamenti, si sente al centro degli argomenti che non vengono mai abbordati. Tutti recitano male, mentono peggio. Il malato, questo lo sa; e il medico ha il sospetto che il malato sappia. Ed ecco così istituirsi quel rapporto convenzionale, di perfetta cortesia: il malato sa che il medico sa, ma non ne parla” (Schwartzenberg, Vianson-Ponté, 1975).
In pratica, contesti comunicativi di questo genere trasmettono ― al di là della volontà di coloro che decidono, magari per motivazioni umanitarie molto nobili e generose, di sottrarre l’informazione al malato ― la “morte sociale” di questi. L’essere umano non è solo un organismo animato, ma è anche essenzialmente un membro della società. Quando viene reciso il legame vitale con la comunità, muore come essere umano.
Questo tipo di morte non ricalca esattamente la morte fisica: può avvenire prima o dopo, rispetto alla cessazione della vita organica. Ci sono tribù in Africa che considerano morta una persona solo quando non si parla più di essa (Thomas, 1982): è un esempio estremo che illustra la divaricazione possibile, anche in altri contesti culturali, tra morte sociale e morte organica.
La morte sociale, inoltre, non è un avvenimento “puntuale”: si verifica a gradi, e attraversa vari stadi; come la malattia stessa, può essere leggera, grave, fatale, oppure reversibile. La progressione nella morte sociale è favorita dal fatto che la morte, nel modo in cui si verifica abitualmente, si prolunga nel tempo. Nel lungo periodo che la persona impiega a morire, si verifica gradualmente la sua morte sociale. L’ospedale è un osservatorio eccellente per rilevare in che modo si passa dal regno dei vivi a quello dei morti. Con il progredire della malattia, cessano le cure infermieristiche usuali, l’interesse medico si affievolisce fino a scomparire (a meno che non si tratti di un “caso interessante”, in un ospedale che abbia anche finalità didattica e di ricerca), i morenti sono separati dai familiari, talvolta ricevono già i trattamenti riservati alle salme...(cfr. Sudnow, 1970).
Nell’esperienza dei più la morte sociale comincia quando si cessa di
84
essere considerati soggetti che possono prendere decisioni responsabili sul proprio destino. La preoccupazione di evitare alla persona che non può guarire lo shock di conoscere la propria situazione porta coloro che sanno ― i sanitari e i familiari ― a farsi carico della gestione della parte finale della vita del malato, sottraendogli le informazioni. In questo modo lo si è già condannato a morte come soggetto, ancor prima che la patologia fisica porti a compimento il suo assalto all’organismo.
Sia le parole che il silenzio hanno il loro lato tragico. Volendo evitare il dramma dell’informazione, si precipita in quello della mancanza di verità. Il silenzio, che può essere un salutare correttivo della retorica più banale e può talvolta offrire la solida consolazione derivante dalla muta solidarietà, in queste condizioni è solo un vuoto di parole. Fa capire al malato inguaribile che non è più qualcuno con cui si possa comunicare. Gli comunica, cioè, che socialmente può già considerarsi morto.
Ma i pazienti inguaribili, avviati verso la morte, vogliono sapere della loro situazione? Questo interrogativo continua a offrire lo spunto per innumerevoli dibattiti. L’abituale mancanza di informazioni al malato sulla prognosi infausta può essere letta in diversi modi. Qualcuno ritiene responsabili della “congiura del silenzio” i medici e i familiari: sono loro che non vogliono parlare, o per malinteso paternalismo, o per risparmiarsi il peso di dover sostenere emotivamente un paziente che si confronta con una prospettiva tragica. Altri invece, attribuiscono la volontà di non sapere ai pazienti: siccome essi rifiutano la verità, i sanitari si adeguano alla loro volontà e li preservano dal trauma di un’informazione non desiderata. O forse i malati fanno finta di non sapere, perché i medici e i familiari non vogliono parlare... Dove sta il torto e la ragione in questo scenario mutevole?
La pragmatica della comunicazione umana ci ha insegnato a sbrogliare matasse di questo genere riferendoci alla “punteggiatura” delle sequenze di eventi (cfr. Watzlawick, 1971). Quando in un rapporto comunicativo si creano delle catene che tendono a prolungarsi all’infinito (l’esempio più tipico è quello di una coppia che litiga: lei brontola, lui si chiude in se stesso; lei brontola perché lui si chiude, lui si chiude perché lei brontola; allora lei brontola ancora di più, mentre lui risponde chiudendosi ancora di più: teoricamente, questa catena non ha fine...), ambedue i modi di punteggiare sono possibili e corretti. Non si tratta di lare ragione all’uno o all’altra, adottando la sua punteggiatura degli eventi, ma di trovare un modo di spezzare la catena.
Le ricerche empiriche sono uno di questi modi. Il tema del consenso informato ha stimolato una quantità di indagini, dalle quali risulta che la
85
falsa attribuzione del desiderio di informazione è uno degli errori più comuni nella pratica clinica. Tra ciò che i pazienti desiderano conoscere e quello che i medici pensano che essi vogliano conoscere esistono discrepanze rilevanti.
In una ricerca americana, per esempio, condotta da Waitzkin e Stoeckle, sono stati registrati 336 incontri tra medici e pazienti in diversi contesti clinici, compresa la pratica privata e gli ambulatori ospedalieri. Si è chiesto ai medici di indovinare il desiderio dei pazienti di essere informati e quale utilità derivasse ai pazienti dal ricevere l’informazione stessa. Anche ai pazienti si è domandato di fornire l’autovalutazione.
La maggioranza dei soggetti desiderava conoscere quasi tutto e pensava che l’informazione sarebbe stata loro utile. Ma nel 65 per cento degli incontri i medici sottovalutavano il desiderio di informazione e l’utilità clinica dell’informazione stessa (Waitzkin, Stoeckle, 1976).
La stessa ricerca fornisce un altro dato importante. I ricercatori chiesero anche ai medici quanto tempo pensavano di aver dedicato a informare il paziente.
Confrontando questa percezione soggettiva con il tempo oggettivamente risultante dalla registrazione degli incontri, risultò che in media i medici stimavano il tempo dedicato all’informazione nove volte di più del reale!
Ai risultati prosaici, ma istruttivi, di questo tipo di ricerche bisogna aggiungere l’esperienza di chi ha infranto la barriera del silenzio e si è messo, senza preconcetti, a parlare con i malati, anche quelli inguaribili e avviati verso la morte, della loro situazione.
Fa ormai parte irrinunciabile del patrimonio di esperienza acquistata nell’accompagnamento dei morenti la convinzione che si muore meglio quando è possibile esprimere le proprie emozioni, comunicarle a qualcuno, condividere i propri stati d’animo.
Da quando Elisabeth Kübler-Ross ha cominciato a disobbedire alla consegna del silenzio con i morenti, dominante negli ambienti ospedalieri, si è aperto un capitolo nuovo di conoscenze dell’animo umano e dei suoi bisogni nel momento in cui si avvicina alla soglia estrema della vita.
Quanto sappiamo sugli stadi del morire, sull’organizzazione della speranza e sulle modalità simboliche della comunicazione fa parte ormai della medicina moderna, allo stesso modo della chimica dei neurotrasmettitori o delle reazione immunologiche (Kübler-Ross, 1984).
86
Informare senza comunicare
I fautori del modello “autonomista”, espressione tipica di una medicina che si è aperta alla modernità, si fanno spesso promotori di un’informazione a oltranza del malato, senza considerare la ripercussione che certe notizie possono avere nel malato stesso. Più che una questione di sensibilità morale, si tratta spesso di una concezione superficiale della comunicazione stessa. Non si considera a sufficienza, infatti, che la comunicazione non è costituita solo dagli aspetti verbali.
Il linguaggio ha sicuramente un’importanza unica per la specie umana, che da esso viene caratterizzata, ma non è l’unico canale attraverso cui comunichiamo. Nella comunicazione umana si hanno due fondamentali possibilità di far riferimento a dei contenuti informativi: o rappresentandoli con un’immagine (come quando si disegna), oppure dando loro un nome. Tecnicamente si parla di comunicazione analogica nel primo caso, e di comunicazione numerica nel secondo, comunicazione analogica è praticamente ogni comunicazione non verbale. Include le posizioni del corpo, i gesti, le espressioni del volto, le inflessioni della voce, la sequenza, il ritmo e la cadenza delle parole stesse, come pure i segni di comunicazione immancabilmente presenti in ogni contesto in cui ha luogo un’interazione.
Il linguaggio numerico ha un’importanza particolare per gli esseri umani, perché serve a scambiare informazioni sugli oggetti e perché ha la funzione di trasmettere la conoscenza di epoca in epoca. C’è però tutto un settore in cui facciamo affidamento quasi esclusivamente sulla comunicazione analogica, spesso discostandoci assai poco dall’eredità che ci hanno trasmesso i nostri antenati. Quando ci avviciniamo ai segmenti estremi della vita ― la nascita e la morte ― scopriamo con sorpresa quanto abbiamo ancora in comune con gli animali.
Le vocalizzazioni, i movimenti di intenzione e i segni di umore degli animali fanno parte della loro comunicazione analogica, mediante la quale definiscono la natura delle relazioni, in mancanza della capacità di fare asserzioni denotative sugli oggetti. Ciò che gli animali capiscono non è certo il significato delle parole, ma la ricchezza della comunicazione analogica che accompagna il discorso. Ogni volta che la relazione è il problema centrale della comunicazione, il linguaggio numerico cede il primato alla comunicazione analogica, è un fenomeno che non si verifica solo tra gli animali, ma in molte circostanze della vita umana, come quando si corteggia o si combatte. E anche quando si reca soccorso. Per
87
questo la comunicazione analogica, che è molto più ricca dell’informazione verbale, è centrale nel rapporto medico-paziente.
Lo stato di malattia, specie quando è grave ed è percepito come una minaccia per la vita, provoca una regressione che ci fa diventare, come i bambini e come gli animali, sommamente recettivi alla comunicazione analogica che accompagna il discorso. E anche se le parole si organizzano abilmente per sostenere delle menzogne ― comprese quelle “pietose” e a fin di bene ― i comportamenti tradiscono la verità. Perché è facile dichiarare qualcosa verbalmente, ma è difficile sostenere una bugia nel regno dell’analogico. Sembra un paradosso: le intenzioni più sublimi che possiamo attribuire agli esseri umani ― la solidarietà, l’amore, il prendersi cura ― passano attraverso il canale povero dei gesti e della comunicazione non verbale. Gli atti di cura corporea e il contatto fisico sono destinati a portare un peso metafisico che sembra quasi sproporzionato. Attraverso gli umili gesti della “carne comune” (Maurice Merleau-Ponty) si esprime il mistero della reciprocità delle coscienze.
Questa percezione più acuta delle esigenze connesse con la comunicazione nell’ambito delle cure sanitarie, che eccede di molto i contenuti informativi che si possono trasmettere con le parole, ci permette di affrontare in modo più differenziato la questione inevitabile: bisogna comunicare o tacere una diagnosi infausta? La questione è diventata un luogo classico di dibattito in cui possiamo assistere allo scontro tra modelli di comportamento che aspirano ugualmente a realizzare un valore morale, ma nella pratica si scoprono come inconciliabili.
Di fatto, il confronto assomiglia di più a un dialogo tra sordi, in quanto si confrontano certezze profonde non disposte a farsi rimettere in discussione dagli argomenti contrari. Chi è convinto che una prognosi infausta non vada condivisa con il malato ― tutt’al più con i suoi familiari ― motiva questo comportamento con alti motivi ideali. È per risparmiare al malato un evento emotivamente catastrofico che si deve fare ogni sforzo per tenere lontano dal suo sguardo l’orrore della morte certa. Ma anche chi difende la posizione contraria, orientata a informare il malato della propria situazione, si giustifica con motivi ideali, che ruotano attorno al rispetto del malato e tendono a prevenire un altro tipo di sofferenze psicologiche: quelle che si aggrumano attorno al sistema di menzogne necessario per mantenere il malato nell’ignoranza della sua situazione.
L’incomprensione tra i partigiani delle due posizioni può raggiungere punte paradossali. Coloro che optano per la comunicazione della diagnosi si sentono accusati di “crudeltà” nei confronti del malato; chi sceglie
88
la menzogna pietosa, in nome della compassione, si trova sospettato di essere solo un piccolo egoista, che vuol risparmiarsi le situazioni più ingrate, con lo sforzo di comunicazione che comportano. I tentativi di guadagnare l’altro alla propria posizione per lo più naufragano clamorosamente. Ciò non dipende dalla debolezza delle argomentazioni, ma dal fatto che gli atteggiamenti di fondo si nutrono di motivi che non sono solo razionali.
Alcuni di questi elementi sono stati messi in luce da uno studio pilota sui comportamenti e sugli atteggiamenti culturali dei medici circa la diagnosi e la prognosi di cancro. La ricerca è stata condotta da un’antropologa americana, Deborah Gordon, su un campione di medici toscani. Il merito della ricercatrice è stato quello di non limitarsi a contare quanti sono per il “dire” e quanti sono per il “tacere”. Ha studiato invece come questi orientamenti sono collegati, in profondità, con le convinzioni che riguardano la vita, la morte e la sofferenza; con il modo di gestire le ‘cattive notizie”, anche in contesti diversi da quello della salute; con i modelli fondamentali di educazione (orientata a promuovere l’autonomia personale oppure consolidare la dipendenza dai genitori e dalla famiglia); con le modalità che vengono utilizzate preferenzialmente per aiutare qualcuno in difficoltà. Ne risulta che anche in una regione relativamente omogenea, come la Toscana, i medici si orientano secondo due modelli profondamente diversi.
Trattandosi di uno studio antropologico, potremmo dire che formano due tribù. Per quella orientata in senso tradizionale, le decisioni relative a cure e trattamenti sono responsabilità del medico (e della famiglia), che scelgono ciò che “è meglio” per il paziente. Di fronte alla morte, l’obiettivo prioritario diventa la difesa del “fragile” dalla cattiva notizia, tenendolo all’oscuro. Per l’altra tribù, invece, l’informazione riguardo alla diagnosi, alla prognosi e al trattamento appartiene al paziente; è un suo diritto, perché deve conoscere e capire per poter decidere. L’ideale a cui tende è quello di rendere il paziente giudice di ciò che è meglio per lui.
Sono tribù molto compatte. I convincimenti di fondo ― riguardo alla vita e alla morte, agli eventi critici e al modo più appropriato per farvi fronte, al compito dei sanitari e al ruolo della famiglia ― sono condivisi da tutti e fortemente contrapposti a quelli dell’altro raggruppamento. Se dalla forma arcaica di lotta tra tribù si vuol passare a una forma più proficua di convivenza sociale, è necessario anzitutto convincersi che la posizione contraria non è solo errore o malafede. Ognuna ha valori importanti da difendere. In una società dove nessuno sembra più disposto
89
ad ascoltare le ragioni dell’altro, la questione della comunicazione della diagnosi al paziente può diventare una palestra di dialogo, nel senso che era caro a Socrate. Quel dialogo che ci fa scoprire quanta ignoranza c’è dietro il nostro sapere, e quanto abbiamo bisogno di mettere insieme frammenti di verità per costruire la saggezza.
Come utilizzare il consenso scritto
Sembra che qualcuno in America abbia avuto l’idea di mettere in circolazione dei formulari rivolti a ottenere dal possibile partner di un incontro sessuale una dichiarazione firmata di consenso al rapporto. Perché ― ironizza l’autore della trovata ― un rapporto sessuale è un fatto pericoloso: dalla piacevolezza del talamo vi potreste trovare in tribunale, accusati di stupro! Basti pensare ai processi che hanno avuto per mesi l’onore delle cronache (dal giovane Kennedy al pugile Tyson) per rendersi conto dell’entità del pericolo. Meglio, dunque, tutelarsi raccogliendo le prove inequivocabili della volontà non ambigua del partner!
Può sembrare una provocazione accostare i goliardici formulari per il consenso al rapporto sessuale alle procedure per ottenere il consenso informato nel contesto sanitario. Il parallelo stabilito tra lo scherzo di un buontempone e una delle pratiche a cui sembra arridere più successo nell’ambito delle nuove regole che stanno ridisegnando i rapporti tra sanitari e cittadini non vuol essere irriverente. Un effetto di “straniamento” si produce nell’uno come nell’altro caso, per il fatto che si applicano nell’ambito dell’intimità le procedure che valgono tra estranei. Non ci sorprende che una transazione commerciale o l’atto di compravendita di un immobile debbano obbedire a precise procedure amministrative: in questi casi tutti ci consideriamo degli estranei, anche all’interno di una stessa famiglia. Una parola di promessa può avere un significato morale e creare obblighi profondi, ma non ha alcuna rilevanza giuridica. L’atto di un notaio è una garanzia per tutti, proprio perché ci tratta come estranei.
Ci troviamo invece completamente spiazzati quando le regole che valgono tra estranei vengono trasposte all’ambito dell’intimità, è impossibile fissare in un formulario da sottoscrivere la complessità di un rapporto amoroso: il consenso scritto appare come una caricatura del consenso, che si ottiene nel rapporto vissuto. Chi argomenta contro le procedure
90
giudiziarie per stabilire se ci sia stato o no il consenso a un rapporto sessuale attinge all’esperienza vissuta, dove l’assenso ci si presenta nella sua fondamentale ambiguità (conosciamo dei “no” che valgono per un “sì” o per un “forse”...). Soprattutto sappiamo che la comunicazione non verbale svolge una funzione interpretativa determinante: i “sì” o i “no” sono detti più dagli occhi o dal tono muscolare che dalle parole. Dobbiamo dire la stessa cosa del consenso scritto a un atto medico?
In parte sì. Quello che si realizza tra il medico e il paziente che gli si affida va ricondotto al paradigma dell’intimità piuttosto che a quello dell’estraneità. Il consenso prende forma in un contesto imbevuto di emozioni molto forti: speranza, paura, fiducia, diffidenza, angoscia. Spesso si tratta di decisioni di vita o di morte; sempre, comunque, di scelte che coinvolgono il benessere e la qualità della vita.
Il consenso inoltre è un processo che si modifica nel tempo. Il malato può cambiare idea, sulla base di ulteriori informazioni che è riuscito ad assimilare o del vissuto della malattia: il rifiuto di ieri può diventare una richiesta di oggi, o viceversa. C’è ancora un’ulteriore analogia con il consenso amoroso: quello che si realizza tra medico e paziente passa anche attraverso la comunicazione non verbale, i silenzi, gli atteggiamenti. Che cosa diventa tutto ciò, ricondotto entro il quadro rigido di un formulario di consenso da espletare come una procedura amministrativa?
Se il parallelo tra l’assenso a un atto amoroso e il consenso a un atto medico appare forse troppo leggero, possiamo fare un rimando di ineccepibile spessore filosofico. In una pagina delle sue Ricerche filosofiche, Ludwig Wittgenstein mette in evidenza la necessità di utilizzare l’esperienza vissuta come chiave interpretativa di un comportamento, come può essere l’esperienza di venir guidati.
“Pensiamo all’esperienza vissuta del venir guidati! Chiediamoci: In che cosa consiste quest’esperienza, quando per esempio, veniamo guidati per una strada?
― Immagina questi casi:
Sei in un campo sportivo, magari con gli occhi bendati, e qualcuno ti conduce per mano, ora a sinistra ora a destra; tu devi sempre essere in attesa degli strattoni della sua mano e devi anche stare attento a non inciampare a uno strattone inaspettato.
Oppure: qualcuno ti conduce per mano, con forza, dove non vuoi.
91
O anche: il tuo compagno di ballo ti guida nella danza; tu ti rendi quanto più possibile recettivo per poter indovinare la sua intenzione a seguire anche la più lieve pressione.
Oppure: qualcuno ti conduce a fare una passeggiata; camminando conversate, e dove va lui vai anche tu.
O ancora: stai camminando per un viottolo di campagna e lasci che ti guidi.
Tutte queste situazioni sono simili l’una all’altra; ma che cosa è comune a tutte le esperienze vissute?”
(Wittgenstein, 1974, p. 94s).
Senza nessuna forzatura, possiamo applicare questa descrizione fenomenologica così differenziata all’essere guidati da un medico verso una decisione terapeutica. Inevitabilmente ci domandiamo: come può un formulario scritto rispecchiare la differenza sostanziale che esiste tra il venir guidati attraverso strattoni e il lasciarsi portare insieme dal ritorno della danza?
Con tutte queste riserve sulla possibile “deriva burocratica” di un uso generalizzato dei formulari per raccogliere il consenso informato, dobbiamo tuttavia riconoscere che è giunta l’epoca in cui la medicina deve trovare linguaggio e gesti per coniugare la pratica terapeutica con il nuovo clima culturale che attribuisce grande valore all’autodeterminazione dell’individuo. In un articolo dedicato a “Gli sviluppi del diritto alla salute in Italia” (L’Arco di Giano, n.4, 1994, pp. 53-73), Amedeo Santosuosso ricostruisce il percorso che ha portato, all’inizio degli anni ’90, all’esplicito e pieno riconoscimento del diritto alla salute come regola interna del rapporto medico-paziente e come cardine del processo decisionale. Benché sia diventata evidente ― a suo dire ― la distanza “tra la vecchia rivendicazione dei medici di procurare ‘il bene’ del paziente (anche senza la sua volontà) e il riconoscimento che il paziente è arbitro della valutazione della qualità della propria vita e che il medico non può sostituire la propria concezione della qualità della vita a quella del paziente” (p. 71), è possibile pensare a un’evoluzione, piuttosto che alla sostituzione di un modello con un altro, previa una dolorosa lacerazione.
La questione, in definitiva, diventa quella dell’uso che si vorrà fare del consenso informato. Non è auspicabile che l’adozione di questa procedura sia svuotata della sua sostanza etica e ridotta a un espletamento formale.
92
Al consenso informato, quale momento cruciale del rapporto che si instaura tra il professionista sanitario e il malato, non possiamo più sottrarci. E non perché ci siamo messi in testa di scimmiottare l’America: il consenso informato ci è richiesto dalla nuova cultura che sta unificando l’Europa. Ma se vogliamo che l’unifichi per il meglio, non dovremmo dimenticare quella formulazione dell’etica orientata al “prendersi cura” reciproco, come struttura primordiale dell’esistenza umana. Ci possiamo realizzare come essere liberi e autonomi perché l’etica delle cure reciproche fa sì che qualcuno si prenda cura di noi, mentre noi ci occupiamo, in una circolarità delle cure, di coloro che hanno bisogno di noi. Nella salute e nella malattia, ma soprattutto nella malattia.
Per la pratica della medicina dell’epoca moderna ― quella che ha interiorizzato il principio del rispetto delle decisioni che nascono dall’autonomia dell’individuo, ma nello stesso tempo non abbandona il valore tradizionale costituito dal legame di una particolare alleanza che si stabilisce tra chi offre le cure e chi le riceve ― il consenso informato è uno strumento. Senza mitizzarlo, è opportuno trattarlo in quanto tale, continuando a domandarci a quale modello di medicina vogliamo farlo servire. E soprattutto bisognerà convincerci che sull’uso del consenso informato abbiamo ancora tanto da imparare. Una medicina preoccupata della dimensione umanistica e interpersonale (così come, a livello normativo, ci viene richiesto anche dal riordino del Sistema sanitario nazionale: D.L. 517/1993, art. 14: “partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini”) dovrà farne un tema privilegiato di ricerca.
93
Il nuovo profilo della pratica medica che abbiamo tracciato non richiede solo un sanitario diverso, ma anche la formazione di un paziente più consapevole del compito che incombe su di lui nel cercare la giusta risposta ai problemi di salute in collaborazione con il medico. Affinché queste considerazioni abbiano il tono della concretezza, presentiamo in conclusione un elenco di consigli al paziente.
Il “buon paziente” dei nostri tempi non è solo colui che tace, si sottomette e segue alla lettera le prescrizioni. Essere un buon paziente oggi richiede intelligenza, volontà e un certo numero di virtù. Per questo, quando si è malati occorre, ricordare che:
― un buon medico non esiste senza un buon paziente. Si può fare molto, in quanto pazienti, per migliorare Io stato della medicina, cominciando a disporsi ad essere un buon paziente. Gli orientali dicono:“Quando il discepolo è pronto, arriva il maestro”;
― il buon paziente non è quello che sopporta e tace. Parlare della propria malattia non è soltanto un diritto, ma un dovere;
― non lasciarsi intimidire dalle apparecchiature diagnostiche. Anche il medico più orientato in senso tecnologico ha bisogno del racconto del paziente per capire che cosa la malattia significa per lui;
― il medico non è né il padrone, né il robot: egli non può esigere un atteggiamento servile, il paziente non deve cercare di ridurlo a un puro esecutore dei suoi desideri;
94
― non fare del medico il proprio complice per piccole frodi (certificati compiacenti, ricette “facili” ecc...): quello che si potrebbe guadagnare su un piano, lo si perderebbe su quello della stima reciproca e della qualità del rapporto;
― la medicina oggi può fare molto. Qualche volta può fare perfino troppo, per esempio prolungando la vita in condizioni che il paziente considera indegne. Per prevenire queste situazioni, occorre far conoscere al medico qual è il proprio confine accettabile tra la buona terapia e l’accanimento terapeutico;
― tra il paziente e il medico ci possono essere divergenze insanabili in materia di scelte etiche. Il medico non deve fare violenza alla coscienza del paziente, ma neppure quest’ultimo deve farla alla coscienza del medico. Esaurite tutte le possibilità di dialogo, non resta che cambiare medico.
95
Cassese S., La riforma amministrativa all’inizio della quinta Costituzione dell’Italia unita, Il Foro Italiano, maggio 1994, pp. 250-271.
D’Agostino F., Diritto, L’Arco di Giano, 1, 1993, p. 51-59.
Faden R., Beauchamp T., A history and theory of Informed Consent, Oxford University Press, New York, 1986.
Fox R., Training for uncertainty, in Merton R.K. e Reader G. (eds), The Student-Physician Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1957, pp. 207- 241.
Fox R., The process of professional socialization: is there a “new” medical student? A comparative view of medical socialization in the 1950s and in the 1970s, in Tancredi L.R. (ed), Ethics of medical care, National Academy of Science, Washington, 1974.
Fox R., The evolution of medical uncertainty, Milbank Memorial Fund, New York, 1980.
Gracia D., Fondamenti di bioetica, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993.
Kübler-Ross E., La morte e il morire, Cittadella, Assisi, 1984.
Lotto A. et al., Il consenso informato in cardiologia, Mediamix, Milano, 1995.
Osborne D., Gaebler T., Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is trasforming the public sector, Haddis-Wesley, Reading Mass., 1992.
96
Rodotà S., Itinerari della cura, in Donghi P., Preta L. (eds), In principio era la cura, Laterza, Roma-Bari, 1995.
Santosuosso A., Gli sviluppi del diritto alla salute in Italia, L’arco di Giano, n. 4, 1994, pp. 53-73.
Schwartzenberg L., Viansson-Ponté P., Cambiamo la morte, Mondadori, Milano, 1975.
Shorter E., La tormentata storia del rapporto tra medico e paziente, tr. it Feltrinelli, Milano, 1986.
Spinsanti S., Certezze e incertezze del sapere medico, in Spinsanti S. (ed), Bioetica e antropologia medica, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, pp. 71-81.
Sudnow D., Dying in a public hospital, in Brim O.G., Freeman O.E. (eds), The dying patient, New York, 1970.
Thomas L.V., La mort africaine, Payot, Paris, 1982.
Waitzkin H., Stoeckle J., Information control and micropolitics of Health care: Summary of ongoing research project, Social Science and Medicine, 10, 1976, pp. 263-276.
Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971.
Wittgenstein L., Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino, 1974.
97
PARTE SPECIALE
IL CONSENSO NELLA PRATICA CLINICA
Vito Pappalepore
98
99
V - Apparato cardiovascolare
103 1. Cardiopatia ischemica
107 2. Ipertensione arteriosa
111 3. Scompenso cardiaco
115 4. Varici
VI- Apparato genitale femminile
121 5. Bronchite cronica ed enfisema polmonare
125 6. Asma e rinite allergici
129 7. Malattie infettive delle vie respiratorie
VII - Apparato osteoarticolare
135 8. Mal di schiena
139 9. Artrosi
VIII - Apparato digerente
145 10. Ulcera gastroduodenale
149 11. Ernia iatale e riflusso gastro-esofageo
153 12. Epatite acuta e cronica, cirrosi epatica
157 13. Colelitiasi
100
SOMMARIO
IX - Apparato urogenitale
163 14. Ipertrofia prostatica
167 15. Carcinoma della prostata
171 16. Prostatiti
175 17. Nefrolitiasi
X - Apparato genitale femminile
181 18. Contraccezione
185 19. Menopausa
189 20. Diagnostica strumentale in ginecologia e ostetricia
193 21. Infezioni ginecologiche
199 22. Depressione
203 23. Cefalea
XII - Metabolismo
209 24. Obesità
213 25. Diabete mellito
217 26. Dislipidemia
101
V
APPARATO CARDIOVASCOLARE
102
103
1 - CARDIOPATIA ISCHEMICA
Inquadramento generale
È una condizione dovuta a diverse eziologie aventi in comune lo stesso meccanismo Fisiopatologico, cioè la discrepanza fra richieste metaboliche e disponibilità di ossigeno al miocardio. Le manifestazioni cliniche sono: ischemia miocardica silente, riscontrabile con l’elettrocardiografia, ma non accompagnata da angina; infarto miocardico acuto; morte improvvisa; insufficienza ventricolare sinistra secondaria a danno ischemico; angina pectoris.
L'angina può essere stabile, cioè correlata con regolarità a un determinato fattore scatenante (per es. uno sforzo fisico), oppure instabile (angina di recente insorgenza, a riposo, oppure ingravescente per frequenza, intensità, durata).
L’iter diagnostico procede dall’anamnesi (valutazione del dolore toracico e sua diagnosi differenziale) alla coronarografia, procedura fondamentale preliminare alla rivascolarizzazione. Fra questi due estremi si collocano: l'ECG a riposo, per lo screening di base; il test ergometrico, per la diagnosi di angina e la valutazione della sua soglia e della performance cardiaca; l'ECG dinamico secondo Holter, per la ricerca di slivellamenti del tratto ST e di episodi di ischemia silente; la diagnostica con radionuclidi (scintigrafia di perfusione miocardica con tallio, tomografia a emissione di positroni) per l’identificazione di aree di ischemia reversibile, suscettibili di rivascolarizzazione.
Eziologia
La causa più comune di ischemia è la malattia aterosclerotica delle arterie coronarie epicardiche; seguono lo spasmo coronarico e altre condizioni cardiache, come l’ipertrofia ventricolare (dovuta a ipertensione arteriosa, stenosi aortica), o extracardiache (ipertiroidismo, grave anemia), in grado di causare insufficienza coronarica.
Terapia
Il piano terapeutico prevede:
• l’informazione e la rassicurazione del paziente;
• la riduzione dei fattori di rischio;
• il trattamento delle forme morbose associate e aggravanti l’angina;
• la terapia farmacologica specifica;
• la rivascolarizzazione meccanica.
I nitrati per via sublinguale alleviano prontamente il dolore nell’attacco anginoso; nella prevenzione a lungo termine dell’angina, invece, sono impiegati, da soli o variamente associati, i nitrati longacting, i betabloccanti e i calcioantagonisti; l’acido acetilsalicilico viene impiegato nella prevenzione dell’infarto miocardico.
La rivascolarizzazione meccanica è affidata all’angioplastica percutanea transluminale
104
delle coronarie (PTCA) e al by-pass aortocoronarico. L’indicazione classica all’angioplastica è rappresentata dalle stenosi prossimali, uniche, di breve lunghezza e non calcificate. Il by-pass è, invece, rivolto alle lesioni del tronco comune, alla malattia trivascolare, alle stenosi multiple e distali.
Informazioni al paziente
La prevenzione primaria della cardiopatia ischemica risiede nell’eliminazione dei fattori di rischio accertati e modificabili. Sono pertanto di estrema importanza:
• l'abolizione del fumo;
• il trattamento dell’ipertensione arteriosa;
• il controllo dei lipidi sierici con la dieta e gli eventuali farmaci ipolipemizzanti;
• il controllo metabolico del diabete mellito;
• il trattamento delle condizioni morbose concomitanti e potenzialmente aggravanti (broncopneumopatie, esposizione all’ipossia, ipertiroidismo, anemie);
• l'esercizio fisico: sia i programmi di prevenzione della cardiopatia ischemica, sia i programmi riabilitativi del post-infarto prevedono un’attività fisica regolare.
L'esercizio fisico ottiene un effetto condizionante, cioè un adattamento emodinamiche si traduce in un miglioramento della contrattilità cardiaca e in un innalzamento della soglia di angina. Le attività di benessere cardiovascolare sono quelle aerobiche, che aumentano l’estrazione dell’ossigeno: camminare, correre, saltare, nuotare, andare in bicicletta, remare, sci di fondo. Sono controindicati gli esercizi isometrici (per es. sollevare pesi). La nitroglicerina sublinguale, di grande utilità nel sollievo immediato del dolore anginoso, è utile anche a scopo preventivo, prima di esporsi ai fattori scatenanti le crisi anginose (sforzo, attività sessuale, freddo...),
Se il dolore anginoso non recede, non bisogna esitare a recarsi in ospedale: nel caso infarto miocardico la prospettiva di sopravvivenza è legata alla tempestività dell'intervento terapeutico (massima entro le prime sei ore).
L'angioplastica coronarica (PTCA) ha avuto grande diffusione negli ultimi anni: il suo successo è legato alla possibilità per il paziente di evitare il tavolo operatorio e l'anestesia generale. È una procedura che in buone mani ha una mortalità bassa attorno all’1%). Consiste nell’inserimento nell’arteria femorale od omerale di un catetere, che reca un palloncino, che a livello della stenosi coronarica, viene gonfiato fino a dilatare il restringimento arterioso e poi retratto. Il paziente è cosciente oppure moderatamente sedato, con l’ausilio di analgesici e anestesia locale. La PTCA, tuttavia, non è esente da rischi: complicanze immediate possono essere la dissezione di un vaso coronarico, la trombosi, lo shock cardiogeno, l’infarto miocardico, il by-pass di emergenza. Nonostante un successo immediato nel 90% dei casi, la ristenosi si presenta entro 6 mesi nel 30-40% dei soggetti.
105

Figura 1 - Coronarografia. Il catetere intraaortico è collocato all’imbocco del tronco comune della coronaria sinistra.
Aorta
Catetere
106
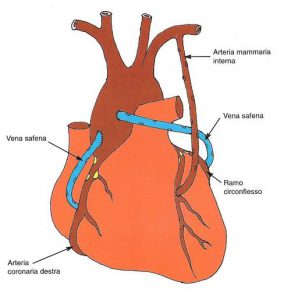
Figura 2 - By-pass aortocoronarico con arteria mammaria interna su IVA e con vena safena su coronaria destra e ramo circonflesso.
107
2 - IPERTENSIONE ARTERIOSA
Inquadramento generale
L’ipertensione arteriosa è una condizione morbosa a patogenesi multifattoriale caratterizzata dall’aumento della pressione arteriosa sistemica a valori superiori alla norma (secondo l’OMS in soggetti dai 35 ai 65 anni la pressione arteriosa non deve superare i valori di 140/90 mm Hg rilevati in tre visite consecutive effettuate a distanza di settimane).
Eziologia
Di fronte al riscontro di ipertensione arteriosa, l’unico problema è la diagnosi differenziale tra la forma essenziale e quella secondaria. La percentuale di ipertensione secondaria è inferiore al 5% dei casi e si associa ad altre patologie quali nefropatie parenchimali bilaterali (per es. glomerulonefrite, malattia policistica del rene, uropatia ostruttiva), aldosteronismo primitivo, sindrome di Cushing, feocromocitoma, ipertiroidismo, coartazione dell’aorta, nefropatie vascolari. L’ipertensione arteriosa primaria o essenziale rappresenta invece più del 95% dei casi e non è possibile, invece, riconoscerne la causa. Il suo esordio avviene tra i 25 e i 55 anni e spesso è presente una familiarità positiva. Si sono, inoltre, riconosciuti altri fattori predisponenti, quali: un aumentato apporto di cloruro di sodio (sale da cucina), l’età, il fumo, l’ipercolesterolemia, l’aumento di peso corporeo, lo stress.
Terapia
L’ipertensione arteriosa è asintomatica; eventuali sintomi e segni sono espressione di complicanze a carico degli organi bersaglio; poiché anche in soggetti normotesi possono comparire gli stessi sintomi e segni, essi non sono patognomonici di ipertensione. Fra i sintomi troviamo: vertigini, flush al volto, cefalea, affaticabilità, epistassi e nervosismo.
Le eventuali complicanze sono costituite da: insufficienza ventricolare sinistra, cardiopatia aterosclerotica, essudati ed emorragie retiniche, edema della papilla, accidenti vascolari, insufficienza renale e cerebrovascolare. La terapia medica può ridurre in grande percentuale l’insorgenza di eventuali complicanze cerebrovascolari e la mortalità per cause cardiache e coronariche.
Informazioni al paziente
L’ipertensione arteriosa costituisce una causa importante e, almeno in parte, prevenibile di patologia cardiovascolare.
In assenza di un trattamento adeguato, l’ipertensione aumenta significativamente il rischio di scompenso cardiaco, coronaropatia, ictus
108
emorragico e trombotico e insufficienza renale. Per questo motivo è fondamentale che il paziente effettui dei periodici controlli dei valori pressori presso il proprio medico curante. È, inoltre, importante ricordare che si possono rilevare notevoli variazioni dei livelli pressori in conseguenza di stimoli emotivi. Per questo un buon rapporto con il proprio medico facilita un’affidabile valutazione diagnostica e quindi prognostica. Quando si diagnostica un’ipertensione arteriosa sarà il medico curante, che, dopo un’accurata valutazione anamnestica, sottoporrà il paziente agli esami diagnostici fondamentali per escludere l’eventuale insorgenza di ipertensione secondaria o di eventuali complicanze di ipertensione primaria, esami da eseguirsi sono:
• esami ematochimici, con un quadro renale (creatininemia, azotemia, uricemia, eventualmente reninemia e catecolamine), lipidico, elettrolitico e tiroideo;
• ECG ed ecocardiogramma;
• fondo oculare.
Esclusa l’insorgenza di un’ipertensione secondaria, che prevede interventi elettivi mirati anche chirurgici, è necessario valutare l’approccio terapeutico migliore per la forma essenziale, di gran lunga più comune. La terapia prevede in prima istanza misure di ordine alimentare e comportamentale, che nell’ipertensione lieve possono talora evitare la somministrazione di farmaci.
Tali misure comprendono:
• «pensione del fumo, che aumenta negli ipertesi di due volte il rischio di infarto miocardico;
• attività fisica isotonica: camminare, correre, nuotare 3-4 volte/settimana per 30-45 minuti;
• dieta iposodica e ipolipidica: corrisponde a una normale dieta con scarso apporto disale aggiunto, pane e grassi, preferendo cibi freschi a quelli conservati, ed eventualmente utilizzando sali esistenti in commercio con meno contenuto di sodio e più potassio;
• consumo moderato di vino, superalcolici e caffè;
Qualora, dopo aver seguito per tre mesi queste abitudini generali, la pressione si mantenesse elevata, è opportuno associare la terapia farmacologica. Attualmente si hanno a disposizione numerosi tipi di farmaci: diuretici, ACE-inibitori, calcioantagonisti, betabloccanti. La risposta è diversa da paziente a paziente, per cui la terapia va personalizzata per ogni soggetto.
Sarà compito del medico curante, che si baserà sulla profonda conoscenza della storia e della personalità del proprio paziente, adeguare la terapia, assicurando l'aderenza al programma terapeutico (che deve essere continuo per tutta la vita), in quanto la prevenzione delle complicanze dell’ipertensione arteriosa rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica.
109
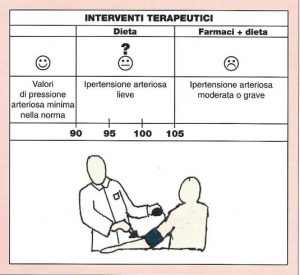
Figura 1 - Approccio graduale nel trattamento dell’ipertensione arteriosa.
110

Figura 2 - Ipotesi di meccanismi eziopatogenici dell’ipertensione arteriosa nello stress.
111
3 - SCOMPENSO CARDIACO
Inquadramento generale
È l’incapacità del cuore a mantenere una gettata sufficiente al fabbisogno metabolico dei tessuti a una normale pressione di riempimento diastolico ventricolare.
I sintomi del paziente scompensato sono secondari a una ridotta perfusione tessutale (astenia e affaticabilità) e a elevate pressioni di riempimento cardiaco con congestione del piccolo circolo (dispnea, ortopnea, dispnea parossistica notturna, edemi periferici). I segni fisici tipici sono: la distensione delle vene giugulari, il terzo tono cardiaco, i rantoli inspiratori, l'ottusità polmonare, l'epatomegalia.
Nella pratica corrente due presidi diagnostici sono di grande utilità: la radiografia del torace e l’ecocardiografia. La radiografia del torace ci fornisce il rapporto cardio-toracico, cioè il rapporto tra il massimo diametro trasverso cardiaco e il diametro trasverso toracico, che supera il valore di 0,5 nelle cardiomegalie; le strie B di Kerley sono un segno radiologico di scompenso cardiaco conseguenti alla stasi linfatica; l’esame evidenzia, inoltre, la ridistribuzione apicale del flusso.
L’ecocardiografia consente di valutare la contrattilità del miocardio con la misurazione della frazione di accorciamento, cioè del rapporto tra i diametri telesistolico e telediastolico ventricolari, indice indiretto della frazione di eiezione.
Eziologia
Cause determinanti sono le condizioni di depressa funzionalità ventricolare (cardiopatie congenite, valvolari, ischemica, dilatativa, ipertensiva) e di ridotto riempimento ventricolare (stenosi mitralica, cardiomiopatie restrittive e malattie pericardiche).
Cause scatenanti sono: l'embolia polmonare con elevazione della pressione in arteria polmonare; le infezioni (febbre, iperpiressia, aumentato fabbisogno metabolico); l’anemia (ridotto trasporto di O2); la gravidanza e l'ipertirodismo (aumentato fabbisogno metabolico); le aritmie (ridotto riempimento ventricolare e perdita dell’efficacia di contrazione); le miocarditi e le endocarditi; l'infarto miocardico; abusi fisici, dietetici (eccesso di sodio), ambientali ecc.
Meccanismi compensatori fisiologici sono: la stimolazione simpatica e la liberazione di catecolamine, con conseguente aumento dell’inotropismo, l’aumento del tono venoso e del pre-load; l’attivazione del sistema renina angiotensina-aldosterone e l’aumento del pre-load; la liberazione del peptide atriale natriuretico ad azione vasodilatatrice; l’ipertrofia cardiaca eccentrica (da sovraccarico di volume) e concentrica (da sovraccarico di pressione). Questi meccanismi con il passare del tempo non riescono più a compensare e si passa alla fase dei sintomi e segni conclamati.
112
Terapia
Il trattamento si propone sostanzialmente quattro obiettivi: 1) riduzione del carico di lavoro cardiaco; 2) controllo della eccessiva ritenzione idrica; 3) aumento dell’inotropismo; 4) riduzione del post-carico.
Il primo punto prevede la riduzione dell’attività fisica, fino all’allettamento. La ritenzione di liquidi viene opportunamente trattata con la restrizione sodica e con i diuretici: tra questi, i diuretici dell’ansa (furosemide, bumetanide e acido etacrinico) sono i più potenti e conservano la loro efficacia natriuretica anche quando la volemia si è normalizzata, ciò che gli altri diuretici non fanno. I tiazidici sono meno potenti, ma utili quando la filtrazione glomerulare è > 50%.
Spironolattone, amiloride e triamterene sono di minore efficacia ma prevengono la deplezione potassica: pericolosa la loro associazione con gli ACE-inibitori per il rischio di iperkaliemia. L’inotropismo cardiaco può essere incrementato con la digitale e le amine simpaticomimetiche. La digitale stimola la contrattilità, aumenta la frazione di eiezione e la portata cardiaca; riduce pressione e volume telediastolici e quindi la congestione polmonare. Si impiega nello scompenso secondario a disfunzione sistolica del ventricolo sinistro (cardiopatia ischemica, ipertensione) e in quello associato ad aritmie quali il flutter atriale e la fibrillazione atriale con elevata frequenza ventricolare. Non è indicata, invece, nelle pericardiopatie, nelle miocardiopatie restrittive, nella stenosi mitralica, ed è controindicata nella miocardiopatia ostruttiva e nei blocchi A-V.
Le amine simpaticomimetiche, adrenalina, isoproterenolo, dopamina e dobutamina, vengono impiegate negli scompensi intrattabili, specie nelle riacutizzazioni, sotto monitoraggio continuo, possibilmente anche della pressione polmonare di incuneamento, in unità di terapia intensiva. Inotropi positivi più recenti sono arminone, milrinone, enoximone. I vasodilatatori sono utilizzati per ridurre l’after-load quelli arteriosi, il pre-load quelli venosi; i vasodilatatori arteriosi come l’idralazina aumentano la gettata, mentre quelli venosi (nitrati) riducono la congestione polmonare. Grande importanza hanno assunto gli ACE-inibitori, che si comportano come vasodilatatori misti, e si sono dimostrati capaci di prolungare la sopravvivenza negli scompensi di grado avanzato.
Informazioni al paziente
Il fondamento della terapia è la restrizione dell’attività fisica: da una modesta riduzione dell’attività nei casi lievi, al riposo a letto nei casi più gravi. I pasti dovranno essere piccoli ed è opportuno rimuovere le situazioni di stress emotivo. Nei soggetti obesi è necessaria restrizione calorica in quanto la perdita di peso riduce il lavoro cardiaco.
Si deve ridurre l’apporto alimentare di sodio evitando l’uso del sale nella cottura dei cibi.
113
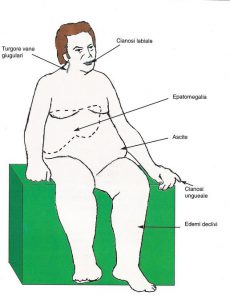
Figura 1 - Manifestazioni cliniche dello scompenso cardiaco conclamato.
114

Figura 2 - Stadi di gravità dell’insufficienza cardiaca secondo la classificazione della New York Heart Association (NYHA).
115
4 - VARICI
Inquadramento generale
Le varici sono dilatazioni sacculate e tortuose permanenti delle vene superficiali, perforanti o profonde. Inizialmente le vene superficiali appaiono tese e si possono anche palpare senza essere ancora visibili; successivamente, diventano visibilmente dilatate e tortuose.
I sintomi non sono necessariamente correlati alle dimensioni e al grado delle varici; arti severamente interessati possono essere asintomatici, mentre vi possono essere pazienti sintomatici in corrispondenza di piccoli siti visibili di varicosità. I sintomi e segni sono rappresentati da dolenzia, stanchezza, senso di peso (soprattutto serale), edema ortostatico.
La diagnosi è facilmente eseguibile con la semplice visita medica e non necessita di ulteriori approfondimenti. L’unico esame strumentale utile per confermare la diagnosi clinica è l'eco-Doppler venoso, che dimostra il livello e le sedi specifiche di incontinenza valvolare.
Eziologia
Le varici sono conseguenti ad alterazioni delle pareti vasali e delle valvole venose, che sono assenti o scarse per fattori congeniti o divenute insufficienti per fattori acquisiti. Ne consegue un ristagno cronico di sangue nel letto venoso con successivo danno delle pareti venose e dei tessuti degli arti inferiori per alterazioni del microcircolo.
Oltre ai fattori congeniti e familiari, esistono fattori acquisiti che aggravano le varici esistenti; fra questi troviamo: la stazione eretta prolungata (per es. pazienti con professioni in cui è necessario stare per lungo tempo in piedi senza movimento), l’obesità, l’aumento della pressione endoluminale, l’ascite, la fase avanzata della gravidanza.
Terapia
La terapia deve essere il più possibile precoce e comprende:
• norme comportamentali, con l’utilizzo di calze elastiche contenitive;
• terapia chirurgica classica: safenectomia;
• scleroterapia.
Varici non adeguatamente trattate possono dar luogo a complicanze quali le tromboflebiti superficiali. Si tratta di processi flogistici della parete con occlusione trombotica di una vena; il paziente avverte febbre, dolore localizzato, indurimento del vaso che assume un colore rosso-bruno e può facilmente andare incontro a rottura ed emorragia in seguito a piccoli traumi. Le varici, una volta guarite con ricanalizzazione delle vene profonde, possono provocare un’incontinenza delle valvole, la cosiddetta sindrome post-flebitica, che si manifesta con pigmentazione, eczema, edema, indurimento sottocutaneo e ulcerazione cronica.
116
Informazioni al paziente
Le varici degli arti inferiori rappresentano una patologia estremamente frequente soprattutto nelle donne. La diagnosi è semplice, ed è essenziale che il paziente si rivolga prontamente al proprio medico in modo da poter affrontare la terapia migliore, e da evitare spiacevoli complicanze come le tromboflebiti, molto più lunghe da curare, soprattutto nelle fasi iniziali sarà il medico curante a consigliare alcune norme comportamentali semplici, ma che permettono di evitare un aggravamento e quindi passaggio a terapie più invasive. I consigli utili per questi pazienti sono i seguenti:
• impiego di calze elastiche: evitando però l’uso di bendaggi elastici, che provocano un effetto di laccio emostatico soprattutto sul polpaccio;
• evitare la stazione eretta o seduta prolungata e la vita sedentaria;
• eseguire movimenti di flesso-estensione sulla punta dei piedi;
• sollevare il materasso di 15-20 cm per il riposo notturno;
• in estate, al mare, non esporre le gambe al sole prolungatamente e camminare ungo la riva con l’acqua a mezza gamba;
• ridurre il peso corporeo;
• frequentare una palestra almeno due volte la settimana.
Nei quadri clinici più conclamati o nelle flebiti ricorrenti è, invece, indicato l’intervento chirurgico, con la classica safenectomia o stripping della vena safena.
L'intervento non presenta complicanze, tuttavia occorre mettere in guardia il paziente sulla possibilità di comparsa di nuove varici, che comunque si possono trattare mediante iniezione di soluzioni sclerosanti. La scleroterapia con compressione è, invece, una tecnica recente, usata attualmente per il trattamento di qualunque varice. Deve, però, essere effettuata da mani esperte; determina l’obliterazione totale della vena mediante fibrosi (iniezione di materiale sclerosante nel vaso e bendaggio per almeno tre settimane); non necessita l’ospedalizzazione e il paziente deve riprendere immediatamente (anche durante il bendaggio) la sua normale attività, camminando il più possibile per promuovere il drenaggio venoso degli arti. Se non effettuata in modo adeguato, provoca facilmente recidive e richiede un nuovo trattamento. Si sono, inoltre, osservate alcune reazioni allergiche e i pazienti vanno avvisati della possibile comparsa di pigmentazione bruna della cute, che usualmente regredisce in poco tempo.
In conclusione, di fronte a questa patologia, il paziente, dopo essersi consigliato con proprio medico curante, può trarre grandi benefici dalle tecniche terapeutiche oggi a nostra disposizione, che consentono già in una fase precoce una risoluzione definitiva del problema.
117

Figura 1 - Vene varicose.
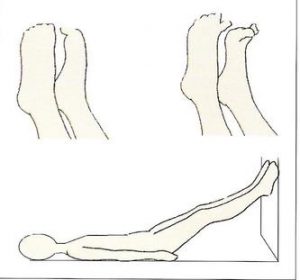
Figura 2 - Esempio di esercizio fisico da praticare stando sdraiati sul dorso a gambe sollevate: flettere le dita dei piedi e poi estenderle alternativamente per circa 30 secondi.
118

Figura 1 - Esempio di esercizio fisico da praticare in posizione eretta: sollevarsi alternativamente sulle punte dei piedi e ruotare all’esterno i talloni.

Figura 2 - Esercizio da praticare in posizione supina con gambe sollevate o appoggiate su un piano: flettere ed estendere i piedi alternativamente per circa 30 secondi.
119
VI
APPARATO RESPIRATORIO
120
121
5 - BRONCHITE CRONICA ED ENFISEMA POLMONARE
Inquadramento generale
Per bronchite cronica si intende un’affezione respiratoria caratterizzata da tosse e catarro per almeno tre mesi all’anno per un periodo di due anni consecutivi. È determinata da un’infiammazione più o meno diffusa dell’albero bronchiale non imputabile a nessun’altra malattia broncopolmonare o cardiaca. Carattere distintivo è l’ostruzione bronchiale, che accomuna anche altre due patologie, cioè l’enfisema polmonare e l'asma bronchiale, nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Nella maggior parte dei casi la bronchite cronica evolve gradualmente nell’enfisema polmonare, in cui la normale architettura dei polmoni viene distrutta con rottura delle pareti alveolari fino alla formazione di sacche d’aria di varie dimensioni. Le alterazioni possono essere marcate soprattutto al centro (enfisema centrolobulare) o sparse diffusamente a tutto il lobulo (enfisema panacinare).
Eziologia
Fattori causali della bronchite cronica sono: il fumo, l’inquinamento ambientale, i fattori climatici (ambienti umidi), la mucoviscidosi, le immunodeficienze. L’insorgenza delle sue manifestazioni subcliniche avviene abitualmente dopo 15-20 anni di esposizione al fumo, con sintomi iniziali quali tosse mattutina ed espulsione di modeste quantità di escreato. Successivamente, la sintomatologia clinica diventa più eclatante con l'aggravamento della tosse e il sovrapporsi nei mesi freddi di episodi di bronchite acuta febbrile, con risposte lunghe alla terapia. In alcuni soggetti la malattia può terminare qui il suo decorso, in altri può evolvere nella forma enfisematosa, in cui ai precedenti sintomi si associa dispnea a volte con caratteri accessionali. La fase delle complicanze rappresenta il periodo terminale della malattia, caratterizzato dal progressivo sviluppo di una cardiopatia destra (cuore polmonare cronico), con dispnea accentuata, edemi perimalleolari, fino a fasi di riacutizzazione di insufficienza respiratoria che spesso conseguono a una sovrapposizione infettiva.
La diagnosi strumentale e di laboratorio comprende i seguenti esami: Rx torace (che evidenzia un aumento della trama bronchiale); esami ematochimici (emocromo, che mostra un’eritrocitosi nei pazienti cronicamente ipossici); ECG (con eventuale ipertrofia e sovraccarico di atrio e ventricolo destro); test di funzionalità respiratoria ed emogasanalisi (per la valutazione del difetto ventilatorio e dell’eventuale ipossia).
Terapia
La terapia varia a seconda della fase patologica in cui ci si trova: l’abolizione del fumo è una condizione terapeutica essenziale; in secondo luogo abbiamo a disposizione una terapia rivolta alla bronchite cronica e una terapia delle complicanze. La terapia in
122
fase cronica comprende: i farmaci broncodilatatori (teofillinici), i mucolitici, la fisiochinesiterapia respiratoria, la profilassi e la terapia antibiotica negli episodi infettivi, i cortisonici. Nella fase avanzata e/o complicata si associano ai precedenti approcci: i farmaci diuretici e la digitale (nel cuore polmonare cronico), la correzione di eventuali squilibri elettrolitici, l'ossigenoterapia.
Informazioni al paziente
La bronchite cronica è una patologia con storia lunga e insidiosa. Per questo motivo è importante che il paziente si rivolga al proprio medico già nelle sue prime manifestazioni (tosse mattutina). Sottovalutare queste fasi iniziali e presentarsi alla visita con quadri clinici più avanzati condiziona una diagnosi più severa e una terapia non sempre risolutiva. Nella fase precoce la visita dal proprio medico curante, associata ad alcuni esami semplici (Rx torace ed esami ematochimici), permette di porre diagnosi.
Gli obiettivi del trattamento saranno mirati a:
• migliorare la qualità della vita riducendo i sintomi e consentendo l’attività lavorativa;
• interrompere o ritardare l’eventuale componente infiammatoria, secretiva e di broncospasmo;
• prevenire le infezioni sovrapposte.
Le norme igieniche rappresentano il primo punto del trattamento: è necessario che il paziente abbia fiducia e collabori con il proprio medico seguendone i consigli, abolendo il fumo e allontanandosi da ambienti di vita o di lavoro inquinati. Doverosa è la profilassi antinfluenzale, che va eseguita in autunno; contrastata e non sempre efficace è, invece, la profilassi con terapia immunomodulante aspecifica. Molto utile è il soggiorno periodico in località a clima secco o temperato (eventuali terme dove eseguire cicli di aerosolterapia). Nelle fasi di sintomatologia più avanzata, invece, la terapia è multifattoriale e mirata a fluidificare le secrezioni e inibire la tosse. Utili, oltre ai farmaci, sono l’umidificazione dell’ambiente e l’abbondante somministrazione di liquidi. Broncodilatatori e antibiotici sono prescritti dal medico nelle forme dispnoiche e infettive. Sono essenziali, comunque, per il paziente l’assoluta costanza e l’aderenza alla terapia assegnata; in caso di esacerbazioni il contatto con il medico curante deve essere repentino per poter instaurare una terapia immediata. In situazioni di ipossia acuta è necessaria l’ospedalizzazione; nelle ipossie croniche il paziente verrà, invece, istruito dal proprio medico all’utilizzo razionale e controllato dell’ossigenoterapia. Esistono in commercio concentratori di ossigeno (costosi ma pratici), oppure sistemi di ossigeno liquido che possono essere utilizzati anche durante la deambulazione.
In conclusione, per ottenere dei buoni risultati da questi obiettivi terapeutici è fondamentale che il paziente segua strettamente, oltre ai convenzionali mezzi terapeutici farmacologici, la lunga opera educativa del proprio medico di fiducia per un regime igienico di vita idoneo e un’attenta e costante terapia riabilitativa.
123

Figura 1 - Modalità di risposta della trachea e dei bronchi a diversi stimoli.
A. Condizioni fisiologiche
B. Modificazioni in caso di colpo di tosse
C. Modificazioni in caso di infiammazione
D. Modificazioni in caso di enfisema
124
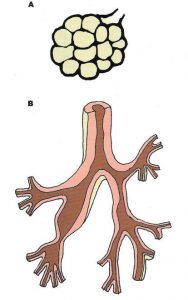
Figura 2 - Bronchite cronica: aumento del contenuto aereo a livello dei sacchi alveolari (A) e iperplasia dell’epitelio bronchiale con restringimento delle vie aeree e aumento a valle del contenuto aereo (B).
125
6 - ASMA E RINITE ALLERGICA
Inquadramento generale
L’asma bronchiale è una malattia delle vie aeree determinata da una ipersensibilità dell’albero bronchiale a stimoli di varia natura. Clinicamente è caratterizzata da attacchi di dispnea parossistica e ricorrente, accompagnata da segni obiettivi e soggettivi (tosse e sibili respiratori) di ostruzione bronchiale totalmente o parzialmente reversibili fra le crisi.
Eziologia
Distinguiamo i seguenti tipi di asma:
• asma estrinseco o allergico: è frequente nelle persone giovani (sotto i 30 anni rappresenta 1’80-90% dei casi di asma), mentre con il passare degli anni il riscontro di una causa allergica diventa sempre più improbabile.
Rappresenta un’evoluzione negativa della semplice rinite allergica, che è un’ipersensibilizzazione delle mucose nasali di fronte ad agenti esterni, con improvvisa e abnorme iperemia congiuntivale e nasale. La rinite allergica e l’asma allergico possono essere di tipo stagionale, da sensibilità ai pollini presenti nell’area dove il soggetto vive, o di tipo perenne, dovute a sensibilità ad allergeni presenti di continuo quali acari della polvere, o derivati epidermici di animali domestici;
• asma intrinseco o non allergenico: è causato da fattori non allergenici quali infezioni, o sostanze irritanti (fumo di sigaretta, aria fredda, fumi di benzina o vernici). In molti individui sia i fattori allergenici che non allergenici appaiono giocare un ruolo significativo nello scatenare le crisi. Fattori emozionali possono, inoltre, aggravare la sintomatologia asmatica.
La diagnosi si basa, innanzitutto, su un’attenta raccolta anamnestica del paziente e su un accurato esame obiettivo. In seconda istanza, vanno eseguiti: test di funzionalità respiratoria (per la valutazione del grado di bronco-ostruzione); Rx torace (che può evidenziare un’eventuale iperdistensione polmonare con possibili aree di atelettasia); ECG (nei casi gravi possibili segni di cuore polmonare). Nell’asma allergico è necessario effettuare le prove cutanee e RAST, atti all’evidenziazione di IgE specifiche per i vari allergeni. Nei casi dubbi è possibile effettuare test di provocazione bronchiale.
Terapia
La terapia è così differenziata nella fase acuta e cronica:
• trattamento dell’attacco acuto: farmaci cortisonici per via e.v., adrenergici e broncodilatatori (1-2 puff di salbutamolo ogni 4 ore e teofillinici per via e.v.); ossigenoterapia nelle forme gravi;
• trattamento cronico: provvedimenti generali ed educativi a seconda delle varie cause di asma; terapia che inibisce l’iperreattività bronchiale, attiva sull'infiammazione,
126
a posologia differenziata a seconda della gravità del caso; terapia broncodilatatrice; immunoterapia specifica nella forma allergica.
Informazioni al paziente
L’asma intrinseco, ma soprattutto quello allergico, è una patologia in aumento negli ultimi anni. Poiché una storia naturale di allergia o di asma viene ritrovata in più della metà degli asmatici, è importante che il paziente si rivolga subito, all’esordio dei primi sintomi, al proprio medico curante, favorendone la raccolta anamnestica e permettendo una diagnosi precoce. Una volta effettuate la diagnosi e la ricerca eziologica, il medico dovrà fare in modo di prevenire e curare le forme acute, prescrivendo, poi, una terapia adeguata di mantenimento. Parlando di prevenzione è fondamentale istruire il paziente a utilizzare alcuni provvedimenti generali. Ove siano presenti manifestazioni di rinite prima, e asma allergico poi, con identificazione della causa allergenica, l’igiene ambientale può migliorare in modo sostanziale la sintomatologia. In particolare, il paziente dovrà allontanare la causa di tale allergia, quali animali domestici, tappeti o moquettes, sito preferito di polveri. Si raccomanda, comunque, in tutte le forme di asma di abolire il fumo, evitare stress fisici e psichici, l’inalazione di aria fredda e gli ambienti inquinati. Sarà sempre il medico a consigliare eventuali vaccini contenenti gli allergeni individuati, che di solito vengono somministrati qualora le precedenti precauzioni non diano miglioramenti consistenti.
È molto importante, inoltre, che il paziente venga istruito a prendere immediatamente precisi provvedimenti terapeutici, qualora si verifichi una crisi e non vi sia la possibilità di un rapido intervento medico. Ricordiamo che i segni di esacerbazione aumentano più facilmente durante la notte e in rapporto a piccoli sforzi. In tal caso il medico suggerirà al paziente di iniziare un breve ciclo di steroidi, o di aumentare le dosi croniche, di tenere sempre a disposizione dei beta-adrenergici (aerosol di salbutamolo) che hanno una rapida azione e permettono di bloccare l’evoluzione dei primi sintomi in una crisi franca.
Il paziente verrà, inoltre, spronato a controllare il peso corporeo e a curare possibili condizioni aggravanti quali lo scompenso di circolo. Nei giovani è di assoluta importanza la pratica di un esercizio fisico costante; tra i vari tipi di sport va preferito il nuoto, che viene normalmente ben tollerato dal paziente asmatico.
Perciò, nonostante nella fase acuta i sintomi di questa patologia siano importanti al punto che nel paziente asmatico resta la paura di soffocare, seguendo le istruzioni comportamentali impartite dal proprio medico e aderendo strettamente alla terapia farmacologica, oggigiorno è possibile affrontare questo problema con serenità, con la certezza di una qualità di vita assolutamente buona senza rischi di alcun genere.
127

Figura 1 - Anatomia delle vie aeree superiori e rapporti con la trachea
A. Naso
B. Bocca
C. Faringe
D. Laringe
F. Trachea
128
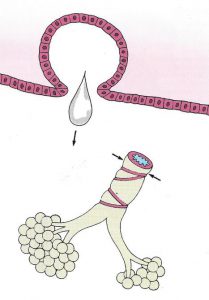
Figura 1 - Attacco asmatico. Aumento della secrezione (A) e contrazione della parete bronchiale (B).
129
7 - MALATTIE INFETTIVE DELLE VIE RESPIRATORIE
Inquadramento generale
Per polmonite si intende un’infezione acuta del parenchima polmonare che interessa gli spazi alveolari e il tessuto interstiziale; l’interessamento può essere di un intero lobo (polmonite lobare), di un segmento di un lobo (polmonite segmentale o lobulare), di alveoli congiunti a bronchi (broncopolmonite) o del tessuto interstiziale (polmonite interstiziale).
Eziologia
I fattori predisponenti l’insorgenza delle malattie infettive respiratorie sono rappresentati da infezioni respiratorie virali, alcolismo, vecchiaia, malnutrizione, neoplasie bronchiali, immunodeficienza, diabete, eventuali manovre endoscopiche o di intubazione. Le cause più comuni negli adulti sono rappresentate dai batteri: Streptococcus pneumoniae (più frequente in assoluto), Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Legionella e Klebsiella. Nella seconda infanzia e nei giovani adulti la polmonite è per lo più causata dal Mycoplasma pneumoniae, mentre nella prima infanzia i principali agenti patogeni sono i virus.
I sintomi sono rappresentati di solito da: temperatura elevata (fino a 38-40°C), brividi, tosse con produzione di materiale purulento, dolore toracico, scadimento delle condizioni generali. Tendenzialmente la forma virale o da micoplasmi ha un accesso più acuto, mentre un quadro meno eclatante (febbre meno elevata, tosse secca) può riconoscere una eziologia batterica. Tuttavia, la diagnosi richiede, oltre a un attento esame clinico (presenza di soffio bronchiale, aumento del fremito vocale tattile, rumori umidi più o meno diffusi), l’effettuazione di un Rx torace, di esami ematochimici (che evidenziano leucocitosi ed aumento degli indici infiammatori) e di un esame colturale sull’escreato.
In particolare, il binomio esame clinico/quadro radiologico fornisce elementi basilari anche per un’iniziale diagnosi eziologica, indicando il trattamento più opportuno.
Terapia
La terapia comprende:
• terapia sintomatica generale: consigli generali comportamentali, trattamento antiflogistico e analgesico; eventualeossigenoterapia;
• antibioticoterapia specifica: nonostante la penicillina sia sempre stato l’antibiotico di elezione nella polmonite pneumococcica (la più frequente fra le forme batteriche), attualmente si preferisce utilizzare un macrolide, in quanto assicura una copertura sia nei confronti dello Pneumococco sia del Micoplasma e della Legionella. Sono stati, inoltre, anche osservati recentemente ceppi di Pneumococchi resistenti alla penicillina. Le forme virali non sono ovviamente sensibili alla terapia antibiotica; tuttavia va sottolineata l’opportunità di ricorrere ugualmente a un trattamento
130
protettivo antibiotico nei confronti di una sovrapposizione batterica.
Fanno eccezione a questo schema terapeutico:
• soggetti anziani, fumatori, bronchitici cronici, ove si può sospettare un’eziologia da Gram-negativi (Klebsiella pneumoniae): si preferisce impiegare allora una terapia antibiotica con una cefalosporina (attiva anche su anaerobi), utilizzata anche nei pazienti ospedalizzati (fra cui troviamo pazienti con un’alta frequenza di germi resistenti agli antibiotici, pazienti immunodepressi per neoplasie o interventi chirurgici recenti);
• soggetti che presentano un rialzo termico e segni di consolidamento nel corso di un’epidemia influenzale: in questo caso è da sospettare una sovrapposizione batterica da Pneumococco, ma anche da Staphylococcus aureus ed Haemophilus influenzae; in assenza di dati microbiologici conviene associare una penicillina con un chinolonico di III generazione.
Informazioni al paziente
Le polmoniti sono abitualmente di facile diagnosi in base alla combinazione dei dati obiettivi e radiologici, ma, essendoci varie forme eziologiche-cliniche, il trattamento va personalizzato da caso a caso. Di fronte al sospetto di polmonite il medico prescriverà l’effettuazione di un esame radiologico del torace urgente per impostare l’antibioticoterapia nel più breve tempo possibile. Inoltre, il paziente andrà istruito a mantenere al meglio le proprie condizioni generali. Fondamentale è il riposo a letto evitando perfrigerazioni; la dieta è libera, con alto contenuto di liquidi e ipercalorica. In caso di dolore il medico prescriverà una terapia analgesica e per alleviare la tosse verrà associato un trattamento fluidificante. Oltre a questi consigli di base, il medico curante adatterà l’antibioticoterapia secondo gli schemi sopra, descritti. È essenziale che il paziente segua strettamente la posologia assegnata continuando il trattamento per tutto il periodo consigliato; anche se la sintomatologia dovesse migliorare in pochi giorni la terapia antibiotica verrà sospesa solo quando il medico scioglierà la prognosi. Infatti, in tutti i casi, prima di interrompere il trattamento, va eseguita una radiografia di controllo per assicurarsi della risoluzione del focolaio. Di fronte a una sintomatologia aspecifica con iperpiressia e tosse, il paziente non deve mai intraprendere una terapia antibiotica di sua iniziativa senza aver prima consultato il proprio medico; infatti, un trattamento erroneo (per esempio nelle sindromi influenzali non complicate) provocherebbe solo una selezione di ceppi resistenti, senza risolvere la patologia di base. Nelle polmoniti resistenti alla terapia, nei casi in cui il paziente sviluppi torpore psichico, ove si presentino dispnea severa, scompenso o altre complicazioni cardiocircolatorie (aritmia, edema polmonare acuto), si rende necessario il ricovero ospedaliero urgente. Attualmente, comunque, la terapia delle polmoniti ha raggiunto eccellenti risultati, la prognosi è sempre ottima soprattutto se lo stato generale del paziente è buono.
131
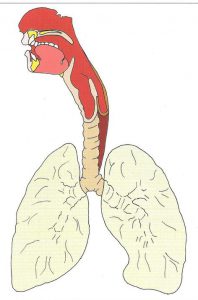
Figura 1 - Anatomia delle vie respiratorie
132
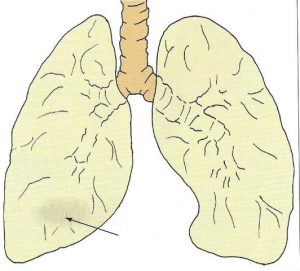
Figura 2 -Area di infiammazione polmonare (polmonite)
133
VII
APPARATO OSTEOARTICOLARE
134
135
8 - MAL DI SCHIENA
Inquadramento generale
Il dolore osteoarticolare rappresenta il sintomo più frequentemente riferito dal paziente al medico di medicina generale (17.6%); fra i dolori osteoarticolari la localizzazione lombo-sacrale rappresenta da sola il 4.6% di tutti i sintomi. Il dolore lombosacrale o “mal di schiena”, come lo chiama il paziente, può essere acuto o cronico; può avere origine dal midollo spinale o da strutture più profonde: rene, pancreas, colon, organi pelvici, tumori retroperitoneali. Le cause raggiungerebbero l’incredibile cifra di 841.
Eziologia
In un’elevata percentuale di pazienti non è possibile formulare una diagnosi eziologica certa. Sicuramente il ruolo della psiche (somatizzazione dell’ansia) influenza l’aumento progressivo delle forme funzionali.
• Lombalgia acuta. Lombalgia miogena: evidenza anamnestica di uno sforzo improvviso o di un trauma acuto; il dolore è localizzato e accompagnato da spasmo della muscolatura spinale, grave limitazione funzionale con assenza di irradiazione all’inguine e alle gambe. Fratture vertebrali: presenza all’anamnesi di una caduta sulle gambe o di un trauma in flessione. In caso di fratture patologiche per la presenza di osteoporosi, morbo di Paget, mieloma multiplo, metastasi ossee, il trauma può anche essere molto lieve o assente. Erniazioni dei dischi intervertebrali lombari: la localizzazione più frequente è L5-S1, quindi L4-L5, più raramente L3-L4. Parestesie e ipoalgesie indicano il coinvolgimento di una radice nervosa, così come l’indebolimento del riflesso achilleo (radice Sio S2) o del riflesso patellare (L3-L4). Sintomi vescicali o intestinali indicano una lesione del cono terminale del midollo spinale o della coda equina.
• Lombalgia cronica. Osteoartrosi: è un processo degenerativo delle vertebre lombari con formazione di osteofiti, restringimento del canale midollare lombare o del forame di coniugazione con conseguente compressione delle radici nervose. I sintomi sono spesso unilaterali. Un dolore che si accompagna durante la deambulazione a parestesie o debolezza a entrambe le gambe indica una sindrome da canale midollare ristretto, che può essere confermata dalla TAC o dalla RMN.
Spondilite anchilosante: colpisce giovani uomini con una lombalgia che si irradia a entrambe le cosce. Nel 90% dei casi è presente positività per l’antigene HLA-B27. L’evoluzione della malattia è caratterizzata da cifosi progressiva con limitazioni all’espansibilità toracica, obliterazione delle articolazioni sacroiliache e deformazione del rachide che assume una conformazione a canna di bambù.
Tra le cause di lombalgia cronica bisogna poi ricordare: le neoplasie ossee, le metastasi ossee, l'osteomielite.
• Dolore riflesso di origine viscerale. Le patologie pelviche proiettano il dolore alla regione sacrale, le affezioni dei due quadranti addominali inferiori alla regione lombare L3-L5, le malattie dei due quadranti addominali superiori al confine toraco-lombare T10-L2.
136
Caratteristicamente, ampi movimenti del rachide non aggravano il dolore e non vi sono segni di contrattura e rigidità.
Terapia
È senza dubbio importante prevenire il mal di schiena mantenendo in buone condizioni la muscolatura del tronco con periodici esercizi fisici ed evitando il sovrappeso. In caso di dolore sono utili il riposo e un blando supporto lombosacrale. La terapia farmacologica si avvale principalmente degli analgesici (propossifene, paracetamolo). Se si sospetta una componente infiammatoria, i FANS possono essere utili. Nel caso di stiramento muscolare i miorilassanti sono spesso dei validi coadiuvanti.
Informazioni al paziente
L’informazione del malato rappresenta un punto importante nel programma terapeutico del paziente con dolore lombo-sacrale.
I malati in genere ignorano la natura, il decorso e le possibilità di prevenzione della loro malattia. Il dolore cronico lombare è spesso considerato dai medici come qualche cosa di ineluttabile e questa sensazione si riflette sui pazienti, che assumono verso la malattia una rassegnata passività. Se gli accertamenti mettono in evidenza una precisa causa viscerale, il paziente sarà informato adeguatamente sulla diagnosi, prognosi e terapia della malattia. Se gli accertamenti escludono una causa viscerale od organica, il paziente dovrà essere informato delle possibilità di prevenzione, di possibili errori posturali come causa della malattia, e del ruolo che può assumere l’ansia nel generare la contrattura muscolare e come la contrattura possa generare dolore, così come il dolore può, a sua volta, generare la contrattura, instaurando in entrambi i casi un circolo vizioso. Si può rassicurare il paziente dicendogli che il 35% delle sindromi algide lombari si risolve spontaneamente entro un mese, il 70% entro due mesi, l’85% entro tre mesi. Esisterebbero certamente meno problemi alla schiena se i soggetti obesi o in sovrappeso seguissero una dieta dimagrante, o se i soggetti adulti effettuassero al mattino esercizi di rafforzamento della muscolatura spinale e lombare. Il dormire con la schiena iperestesa è una condizione di disagio per il paziente con mal di schiena, che può trarre beneficio dal sollevare durante il sonno le gambe con un cuscino. In auto, un sedile mal disegnato, lo schienale reclinato (va invece mantenuto a 90° gradi), o il mantenere la medesima posizione a lungo possono provocare disagio a un paziente con mal di schiena. Durante il lavoro, una prolungata posizione in flessione è nociva. La schiena deve essere ben appoggiata sulla sedia. Anche in questo caso lo schienale deve essere inclinato a 90°. Se è necessario sollevare un peso, le gambe vanno piegate, la colonna lombare va tenuta dritta, e il peso portato vicino al tronco.
137

Figura 1
138

Figura 2
139
9 - ARTROSI
Inquadramento generale
L’artrosi, chiamata anche osteoartrosi o malattia articolare degenerativa, è una patologia caratterizzata da un’alterazione regressiva della cartilagine articolare con formazione di nuovo osso e di tessuto connettivo all’interno dell’articolazione.
Il dolore articolare, di cui l’artrosi è la causa di gran lunga più comune, è il sintomo in assoluto più frequente nell’ambulatorio di medicina generale (17.3%). Come patologia, sempre in medicina generale, l’apparato osteoarticolare è al primo posto nel sesso femminile e al secondo nel sesso maschile dopo le malattie vascolari. La prevalenza aumenta con l’età: nel sesso femminile è del 2% nella popolazione di età inferiore a 45 anni, del 30% tra i 45 e i 64 anni, del 68% sopra i 65 anni.
Eziologia
L’inizio del processo patologico è caratterizzato da una diminuzione della rete di collagene della cartilagine con riduzione della concentrazione dei protoglicani, incremento di enzimi condrolesivi, e del contenuto idrico; frammenti cartilaginei possono essere inglobati a livello della sinovia determinando flogosi. L’osso subcondrale va incontro a un processo di eburneizzazione e sclerosi ossea con formazione di osteofiti. Nella maggior parte dei casi l’artrosi è primaria senza che vi siano chiari fattori predisponenti. Nelle forme secondarie sono presenti alterazioni che accelerano la patogenesi dell’artrosi come l'artrite settica, che, distruggendo la cartilagine, innesca il processo degenerativo dell’artrosi. Altre cause sono: anomalie anatomiche congenite, traumi e alterazioni del carico articolare come meniscectomia, obesità, microtraumatismi articolari professionali.
Le localizzazioni più’ frequenti sono le ginocchia (75%), le mani (60%), i piedi (40%). Nelle mani le articolazioni maggiormente coinvolte sono le interfalangee distali (con formazione dei cosidetti noduli di Heberden) e la carpometacarpale del pollice. Nei piedi comune è l’interessamento della metatarsofalangea dell’alluce. Meno frequentemente interessate sono le articolazioni del rachide cervicale e lombare, delle caviglie, e delle spalle. L’osteoartrosi colpisce una sola o un numero ristretto di articolazioni. Il dolore si aggrava dopo particolari attività fisiche che comportino carico per l’articolazione. Nell’80% dei pazienti è presente rigidità mattutina, solitamente di 10-30 minuti; raramente supera l’ora. Il dolore può insorgere anche di notte o per inattività. Talvolta il paziente avverte degli scrosci. È presente una riduzione della mobilità articolare e col tempo si verificano deformazioni e sublussazioni.
La diagnosi è clinica e radiologica. Tutti gli esami ematochimici e i test reumatici sono negativi. I segni radiologici più importanti sono la riduzione dell’interlinea articolare, la sclerosi dell’osso subcondrale, gli osteofiti marginali, le cisti subcondrali.
140
Terapia
Non esiste un trattamento eziologico dell’artrosi. La terapia sintomatica ha lo scopo di ridurre il dolore e deve essere indirizzata al mantenimento e alla prevenzione della riduzione della motilità osteoarticolare. Nelle forme più lievi può essere sufficiente rassicurare il paziente sul decorso dell’artrosi, istruirlo a non abusare dell’articolazione e all’uso occasionale degli analgesici.
Nella terapia farmacologica dell’artrosi la superiorità dei FANS rispetto agli analgesici non è mai stata dimostrata, né è dimostrata la capacità dei FANS di rallentare l’aggravamento dell’artrosi. Se sono presenti segni di flogosi è più razionale utilizzare i FANS. Fra gli analgesici sono da preferirsi per i minori effetti collaterali il paracetamolo e il propossifene, in particolare in quei pazienti in cui i FANS sono controindicati. L’uso intraarticolare di steroidi può determinare in alcuni pazienti un miglioramento duraturo, ma le infiltrazioni non vanno ripetute più di 3-4 volte l’anno. Utile è la fisioterapia. Nei casi più gravi si procede alla chirurgia.
Informazioni al paziente
Il paziente va tranquillizzato informandolo che l’artrosi nella maggior parte dei casi è un processo degenerativo cronico, la cui evoluzione lenta può essere condizionata da opportune regole di vita. Fanno eccezione le forme più gravi e avanzate, che richiedono provvedimenti chirurgici quali l’inserimento di una protesi totale di anca o ginocchio.
L'artrosi può essere provocata da un incongruo carico articolare. Può essere utile eliminare posture scorrette, o l’uso di un corsetto ortopedico che possa modificare una iperlordosi lombare. La riduzione di un eccessivo carico articolare sulle ginocchia, legato all’obesità, può evitare l’inevitabile progressione della malattia. Se l'artrosi del ginocchio è secondaria a una condizione di ginocchio varo o valgo, può essere indicato l’intervento di osteotomia. In tutti i casi delle buone calzature sportive possono distribuire meglio il peso sul piede e sulle ginocchia e ridurre i microtraumi legati alla deambulazione.
Tutti i pazienti sofferenti di artrosi traggono giovamento anche dal potenziamento della muscolatura satellite. Non è facile per il paziente potenziare la muscolatura senza un carico adeguato della stessa. Il fisioterapista, con opportuni esercizi isometrici, o utilizzando un carico graduale, può correggere l’ipotrofia muscolare legata al dolore e alla conseguente ipofunzione. Anche la stimolazione elettrica transcutanea può dare buoni risultati sulla muscolatura. Il calore applicato sulle articolazioni riduce il dolore e la rigidità prima dell’esercizio fisico. La forma di calore più comoda per il paziente è certamente il bagno o una doccia calda. In un numero ridotto di casi il paziente trae giovamento dall’applicazione di freddo.
141
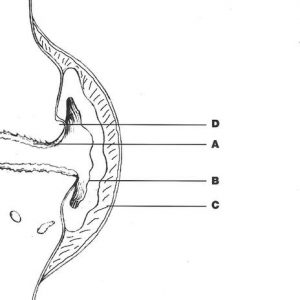
Figura 1 - - Articolazione artrosica.
A. Riduzione della concentrazione di acqua e diminuzione della rete di collagene.
B. Infiammazione della sinovia.
C. Capsula ispessita.
D. Sclerosi ossea con formazione di ostefita.
142

Figura 2 - Alterazioni artrosiche a carico della mano.
143
VIII
APPARATO DIGERENTE
144
145
10 - ULCERA GASTRODUENALE
Inquadramento generale
La malattia ulcerosa è certamente tra quelle di più comune riscontro nella pratica clinica ambulatoriale, interessando il 40% circa di tutti i pazienti di pertinenza gastroenterologica. L’età di insorgenza è assai variabile, ma le fasce di età più interessate sono la quarta, la quinta e la sesta decade di vita.
La sintomatologia è assai variabile e va dall’assoluta mancanza di sintomi, nel qual caso la malattia può manifestarsi soltanto per la comparsa di una complicanza (per es. emorragia digestiva), ai tipici casi di dolore epigastrico a digiuno per l’ulcera duodenale, e post-prandiale per l’ulcera gastrica, a sintomatologie variegate e complesse, in grado di simulare altre malattie addominali ed extra-addominali.
La diagnosi è attualmente assai semplice con l’ausilio delle metodiche radiologiche e di quelle endoscopiche, che hanno ormai quasi completamente sostituito le prime, e che hanno sensibilità e specificità assai vicine al 100%.
La storia clinica della malattia, che si riteneva potesse durare 20-30 anni e non era stata sostanzialmente modificata dall’avvento, per altri versi determinante, dei farmaci anti-secretori, sembra attualmente radicalmente modificata dalla scoperta del ruolo patogenetico dell’Helicobacter pylori e dall’efficacia delle terapie attuate per la sua eradicazione.
Eziologia
L’eziopatogenesi dell’ulcera gastroduodenale non è univoca, in quanto con questa dizione si comprendono entità nosologiche diverse e assimilabili soltanto per l’epifenomeno ulcera, che le caratterizza.
È, infatti, assai diversa l’eziologia di un’ulcera gastrica che esprime la necrosi di un tessuto neoplastico, da un’ulcera acuta da antinfiammatori (gastrica o duodenale), da un’ulcera bulbare classica, la cui eziopatogenesi riconosce certamente un ruolo da parte dell’Helicobacter pylori, da un’ulcera da eccessiva increzione di gastrina, come nella sindrome di Zollinger-Ellison.
Ciò che accomuna la patogenesi di queste forme è, comunque, l’importanza dell’aggressione della mucosa da parte dell’acido cloridrico, che condiziona un pH endoluminale di circa 1. Infatti, non è possibile che si formi una lesione ulcerativa in assenza di acido cloridrico.
La mucosa gastrica è in grado di resistere all’aggressione acida grazie a complessi meccanismi di difesa, che prendono il nome di barriera mucosa, comprendenti componenti fisiche, chimiche e fisiologiche.
L’ulcera si forma, dunque, qualora risulti alterato l’equilibrio tra fattori aggressivi e fattori protettivi, a vantaggio dei primi; ciò può avvenire per riduzione dell’efficacia della barriera mucosa, come nei primi due casi citati, o per l’eccesso di secrezione acida, come nella sindrome di Zollinger-Ellison, o per l’insieme delle due
146
cose, come verosimilmente avviene nell’ulcera associata all’Helicobacter pylori.
Terapia
La terapia è assai differente, in relazione al tipo di patologia ba sale, e sarà dunque esclusivamente chirurgica nell'ulcera associata a neoplasia gastrica e, al contrario, medica, negli altri casi.
I presidi farmacologici fondamentali sono i farmaci antisecretori, sempre più potenti e maneggevoli, a cui andranno, però, sempre associati i protettori di mucosa nei casi di ulcere da FANS, e gli antibiotici contro l’Helicobacter pylori nell’ulcera associata a quest’ultimo.
Informazioni al paziente
L’atteggiamento del paziente nei confronti della malattia è di importanza fondamentale nella corretta gestione della stessa. Infatti, un atteggiamento di sottovalutazione della malattia da parte del paziente, può condurre a un’aumentata incidenza di complicanze e quindi di ospedalizzazione e mortalità. Ad aumentare la possibilità di sottovalutazione concorre, purtroppo, l’efficacia stessa sui sintomi, oltre che sulla guarigione della lesione, dei farmaci antisecretori, che conduce frequentemente a un loro uso improprio, spesso sintomatologico. Inoltre, l’efficacia sui sintomi degli antisecretori può a volte condurre a una scorretta diagnosi, mascherando di fatto una situazione più grave dell’atteso (ulcera su cancro) e riducendo le possibilità di una diagnosi precoce, attualmente facilitata dall’endoscopia. Al contrario, la sopravvalutazione dei sintomi e della gravità stessa della malattia può portare a un eccesso di esami e/o cure, che si può riflettere negativamente sulla salute del paziente stesso. Non bisogna, infatti, dimenticare che ogni esame diagnostico presenta un minimo di rischio (per es. patologia da raggi, complicanze degli esami invasivi...), e che ogni terapia farmacologica può determinare effetti collaterali anche importanti.
Sarà, dunque, compito del medico informare correttamente il paziente della natura della malattia, della sua presumibile storia clinica, delle terapie disponibili e dei possibili esiti delle stesse, non dimenticando di citare le possibili complicanze conseguenti, o indipendenti da una scorretta condotta diagnostica e/o terapeutica.
Sarà, infine, assai frequentemente richiesto dal paziente un suggerimento sulla dieta più indicata per controllare la malattia. A questo riguardo il paziente ulceroso non necessita di alcuna dieta punitiva. Sarà sufficiente astenersi dagli alcolici e dagli abusi che possano in qualche modo causare generici disturbi della digestione (grassi in eccesso, pasti troppo abbondanti ecc.). Necessario è, infine, eliminare il fumo.
147

Figura 1 - Insieme delle componenti del processo cicatriziale dell’ulcera peptica, con l’area proliferativa ai margini mentre il fondo dell’ulcera è costituito da tessuto di granulazione.

Figura 2 - Bilancio tra i fattori aggressivi e difensivi che controllano l’integrità della mucosa gastroduodenale.
148
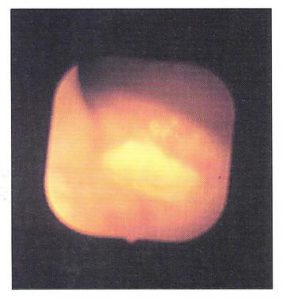
Figura 3 - Immagine endoscopica di un'ulcera gastrica (per gentile concessione del dr. E. Fesce)
149
11 - ERNIA IATALE E REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO
Inquadramento generale
La patologia da reflusso gastro-esofageo è di inquadramento relativamente recente e pertanto ancora spesso miscono sciuta. Si presenta con quadri clinici assai variabili per aspetti funzionali e anatomo-patologici e presenta una sintomatologia, pure variabile, ma assai caratteristica e che generalmente ben si differenzia dalla sintomatologia della malattia ulcerosa, con cui spesso viene confusa.
I sintomi più tipici sono la pirosi retrosternale e il rigurgito, che possono però essere mascherati e presentarsi come sapore acido o amaro in bocca, sensazione di bruciore orale, di facile ripienezza gastrica ed episodi frequenti di vomito. Ad essi si possono associare sintomi atipici come la disfagia e l'odinofagia, e dolori toracici simil-anginosi. Infine, la patologia può essere causa di sintomatologia extraesofagea, in particolare laringea e polmonare.
La prevalenza è assai difficilmente stimabile, perché la diagnosi non è sempre semplice per varie ragioni: il paziente tende frequentemente a sottostimare la sintomatologia, che giudica “nei limiti della norma”; altre volte la sintomatologia può essere del tutto assente, e, infine, la diagnosi deriva spesso da un’anamnesi accurata e mirata al problema piuttosto che dall’evidenza strumentale di lesioni e/o disturbi funzionali. Questi concetti hanno condotto a rappresentare la malattia da reflusso gastro-esofageo come un iceberg (Castell, 1985), in cui ciò che emerge dall’acqua è soltanto la minima parte del problema e rappresenta i pazienti più gravi, che necessitano di un’attenta sorveglianza e continua terapia; vi è poi una fascia di popolazione in cui il problema è modesto e facilmente sottovalutato, rappresentata dalla parte di ghiaccio appena sotto il pelo dell’acqua; infine, vi è la maggior parte della patologia nascosta sotto la superficie, come la parte sottomarina dell’iceberg.
Dati recenti indicano una prevalenza della sintomatologia da reflusso in oltre il 30% nella popolazione nordamericana, mentre in Europa la percentuale sarebbe inferiore al 20%.
Fattori che possono influenzare l’insorgenza di una patologia da reflusso sono l’età, il consumo di alcol e il fumo, mentre l’influenza del sesso (con un rapporto M:F superiore a 2:1) è limitata all’esofagite documentata, che è presente soltanto nel 60% circa dei pazienti.
L’ernia iatale si riscontra nel 60% dei pazienti con esofagite da reflusso e, d’altro canto, soltanto il 10% dei pazienti con ernia iatale lamenta sintomi da reflusso.
Per quanto riguarda l’ernia iatale, la sua incidenza è strettamente dipendente dall’età, con una prevalenza che supera il 50% a 50 anni e si avvicina al 100% in età senile.
Eziologia
La causa prima della malattia è la presenza di un reflusso gastro-esofageo patologico. Lo sfintere esofageo inferiore (LES), non è una valvola a continenza assoluta e pertanto il
150
reflusso è un meccanismo, entro certi limiti, fisiologico. Può essere causa di malattia in varie situazioni: quando è più frequente e/o abbondante per motivi di vario tipo (incontinenza del LES, con o senza ernia iatale, rallentato svuotamento gastrico, presenza di reflusso duodeno-gastrico), quando l’esofago ha una motilità patologica, che non consente una rapida e completa pulizia del refluito e, infine, in analogia alla patologia di tipo ulceroso-peptico, quando la mucosa esofagea si presenta più vulnerabile, per riduzione dei meccanismi di difesa (barriera mucosa).
Terapia
La terapia dipende strettamente dal grado di severità della malattia. Se, infatti, nelle forme con sintomi tipici, ma senza segni obiettivi di esofagite, saranno sufficienti norme comportamentali e dietetiche, con l’ausilio di farmaci antiacidi, antisecretori, citoprotettori e procinetici al bisogno, ben diverso sarà il comportamento nelle forme moderate o severe. In questi casi, infatti, sarà necessario, oltre alle norme suddette, instaurare una terapia regolare con antisecretori e procinetici, da proseguire anche in regime di “mantenimento”, a dosi più elevate nei casi più gravi. La terapia chirurgica andrà effettuata in caso di inefficacia della terapia medica (per reale inefficacia o scarsa compliance), forte tendenza alle recidive, insorgenza di complicanze.
Informazioni al paziente
Da quanto esposto appare evidente che l’informazione al paziente sia, oltre che un obbligo deontologico, anche un importante presidio terapeutico. Bisogna, infatti, spiegare al paziente le caratteristiche di presentazione della sintomatologia e l’importanza di non sottovalutarla, per non rischiare di aggravare la malattia e di andare incontro alle sue complicanze. È, d’altro canto, tranquillizzante sapere che una buona condotta terapeutica riduce le complicanze e praticamente azzera la mortalità.
Le norme comportamentali riguardano in primo luogo l’alimentazione. Sono da evitare i grassi in eccesso, la menta, le spezie, l’aglio, la cipolla e il cioccolato, l’alcol. Caffè, tè e bibite gassate dovranno essere limitate. Il fumo aumenta gli episodi di reflusso e riduce la capacità di svuotamento dell’esofago e andrà, dunque, sospeso. Infine, sarà necessario diminuire di peso, non coricarsi prima di 2-3 ore dalla fine del pasto, non indossare abiti stretti in vita, mantenere l’intestino pulito e, in caso di sintomatologia notturna, sollevare la testata del letto con un rialzo di 10-15 cm.
151
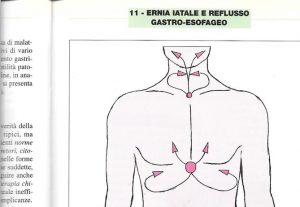
Figura 1 - Sede e irradiazione del dolore e della pirosi nel reflusso gastro-esofageo.

Figura 2 - Il concetto di Castell che rappresenta la malattia da reflusso gastro-esofageo come un iceberg.
152

Figura 3 - Durante il riposo a letto del paziente, la parte superiore del corpo va rialzata di circa 15 cm per ovviare al reflusso gastro-esofageo.

Figura 4 - Immagine endoscopica di esofagite erosiva (per gentile concessione del dr. E. Fesce).
153
12 - EPATITE ACUTA E CRONICA, CIRROSI EPATICA
Inquadramento generale
Le malattie epatiche sono assai numerose. Tra esse un ruolo preminente è occupato dalle epatiti virali acute, con la loro possibile evoluzione in epatiti croniche e cirrosi.
La prevalenza è assai variabile in relazione all’eziologia e quindi alla regione geografica di rilevamento, con prevalenza delle forme virali, rispetto a quelle alcoliche e autoimmuni, nelle regioni più meridionali e a basso tenore igienico.
In Italia i portatori di virus dell'epatite sono 2.000.000, i pazienti affetti da epatite cronica sono 500.000, 16.000 sono i casi di cirrosi con esito letale all’anno.
Eziologia
L'eziologia delle epatiti acute e croniche è varia: va da quella virale classica a quella etilica, a quella da farmaci, all’autoimmune, a cui si aggiungono le forme più rare, come il morbo di Wilson (da accumulo di rame). Altre forme esordiscono già con aspetti di cronicità, o addirittura di cirrosi, come la colangite sclerosante (a eziologia ignota), l'emocromatosi (da alterato metabolismo del ferro), la cirrosi biliare primitiva (a eziologia non del tutto nota, ma di tipo autoimmunitario), ecc.
I virus che causano epatite sono innumerevoli, ma quelli più importanti sono il virus dell’epatite A, quello dell’epatite B e quello dell’epatite C.
L'infezione da virus A decorre asintomatica nel 90% dei casi, mentre assume le caratteristiche dell’epatite acuta nel 10%. Nella stragrande maggioranza dei casi, evolve verso la guarigione, con rari casi di decorso prolungato e casi eccezionali di epatite fulminante (1:1000). La cronicizzazione non è descritta.
Anche l’infezione da virus B decorre asintomatica nel 90% dei casi, ma la forma fulminante è più frequente (1% delle forme acute) e la cronicizzazione avviene nel 10% circa dei soggetti contagiati, sintomatici o no. Tra questi, il 40% può essere considerato portatore sano, mentre il restante 60% sviluppa un’epatite cronica di vario tipo, con possibile evoluzione verso la cirrosi e l’epatocarcinoma.
Ben diverso è, invece, il comportamento del virus dell’epatite C, che causa epatite acuta soltanto nel 5% dei casi, con rarissimi casi di epatite fulminante, ma che in una elevata percentuale di casi (fino al 70%), conduce all’epatite cronica, la cui evoluzione verso la cirrosi riguarda almeno la metà dei casi. Anche il virus dell’epatite C, infine, aumenta la probabilità di insorgenza di epatocarcinoma.
Il ruolo dell’alcol nell’insorgenza dell’epatite e nella sua evoluzione verso la cirrosi, in Italia, è attualmente minore. Sono, infatti, pochi i casi a eziologia esclusiva- mente alcolica, mentre sono molto frequenti i casi di associazione virus-alcol.
154
Terapia
La terapia delle epatiti virali acute è ancora, nella maggior parte dei casi, soltanto di sostegno. È comunque possibile l’uso, in alcuni casi, dell’interferone e di altri farmaci antivirali (peraltro ancora in sperimentazione). Nell’epatite alcolica e da farmaci il presidio terapeutico fondamentale, è la sospensione della noxa patogena.
Nella cirrosi la terapia riguarda prevalentemente le complicanze, anche se è stato recentemente riconosciuto ai farmaci antifibrotici (colchicina) un ruolo terapeutico li rallentamento della progressione della malattia. Un’importante chance terapeutica è offerta oggi dal trapianto epatico, che ha raggiunto un’efficacia e un’affidabilità elevatissime, consentendo la “guarigione” di epatiti fulminanti e cirrosi considerate terminali.
Informazioni al paziente
Le conoscenze attuali su epatite e cirrosi consentono certamente una netta riduzione di morbilità e mortalità, se si attua una corretta opera di informazione. Infatti, la vaccinazione contro l’epatite B (oggi obbligatoria in età infantile), consentirebbe, se diffusa anche all’adulto, la completa eradicazione della malattia. Analogo discorso per l’epatite A, in cui l’infezione decorre in forma più grave nell’adulto e per cui, pertanto, è oggi importante proporre la vaccinazione su larga scala.
Per quanto riguarda, infine, l’epatite C, non essendo ancora disponibile il vaccino, sarà molto importante informare sui comportamenti “a rischio” e sulle conseguenti precauzioni da attuare per ridurre la probabilità di infezione.
Il principale fattore di rischio è la tossicodipendenza, responsabile dell’infezione nel 36% dei casi. Altri fattori di rischio specifici sono: le trasfusioni (5%), i rapporti sessuali e la convivenza (13%), il rischio lavorativo (3%) e la dialisi (1%), mentre un fattore del tutto aspecifico, è il basso livello socio-economico, presente nel 55% degli infetti.
Gli effetti dell’alcol, infine, sono ormai ben noti a tutti, ma un impegno da parte del medico di medicina generale non potrà che giovare e consentire di ridurre ulteriormente le conseguenze deleterie del suo abuso e di rallentare la progressione delle epatopatie ad eziologia etilica esclusiva o associata.
Il paziente cirrotico, infine, deve essere informato della natura cronica e della lenta evolutività della sua malattia, deve imparare a convivere con essa, cercando di non accelerarne l’evoluzione e di controllarne, con l’aiuto del medico, le complicanze.
In particolare, non andrà mai sottovalutato il rischio di degenerazione neoplastica, che impone un frequente controllo con esami ematochimici ed ecografici (almeno 2 volte l’anno), anche nei casi ben compensati e apparentemente stabili.
155

Figura 1 - Rappresentazione schematica del virus dell’epatite A.
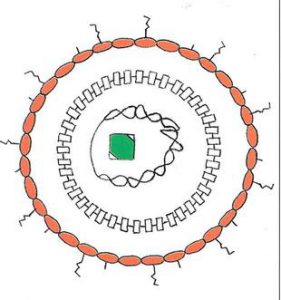
Figura 2 - Rappresentazione schematica del virus dell’epatite B.
156
Figura 3 - Il virus A penetra per via orale, provoca la malattia ed è eliminato con le feci.
FOTO 4
Figura 4 - Vie di penetrazione (orale: 1; parenterale: 2) e patogenesi dei virus B e C.
157
13 - COLELITIASI
Inquadramento generale
La colelitiasi, o presenza di calcoli nella colecisti, rappresenta una patologia estremamente frequente in entrambi i sessi, particolarmente al di sopra dei 50 anni. I calcoli, il cui principale componente è di solito il colesterolo, si formano più facilmente in pazienti che presentino alcuni fattori di rischio quali obesità, ipercolesterolemia, consumo di una dieta ricca di grassi. La colelitiasi può essere asintomatica, ed essere diagnosticata nel corso di una valutazione effettuata per altri motivi, oppure sintomatica con disturbi da lievi (dispepsia, nausea, intolleranza verso alcuni cibi quali i fritti) fino a una sintomatologia più importante con vomito e dolore addominale intenso, localizzato al quadrante superiore destro, irradiato posteriormente (colica biliare).
La diagnosi viene effettuata con i seguenti esami:
• esami ematochimici, per la valutazione degli indici di stasi (transaminasi e fosfatasi alcalina);
• ecografia addominale superiore;
• colecistografia, utilizzando un mezzo di contrasto per via orale;
• colecistocolangiografia, utilizzando un mezzo di contrasto per via endovenosa (poco utilizzata attualmente).
Eziologia
I calcoli delle vie biliari sono fondamentalmente di due tipi: i calcoli di colesterolo e quelli di pigmento. I primi, che sono certamente i più comuni, riconoscono come causa prima della loro formazione la sovrasaturazione di colesterolo della bile, che condiziona la nucleazione di cristalli di colesterolo e, in condizioni di alterazione del pool di acidi biliari o malfunzionamento della colecisti, formazione dei calcoli.
I calcoli di pigmento, invece, contengono prevalentemente bilirubina e si distinguono in neri e marroni, in relazione alla presenza, insieme alla bilirubina, di fosfati, carbonati e palmitati di calcio e colesterolo. I calcoli neri si associano all’emolisi, quelli marroni alla colestasi extraepatica (da ostruzione dei dotti biliari).
Terapia
La terapia va dall’approccio medico a quello chirurgico:
• la terapia farmacologica si avvale dell’acido ursodesossicolico e chenodesossicolico;
• il trattamento chirurgico comprende la classica colecistectomia e tecniche di più recente acquisizione (per es. l’accesso per via laparoscopica);
• una tecnica particolare è la litotrissia a onde d’urto.
158
Informazioni al paziente
Teoricamente si possono verificare tutte le possibili conseguenze cliniche legate alla formazione dei calcoli. La maggior parte dei pazienti resta asintomatica per lunghi periodi; tuttavia, i calcoli possono attraversare il dotto cistico determinando un’ostruzione transitoria con conseguente colica biliare della durata anche di alcune ore. Un’ostruzione persistente del dotto cistico può determinare un’infiammazione, la cosiddetta colecistite acuta, in cui si associano al dolore, nausea e vomito, tipici della colica biliare, e anche febbre alta, brivido e ittero. Per avere la possibilità di prevenire una simile complicanza è importante che il paziente si rivolga al proprio medico non appena compaiono i primi sintomi sordi, quali la difficoltà di digestione e l'intolleranza nei confronti di alcuni cibi. I metodi per lo studio della colelitiasi sono migliorati negli ultimi anni: i due approcci di scelta sono l’ecografia e la colecistografia. L’ecografia è un esame altamente sensibile, assolutamente non invasivo per il paziente e trova i suoi limiti nella presenza di tessuto adiposo, di ossa e di gas intestinale e nell’abilità dell’operatore. La colecistografia riveste un ruolo importante nella valutazione funzionale della colecisti e dell’eventuale radiotrasparenza dei calcoli (parametri fondamentali nell’approccio terapeutico); il suo limite è rappresentato dall’assunzione da parte del paziente di mezzo di contrasto per via orale, che non sempre può essere utilizzato (per es. nei danni epatocellulari o nelle allergie ai mezzi di contrasto).
Una volta effettuata la diagnosi è importante il seguente approccio terapeutico:
1) colelitiasi asintomatica: non si prevede nessuna terapia; tuttavia, al paziente è consigliata una dieta a scarso contenuto di grassi e con maggiore contenuto proteico (latte scremato, prosciutto magro, carne di manzo, pesce), limitando l’assunzione di cibi irritanti quali caffè, tè, alcol, agrumi, cioccolata;
2) colelitiasi sintomatica: il trattamento farmacologico non ha dato a tutt’oggi buoni risultati; solo in una piccola percentuale di casi si è avuta una dissoluzione dei calcoli dopo due anni di trattamento, che peraltro presenta numerosi effetti collaterali (per es. nausea, diarrea). Perciò, la terapia medica può essere consigliata limitatamente ai soggetti anziani o con patologie concomitanti che non possono essere sottoposti ad altri trattamenti. Sicuramente più efficace è il trattamento con litotritore, generatore di onde d’urto extracorporeo, che permette in modo non invasivo la frammentazione dei calcoli senza che il paziente venga sottoposto né ad anestesia né a sedativi. Anche in questo caso ci sono però delle limitazioni: la colecisti deve essere funzionante, i calcoli radiotrasparenti e con dimensioni non inferiori ai 10 mm. La colecistectomia rappresenta, quindi, il trattamento di elezione nei pazienti sintomatici: si tratta di un intervento chirurgico sicuro, per lo più privo di complicanze soprattutto con le nuove tecniche (via laparoscopica, che evita un taglio addominale di una certa invasività), senza causare problemi nutrizionali, né restrizioni alimentari e di vita nel periodo post-operatorio.
In conclusione, attualmente i criteri di scelta sia diagnostica sia terapeutica nella colelitiasi sono vasti e danno ottimi risultati, ma solo un rapido e chiaro approccio con il proprio medico di famiglia potrà permettere al paziente di poterne usufruire al meglio.
159

Figura 1 - Incisioni laparoscopiche più in uso per l’intervento di colecistectomia.
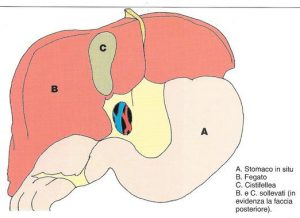
Figura 2 - Rapporto della cistifellea con gli organi vicini.
160

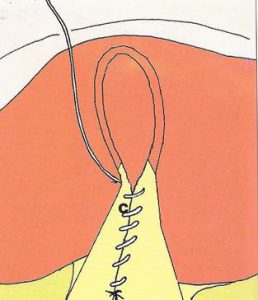
Figure 3/4 - fasi dell'intervento tradizionale di colecistectomia.
A. Fegato
B. Cistifellea
C. Punti di sutura
161
IX
APPARATO UROGENITALE
162
163
14 - IPERTROFIA PROSTATICA
Inquadramento generale
Malattia associata al processo di invecchiamento, l’ipertrofia prostatica benigna (IPB), o adenoma prostatico, ha un’incidenza crescente a partire dalla quarta decade di vita, colpisce il 50% dei maschi alla sesta decade e più del 70% alla settima decade.
Nell'IPB è presente, una disfunzione dello sfintere liscio vescicouretrale e della muscolatura liscia del detrusore, che si trovano sotto il controllo del sistema nervoso autonomo (alfa-adrenergico).
Le manifestazioni cliniche sono tipicamente legate al grado di disfunzione sfinterodetrusoriale e di ostruzione uretrale. Il paziente lamenta ritardo della minzione, riduzione del calibro e della forza del flusso, gocciolamento terminale, nicturia, pollachiuria, minzione imperiosa, sensazione di svuotamento incompleto; possono comparire disturbi di maggiore entità e complicanze più o meno tardive, quali l'ematuria, le infezioni delle vie urinarie, la ritenzione acuta o cronica, i diverticoli vescicali, i calcoli prostatici, l'insufficienza renale.
Eziologia
La prostata normale è ormonodipendente: possiede recettori specifici per gli androgeni e per gli estrogeni, i quali esercitano effetti sinergici sulla crescita dell’organo. Nell'IPB risulta preponderante l’influenza androgenica, che si esplica principalmente sull’epitelio prostatico e in minor misura sulla componente stromale.
L’IPB origina dalla “zona di transizione” della prostata, costituita da due piccoli lobuli che si trovano in stretto rapporto con lo sfintere preprostatico; si tratta di una zona anatomicamente separata dalla porzione periferica della ghiandola periuretrale.
Terapia
La terapia dell’IPB è di tipo chirurgico e di tipo medico. La terapia chirurgica è l’unica che permette di risolvere completamente l’ostruzione e di annullare il rischio di complicanze.
Terapia chirurgica. Due sono le modalità operative: l'intervento di enucleazione a cielo aperto e l'ablazione endoscopica. L’intervento di enucleazione a cielo aperto è elettivo nelle ipertrofie voluminose, nei diverticoli e nelle calcolosi vescicali non asportabili endoscopicamente. L’approccio è addominale, previa incisione trasversale sovrapubica, cui segue l’enucleazione dell’adenoma.
L’elettroresezione endoscopica della prostata (TUR) è un intervento di minore invasività, che viene effettuato nella maggior parte dei pazienti; viene normalmente praticato in anestesia generale e solo in una piccola frazione di pazienti selezionati può essere praticato in anestesia locoregionale con sedazione endovenosa. Consiste nell’inserimento per via transuretrale di un resettore che procede all’asportazione
164
del tessuto adenomatoso mediante resezione a fette, sotto visione endoscopica. È indicato nelle ipertrofie moderate, nei lobi medi di piccole dimensioni, nella sclerosi del collo vescicale.
I trattamenti alternativi alla chirurgia sono rappresentati da procedure poco invasive quali la dilatazione uretrale con palloncino e l’inserimento di stent uretrali e l’ipertermia; si tratta di trattamenti palliativi, eseguiti per lo più per garantire sollievo dai sintomi al paziente in attesa di un intervento risolutivo.
La terapia medica si avvale di alfa-bloccanti, che riducono le resistenze uretrali; di inibitori delle 5-alfa-reduttasi e di progestinici, che interferiscono sull’azione del testosterone sulla prostata; di farmaci di estrazione vegetale per lo più ad azione anticongestivante, la cui efficacia è ancora in discussione.
Informazioni al paziente
Sebbene il soggetto affetto da ipertrofia prostatica sia attratto da proposte terapeutiche alternative oggi disponibili, perché scarsamente o affatto invasive, occorre ricordare che l’efficacia di tali trattamenti è chiaramente inferiore a quella della chirurgia, e che solo quest’ultima resta a tutt’oggi il trattamento risolutivo.
L’intervento va praticato nei casi in cui l’ostruzione comporti importanti sintomi soggettivi o complicanze gravi: sono indicazioni assolute la totale incapacità a urinare, il catetere a dimora, i calcoli, i diverticoli, l’idronefrosi.
I rischi dell'intervento, a parte quelli generici rappresentati da concomitanti cardiopatie, pneumopatie, coagulopatie, sono i seguenti:
● l'emorragia è la più frequente complicanza intra e post-operatoria, può richiedere l’emotrasfusione e pertanto è opportuno il predeposito di sangue;
● le stenosi uretrali sono una complicanza frequente (fino al 10% dei casi) specie in seguito a TUR;
● l’incontinenza da stress è una sequela frequente, ma tende a migliorare col tempo e risponde alla terapia medica.
Mentre sono complicanze piuttosto rare l'infezione della ferita chirurgica, l'orchiepididimite, e le fistole transitorie in sede di ferita, i disturbi della sfera sessuale risultanti dall’intervento meritano attenzione: una sequela praticamente inevitabile è l’eiaculazione retrogada. L'impotenza, invece, tende ad essere sopravvalutata, e un deficit erettile da causa organica connesso all’intervento incide probabilmente in misura assai bassa. La mortalità dell’intervento è inferiore al 5%.
I tempi di degenza media sono: 10 giorni per l’intervento a cielo aperto, 7 per la TUR; il paziente deve portare il catetere a dimora per circa 7 giorni nel primo caso, per 3 nel secondo.
165
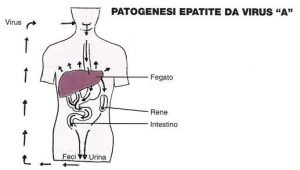
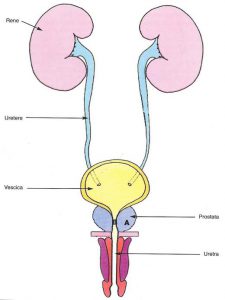
Figura 1 - Apparato urinario maschile. Si evidenzia ipertrofia prostatica (A) con riduzione del lume uretrale (B).
166

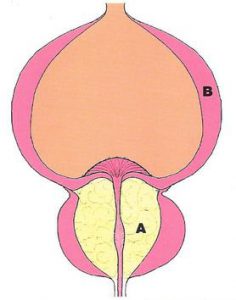
Figura 2 - Schematizzazione delle diverse tecniche di intervento per l’asportazione chirurgica dell’adenoma prostatico.
Figure 3/4 - L'adenoma prostatico (A) causa una ostruzione che compromette il normale deflusso urinario, e un ispessimento progressivo della parete vescicale (B).
167
15 - CARCINOMA DELLA PROSTATA
Inquadramento generale
il carcinoma della prostata rappresenta una delle neoplasie più frequenti nel sesso maschile. L’evoluzione della malattia è alquanto variabile e può dipendere anche dal fatto che il carcinoma prostatico può rimanere a lungo asintomatico, o esordire invece in forma conclamata e sintomatica.
I sintomi sono spesso di scarsa entità, per lo più ostruttivi e imputabili alla componente adenomatosa della ghiandola; sono da ricordare la disuria o stranguria; l’ematuria; il dolore (perineale, vescicale, uretrale, rettale, sciatico).
L’inquadramento diagnostico prevede l'esplorazione rettale, l’ecografia transrettale, la biopsia ecoguidata, la ricerca di markers tumorali specifici, in particolare l’antigene prostatico specifico (PSA), che si correla allo stadio clinico e patologico, al grading e al volume della neoplasia.
Eziologia
L’eziologia della malattia è in gran parte sconosciuta; è comunque multifattoriale, derivando dalla complessa interazione di molti fattori (predisposizione genetica, influenze ormonali, ambientali, dietetiche).
Terapia
La scelta del trattamento dipende da una valutazione globale comprendente l’età del paziente (solitamente avanzata), il decorso subclinico della malattia, l’aspettativa di vita, i fattori prognostici specifici del tumore (grado di differenziazione, volume, stadio, PSA), le malattie concomitanti.
Nell’ipotesi di un intervento chirurgico si impone una laparoscopia preliminare con linfoadenectomia di stadiazione, per escludere forme avanzate potenzialmente non suscettibili di guarigione. Tra le procedure ricordiamo:
― la prostatectomia radicale: indicata elettivamente nei tumori localizzati (carcinoma intracapsulare).
Si effettua con due modalità:
● approccio retropubico: consente una linfadenectomia preliminare ed è pertanto preferibile all’approccio perineale;
● l’approccio perineale: relativamente avascolare, consente una più semplice anastomosi vescico-uretrale; è elettivo per gli obesi;
― la chirurgia endoscopica (TUR): trova principale indicazione nella disostruzione palliativa.
Le maggiori remore al ricorso alla chirurgia radicale della prostata derivano da importanti complicanze, di grande impatto psicologico e funzionale, quali l’impotenza e l’incontinenza urinaria.
168
È oggi possibile, tuttavia, mantenere una certa funzionalità dei nervi erettori per lo meno nei giovani in presenza di tumori di basso stadio e grado.
L’incontinenza da stress può essere definitiva, ma rara, mentre un’incontinenza post-catetere è solitamente transitoria. Altri tipi di terapia comprendono:
● la radioterapia: il suo ruolo è in corso di valutazione, non avendo finora ottenuto risultati ottimali. La radioterapia esterna con megavoltaggio (acceleratore lineare) è impiegata a scopo radicale; la radioterapia interstiziale è attuata mediante infissione di aghi di iodio radioattivo, dopo linfoadenectomia di staging;
● la terapia medica: trova impiego nelle forme avanzate e nelle recidive, ed è casata sulla modificazione dell’equilibrio ormonale. Si utilizzano inibitori ormonali goserelin), antiandrogeni (ciproterone acetato, flutamide, nilutamide, aminoglutetimide) ed estrogeni.
Informazioni al paziente
Date le scarse conoscenze sull'eziopatogenesi del carcinoma prostatico, poche sono anche le misure atte a prevenirlo. Nessun fattore di rischio modificabile è stato identificato con certezza. Tuttavia possono essere fatte alcune considerazioni:
● si ritiene che il fattore di rischio più importante sia l’età: tale rischio triplica o quadruplica nei soggetti con familiarità positiva (parente di primo grado) per cancro della prostata, e comunque aumenta se sussiste familiarità per neoplasie;
● alcuni studi hanno evidenziato una correlazione tra cancro della prostata ed esposizione al cadmio (proveniente, per esempio, dal fumo di sigaretta);
● sembra esistere un rapporto tra consumo di grassi, soprattutto quelli provenienti dalla carne, dalle uova, dal latte, e aumentato rischio di carcinoma.
A tutt’oggi, quindi, le sole misure preventive raccomandabili sono la limitazione lei fumo e dell’apporto di grassi con la dieta.
L’esplorazione digitale rettale è una manovra diagnostica di screening su cui vi è ampio consenso da parte dei medici. Nonostante i suoi limiti di sensibilità, l’American Cancer Society ne raccomanda l’esecuzione in tutti i soggetti al di sopra dei 40 anni asintomatici, permettendo contemporaneamente anche il depistaggio delle neoplasie rettali.
169
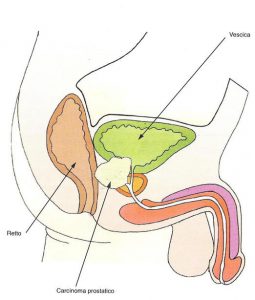
Figura 1 - Carcinoma prostatico in stadio avanzato, infiltrante le strutture circostanti.
170

Figura 2 - Intervento di prostatectomia radicale.
A. Le linee tratteggiate rappresentano le sezioni di taglio sul collo vescicale e sull’uretra;
B. Approccio sovrapubico;
C. Approccio perineale
171
16 - PROSTATITI
Inquadramento generale
Le infiammazioni della ghiandola prostatica, rare in età prepuberale, sono di frequente riscontro nel soggetto adulto.
Trascurando le forme non comuni di prostatite specifica (gonococcica, tubercolare, micotica, parassitarla) e non specifica (granulomatosa), possiamo sostanzialmente distinguere i seguenti tipi di prostatite di più frequente riscontro:
batterica (acuta e cronica);
non batterica;
prostatodinia.
Eziologia
La prostatite batterica acuta è solitamente sostenuta da germi aerobi Gram negativi: E. Coli e Pseudomonas sono i più frequenti.
Fattori patogenetici sono: l’infezione uretrale ascendente, il reflusso urinario nei dotti prostatici, la diffusione di germi per via ematica e linfatica.
L’esordio clinico può essere drammatico, con febbre, brividi, malessere generale, sintomi disurici irritativi e ostruttivi.
La diagnosi è generalmente possibile con il semplice ausilio dell’urinocoltura.
La prostatite cronica è causata per lo più dagli stessi germi responsabili della forma acuta; il momento patogenetico fondamentale è rappresentato dal reflusso intraprostatico di urina.
Il quadro sintomatologico è piuttosto variegato: lieve o moderata disfunzione della minzione, dolore o fastidio in sede sovrapubica, o perineale, o scrotale, o peniena, occasionalmente dolore post-eiaculatorìo o emospermia. Ma la caratteristica principale e più frequente è rappresentata dalle infezioni delle vie urinarie (IUV) ricorrenti, spiegabili con la permanenza dei batteri nel liquido prostatico, e conseguente possibilità di reifezione a distanza.
I calcoli prostatici, di riscontro molto frequente con l’avanzare dell’età, entrano verosimilmente in causa come possibile serbatoio di infezione cronica.
La diagnosi delle prostatiti batteriche croniche si avvale, oltre che dell’esame delle urine, dell’esame microscopico e colturale del liquido prostatico e dello sperma.
Le prostatiti non batteriche, o abatteriche, sono in realtà sindromi in cui, accanto a una eziologia batterica ipotizzabile, ma non documentata con certezza, si affiancano forme infiammatorie non infettive.
Tra i batteri si riconosce una potenziale causalità all’Ureaplasma urealyticum e alla Chlamydia trachomatis: la scarsa conoscenza degli agenti eziologici e la loro difficile individuazione con le usuali procedure diagnostiche rende ragione della difficoltà nell’eradicare la flogosi.
La definizione di prostatodinia si riferisce ai seguenti disturbi:
172
tensione mialgica del pavimento pelvico;
anomalie funzionali della minzione;
disturbi emozionali da stress.
Si tratta di forme in cui giocano un ruolo eziopatogenetico disfunzioni del sistema nervoso autonomo (il simpatico pelvico nella tensione mialgica) e disordini psichici.
Terapia
La terapia antibiotica delle prostatiti acute è solitamente efficace e solo in rari casi si impone il ricovero per ritenzione urinaria acuta.
Il maggiore problema terapeutico nelle prostatiti croniche è rappresentato dalla scarsa diffusibilità degli antibiotici attivi contro i Gram negativi nel liquido prostatico. Ciò comporta trattamenti antimicrobici prolungati, che talora si possono rivelare inefficaci, e in alcuni casi si rende necessaria una terapia soppressiva continua a basse dosi di antibiotici.
Nelle prostatiti abatteriche il trattamento antibiotico è empirico, deve essere protratto per più settimane e diviene importante informare il paziente della sua condizione, rassicurandolo della sostanziale benignità della forma morbosa, nonostante la tendenza alla cronicità.
Per controllare i disturbi irritativi della minzione, farmaci anticolinergici e antinfiammatori saranno utili.
Nella prostatodinia sono utili i miorilassanti, gli ansiolitici, gli alfabloccanti, e l’esecuzione di esercizi fisioterapici.
Informazioni al paziente
Nella prostatite acuta il paziente deve stare a riposo a letto, ricevere un’adeguata idratazione e utilizzare una sedia più soffice. Oltre che con i comuni analgesici, il dolore può anche essere alleviato da semicupi e da piccoli clisteri caldi. A questi, nelle prostatiti croniche, potrà aggiungersi il massaggio prostatico. Nelle prostatiti non batteriche il paziente potrà esercitare una regolare attività fisica e sessuale e non avrà limitazioni dietetiche particolari, salvo la restrizione degli alcolici e dei cibi piccanti.
173

Figura 1 - Rapporti della prostata con gli organi vicini.
174

Figura 2 - Vie di diffusione dell’ascesso prostatico nelle strutture contigue.
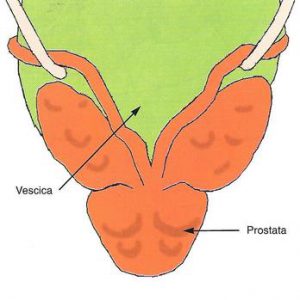
Figura 3 - Prostatite tubercolare.
175
17 - NEFROLITIASI
Inquadramento generale
La calcolosi renale è una malattia estremamente frequente nei paesi ad alto grado di sviluppo; predilige i soggetti maschi di razza bianca con anamnesi familiare positiva per nefrolitiasi, nonché portatori di patologie flogistiche intestinali, infezioni delle vie urinarie, gotta, fratture patologiche.
Eziologia
Il meccanismo patogenetico è costituito dalla sovrasaturazione di ioni nelle urine e dal loro successivo combinarsi in fase solida attraverso un processo di nucleazione: perché ciò avvenga è necessaria un'abnorme escrezione urinaria di calcio e di ossalato, nonché di acido urico.
L’ipercalciuria può essere imputabile a: un aumentato assorbimento di calcio a livello intestinale e a successiva inibizione del riassorbimento tubulare; un difetto renale di riassorbimento; un aumentato riassorbimento osseo, come accade nell’iperparatiroidismo primario.
L’iperuricosuria è associata a un eccessivo apporto di purine: l’elevata escrezione di urato monosodico a pH normale induce la cristallizzazione dell’ossalato di calcio.
L’iperossaluria è dovuta soprattutto a un aumentato assorbimento di ossalato nel corso di malattie flogistiche intestinali, a malassorbimento lipidico, a resezioni o by-pass ileali.
Un fattore predisponente la sovrasaturazione è, inoltre, l’ipocitraturia, causata da acidosi tubulare e metabolica; il citrato agisce, infatti, da chelante.
Nella cistinuria, malattia autosomica recessiva, vi è un errore congenito di trasporto degli aminoacidi bibasici a livello del tubulo prossimale; la cistina è scarsamente solubile e la cistinuria promuove la cristallizzazione dell’ossalato e del fosfato di calcio.
Terapia
La manifestazione clinica più tipica della nefrolitiasi è la colica renale, ma talora il paziente lamenta solo una lombalgia, oppure è totalmente asintomatico. La diagnosi si avvale dell’urografia, che tende a escludere eventuali anomalie delle vie escretrici, e dell’ecografia, che ha il vantaggio di una minore invasività.
Nel trattamento della nefrolitiasi, la terapia medica ha un ruolo limitato alla cura sintomatica della colica e delle sue complicanze; d’altro canto, disponiamo oggi di procedure terapeutiche alternative a quella medica, che consentono un approccio incruento o scarsamente invasivo e limitano la chirurgia convenzionale a una
176
ridotta percentuale di pazienti (meno del 10%). Ricordiamo la terapia endoscopica con estrattori e la litotrissia con ureterorenoscopio nelle calcolosi ureterali; la chemiolisi attraverso catetere transuretrale o nefrostomico; la litotrissia percutanea renale mediante nefroscopio introdotto nelle cavità renali; la litotrissia extracorporea a onde d’urto (ESWL), con la quale possono essere frantumati i calcoli renoureterali nella maggior parte dei casi, a patto di una buona funzionalità renale, di normalità della via escretrice e di dimensioni contenute del calcolo.
Informazione al paziente
Il problema clinico più importante per il medico che deve curare il soggetto affetto da nefrolitiasi è la tendenza della malattia a recidivare. Pertanto, rivestono un ruolo determinante le misure profilattiche, che il paziente deve conoscere e mettere in atto.
Trattamento idropinico: bisogna assumere liquidi in quantità sufficiente ad assicuare una diuresi di almeno due litri al giorno, ripartendo bevande varie nelle 24 ore. È necessario porre particolare attenzione al rischio di disidratazione connesso all’attività sportiva o ai viaggi.
Apporto sodico: è raccomandabile una restrizione, poiché un’elevata assunzione di sodio aumenta la concentrazione urinaria di calcio e favorisce la cristallizzazione dell’ossalato di calcio.
Dieta: è da evitare una drastica riduzione del calcio, che provocherebbe un aumentato assorbimento di ossalato. Un apporto moderato di calcio (550-650 mg giornalieri), equivalente a un unico pasto di prodotti caseari, è ragionevole.
Nella litiasi urica occorre ridurre l’apporto di purine (frattaglie, uova di pesce, cioccolato, selvaggina). Gli individui affetti da gotta presentano un elevato rischio di nefrolitiasi da urati, poiché nella gotta il pH urinario è generalmente acido (inferiore a 5.5) e in tali condizioni l’acido urico precipita in cristalli. Da qui l’opportunità li alcalinizzare le urine, che il medico attuerà con farmaci, mentre il paziente potrà ritradurre nella dieta latticini, legumi verdi e frutta.
La litiasi ossalica è, come abbiamo detto, associata a patologie infiammatorie del tubo digerente: tuttavia, può dipendere anche da un’eccessiva assunzione di ossalati con i cibi; quelli che ne costituiscono una fonte sono: il cacao, il tè, gli spinaci, il rabarbaro, i fichi, il pepe.
Sono, invece, ricchi di fosfato i formaggi, le uova, i legumi secchi, i frutti di mare li cui è opportuno ridurre il consumo nella litiasi fosfatica; il fosfato è presente nei calcoli di magnesio-ammonio-fosfato, frequentemente associati alle infezioni da microrganismi del tratto urogenitale.
177
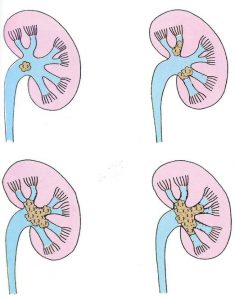
Figura 1 - Rappresentazione schematica della localizzazione dei calcoli renali.
178

Figura 2 - La litotrissia percutanea renale permette la frantumazione dei calcoli mediante un nefroscopio introdotto nelle cavità renali.
179
X
APPARATO GENITALE FEMMINILE
180
181
18 - CONTRACCEZIONE
Inquadramento generale
Il metodo anticoncezionale ideale dovrebbe possedere 4 requisiti essenziali:
● efficacia, ossia garanzia che non si verifichino gravidanze indesiderate;
● innocuità, ossia non produrre effetti dannosi;
● reversibilità, ossia poter tornare alle condizioni di fertilità alla cessazione;
● accettabilità, non interferenza con le abitudini sessuali e/o convinzioni etiche personali.
Metodi naturali: presentano, in genere, un’elevata percentuale di insuccesso.
Coito interrotto: insuccesso legato a mancato controllo dell’eiaculazione o a fuoriuscita “precoce” degli spermatozoi; a lungo termine si può verificare un deterioramento dei meccanismi affettivi di coppia.
Metodo Ogino-Knaus: astensione dai rapporti sessuali nei giorni immediatamente precedenti e successivi l’ovulazione; per individuare il momento dell’ovulazione si utilizza una formula matematica e un periodo di 1 anno di osservazione dei cicli mestruali.
Misurazione della temperatura basale: a metà ciclo, dopo in brevissimo abbassamento, si innalza di circa 0,5/1 °C; vengono pertanto considerati sicuri i giorni seguenti il terzo dall’innalzamento della temperatura (rialzi febbrili possono indurre errori di calcolo).
Metodo Billings, o del muco cervicale: il muco cervicale, sotto stimolazione estrogenica, all’avvicinarsi dell’ovulazione, aumenta in quantità, diviene fluido, trasparente e filante: nel momento dell’ovulazione può essere disteso fino a 10 cm. Rapporti “sicuri” si possono avere prima delle suddette modificazioni e alla loro scomparsa.
Metodo sintotermico: è la combinazione del metodo della temperatura basale e del muco cervicale.
Metodi chimici: da usarsi sempre in associazione con metodi di barriera; sono costituiti dagli spermicidi (disponibili in gel, ovuli, crema).
Metodi di barriera: sono nel complesso dei metodi efficaci. Ricordiamo in particolare:
il preservativo maschile: è l’unico metodo che, usato durante i rapporti, protegge dalle malattie a trasmissione sessuale (HIV, epatite, ecc...), sempre che venga correttamente utilizzato;
il diaframma: è una semisfera di gomma che va introdotta prima del rapporto, e va mantenuta per 6-8 ore dopo il termine dello stesso;
il preservativo femminile: è costituito da una guaina in poliuretano che, introdotta in vagina, si distende creando una barriera al passaggio degli spermatozoi.
Metodi meccanici:
spirale, o dispositivo intrauterino (I.U.D.): è costituito da una struttura in plastica ricoperta di rame; viene introdotta e rimossa dal ginecologo; la permanenza utile
182
nell’utero va dai 2 ai 5 anni. Controindicazioni assolute sono: gravidanza in atto o presunta, infiammazioni acute o ricorrenti della pelvi o del canale cervicale, anomalie uterine, tumori certi o sospetti, allergia al rame.
Spesso provoca, specie nei mesi immediatamente successivi alla sua introduzione, un aumento del flusso mestruale e una maggiore durata dello stesso.
Metodi ormonali:
pillola: la combinazione fra estrogeni e progestinici è in grado di sopprimere l’ovulazione. Altri meccanismi accessori completano e rafforzano quest’attività, come le modificazioni endometriali e mucocervicali e modificazioni della peristalsi tubarica. Controindicazioni assolute sono: gravi patologie epatiche, processi flebitici o tromboflebitici, diabete grave, ipertensione arteriosa, patologie tumorali.
Numerosi studi hanno dimostrato in pazienti che hanno assunto contraccettivi orali una minor incidenza di tumori ovarici e dell’endometrio. Come pure di eventi tromboembolici in donne non fumatrici.
La pillola del giorno dopo è una contraccezione di emergenza; gli estrogeni in alte dosi prevengono l’impianto dell’ovulo fecondato.
Informazioni al paziente
Nella scelta iniziale e nell’uso continuativo di un metodo contraccettivo giocano molti fattori ma almeno tre sono i requisiti fondamentali che si richiedono a questo: efficacia del metodo, sicurezza e sua accettabilità.
Alla prima visita il ginecologo eseguirà un esame obiettivo generale e pelvico dettagliato e cercherà di creare un rapporto di fiducia con la donna e soprattutto con l’adolescente anche se non sessualmente attiva, in modo da poter correttamente individuare le concomitanti o future problematiche, correlate alla contraccezione. Solo così il medico potrà prescrivere alle pazienti il tipo di contraccettivo più adatto.
183

Figura 1


Figura 2 - A) Spermatozoi
B) Muco cervicale
184
Figura 1 - Modalità d’inserimento del diaframma.
A. Diaframma
B. Inserimento in vagina
C. Diaframma posizionato sul collo uterino
D. Controllo inserimento corretto

Figura 2 - Tecnica di inserimento della spirale.
A. Spirale nell’inseritore
B. C. D. Stadio d’inserimento in utero
185
19 - MENOPAUSA
Inquadramento generale
Si intende per menopausa il momento dell’ultimo ciclo mestruale, e compare in media intorno ai 50 anni, ma con una grossa variabilità, tanto che sono possibili menopause precoci anche intorno ai 40 anni.
Eziologia
Il substrato anatomo-fisiologico è rappresentato da una alterazione del meccanismo ovulatorio, e successivamente dall’esaurimento dei follicoli primari ovarici; la variabilità prima e la diminuzione poi della produzione di progesterone sono responsabili delle diverse sindromi del periodo del climaterio (dal greco Klimater, scala a gradini), periodo di transizione, che dura 2-3 anni, in cui distinguiamo:
premenopausa: la riduzione dell’attività luteale determina una situazione di iperestrogenismo relativo, con predisposizione ai tumori genito-mammari, mastodinia frequente, aumento di peso determinato sia da ritenzione idrica di tipo premestruale che regredisce più difficilmente, sia da una bulimia sostenuta da fattori psicologici.
I cicli mestruali si fanno progressivamente più irregolari, fino ad arrestarsi nella menopausa vera e propria in cui insorge il segno classico della menopausa, le vampate di calore, reazione dei centri vasomotori centrali alla diminuzione estrogenica.
Si manifestano poi dei fenomeni involutivi a carico dei depositi adiposi sovrapubici e mammari, e a carico del tessuto ghiandolare mammario.
Insieme alla cessazione della funzione riproduttiva si hanno disturbi del comportamento quali insonnia, depressione più o meno grave, alterazione della libido e del comportamento sessuale.
Postmenopausa: cessano in genere tutti i fenomeni di ordine vasomotorio; si accentuano i fenomeni involutivi, e compare l’osteoporosi.
Terapia
È fondamentale l’approccio psicologico alla paziente che si avvicina alla menopausa; in certi casi può essere indicata la psicoterapia.
Sulla necessità o meno del trattamento ormonale esistono due posizioni estreme: da un lato non trattare alcuna paziente, basandosi sul fatto che la menopausa è un fenomeno fisiologico, e che ogni terapia non fa che prolungare questo periodo; all’opposto trattare tutte le pazienti per prevenire i fenomeni ossei, cardiovascolari e involutivi, attraverso l’uso di estrogeni o di estroprogestinici. Ma queste due posizioni estreme non tengono conto del “fattore donna”: una paziente con disturbi severi da privazione o con ansia, o timore dell’invecchiamento, mal sopporterà un atteggiamento di attesa, e si rivolgerà a un altro medico, così come un’altra paziente finirà
186
per interrompere un trattamento ormonale di cui non senta la necessità. L’uso degli estrogeni è rigorosamente proscritto nel caso di presenza o anche solo di anamnesi positiva per neoplasia genito-mammaria; sono da evitare, inoltre, in caso di patologie che regrediscono spontaneamente alla riduzione estrogenica (per es. fibroma uterino).
Idealmente, il trattamento ormonale sostitutivo deve avvicinarsi il più possibile a quanto si intende sostituire: vale a dire 17-(3-estradiolo e progesterone; lo schema terapeutico, la posologia e la modalità di somministrazione vanno considerati in funzione della reale e specifica carenza estrogenica della donna, delle sue specifiche aspettative nella vita di relazione, scegliendo fra la somministrazione per os, la via percutanea e le forme iniettabili-ritardo. In genere quando si decide di sospendere il trattamento, si sceglieranno via via farmaci sempre meno potenti, arrivando a una sospensione graduale della terapia.
Un caso a parte sono le menopause precoci, o di tipo idiopatico o chirurgico: sono donne in cui il trattamento è fortemente indicato, sia per prevenire fenomeni di osteoporosi precoce, sia per evitare l’involuzione dei caratteri sessuali; spesso sono pazienti altamente motivate ad assumere il trattamento.
Una domanda che spesso pongono le pazienti è la relazione tra estrogeni e tumore: non vi è una totale uniformità di giudizio. Per quanto riguarda il seno, non sembra esserci, sui grandi numeri, un aumento significativo dell’insorgenza cancerosa; tuttavia, per il possibile ruolo carcinogenetico degli estrogeni non si inizia una terapia in presenza di un nodulo al seno di cui non sia stata accertata la natura.
L’associazione di estroprogestinici con progesterone sembra essere protettiva nei confronti dell’insorgenza del cancro endometriale; questo tipo di tumore compare nell’80% dei casi dopo la menopausa, e la sua relazione con un’anomala stimolazione estrogenica sembra dimostrata: l’uso del solo estrogeno incrementa considerevolmente il rischio di insorgenza.
L’osteoporosi è, entro certi limiti, un fenomeno fisiologico; la menopausa accelera un processo inesorabile di osteopenia e la terapia sostitutiva esercita un effetto protettivo sia con un suo proprio meccanismo d’azione sia in sinergia con la calcitonina. A oggi non possiamo prevedere quali donne andranno incontro a una vera e propria patologia ossea, ed è parere ancora controverso se la prevenzione dell’osteoporosi giustifichi da sola una terapia ormonale sostitutiva.
Informazioni al paziente
Il rischio per la donna di rimanere incinta è presente per un anno dopo l’ultima mestruazione se questa è insorta oltre i 50 anni, per due anni se questa è insorta prima dei 50. In considerazione dell’elevato rischio di Sindrome di Down nella prole, il medico dovrebbe consigliare un’adeguata terapia anticoncezionale.
187

Figura 1 - Formulazione transdermica di estrogeni da associare a progestinici per via orale.

Figura 2 - Vampate di calore: un tipico disturbo della menopausa.
188

Figura 1 - Osteoporosi: conseguenza frequente, talvolta grave, della menopausa.
189
20 - DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Inquadramento generale
Una valutazione periodica dello stato di salute della donna effettuata anche mediante l’ausilio di indagini strumentali fornisce al medico l’opportunità di formulare diagnosi precoci o di prevenire l’insorgenza di eventuali patologie.
Metodiche di indagini ginecologiche.
Colposcopia: permette di visualizzare l’epitelio del collo uterino, la sua vascolarizzazione, e il tessuto connettivo sottostante. È un mezzo incruento e obiettivo per controllare l’intero tratto genitale inferiore comprendente vulva, vagina, esocervice e bassa endocervice (vulvo-vaginoscopia). Quest’ultima è particolarmente interessante nel caso di infezioni da papilloma virus e ci permette, inoltre, di poter effettuare, ove lo riteniamo necessario, un prelievo bioptico.
Ecografia pelvica e transvaginale: incruenta, utile per la diagnosi di patologie pelviche e intraddominali, utile anche per guidare procedure ginecologico-ostetriche invasive. Poiché la sezione ecografica è molto limitata, l’elaborazione di una diagnosi si basa sulla sommatoria di sezioni multiple a due dimensioni; l’operatore deve, quindi, ricostruire l’anatomia ricreando uno spazio tridimensionale.
Isterosalpingografìa: è la radiografia dell’utero e delle tube resi radiopachi con mezzo di contrasto. Quando l’ambito di indagine sia quello della sterilità può essere considerata una metodica di scelta per la valutazione della pervietà tubarica. Controindicazioni sono: infezioni pelviche, gravidanza presunta o accertata.
Isteroscopia: è l’esplorazione endoscopica della cavità uterina; permette di individuare cause di metrorragia, di infertilità, di ricercare lesioni intracavitarie, ecc. Mediante l’isteroscopia operativa possiamo eseguire biopsie endometriali, polipecto- mie, rimuovere “lost IUD”, effettuare una sterilizzazione tubarica. Controindicazioni sono: infezioni pelviche, gravidanza presunta o accertata.
Laparoscopia: è l’esplorazione endoscopica della cavità addomino-pelvica. Nel corso di essa possono essere effettuati interventi chirurgici a livello ovarico, tubarico o peritoneale.
Vabra: aspirazione di materiale endometriale che viene in seguito sottoposto ad esame citologico, utile per la diagnosi differenziale tra metrorragie disfunzionali, iperplasie endometriali e carcinoma endometriale.
Metodiche di indagini ostetriche.
Ecografia: si esegue normalmente nel secondo e nel terzo trimestre della gravidanza. La prima si effettua a 18/20 settimane, permette di evidenziare patologie del tubo neurale, lunghezza degli arti, anomalie dell’apparato urinario, gastroenterico, cardiovascolare, respiratorio, genitale, del cranio e del collo. La seconda ecografia ci permette di stabilire la maturità del polmone fetale e della placenta.
Amniocentesi: consiste nel prelievo di liquido amniotico nel periodo intorno alla 16a settimana (amniocentesi precoce) e dopo la 25a settimana (amniocentesi tardiva),
190
allo scopo di determinare il corredo cromosomico fetale per escludere anomalie cromosomiche, il sesso per malattie recessive legate al sesso, effettuare il dosaggio di alfafeto-proteine la cui concentrazione aumenta in caso di patologie del tubo neurale i dosaggi enzimatici nelle cellule fetali per evidenziare malattie metaboliche del feto. L’amniocentesi tardiva è effettuata oggi di rado, per diagnosticare l’immunizzazione matemo-fetale.
Prelievo dei villi coriali: viene eseguito alla 9a-12a settimana e permette di determinare il corredo cromosomico, o errori congeniti del metabolismo del feto. Si possono avere falsi positivi (1-2%) o malformazioni agli arti superiori anche se all’esame dei villi il cariotipo appariva normale.
Funicolocentesi: esame invasivo eseguibile tra la 18a e 22a settimana, consiste nel prelevare, sotto guida ecografica, un campione di sangue fetale tramite puntura di uno dei vasi del cordone ombelicale. Le indicazioni sono le stesse del prelievo dei villi coriali oltre alla possibilità di diagnosticare l’avvenuta infezione fetale di virus della rosolia o da toxoplasma.
Informazioni al paziente
Per quanto riguarda la ginecologia le due pratiche più comunemente utilizzate sia come mezzo diagnostico che come mezzo operativo e terapeutico sono l’isteroscopia e la laparoscopia. La prima può essere eseguita ambulatoriamente, è incruenta e poco dolorosa se si esegue in fase preovulatoria nella donna fertile, oppure preparando il collo uterino con estrogeni locali nella donna in post-menopausa.
La seconda metodica è invasiva e deve essere praticata in ospedale e in anestesia generale o locale.
In campo ostetrico il comportamento che il medico deve tenere con le gestanti è quello di dare informazioni sulle metodiche di diagnosi prenatale illustrando le singole possibilità. L’amniocentesi è, per esempio, uno degli esami più discussi; alcuni consiglierebbero la sua esecuzione per tranquillizzare al massimo la coppia, altri sono dubbiosi anche nei casi particolarmente utili (età materna superiore ai 35 anni, precedenti patologie a carico del feto) oltre che per i rischi di abortività legati a questa indagine.
Per quanto riguarda la funicolocentesi, sia per l’alta percentuale di aborti conseguente alla tecnica (2-5%), sia per i falsi positivi prima ricordati, tale tecnica è da eseguirsi presso pochi centri specializzati e come esame di secondo livello.
191
FOTO 1
Figura 1 - Isteroscopia.
192
FOTO 2
Figura 2 - Amniocentesi.
A. Siringa per il prelievo del liquido amniotico
B. Sonda ecografica
193
21 - INFEZIONI GINECOLOGICHE
Inquadramento generale
Le infezioni ginecologiche sono patologie frequenti, spesso recidivanti e possono propagarsi ad altri organi della riproduzione fino a compromettere la fertilità della donna.
Vengono classificate in: infezioni della vulva, della vagina, della cervice e degli organi pelvici. Possono dipendere da infezioni esogene causate cioè da microrganismi esterni, o endogene dovute ai normali saprofiti del tratto inferiore dell’apparato genitale. La flora batterica vaginale è dinamica, modificandosi in dipendenza dell’età, della fase del ciclo mestruale, delle terapie farmacologiche, della gravidanza, ecc.
Dal menarca fino alla menopausa, predominano i lattobacilli, che mantengono il pH a valori di acidità. L’ambiente acido vaginale è meno favorevole all’attecchimento di microrganismi patogeni che prediligono un ambiente alcalino.
Eziologia
I microrganismi causa di vulviti, vaginiti, cerviciti, salpingiti, cistiti ed endometriti sono rappresentati, con maggior frequenza, da: Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardenella vaginalis, Chlamydia vaginalis, herpes virus tipo 1 e tipo 2, papilloma virus, gonococchi e germi piogeni (E. coli).
● Miceti: la Candida albicans è un fungo, saprofita del tubo digerente, che in condizioni favorevoli può proliferare. I sintomi legati all’infezione da Candida sono irritazione e prurito alla vulva, perdite biancastre. A volte può associarsi dolore dopo la minzione a causa del contatto dell’urina con il tessuto vulvare infiammato e/o di un concomitante interessamento delle vie urinarie. Anche il partner può lamentare prurito e manifestare papule o vescicole a livello del glande. In caso di infezioni recidivanti bisogna sempre ricordare che il serbatoio intestinale può essere fonte di infezione continua.
● Trichomonas vaginalis: protozoo ubiquitario la cui via di trasmissione principale è quella sessuale. Il quadro clinico più frequente è una vulvo-vaginite subacuta caratterizzata da perdite giallo-verdi di aspetto schiumoso; il prurito non è costante, spesso è presente dispareunia intensa. Le recidive sono frequenti.
● Chlamydia: è una delle più frequenti malattie a trasmissione sessuale; in 1/3 dei casi può interessare, anche in modo grave, la zona pelvica.
● Batteri piogeni/gonococco: la comparsa di un’infezione da piogeni è favorita da diversi fattori, quali una concomitante infezione gonococcica; quest’ultima raramente si manifesta con sintomi di flogosi vaginale e può decorrere in maniera asintomatica fino alla comparsa di sintomi riguardanti la risalita del batterio nella pelvi (salpingiti). Frequente è anche la colonizzazione delle ghiandole del Bartolini (bartolinite).
● Gardenella vaginalis: è frequentemente il responsabile di vaginiti spesso asintomatiche. L’eritema e la congestione vulvare non sono acute, la leucorrea è scarsa ma presenta un caratteristico odore sgradevole (fish odor).
194
● Virus: herpes simplex tipo 1 e tipo 2: entrambi possono provocare infezioni genitali, anche se implicato è più spesso il tipo 2. La diagnosi di vulvo-vaginite herpetica in fase acuta è semplice per la presenza delle caratteristiche vescicole; nei casi asintomatici solo l’isolamento del virus permette una corretta diagnosi.
● Papilloma virus: è oggi ritenuto uno dei più importanti virus, che causano patologie a trasmissione sessuale, per il rapporto tra infezione e sviluppo di tumori maligni al collo dell’utero. La diagnosi clinica si basa sull’individuazione delle classiche lesioni epiteliali a livello vulvo-vaginale e cervicale (condilomi acuminati, condilomi piatti).
Terapia
Il ketoconazolo, il miconazolo e la ciclopiroxolamina sono le sostanze attive più utilizzate per il trattamento delle infezioni da Candida. Il trattamento delle infezioni da T. vaginalis si avvale di antibiotici della classe dei metronidazolici (metronidazolo, ornidazolo, timidazolo) per via orale o topica, mentre quello delle infezioni da Chlamydia si avvale di tetracicline, rifampicina e macrolidi. Penicilline o doxiciclina sono impiegate nelle infezioni da piogeni/gonococchi. Nel trattamento delle infezioni da G. vaginalis si usa il metronidazolo 500 mg/die per os per 8 giorni anche per il partner.
Il trattamento delle infezioni virali da herpes simplex si avvale dell’aciclovir. Il trattamento delle forme da papilloma virus è essenzialmente fisico (diatermocoagulazione o laser CO²)
Informazioni al paziente
La diagnosi clinica di vaginite si fonda sulla presenza di sintomi soggettivi quali prurito, bruciore, perdite vaginali, oltre all’osservazione di segni oggettivi di flogosi.
È possibile, talvolta, identificare l’agente eziologico con la sola osservazione dei segni e dei sintomi; altre volte è evidenziabile solo con l’aiuto di un esame colturale.
È importante valutare attentamente patogenicità e carica batterica dell’agente eziologico. Per esempio, la presenza di una bassa carica di germi saprofiti non giustifica un accanimento terapeutico, mentre il riscontro di un solo gonococco richiede un pronto trattamento. La terapia in corso di infezioni ginecologiche deve essere sempre mirata; la via topica risulta essere quella di prima scelta per vulviti e vaginiti, a meno che l’agente patogeno responsabile non abbia la tendenza a localizzarsi in sedi extra-genitali o a propagarsi all’apparato generale interno.
È sempre importante il trattamento del partner, anche se asintomatico, per evitare contaminazioni ripetute. È necessario informare la paziente di non interrompere spontaneamente una terapia correttamente prescrittale alla scomparsa dei primi sintomi soggettivi, con conseguente mancata “sterilizzazione” del focolaio infettivo.
195
FOTO 1
Figura 1 - Vie ascendenti di infezione gonococcica.
A. Vagina
B. Utero
C. Salpingi
196
FOTO 2
Figura 2 - Prelievo endocervicale per la ricerca di clamydia.
FOTO 3
Figura 3 - Infezione della ghiandola del Bartolino (frequente complicanza nell’infezione da mycoplasma)
197
XI
SISTEMA NERVOSO
198
199
22 - DEPRESSIONE
Inquadramento generale
Il 7% della popolazione europea soffre di depressione maggiore, l’1.8 è colpito dalla forma minore (distimia) e l’8.3 presenta sintomi di depressione senza essere peraltro affetto dalla malattia conclamata. Le donne hanno una probabilità doppia di essere colpite da depressione maggiore rispetto agli uomini. Nonostante l’elevata incidenza della malattia e l’efficacia della terapia, un terzo dei pazienti depressi non viene trattato.
Eziologia
La depressione è attualmente compresa tra i disturbi dell’umore, caratterizzati da esagerazioni estreme e alterazioni della sfera affettiva cui concomitano disfunzioni cognitive e psicomotorie. Sono il risultato di interazioni fra il corredo genetico e l’ambiente. È ormai accettato il ruolo (ipoattività funzionale relativa e/o iporegolazione dei recettori postsinaptici) dei neurotrasmettitori centrali, noradrenalina, serotonina, dopamina. Le sindromi più importanti per il medico di medicina generale in questo gruppo sono la depressione maggiore (disturbo unipolare), la sindrome maniacodepressiva (disturbo bipolare), la distimia, la depressione atipica e i sintomi depressivi primitivi o secondari a patologie organiche (malattie cardiovascolari, neoplasie maligne, ecc.) e a farmaci (glucocorticoidi, alfametildopa, propranololo, benzodiazepine, reserpina, neurolettici, cimetidina, indometacina, antineoplastici). La diagnosi di un episodio depressivo maggiore si basa sui criteri (A, B, C, D) riportati dalla quarta edizione del Diagnostic and Statistical of Mental Disorders (DSM-IV).
A. Almeno cinque dei seguenti sintomi devono essere presenti contemporaneamente per due settimane, di cui uno deve essere l’umore depresso o la perdita di interesse o di piacere: 1) umore depresso o irritabile; 2) marcata e stabile diminuzione di interesse o di piacere per quasi tutte le attività; 3) significativa perdita o aumento di peso; 4) insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno; 5) agitazione o rallentamento psicomotorio, osservati dagli altri e non soggettivi; 6) affaticabilità e mancanza di energie quasi ogni giorno; 7) sentimenti di svalutazione o sensi di colpa; 8) diminuita capacità di concentrazione e di decisione; 9) ricorrenti pensieri di morte o di suicidio.
B. Un fattore organico non ha iniziato o mantenuto il disturbo, che non rappresenta una reazione normale alla morte di una persona amata.
C. Quindici giorni prima, dopo la sindrome depressiva, e durante, non si sono manifestati deliri o allucinazioni.
D. Disturbo non sovrapposto a schizofrenia, o a un disturbo delirante o psicotico.
200
Terapia
La terapia si avvale dei farmaci triciclici e di inibitori della ricaptazione della serotonina. I triciclici richiedono 10-20 giorni per ottenere il massimo effetto. I loro principali effetti collaterali sono: secchezza delle fauci, midriasi, ritardo della minzione.
Controindicazioni sono: ipertrofia prostatica, glaucoma, epilessia, gravi cardiopatie, terapia con MAO-inibitori. Sono considerati i farmaci di prima scelta per la depressione. L’efficacia dei vari prodotti è sovrapponibile. Ricordiamo l’amitriptili- na, la doxepina (se prevalgono ansia e disturbi del sonno), la clomipramina, l’imi- pramina e la nortriptilina (se prevalgono, invece, astenia e inibizione). Nei casi lievi e moderati si utilizzano gli inibitori della ricaptazione della serotonina: fluoxe- tina, sertralina, paroxetina; questi farmaci sono meglio tollerati. Nelle forme di minore gravità, in particolare nelle forme reattive e nevrotiche, si utilizzano: trazodone, mianserina, minaprina, amineptina.
Se la terapia farmacologica è inefficace può essere utile la psicoterapia, associata eventualmente alla terapia farmacologica.
Informazioni al paziente
Oltre che tranquillizzare il paziente circa la sua malattia, è ai Daziente necessario spiegare al paziente che la terapia è efficace
nell’80% dei casi. Il trattamento si avvale di farmaci, consigli di vita ed eventualmente della psicoterapia. La terapia consente al paziente di affrontare e superare la malattia. I farmaci devono essere assunti con precisione e costanza informando il paziente che potrebbero passare alcune settimane prima di ottenere beneficio. È possibile che il paziente debba provare diversi tipi di farmaci prima di sentirsi meglio. Alcuni consigli di vita adattati individualmente ad ogni paziente possono essere utili: 1) cercare situazioni che fanno sentir bene; 2) proporsi obiettivi realistici; 3) approfondire la conoscenza della depressione facendosi suggerire un buon libro sull’argomento dal medico di famiglia; 4) riflettere su quali problemi familiari possano aver aggravato la depressione; 5) cercare di tenersi attivi; 6) non allontanarsi dalle altre persone; 7) discutere con il medico, i familiari, o gli amici, di eventuali pensieri suicidi.
201
FOTO 1
Figura 1 - Le passeggiate, gli amici, lo stadio, il teatro, la musica, lo sport: abitudini di vita che "fanno star bene".
202
FOTO 2
Figura 2 - Evitare fumo, alcol, caffè e sedativi.
203
23 - CEFALEA
Inquadramento generale
Si ritiene che circa l’80-90% della popolazione adulta normale lamenti manifestazioni cefalalgiche ricorrenti; di queste, il 30-50% sono gravi o disabilitanti. L’incidenza nel sesso femminile è fino a tre volte superiore che nel sesso maschile. Le più comuni sono la cefalea muscolotensiva, l’emicrania classica, quella comune, la cefalea a grappolo.
Eziologia
Cefalea muscolo-tensiva. È il tipo più frequente. È sostenuta da una contrattura muscolare del collo e da trigger-point situati a livello dell’inserzione occipitale del trapezio e del passaggio cervico-dorsale, nonché da trigger-point secondari sullo sternocleidomastoideo e sullo splenio del capo. Il dolore è spesso continuo, quotidiano, riferito alla regione periorbitale, o alla fronte, o all’occipite. Può avere andamento ciclico. Sono fattori favorenti le scorrette posture cervicali; frequentemente, specie nell’anziano, coesiste un’artrosi unco-disco-vertebrale, ma spesso, e soprattutto nel giovane, si tratta di una somatizzazione dell’ansia che ha per bersaglio la muscolatura del collo. Si associano spesso vertigini e cenestesiopatie secondarie ad alterazione dell’informazione propriocettiva del collo.
Emicrania classica ed emicrania comune. Il momento iniziale è una vasocostrizione che, nella forma classica, è in grado di produrre ischemia encefalica con i sintomi ad essa correlati: scotomi, fotopsia, parestesie ed emiparesi fugaci, confusione e vertigini. Alla vasocostrizione fa seguito una vasodilatazione responsabile della tipica cefalea pulsante, accompagnata da nausea e vomito. Nella forma comune la vasocostrizione non è tale da provocare sintomi neurologici. L’attacco emicranico classico dura 2-6 ore, il dolore è unilaterale e alleviato dal sonno. Nell’emicrania comune il dolore è uni o bilaterale, accompagnato da nausea ma non da vomito né da disturbi visivi; può persistere per giorni, talora si associa o si sovrappone a cefalea muscolo-tensiva.
Cefalea a grappolo. Così definita per il raggruppamento di episodi in un dato ambito temporale: svariati attacchi nella stessa giornata, ripetuti per diverse settimane, seguiti da lunghi intervalli (mesi o anni). Si tratta di parossismi violenti, generalmente notturni, caratterizzati da dolore urente retrorbitario unilaterale, con lacrimazione e congestione nasale e congiuntivale unilaterale.
Altre forme di cefalea sono: cefalea da sinusite: flogosi acute dei seni paranasali che si accompagnano a dolore esacerbato dalla pressione del seno affetto; la sinusite cronica è una frequente causa di cefalea intercorrente. Cefalea da sforzo: (scatenata da tosse, sternuti, attività sportiva, coito); dovuta a modificazioni della pressione intracranica, è generalmente di breve durata; può essere intensa e tipicamente recidivante con il ripetersi dell’attività scatenante.
Una considerazione a parte merita l’arterite a cellule giganti, nota anche come
204
arterite temporale, una vasculite che colpisce le grosse arterie dell’intero organismo, specialmente le carotidi esterne e le loro branche, ed è associata in circa il 50% dei pazienti alla polimialgia reumatica. L’esordio avviene oltre il cinquantesimo anno di età. Il dolore può essere localizzato, oltre che a livello temporale, anche ad altre aree craniche superficiali. Nei casi più tipici è associato alla deglutizione, alla masticazione, ai movimenti delle braccia. Il paziente lamenta sovente calo ponderale, debolezza dei muscoli dei cingoli scapolare e pelvico, e talora va incontro a cecità a rapida insorgenza, parziale o completa, per neuropatia ischemica del nervo ottico. Il test di screening più utile è la VES, che risulta elevatissima, mentre la diagnosi di certezza è fornita dalla biopsia dell’arteria temporale.
Terapia
Oltre ai comuni analgesici, la terapia della cefalea muscolotensiva prevede l’uso delle benzodiazepine; è utile associare tecniche di elettroanalgesia, di rilassamento (training autogeno, biofeedback), blocchi anestetici locali, psicoterapia.
Nell’emicrania classica e in quella comune il dolore lieve può essere alleviato da analgesici come ibuprofene o acetoaminofene; gli attacchi severi, invece, richiedono l’uso di ergotamina tartrato associata a caffeina, ripetibile fino a 4-6 volte/die ogni 30-60 minuti. La profilassi dell’emicrania può essere tentata nei pazienti che lamentano parecchi attacchi mensili con propranololo, associazioni della belladonna con ergotamina e fenobarbital, amitriptilina, calcioantagonisti (nifedipina e verapamil). La metisergide andrà usata con cautela per il rischio di fibrosi retroperitoneale.
La terapia della cefalea a grappolo si avvale dell’ergotamina; l'ossigeno al 100% allevia il dolore nelle crisi di breve durata. Nella profilassi sono utili il prednisolone e i sali di litio. La terapia dell’arterite a cellule giganti è affidata al prednisolone, a dosi iniziali piuttosto elevate (60-80 mg/die) con successiva riduzione scalare.
Informazioni al paziente
Il massaggio del cuoio capelluto e della muscolatura del collo, eventualmente associato a metodiche di rilassamento, oltreché un colloquio informativo con il medico circa la natura benigna della condizione morbosa, sono utili nella cefalea muscolo-tensiva. Molti sono i fattori in grado di scatenare un attacco di emicrania, per esempio i farmaci, nitrati, vasodilatatori, indometacina, contraccettivi orali. In altri casi è in gioco lo stress psicologico, già in causa nella cefalea tensiva. Può essere utile eliminare l’abuso di caffè, le malattie dentali, la mancanza di riposo. In soggetti sensibili possono causare emicrania: vino e altre bevande alcoliche, cioccolato, formaggio.
205

Figura 1 - Cefalea muscolo tensiva: trigger point situati sul trapezio (A), sullo sternocleidomastoideo (B) e sullo splenio del capo (C).
206

Figura 2 - Arterite a cellule giganti: principali manifestazioni cliniche.
207
XII
METABOLISMO
208
209
24 - OBESITA'
Inquadramento generale
Si può parlare di obesità quando il peso corporeo supera del 20% il peso corporeo ideale. L’obesità causa un aumento della morbilità e mortalità principalmente per coronaropatie e vasculopatie determinate per lo più attraverso l’ipertensione arteriosa, l’iperlipemia, il diabete. Tuttavia, anche quando queste complicazioni sono assenti permane, in misura minore, un rischio legato all’obesità in quanto tale. L’obesità può essere classificata come lieve (dal 20 al 40% di sovrappeso), moderata (dal 41 al 100%), severa (> 100%). L’obesità lieve comporta rischi modesti, mentre un’obesità severa eleva il tasso di mortalità a un valore dieci volte superiore.
Eziologia
L’obesità è generalmente dovuta a errate abitudini alimentari e alla sedentarietà. Quando l’assunzione calorica supera il dispendio, le calorie in eccesso vengono immagazzinate nel tessuto adiposo e se questo bilancio calorico positivo persiste compare obesità. Influenze ambientali, culturali e genetiche contribuiscono a indurre obesità.
L’obesità secondaria può essere causata da diverse malattie. L'ipotiroidismo, riducendo il fabbisogno calorico può favorire l’obesità; tuttavia, solo una parte degli ipotiroidei manifesta obesità e solo una piccolissima percentuale di obesi presenta una ipofunzione della tiroide. L’impiego di ormoni tiroidei in modo indiscriminato è negativo, perché la riduzione di peso è soprattutto a carico della componente muscolare e gli effetti collaterali sono importanti. Il morbo di Cushing, l'insulinoma e alcuni disordini ipotalamici possono indurre in una piccolissima percentuale dei casi obesità. L’obesità ha un impatto notevole sul diabete mellito e sulle dislipi- demie attraverso una riduzione della secrezione e della sensibilità all’insulina. Inoltre, la grande obesità per stress meccanico aggrava l’osteoartrosi, le varici, le tromboembolie, le ernie addominali e iatali e la colelitiasi. Infine, l’obesità aggrava l’ipertensione arteriosa e la sindrome da ipoventilazione polmonare,
Terapia
La terapia dell’obesità deve prevedere non solo una restrizione calorica, ma anche una modificazione permanente dello stile di vita secondo un programma di attività fisica in sintonia con le possibilità e l’ambiente che circonda il paziente.
Dalla valutazione del fabbisogno giornaliero (grossolanamente 33 Kcal / kg di peso corporeo) si può individuare il deficit giornaliero necessario per raggiungere una certa riduzione ponderale, tenendo conto che, generalmente, mantenendo costante l’attività fisica, un deficit di 7700 Kcal porta a una perdita di peso corporeo di 1 kg. La diminuzione di peso settimanale deve essere compresa tra 0.5 e 1 kg. Devono
210
essere evitati trattamenti drastici come diete dimagranti a basso contenuto calorico (< 1200 Kcal), un’attività fisica troppo intensa, l’assunzione di alimenti dietetici e di farmaci, che modificando lo stile di vita in modo troppo repentino e innaturale, sono difficili da mettere in pratica e impossibili da mantenere. Dietilpropione e fenfluramina sono i farmaci anoressizzanti che inducono minor assuefazione.
Informazioni al paziente
Il medico deve informare il paziente che raggiungere e mantenere il peso desiderato sono legati a una revisione delle sue abitudini alimentari e a un programma di attività fisica.
Si devono analizzare i motivi che spingono il paziente ad affrontare un programma di dimagramento, considerando che l’obiettivo finale dovrà essere raggiunto gradualmente in modo da ottenere una modificazione permanente dello stile di vita. I consigli più utili per il paziente possono essere:
1 dividere la razione alimentare giornaliera in tre o quattro pasti; si consiglia di non saltare i pasti poiché tale pratica è controproducente;
2. la dieta deve essere equilibrata per evitare carenze di sostanze nutritive;
3. aumentare il consumo di verdura cotta e cruda;
4. il consumo di acqua naturale o gassata è libero, lo stesso vale per il caffè, il tè, la camomilla, purché non zuccherati;
5. le spezie utilizzate nella preparazione dei cibi (pepe, peperoncino, aglio, cipolla ecc.) sono completamente libere, i cibi cucinati e saporiti sono da preferire ai cibi pronti;
6. tutti i modi di cucinare i cibi sono validi; evitare però la frittura perchè i cibi assorbono l’olio;
7. consumare pesce almeno due volte alla settimana;
8. limitare a un cucchiaino la quantità di olio aggiunta come condimento;
9. evitare dolci, zucchero, bevande zuccherine; sostituire lo zucchero con dolcificanti come aspartame e saccarina;
10. mangiare lentamente, evitando durante il pasto di guardare la televisione o leggere il giornale; allontanare i piatti di portata dopo esservi serviti;
11. quando si deve acquistare del cibo preparare una lista a cui attenersi;
12. limitare le tentazioni: conservare il cibo, di cui si vuole limitare l’assunzione, lontano dalla vista;
13. aumentare l’attività fisica: utilizzare le scale al posto dell’ascensore, muoversi a piedi per i piccoli spostamenti, utilizzare i mezzi pubblici invece dell’automobile, scendere dall’autobus una fermata prima.
14. programmare l’attività fisica: camminare un’ora al giorno a passo sostenuto, fare della ginnastica, della cyclette in casa o in palestra.
211

Figura 1 - Preferire mezzi di trasporto che consentano di svolgere attività fisica.

Figura 2 - Evitare atteggiamenti sedentari e praticare un’attività fisica quotidiana.
212
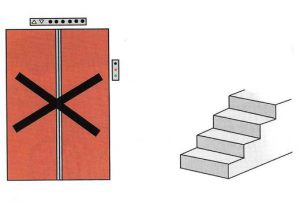
Figura 3 - Utilizzare le scale invece dell’ascensore è un modo per aumentare l’attività fisica.
213
25 - DIABETE MELLITO
Inquadramento generale
Il diabete mellito è una sindrome che risulta dall’interazione tra fattori ereditari e ambientali, caratterizzata da un’anomala secrezione di insulina, livelli ematici elevati di glucosio e complicanze d’organo come la nefropatia, la retinopatia, la neuropatia e un’accelerata aterosclerosi.
Eziologia
L’attuale classificazione comprende 5 classi:
● diabete mellito insulino-dipendente (Tipo I): si riconosce una eziologia in parte genetica, virale e immunomediata (autoimmunità diretta contro le isole pancreatiche). Ha un’insorgenza precoce con carenza assoluta di insulina, iperglicemia elevata e chetoacidosi;
● diabete mellito non insulino-dipendente (Tipo II): l’eziologia è sconosciuta. Insorge nell’adulto, presenta una carenza relativa di insulina, non chetoacidosi;
● diabete secondario a patologie pancreatiche (carcinoma, pancreatite cronica, asportazione chirurgica), endocrine (sindrome di Cushing, feocromocitoma, acromegalia, iperaldosteronismo), somministrazione di farmaci;
● diabete gestazionale che compare solo in gravidanza;
● diabete da alterata tolleranza ai carboidrati la glicemia a digiuno è nella norma, ma la curva da carico di glucosio è alterata. Evolve verso il diabete conclamato se non si eliminano eventuali concause, quali obesità, dislipidemie, ipertensione, stress.
Il primo segno dell’iperglicemia è la poliuria, per l’effetto diuretico osmotico del glucosio. Iperglicemia e glicosuria protratte causano sete, fame e perdita di peso. La microangiopatia causa insufficienza renale se sono interessati i capillari glomerulari, o alterazioni della vista se sono interessati i capillari retinici. Inoltre, circa il 30% dei diabetici ha probabilità di sviluppare vasculopatie periferiche, con gravi complicanze quali amputazioni dei piedi. Per l’aumentata incidenza e la precoce comparsa di aterosclerosi, il rischio di morte per cause cardiovascolari è 3,5 volte superiore alla norma. La forma più frequente di neuropatia diabetica è la polineuropatia distale bilaterale, con ridotta sensibilità dei piedi e ulcere plantari penetranti senza dolore. Nella polineuropatia diabetica si verificano diarrea acquosa intermittente, disturbi della sudorazione, ipotensione posturale e negli uomini impotenza sessuale.
La diagnosi si basa sulla determinazione di: glicemia basale e nell’arco della giornata (profilo glicemico); glicosuria, eseguita a digiuno, che esprime la presenza di iperglicemia nelle ore che hanno preceduto la minzione; emoglobina glicosilata, che permette la valutazione della glicemia media di un periodo di 2-3 mesi; carico orale di glucosio (OGTT), effettuato di solito solo nel sospetto di diabete mellito in gravidanza, in presenza di neuropatia o vasculopatia periferica.
214
Terapia
Si basa su tre approcci fondamentali:
dieta: va stabilito il livello energetico ottimale, in considerazione dell’età del paziente, peso corporeo, attività fisica abituale. Qualitativamente la dieta deve essere “quasi normale” con un 55-60% di carboidrati, 30% di lipidi, 10-15 % di protidi.
Ipoglicemizzanti orali: sulfaniluree, biguanidi e associazioni dei due tipi di farmaci sono riservati ai pazienti con diabete di tipo II.
Terapia insulinica: indispensabile in tutti i pazienti con diabete insulino-dipendente, nel coma chetoacidosico o quando viene meno la risposta agli ipoglicemizzanti orali.
Informazioni al paziente
Il diabete va diagnosticato e curato precocemente per evitare gravi complicanze. Il medico, una volta riconosciuti i soggetti a rischio (familiarità positiva, presenza di sintomi indicativi, obesità), può fare diagnosi solo con esami ematologici. Più difficile è la terapia alla cui base sta la dieta; il medico deve preparare uno schema con i cibi concessi e quelli da evitare. In linea generale è preferibile utilizzare diete ricche di fibre vegetali idrosolubili (fave, fagioli, ceci, piselli, mele, pere, carote, fagiolini, cavoli, verza). Come dolcificanti è da preferirsi l’aspartame che è acalorico; è opportuno moderare il consumo di uova e formaggi e utilizzare come condimento solo olio di oliva. Quando la dieta e l’esercizio fisico non sono sufficienti si associa la terapia farmacologica orale. La terapia insulinica viene, invece, impostata solo nei casi già citati utilizzando i vari tipi di insulina disponibili (ad azione lenta, rapida o intermedia) in modo da riprodurre la situazione fisiologica. Importante in questi casi è il monitoraggio glicemico, effettuato anche dal paziente stesso a casa, attraverso apposite strisce (stick) su cui si versa una goccia di sangue e un lettore che evidenzia la glicemia nell’arco della giornata. Recente è l’utilizzo dell’apparecchio infusore, costituito da un serbatoio a siringa che instilla piccole quantità di insulina ad intervalli di tempo variabili fra 1’ e 30’ nelle 24 ore. È più sicuro in quanto determina una curva glicemica fisiologica, e permette una normale conduzione di vita.
215

Figura 1 - Siringa per insulina.

Figura 2 - Come praticare l’iniezione di insulina.
216
|
Verdure, ortaggi e legumi Frutta Carni, pollame, selvaggina Pesce Carne e pesci conservati, salumi ed insaccati Uova Latte e derivati Formaggi Pane, pasta, riso e altri prodotti da forno Condimenti e varie Bevande Dolcificanti
|
fresche o surgelate o conservate in scatola al naturale. Legumi (piselli, ceci, fave, lenticchie, fagioli) fresca o conservata in scatola al naturale vitello, manzo, cavallo, pollo, tacchino, coniglio, agnello, maiale, selvaggina scelta nelle parti più magre e accuratamente private del grasso visibile. fresco o surgelato carne in scatola in gelatina, tonno al naturale. Prosciutto crudo o cotto sgrassato, bresaola in quantità non superiori a due la settimana, cucinate a piacere tranne che preparate con burro e panna latte magro o parzialmente scremato, yogurt magro fiocchi di latte magro, ricotta, mozzarella, tornino, crescenza, quartirolo, robiola bianco o integrale nelle quantità previste dallo schema dietetico. Il pane può essere sostituito da pasta o riso nella seguente misura: g 50 di pane = g 40 di pasta o riso = g 180 di patate olio di oliva o di semi di mais, girasole, soja, vinacciolo; brodo sgrassato, gelatina di carne. Sale in modeste quantità, aceto, succo di limone, erbe aromatiche (basilico, origano, ecc.), verdure per condimenti (aglio, cipolla, ecc.), sottaceti, spezie té, caffè, camomilla ed altri infusi (non zuccherati), acqua minerale o naturale; spremute di frutta (solo in sostituzione della frutta). Vino e birra dietro prescrizione medica aspartame, saccarina
|
217
Inquadramento generale
Le malattie cardiovascolari rappresentano la più frequente causa di morte e di invalidità in Italia. Numerosi sono i fattori che aumentano il rischio cardiovascolare: il fumo, l’ipertensione arteriosa, il diabete, il sovrappeso, l’ipercolesterolemia. I dati epidemiologici dimostrano che il rischio cardiovascolare si riduce con il diminuire dei livelli plasmatici di colesterolo totale e del rapporto LDL/HDL colesterolo, tuttavia non è possibile stabilire un livello soglia unico di protezione o di rischio. La riduzione dei livelli di colesterolo totale diminuisce il rischio cardiovascolare in modo proporzionato all’età: ridurre il livello plasmatico del 10% riduce il rischio cardiovascolare del 50% a 40 anni e del 20% a 70 anni.
Eziologia
Le iperlipidemie sono disturbi del trasporto lipidico che derivano da una accelerata sintesi o da una ritardata degradazione delle lipoproteine vettrici. Si dividono in forme primarie e in forme secondarie.
Iperlipidemie primarie. L’Ipercolesterolemia poligenica: forma più comune di dislipidemia, i valori di colesterolo non sono in genere superiori a 300 mg/dl. È dovuta all’interazione tra fattori genetici e abitudini di vita non corrette. Ipercolesterolemia familiare: disordine su base genetica da deficit del recettore, con una prevalenza di 1 a 500 per gli eterozigoti e 1 a 1.000.000 per gli omozigoti. Nei pazienti eterozigoti i valori di colesterolo variano da 300 a 500 mg/dl e sono presenti xantomatosi tendinea, e/o ipercolesterolemia in un parente di I grado, e/o storia familiare di cardiopatia ischemica (C.I.) o vasculopatia periferica. Altri tipi di ipercolesterolemia familiare sono: la Iper-apo-B lipoproteinemia (di recente individuazione in cui il difetto genetico è nella mutazione dell’apolipoproteina e non nel recettore), l’ipercolesterolemia congenita e le forme combinate. Queste sono caratterizzate da ipercolesterolemia (colesterolo totale tra 300 e 500 mg di) e/o C.I. o vasculopatia periferica in un parente di primo grado, livelli elevati di apo-B-lipoproteine, presenza di almeno un allele e4 dell’apolipoproteina E. Iperlipidemia familiare: si distingue una forma semplice (trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e una forma multifenotipica con trigliceridi > 200 mg/dl, e colesterolo HDL >175 mg/dl. Ipo-alfa-lipoproteinemia familiare: colesterolo HDL < 35 mg/dl. Tutte queste tre forme devono presentare xantomatosi eruttiva, iperlipemia e/o cardiopatia ischemica o vasculopatia periferica in un parente di primo grado.
Iperlipidemie secondarie. Compaiono in corso di diabete mellito, eccessiva assunzione di etanolo, obesità; l’assunzione di diuretici tiazidici e betabloccanti può innalzare i valori plasmatici dei trigliceridi o aggravare una preesistente ipertrigliceridemia; l’ipotiroidismo, la malattia di Cushing, la colestasi, la sindrome nefrosi- ca, i contraccettivi orali possono elevare le concentrazioni piasmatiche di colesterolo
218
e dei trigliceridi o aggravare una dislipidemia preesistente.
Terapia
Studi clinici controllati sono favorevoli all’impiego di terapie ipocolesterolemizzanti nelle forme primarie e familiari, ma non sono conclusivi per le altre forme. La terapia deve basarsi su un intervento globale sui fattori di rischio cardiovascolare: il fumo, il sovrappeso, la sedentarietà. In molti casi l’iperlipidemia si normalizza con una dieta adeguata. È bene aumentare il consumo di carboidrati complessi, frutta, verdura, olio di oliva. Nelle iperlipidemie primarie e familiari caratterizzate dalla sola ipercolesterolemia si utilizzano le statine, le resine, l'acido nicotinico. Quando si associa un’ipertrigliceridemia, se i valori sono < 400 mg/dl i farmaci utilizzati sono le statine e le resine, se i valori dei trigliceridi sono > 400 mg/dl si utilizza una terapia combinata (acido nicotinico, fibrati, statine). Una terapia di associazione si può impiegare tutte le volte che la monoterapia non è sufficiente. Se il colesterolo HDL è < 35 mg/dl, si raccomandano il controllo del peso, l’effettuazione di un’adeguata attività fisica, la cessazione del fumo.
Informazioni al paziente
Il primo obiettivo di riduzione del rischio cardiovascolare è al paziente l’abolizione del fumo. La terapia sostitutiva con nicotina può essere utile. La dieta è alla base del trattamento di ogni forma di dislipidemia e va proseguita per almeno 6-12 mesi prima di iniziare una terapia farmacologica. Una dieta appropriata prevede l’assunzione di non più di 200 mg al giorno di colesterolo, i grassi non devono rappresentare più del 30% delle calorie complessive, i grassi saturi non devono superare il 7%. Una dieta adeguata può ridurre il colesterolo di 50 mg e normalizzare i trigliceridi. In caso di ipertrigliceridemia vanno ridotti gli alcolici. L’attività fisica è estremamente utile: consente non solo di bruciare calorie e mantenere un corretto peso corporeo, ma anche di diminuire il colesterolo LDL e i trigliceridi, aumentando il colesterolo HDL. È bene incoraggiare un minimo di 30-60 minuti di attività moderata 3-4 volte alla settimana (camminare, andare in bicicletta, ecc.), aumentare le attività quotidiane (fare le scale a piedi, utilizzare il meno possibile l’automobile) dopo aver valutato il rischio nei pazienti cardiopatici con un test da sforzo. Dieta e attività fisica devono essere rigorose se il peso corporeo supera del 30% il peso ideale rapportato all’altezza. È infine indispensabile il controllo dei valori pressori e della glicemia.
219
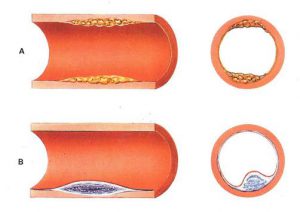
Figura 1 - Fasi iniziali (strie lipidiche, A) e avanzate (placca fibro-calcifica, B) del processo aterosclerotico.
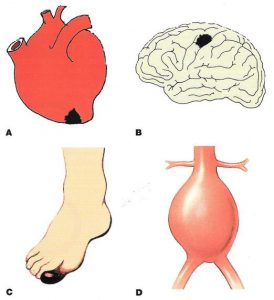
Figura 2 - Complicanze d’organo imputabili alla dislipidemia.
A. Infarto miocardico
B. Ischemia cerebrale
C. Vasculopatia periferica
D. Aneurisma dei grossi vasi