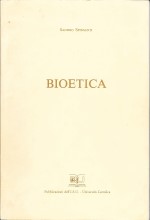
- Documenti di deontologia e etica medica
- Bioetica
- Bioetica in sanità
- Etico bio-medica
- Etica medica
- Le ragioni della bioetica
- Fondamenti di bioetica
- L'etica per una medicina umana
- La quotidiana fatica di essere razionali in medicina
- Le stagioni dell'etica in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Die Medizinische anthropologie
- Verso una medicina della persona
- Bioetica global o la sabiduria para sobrevivir
- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche
- De la nature et de la personne en bioéthique
- Il valore della complessità e la metodologia clinica
- Quale etica per l'ebm?
- Cattivi pensieri sugli errori in medicina
- Il medico: servo di tre padroni?
- Il medico servo di tre padroni
- Ethical foundations for a culture of safety
- Etica e malattie rare
- Interessi plurali, interessi in conflitto nella pratica clinica
- Conflitto di interessi
- Commento a "Problemi etici nel trapianto renale da vivente"
- La bioetica: una via per la crescita della coscienza
- L'incertezza medica incontra la bioetica
- Il giudizio morale è fuori dall'emotività
- Legge, deontologia ed etica
- Implicazioni etiche dell'obiezione di coscienza nella professione medica
- La boxe: un problema di etica medica?
- L'etica in medicina
- Cancro e persona umana: considerazioni etiche
- Tecnologie riproduttive ed educazione al giudizio etico
- La professione del medico in un contesto nuovo
- Istruzioni per boicottare la bioetica
- L'etica nella vita del medico
- Quale etica per la medicina?
- Bioetica: problematiche emergenti e prospettive
- L'etica all'ombra del «tao»
- Obtaining Consent from the Family: A Horizon for Clinical Ethics
- La bioetica clinica
- Le regole del gioco
- Verso la medicina delle scelte
- La qualità nel Servizio Sanitario
- Domande a Sandro Spinsanti
- Bioetica clinica per operatori sanitari
- Etica e terapia
- La decisione in medicina come problema etico
- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche
- Scienza e coscienza come responsabilità morale
- Troppe domande ancora senza risposta
- Un diritto gentile
Sandro Spinsanti
BIOETICA
Pubblicazioni dell'ISU - Università Cattolica, Milano 1985
pp. 231
5
SALUTE E CULTURA, OGGI
La salute è diventata uno dei nodi cruciali della cultura contemporanea. Le polemiche scatenate dal varo della riforma sanitaria e dalla sua difficile attuazione (scioperi dei medici, disagi degli utenti dei servizi sanitari, degrado e burocratizzazione dell’assistenza) hanno contribuito a portare in primo piano nell’opinione pubblica i problemi organizzativi della sanità. Ma soprattutto matura lentamente la convinzione che al di sopra delle questioni di politica sanitaria campeggi il problema della salute dell’uomo, e che questo sia essenzialmente un problema di civiltà. Come suggerivano di recente i vescovi francesi in un documento dedicato al mondo della sanità, si sta operando insensibilmente uno slittamento tra due tipi di civiltà: mentre il XIX sec. metteva in risalto soprattutto il diritto al lavoro, il nostro tempo insiste sul diritto alla felicità. È uno spostamento di prospettiva che incide non solo sui problemi della salute, ma sulla concezione stessa dell’uomo.
Il problema della salute, al centro dell'opinione pubblica e delle preoccupazioni personali, sta diventando una discriminante culturale e politica. Su di esso si manifestano in tutta la loro diversità le concezioni antropologiche che sottendono la convivenza civile. Ciò crea tensioni, che fanno del mondo sanitario un luogo di vivaci conflitti. Ne osserviamo anzitutto in sede di programmazione economica. Le spese per la salute pongono all’economia politica di tutti i paesi ad alto sviluppo industriale problemi ardui. Aumentano ovunque in modo esponenziale, secondo una progressione geometrica, qualunque sia il sistema dei servizi adottato 1. I responsabili
6
della politica economica si trovano di fronte al dilemma di conciliare la qualità del servizio con la sua efficacia ed economicità. La difficoltà del problema è costituita dal fatto che l’economia politica applicata alla salute deve tener conto di numerose variabili che trascendono l’ambito tecnico di questa disciplina. La salute e la malattia sono infatti realtà sociali che riflettono ogni minima variazione culturale, ivi compresi i cambiamenti che avvengono nella scala dei valori. Una politica della salute conduce inevitabilmente a delle scelte, determinate dagli orientamenti prioritari verso certe classi di età, verso determinate patologie o finalità sociali.
Mai, in ogni caso, una tale politica potrà lasciarsi guidare esclusivamente da considerazioni del tipo costi/benefici, perché la vita umana non è un bene omogeneo agli altri beni. Anche l’economia politica, quando deve decidere degli investimenti da fare, non può sottrarsi ad interrogativi di tipo etico. Questo è il motivo per cui in campo sanitario si scontrano così violentemente le ideologie. Il dibattito diventa più acceso quando si toccano temi come l’aborto o la pianificazione delle nascite o la cura dei tossicodipendenti, ma praticamente sottende qualsiasi decisione nel campo della salute. Qui vengono infatti a collisione i diversi progetti che si hanno sull’uomo, sul suo divenire e la sua felicità, nonché le diverse concezioni della società. I partiti politici sono aggressivamente presenti in questo settore: non possono infatti dimenticare che nella sanità pubblica l’aspetto organizzativo ha un’importanza capitale. Spesso coesistono interessi contrari: il liberalismo, sostenuto dal corpo medico, si scontra col centralismo tecnocratico, rappresentato daH’amministrazione, e con i progetti decentrati e partecipativi, promossi dai movimenti ad ispirazione socialista. Da quest’ultima area vengono anche le spinte più decisive verso il rifiuto della condizione di “assistito”, tradizionalmente riservato al malato.
7
Coadiuvata dal processo psicologico di regressione che accompagna spesso l’installarsi della malattia, la condizione del malato è quella di colui che riceve. La dipendenza totale da chi gli presta le cure lo espone a molti arbitrii. Per difendere il malato e conferirgli un ruolo attivo, si parla ora dei suoi “diritti”; si cerca di diffondere informazione, affinché il malato non si rassegni, delegando in tutto il medico 2. La convinzione che la salute sia un prodotto industriale come un altro, il cui aumento dipende dal volume degli stanziamenti che si fanno nel settore, porta con sé anche l’attesa che il gruppo professionale che si occupa della salute gestisca in toto il settore. Un’educazione sanitaria accurata dovrebbe contrastare tale tendenza, permettendo all’individuo di affrontare da protagonista tutto quello che gli capita nel campo della salute. Questa è non solo un diritto da rivendicare alla società, ma anche un “dovere” che domanda un impegno positivo; una “virtù”, come la chiama I. Illich. La salute non si può ricevere, bisogna “farla”.
I conflitti cui abbiamo accennato sono i più macroscopici. Al di sotto, uno sguardo accurato scopre che le questioni della salute confrontano l’uomo non solo con scelte sociali, politiche e ideologiche diverse, ma con il problema maggiore dell’umanesimo nella sua totalità: il rapporto che l’uomo ha con il suo corpo. I vescovi francesi nel documento “Il mondo della sanità e la chiesa” esprimono il problema di fondo in questi termini: “Se gli ‘utenti’ e i ‘professionisti’ vogliono veramente fare opera durevole, devono porsi contemporaneamente di fronte ai poli importanti dell’esistenza umana: le profondità psicologiche della sessualità e la precarietà di cui la morte è il momento essenziale. Nonostante siano sempre vissuti in una dimensione politica ed economica, questi due poli non si lasciano rinchiudere in queste dimensioni. In questo caso non si può barare, si è obbligati a prendere posizione di fronte a se stessi, si è portati ad accettare la propria condizione umana o fuggire in mille modi. Il processo interiore è identico, anche se ognuno lo vive secondo il proprio livello intellettuale. Ciò si spiega perché nel medesimo slancio curanti e utenti sono portati a porsi di fronte a un aspetto fondamentale del mistero
8
dell’uomo: la precarietà dell’uomo e della società. Il mondo della salute nasce forse da questa tensione tra una organizzazione che tende a soddisfare i bisogni dell’uomo, così come altre funzioni collettive, e un’aspirazione fondamentale a vivere, sopravvivere o vivere meglio. È forse questo il luogo dell’esperienza umana fondamentale, e tutto ciò che in esso si vive ne è immediatamente impegnato o la rimette direttamente in causa. E ciò, ben lungi dal chiudersi su un piccolo mondo, apre su un universo e crea un nuova mentalità”.
Lo stadio attuale di civiltà industriale avanzata in cui ci troviamo ci pone di fronte al corpo, come luogo della esperienza esistenziale più pregnante, in modo diverso rispetto al passato. Abbiamo superato, forse definitivamente, il dualismo tradizionale che contrapponeva l’anima al corpo. In polemica con lo spiritualismo dualista — il corpo come pura materialità e l’anima come principio spirituale — il pensiero moderno ha ritrovato l’unità dell’uomo reale. La corporeità, vista come momento essenziale del soggetto, è la mediazione che rende il soggetto spirituale presente al mondo oggettivo e alla soggettività delle altre persone umane. Tuttavia oggi la nostra presenza del mondo tramite il corpo è legata a varie forme di disagio. Si diffonde la convinzione che a un rapporto sbagliato con la natura, oggetto del vivace dibattito ecologico, si accompagni la perversione del rapporto con la concreta struttura biologica del nostro corpo.
La perdita dell'armonia corporea è una delle malattie più gravi della civiltà. Abbiamo disimparato il linguaggio delle funzioni vegetative. Il corpo sembra aver perso la sua trasparenza: ci è diventato estraneo, quasi nemico. L’alienazione ha assunto un aspetto biologico ben definito, che passa attraverso il rapporto che abbiamo col nostro corpo. “Riappropriazione del corpo” è diventato lo slogan di diversi movimenti culturali, che propugnano un salto nella qualità della vita. Riappropriarsi del corpo è il presupposto per vivere da protagonisti l’avventura della salute.
Come si situano i cristiani in questa questione cruciale per la nostra civiltà? Alla concezione materialistica dell’uomo che si diffonde nel mondo della sanità i cristiani non hanno da opporre uno spiritualismo esasperato, bensì la visione dell’uomo “totale” che deriva dalla storia della salvezza. L’attività terapeutica di Gesù resta il luogo privilegiato di questa riflessione. Il contributo antropologico che può offrire la teologia cristiana si articola essenzialmente sul concetto stesso di salute, alla luce dell’esperienza creaturale e di quella salvifica, e sull’apporto della fede e della comunità fraterna al processo della guarigione.
9
Parte Prima
LA NORMATIVA ETICA IN CAMPO BIO-MEDICO
10
11
Capitolo Primo
L’ETHOS IPPOCRATICO
1. Il giuramento di Ippocrate nel contesto storico
Quanti hanno una conoscenza precisa di ciò che è contenuto nel giuramento di Ippocrate? Eppure non c’è persona mediamente informata che ne ignori l’esistenza, che non lo sappia indicare come uno dei documenti che costituiscono il nucleo essenziale del patrimonio spirituale dell’Occidente. Sono poche righe, estremamente concise, specchio di una prassi medica segnata dal tempo. Tuttavia hanno attraversato i secoli, sempre continuamente citate come portatrici di un ideale che trascende il proprio tempo e la propria cultura. Il giuramento ha contribuito in modo determinante a far diventare Ippocrate un eroe culturale in tradizioni tutt’altro che inclini all’ecumenismo: cristiani ed ebrei, musulmani e illuministi gli hanno unanimemente tributato un rispetto che confina con la venerazione. Giuramento ippocratico ed etica medica sono diventati due concetti correlati, un binomio inscindibile. Tuttavia, quante ombre dietro questa apparente luminosità!
La realtà storica del giuramento è probabilmente molto diversa da quella immaginaria che ha permesso nei secoli di renderlo simbolo delle più alte idealità che possono ispirare il medico nella sua professione. Presentando una moderna edizione del giuramento, il curatore faceva un bilancio della situazione dal punto di vista storiografico: “qual è la data del giuramento? è mutilato o interpolato? chi faceva il giuramento: tutti i medici e solo gli appartenenti a una corporazione? quale forza obbligante c’è dietro la sua sanzione morale? era una realtà o un semplice ‘consiglio di perfezione’? L’onesto ricercatore deve dire di non saperne
12
nulla” 3. In seguito studi storici di grande valore hanno portato un po’ di luce su alcuni di questi interrogativi. I risultati della ricerca storica mettono in crisi molti luoghi comuni circa l’origine, il significato e l’utilizzazione del giuramento.
Passiamo brevemente in rassegna le principali acquisizioni, dovute principalmente agli studi di Edelstein e Sigerist 4. Sono problemi che non interessano solo gli eruditi, ma tutti coloro che si interrogano sul rapporto tra etica e medicina. Rituffandoci nelle origini, nel momento in cui per la prima volta la cultura occidentale ha intuito il legame e ha cercato di formularlo, ritroviamo lo stato germinale di ciò che si configurerà come “ethos” medico.
È opportuno, in primo luogo, considerare il contenuto e la struttura del giuramento. Dopo l’invocazione degli dei, — Apollo, Esculapio, Igea e Panacea — la prima parte è dedicata ai doveri verso la famiglia del maestro. Colui che giura si impegna a condividere i propri beni col maestro e a considerare i suoi figli come propri. La seconda parte è il vero e proprio codice etico, che enumera i doveri che il medico si assume verso i pazienti. È costruito in modo simmetrico. Al centro troviamo la sola affermazione positiva di tutto il giuramento: “conserverò casta e pura da ogni delitto sia la mia vita che la mia arte”. È preceduta da tre proibizioni: non recare danno o ingiustizia al malato, non somministrare a nessuno medicine letali, non provocare rimedi abortivi alle donne. La clausola di purità è seguita da tre altre proibizioni: non praticare la chirurgia, non avere rapporti sessuali con nessun membro della famiglia del paziente, non divulgare segreti uditi nell’esercizio della professione. L’ultimo paragrafo, infine, indica che la ricompensa per l’osservanza del giuramento sarà la fama e la buona reputazione, il disonore invece colpirà lo spergiuro.
13
La nobiltà dei propositi giurati non paralizza il senso critico dello storico. Per il quale le clausole del giuramento presentano dissonanze vistose con quanto egli conosce circa la pratica della medicina nella Grecia classica. L’enigma più evidente è quello dell’esercizio della chirurgia. Sappiamo con certezza che il medico ippocratico era anche chirurgo. Anzi, gli scritti chirurgici sono tra i migliori del Corpus Hippocraticum, e sono spesso attribuiti al maestro stesso. Un problema presenta anche la clausola dell’aborto: come conciliare questa proibizione con il fatto accertato che l’aborto era generalmente praticato in Grecia, non solo dalle levatrici ma anche da medici ippocratici, che era accettato dalla società e perfino raccomandato dai maggiori filosofi, come Platone? Anche per quanto riguarda l’eutanasia la clausola del giuramento è in contrasto con quanto sappiamo della civiltà greco romana. Il suicidio, soprattutto per influenza dello Stoicismo, era generalmente accettato; conosciamo molti casi in cui il veleno è stato somministrato da medici.
Queste contraddizioni patenti rendono impossibile allo storico sottoscrivere l’immagine del giuramento come strumento, già in uso al tempo di Ippocrate, per inculcare al medico un’etica particolare, impregnata di idealismo o di filantropia, che lo impegna per il fatto stesso di abbracciare la professione medica. I discorsi convenzionali che si fanno sul giuramento ippocratico come simbolo di un ethos perenne, soggiacente a tutte le trasformazioni morali ed etiche, al quale il corpo medico si sarebbe sempre attenuto fin dagli albori della civiltà greca 5, non hanno un riscontro storico. Già in una prima ricognizione di quanto è storicamente appurato Jones escludeva che il testo trasmessoci dalla tradizione possa essere considerato come un giuramento da deporre obbligatoriamente per essere ammessi nella corporazione dei medici asclepiadi 6. La prima parte del giuramento, sotto forma di un accordo contrattuale, lega l’aspirante medico al maestro e alla sua famiglia, non a una corporazione. Se non si tratta, dunque, di un giuramento corporativo, qual è
14
sua natura? Le ipotesi formulate da Jones, e confermate poi dagli studi successivi, partono dalle informazioni storicamente attendibili che possediamo sull’età classica. Sappiamo da Platone (cfr. Protagora 311 B) che i medici insegnavano la medicina ai loro figli, e che Ippocrate insegnava ad altri discepoli dietro compenso. Siamo inoltre informati che nel periodo migliore della medicina greca c’erano delle scuole esclusive che restringevano il loro insegnamento ai membri di un clan (genos) e ad esterni, che venivano in qualche modo adottati. È probabile che questi membri adottati facessero un giuramento e firmassero un contratto legale. Gli studenti apprendisti venivano in qualche modo assunti nella famiglia e assumevano diritti e doveri dei membri della famiglia. Il giuramento, accordo privato tra il maestro e l’apprendista, definiva le relazioni tra quest’ultimo e la società in cui entrava, nonché le regole di condotta a cui quella società si attendeva che egli si conformasse. Nel corso del tempo può essersi evoluto un formulario, non proprio stereotipato e universale, ma con omissioni, alterazioni o addizioni, per adattarsi al periodo, alla scuola o al luogo. Nello schema, oltre alle promesse fatte al maestro, erano incorporate le clausole che avevano come oggetto la probità e l’onore medico. Questa l’ipotetica evoluzione del giuramento, la sua funzione e il suo contenuto originari.
Tuttavia il giuramento che la tradizione ci ha consegnato attribuendolo a Ippocrate non può essere identificato con il giuramento ipoteticamente in uso nelle scuole ippocratiche del V e IV sec. a.C. Le clausole etiche che definiscono il rapporto del medico col malato, infatti, sono inconciliabili con ciò che conosciamo della pratica medica nel mondo classico. Sigerist è perentorio: “La spiegazione di tutte queste contraddizioni è semplicemente che il giuramento ebbe origine in un ambiente che era totalmente differente da quello di Cos o di Cnido: cioè in un ambiente filosofico, tra i Pitagorici” 7. Egli fonda la sua opinione sugli studi più conclusivi sull’argomento, che sono quelli condotti da Edelstein. A differenza di chi considera il giuramento come un messaggio di validità universale, unanimamente accettato nell’ambito della grande medicina greca dell’epoca classica, Edelstein lo fa risalire a un gruppo che rappresentava un piccolo segmento dell’opinione greca. Gli scritti medici, dall’epoca di Ippocrate a quella di Gallieno, dimostrano la violazione sistematica e costante di quasi tutte le ingiunzioni del giuramento. Soltanto
15
verso la fine dell’epoca classica avvenne un profondo cambiamento, le cui radici affondano nella filosofia pitagorica, che cominciò a definirsi verso la fine del IV sec. a.C. La filosofia pitagorica includeva ideali di giustizia, fortezza, purezza e santità, e di rispetto della vita. Al greco medio non possiamo attribuire un rispetto della vita come valore. Basti pensare all’esposizione di bambini deboli o deformi, pratica diffusa non solo a Sparta, ma anche ad Atene. C’erano tuttavia gruppi religiosi nella società greca, specialmente orfici e pitagorici, i quali, forse sotto influenza indiana, nutrivano un profondo rispetto per la vita. Nel loro ambito ci si ispirava a una moralità più stretta rispetto all’etica platonica e aristotelica, o alla pratica medica comune. Il giuramento ippocratico è storicamente attendibile solo se lo consideriamo come un prodotto dell’etica pitagorica, applicata alla medicina. Il suicidio e l’aborto erano condannati dai pitagorici; di conseguenza, fu considerato non etico per il medico prestare la propria mano per azioni che conducevano alla distruzione della vita. La chirurgia fu separata dalla medicina generica. Il medico che si ispirava alla nuova filosofia poteva cosi lasciare al chirurgo lo spargimento del sangue e il rischio che il paziente morisse sotto il bisturi. In tale ambiente il giuramento cominciò a diventare popolare. I medici pitagorici potrebbero averlo redatto come un programma di riforme, e forse anche come protesta contro le pratiche correnti. In seguito fu considerato opera del grande Ippocrate, cosi come gli furono ascritte le opere mediche della biblioteca di Alessandria, ricorrendo a un processo di accreditamento comune nell’antichità. Il suo studio divenne parte del curriculum medico, idealmente la prima opera con cui lo studente di medicina si familiarizzava. I commentatori supposero che il maestro avesse scritto il giuramento come primo dei suoi libri e imposero al principiante di leggere questo trattato per primo 8.
La scuola pitagorica fece il ponte tra il paganesimo e il cristianesimo, il quale doveva cambiare i fondamenti della civiltà antica. Il cristianesimo si trovò in accordo con i principi pitagorici relativi alla vita e alla medicina. E proprio alla sua consonanza con il cristianesimo il giuramento ippocratico deve il successo che lo fece diventare il nucleo di tutta l’etica medica. Appena menzionato in epoca precristiana, godette invece di popolarità una volta entrato nell’area culturale cristiana. I padri della chiesa abbondarono nelle lodi di Ippocrate e della sua regolazione pratica della medicina 9; in seguito
16
Ippocrate fu egli stesso considerato come un “padre della chiesa” dai medici, e la sua autorità mai rimessa in discussione. L’ideale etico che traspare dal giuramento fu proiettato sugli altri scritti, e in genere su tutta la medicina dell’antichità. Emergeva cosi la figura del medico come “filantropo”, che si impegnava con un giuramento di dedicarsi al servizio dei malati. Ma la finalità del giuramento medico era realmente la “filantropia”? Ulteriori precisazioni vengono dalle ricerche storiche recenti. Alcune indicazioni possono essere ricavate dall’analisi sia del contenuto che della struttura del documento. Le clausole tengono a stabilire non quello che il medico dovrebbe fare per essere un buon medico, ma le azioni dalle quali astenersi. Il fine è quello messo in rilievo dall’unica clausola positiva, posta architettonicamente al centro della seconda parte: conservare la vita pura per accrescere la propria “reputazione” (doxa). Sigerist ha particolarmente insistito su questa finalità del giuramento e dell’etica medica greca 10. Il medico era costretto ad occuparsi della propria reputazione, e ciò in forza delle condizioni della pratica medica dell’antichità. Il medico era, in pratica, un artigiano; esercitava la sua “arte” (techne) come gli altri artigiani, passando da un luogo all’altro. La buona reputazione e la fama che lo precedevano erano condizioni indispensabili per l’affermazione professionale 11. Non esistendo nessuna licenza per praticare la medicina concessa dallo stato o da altra organizzazione, la reputazione era la sola credenziale che il medico possedesse. L’acquistava con l’apprendimento, l’abilità, la coscienziosità, la corretta prognosi, e in generale conducendo una vita onesta. Il giuramento si colora cosi di una luce utilitaristica. Comprendiamo quindi perché, ai fini della reputazione, il medico si allineasse mediante il giuramento con le posizioni etiche più rigide, come quelle diffuse dai pitagorici, che richiedevano dal medico più di quanto gli imponevano la morale e la pratica corrente. Queste precisazioni storiche fanno forse scendere il medico che nell’antichità usava il giuramento ippocratico dal piedistallo del semidio filantropico, ma gli conferiscono anche, a suo vantaggio, uno spessore di umanità che lo rende più credibile. Anche attraverso la porta della ricerca della reputazione — non certo l’ideale più sublime che possiamo concepire dal punto di vista etico — entrava nella medicina il principio
17
che la medicina è un’arte in cui la conoscenza è inseparabile dalla moralità. Cominciava cosi a delinearsi la figura del medico come vir bonus sanandi peritus.
Le conoscenze storiche acquisite ci mettono in grado di tracciare un quadro meno aprioristico dell’evoluzione dell’ethos medico nel mondo greco-romano, e del ruolo che vi ha svolto il giuramento ippocratico 12. Non c’è dubbio che il mondo classico sia arrivato a formulare l’ideale che deve ispirare il medico, e gli obblighi che acquisisce verso il malato, nei termini di misericordia, solidarietà, fratellanza universale: in una parola, come un’“etica della filantropia”. Tuttavia questo ideale non è stato l’unico, né si è imposto in tutto l’ambiente medico. Nell’epoca classica della civiltà greca il comportamento del medico non si ispirava agli obblighi verso l’umanità. La “filantropia” negli scritti ippocratici (V sec.) è intesa come gentilezza e buone maniere, contrapposta alla misantropia. I suggerimenti impartiti al medico riguardano i comportamenti più efficaci da tenere nel corso del suo lavoro, al fine di conseguire la fiducia del paziente e distinguersi dai ciarlatani. In altri termini, si tratta più di “etichetta” medica che di etica. L’ethos medico è quello di una corretta prestazione esterna. L’età classica, come risulta dagli scritti platonici, giudicava il lavoro manuale sulla base della competenza e dell’efficienza. Nessuna idealizzazione esaltava la medicina sopra le altre professioni: era considerata un’arte come le altre, estranea a valori come l’intenzione interiore e il cuore.
Il secondo stadio dell’evoluzione dell’ethos medico presuppone la trasformazione spirituale che si è espressa nell’insegnamento pitagorico e nella filosofia stoica, che considerava possibile a ogni stato di vita seguire le regole dell’etica. Anche l’ethos dell’artigiano medico fu riformulato in accordo con vari sistemi filosofici. Nell’arco di tempo che si estende dal IV sec. al II sec. d.C. la medicina è stata elevata al rango di arte filantropica. La moralità della prestazione esterna, caratteristica dell’epoca classica, cede ora alla moralità dell’intenzione: il medico, secondo Gallieno, non può non essere filosofo. Sorge cosi l’umanesimo medico dell’antichità. La sua espressione letteraria sono gli scritti deontologici del Corpus Hippocraticum: il giuramento in primo luogo, ma anche i Precetti, Sul medico, Sul decoro. Composti in epoca ellenistica o addirittura
18
cristiana, rispecchiano l’ideale completo del medico come amore dell’umanità, filantropia. A un’analisi più accurata si riconoscono nei vari scritti sfumature filosofiche diverse. Cosi nello scritto Sul medico predominano le virtù della scuola aristotelica: il medico deve essere onesto, prudente, gentile. I Precetti e Sul decoro rivelano valori stoici, come la saggezza e la scelta razionale. Negli scritti di Scribonio Largo — il quale, incidentalmente, è il primo autore a menzionare il giuramento ippocratico nella prefazione al Compositiones: I sec. d.C. — l’etica della prestazione esterna e dell’intenzione interiore sono diventate ormai una unità inseparabile. L’umanesimo stoico trasmesso da Cicerone diventa per Scribonio Largo il fondamento di specifiche virtù professionali. Il medico come filantropo deve simpatia (misericordia) e umanità (humanitas) a ognuno dei suoi malati, sulla base della fratellanza tra gli uomini. L’amore dell’umanità diventa la virtù professionale del medico.
Anche se l’umanesimo medico è rimasto ristretto a una piccola minoranza di medici, resta tra gli ideali più sublimi concepiti dall’antichità. Il giuramento di Ippocrate assume il suo pieno significato solo se interpretato nel modo in cui fu compreso da Scribonio e dai suoi successori. E proprio perché ci è stato consegnato dall’antichità incastonato nell’ideale dell’etica della filantropia, di cui si è fatto supporto, ha potuto costituire nel corso dei secoli un punto di riferimento costante.
2. La tradizione e l’uso moderno del giuramento
La ricerca storica contemporanea ha esteso lo studio dei trattati ippocratici, oltre alla loro origine e alla formazione del Corpus Hippocraticum, anche al ruolo che hanno svolto nella storia del pensiero e della pratica medica 13. Ippocrate è stato, nelle epoche e culture più diverse, lo schermo di proiezione di un ideale, la perfetta incarnazione dell’atteggiamento medico volta a volta ritenuto più appropriato, spesso molto lontano dalla pratica affettiva dei medici del tempo. Il giuramento attribuitogli ha contribuito in modo determinante alla cristallizzazione dell’etica medica attorno al suo nome.
19
L’opera degli storici, che ha portato a profonde revisioni del quadro oleografico che vedeva nella professione medica dell’antichità un gruppo omogeneo di guaritori con nobili intenzioni, dediti ai sublimi ideali del “sacro giuramento”, non ha risparmiato neppure le visioni più convenzionali relative al Medio Evo. Lo standard etico del medico durante l’epoca che si estende dalla disgregazione dell’Occidente fino alle prime regolazioni ufficiali della professione, ad opera di Federico II, risulta notevolmente poco elevato. I medici non erano soggetti né a misure penali e legali, né all’organizzazione di una corporazione universale. Durante il primo Medio Evo i medici furono esposti a due influenze divergenti, che abbiamo già visto operanti nell’antichità; una idealistica, l’altra pratica: in altri termini, “etica ed “etichetta”. L’etichetta medica quotidiana che troviamo nei trattati dell’epoca 14 consiste in ammonizioni al medico a evitare eccessi di vino e ostentazione nell’abbigliamento, all’esercizio della pazienza con malati difficili, a non dar prova di avarizia nell’esigere il pagamento delle tariffe. Le motivazioni del comportamento medico quotidiano non dimostrano un orizzonte più alto di quello dell’opportunismo. Anche nell’ambito della cristianità, il comportamento concreto del medico si modella secondo criteri che chiameremmo secolari. Per quanto riguarda l’etica, invece, gli scritti a nostra disposizione combinano gli ideali ippocratici (in senso filantropico) con quelli cristiani. Si configura cioè un “ippocratismo cristiano”, in cui i precetti ippocratici — in particolare le ingiunzioni circa la somministrazione di veleni, l’aborto e la violazione della fiducia del paziente — non costituivano un codice di condotta imposto da un’istanza professionale dotata di autorità, ma piuttosto un insieme di ideali che il medico di nobili intenzioni era esortato a seguire. La forma più vistosa dell’ippocratismo cristiano è la revisione del giuramento “in modo che un cristiano possa giurarlo” 15. L’invocazione ad Apollo e alle altre divinità viene sostituita con quella della Trinità; cadono le clausole relative all’esercizio della chirurgia e alla condivisione dei beni e conoscenze con i membri della
20
famiglia del maestro; permangono invece le proibizioni tradizionali relative a veleni, aborto e divulgazione dei segreti. La modifica della parte del giuramento concernente i rapporti tra maestro e discepolo è interpretata da Jones come superamento di una concezione elitaria, incompatibile con l’universalismo cristiano. Più radicalmente, le clausole che codificavano gli obblighi assunti dal discepolo all’essere cooptato nella famiglia del maestro non avevano più ragione di esistere, essendo cambiate le modalità dell’insegnamento della medicina. Non è escluso che si possa riconoscere un’eco del senso di fratellanza cristiana nell’impegno a “insegnare quest’arte a chiunque lo richieda, senza invidia e senza richiedere un contratto”. In epoca medievale le influenze del giuramento ippocratico sono rintracciabili anche al di fuori dell’area cristiana. Le ritroviamo nel “giuramento di Asaf”, contenuto in un manoscritto del VII secolo, la più antica opera medica della letteratura ebraica. Il giuramento appare anche in versione musulmana, in cui la sola modifica significativa è la sostituzione del pantheon greco con affermazioni in armonia con la teologia islamica 16.
Nella transizione dal medio evo alla civiltà occidentale moderna il giuramento di Ippocrate continuò ad essere modello per l’ideale etico dei medici. In alcune scuole di medicina si richiese, al termine del curriculum e prima di iniziare ufficialmente l’esercizio della professione, di tenere il giuramento nella sua forma originale: una pratica che non è del tutto scomparsa neppure al giorno d’oggi. La valorizzazione più enfatica del giuramento fu quella che ne fece il regime nazista in Germania. Si tratta, piuttosto, di una cinica strumentalizzazione. Himmler ne fece fare un’edizione di cui egli stesso scrisse la prefazione. Il giuramento, a suo dire, “contiene un’eredità di pensiero ariana, che attraverso duemila anni ci parla un linguaggio vivo” 17. Sotto la pressione nazista il giuramento, che aveva avuto per lo più un’esistenza marginale, fu diffuso ampiamente nell’ambito medico. Esso fu assunto a simbolo di un’etica particolare del corpo medico, che il regime distorceva nel senso di una fedeltà e lealtà dei medici agli indirizzi ideologico-sanitari del nazismo 18.
21
Dopo il nazismo il giuramento ippocratico cadde in sospetto. Una delle prime preoccupazioni dell'Associazione Medica Mondiale, nell’assemblea generale tenutasi a Ginevra nel 1948, fu una dichiarazione che restaurasse l’immagine della medicina dedita ai fini umanitari, dopo i crimini medici che agghiacciarono l’opinione pubblica al processo di Norimberga. Pur abbandonando lo schema ippocratico tradizionale, la dichiarazione di Ginevra non rinuncia al simbolo del giuramento. Un giuramento laico, ormai, in cui l’istanza suprema a cui si fa appello è l’onore del medico che assume gli impegni. Affinché il giuramento potesse essere applicabile alle condizioni moderne della prassi medica, le affermazioni circa le responsabilità del medico di fronte al suicidio, all’eutanasia e all’aborto sono sfumate in generalizzazioni. Il medico si impegna a “mantenere il massimo rispetto per la vita umana fin dal tempo del concepimento, a non usare, anche sotto minaccia, le conoscenze mediche contrariamente alle leggi dell’umanità”.
Un’esplicita ostilità al giuramento di Ippocrate, quale simbolo dell’etica capitalistica, è nutrita nei paesi socialisti. Gli studi dedicati all’“ethos ippocratico” dalla sezione marxista-leninista della facoltà di medicina di Halle, nella Rep. Popolare Tedesca, possono valere come illustrazione didattica dell’ideologia medica socialista 19. L’interpretazione marxista della storia non può accettare l’esistenza di un’etica medica atemporale. L’etica, come tutte le sovrastrutture, è determinata dai rapporti socio-economici esistenti nella società. Di qui si passa conseguentemente ad auspicare una nuova etica medica, espressione della nuova società socialista. L’ethos medico socialista viene praticamente ad equivalere alle esigenze sociali della professione: il medico, prima che professionista, va considerato come un membro dello Stato socialista; più che un tecnico, un operatore attivo del nuovo ordine sociale. Tale concezione esula completamente dall’ottica del giuramento di Ippocrate. Nonché, più in generale, da tutto l’umanesimo medico dell’antichità. Secondo Edelstein 20,
22
il solo tratto che distingue l’umanesimo pagano dall’atteggiamento cristiano e da quello che sarà proprio dei riformatori umanisti del XIX sec., è la mancanza di ogni riconoscimento di responsabilità sociali da parte del medico. Benché alcune malattie fossero ricondotte alle condizioni sociali, l'evangelo dell’amore fraterno considerava solo la relazione tra il singolo medico e il singolo paziente. L’etica medica socialista non riesce perciò a fare l’opera di assimilazione del documento ippocratico che invece è felicemente riuscita ad altri orientamenti e culture. Gli ideologi comunisti tedeschi, pur riservando al giuramento il rispetto dovuto a un documento storico del passato, auspicano la creazione di un nuovo giuramento, che renda ragione degli aspetti peculiari dell’etica medica socialista 21.
L’auspicio ha trovato realizzazione nel giuramento che il Presidium del Soviet Supremo ha imposto a tutti i medici russi, nel 1971. Anche se il giuramento ippocratico ha fatto da padrino, non sopravvivono più neppure le rassomiglianze formali. Il giuramento ha un significato esplicitamente politico. Il giovane medico si impegna ad esercitare là dove la società ha bisogno della sua opera e ad aderire internamente ai principi marxisti e all’etica comunista che regolano la società (“lasciarmi guidare in tutte le mie azioni dai principi della morale comunista, ricordarmi sempre dell’alta vocazione del medico sovietico e della responsabilità nei confronti del popolo e del governo sovietici”). All’ideale di dovere umanitario nei confronti del singolo paziente è sovrapposto l’impegno del medico a servire gli interessi della società.
3. Pro e contro il giuramento ippocratico
Generazioni di medici hanno considerato il giuramento di Ippocrate come la “magna carta” dell’etica medica. Eppure oggi l’unanime rispetto che la tradizione ha creato attorno a questo documento è infranto da alcune voci critiche. Non è più sufficiente nominarlo, per evocare l’indiscusso riferimento dei medici alle più alte idealità umanitarie. Nei confronti del giuramento ippocratico è subentrato un centro disincantato, indubbiamente facilitato dalla divulgazione degli studi filologici e storici che hanno permesso di comprenderne con più precisione la natura e la finalità. Oggi sappiamo che l’antichità è stata molto meno “ippocratica”
23
di quanto una certa tradizione, nutrita di retorica, ha voluto far credere. Per alcuni critici l’interpretazione del giuramento ippocratico in ambito medico è l’esempio eclatante delle distorsioni che ha subito la storia ad opera di medici, a servizio della loro concezione elitaria ed esclusiva della professione: gli aspetti corporativi e utilitaristici del giuramento sono stati passati sotto silenzio; il giuramento ha potuto cosi essere reso simbolo di un ethos astorico, con pretese universalistiche 22. Non è un caso ― osservano alcuni con fastidio — che il giuramento venga puntualmente tirato in ballo dall’ala meno progressista dei medici quando si discute di problemi di etica o di politica sanitaria, per brandirlo contro una concezione più sociale della medicina. Presso i rappresentanti della medicina liberale il giuramento, magari riprodotto in formato pergamena, è contornato di una venerazione che non può essere rapportata al suo effettivo contenuto. In alcune facoltà viene anche oggi consegnato in forma solenne ai neo-laureati in medicina. Anche persone non sospette di faziosità partigiana hanno espresso le loro riserve rispetto a questa pratica. I giovani medici — nota ironicamente lo storico della medicina Sigerist — giurano che non eseguiranno operazioni chirurgiche, che sono pronti a condividere lo stipendio con i loro insegnanti e a considerare i loro figli come figli propri. Eppure i medici non esitano a fare operazioni, e molti pochi medici hanno condiviso le loro entrate con il loro professore e adottato i suoi figli; tradiscono segreti professionali, quando si tratta dell’interesse della comunità. I problemi dell’aborto sono regolati dalla legge e una gravidanza viene interrotta quando esiste indicazione medica 23. Il giuramento nel suo tenore tradizionale è chiaramente inadeguato a offrire direttive etiche per il lavoro pratico del medico di oggi. Se una parte dei medici vi resta cosi ostinatamente attaccata, si spiega non con il contenuto del giuramento, bensì con il significato simbolico che ha acquisito. Esso esprime non un’etica comune al corpo medico, ma l’esprit de corps che unisce i medici; fonda miticamente l’ordine di un gruppo. Coloro che avversano l’organizzazione corporativistica della medicina sono ostili al giuramento, in quanto con la sua semi-sacralità rituale consacra un’auto-comprensione della classe medica come una casta. Secondo Luth, la funzione del giuramento ippocratico sarebbe analoga a quella dell’araldica e continuerebbe ad accreditare una concezione della storia della professione medica come di una successione quasi-apostolica...
24
Le critiche non si rivolgono, dunque, al giuramento nella sua realtà storica, bensì all’uso che viene fatto, e alla comprensione dell’identità professionale del medico che su di esso si fonda. Si rimprovera al giuramento di ostacolare il passaggio a una concezione della medicina meno impregnata di sacralità, più agganciata al gioco dei rapporti democratici, nella rispondenza rispettiva dei diritti e dei doveri. Esso rispecchia inoltre una visione della medicina centrata sulla persona del medico. Nel giuramento manca qualsiasi riferimento ai collaboratori del medico, che ― ieri come oggi — sono parte essenziale di qualsivoglia impresa terapeutica. Anzi, oggi ancor più di ieri, perché la medicina è in misura determinante lavoro d’équipe, opera di collaborazione. Tuttavia la figura del medico come eroe che si staglia solitario sulla massa, obbligato da un ethos particolare, è resistente a ogni trasformazione; l’uso di un giuramento per essere introdotti nella professione contribuisce a perpetuarla. È assolutamente aliena al giuramento un’ottica relazionale, in cui emerga anche il paziente come soggetto di diritti e doveri, in un rapporto di cooperazione che non esclude il conflitto. Nel giuramento il paziente è sospinto sullo sfondo, come oggetto cui è riservata la nobile abnegazione del medico.
Non c’è, dunque, più posto nella nostra epoca per il giuramento medico, ippocratico o “revisionato” che sia? La conclusione sarebbe affrettata. Lo dimostra l’uso del giuramento nell'Unione Sovietica. La concezione socialista della medicina, della sua articolazione con la realtà sociale e dello statuto professionale del medico, sono “toto coelo” diverse da quelle dell’area culturale che ha prodotto la medicina liberale. Eppure si è preferito rimodellare il giuramento, piuttosto che rinunciarvi del tutto.
Oggi siamo più che in passato acutamente coscienti delle ambiguità che possono deformare il senso del giuramento. Ciò non giustifica però nessun tentativo di ridurre l’“ethos ippocratico” a un puro flatus vocis. Esso è venuto a significare l’obbligo che ha il medico di servire non solo l’uomo in carne ed ossa che si affida alle sue cure, ma l’umanità. Una dottrina utopica che ha, tra l’altro, il merito non trascurabile di evidenziare lo scarto tra l’ideale e la pratica quotidiana. Come tutte le dottrine utopiche, anche l’ethos ippocratico — e il giuramento che ne è diventato simbolo — apre al reale l’orizzonte del possibile.
25
Capitolo Secondo
LA DEONTOLOGIA MEDICA
L’aspirazione a essere non solo un medico, ma un “buon” medico, è una costante che percorre tutta la storia della medicina. I criteri per stabilire che cosa costituisca la bontà” del medico variano da cultura a cultura, e nelle diverse epoche. Gli ideali personali e i valori si intrecciano con le richieste sociali, le norme che si ispirano alla religione con quelle che si fondano sulla ragione. Per misurare la complessa varietà di questo “di più”, oltre la competenza professionale, che si richiede al medico, basta pensare alle diverse forme letterarie che l’hanno veicolato: preghiere (come quella famosa attribuita a Mosè Maimonide), giuramenti (da quello di Ippocrate al giuramento che il Soviet supremo ha imposto ai medici russi), codici deontologici, civili e penali. Il criterio scelto per stabilire delle norme può essere religioso o razionale; l’istanza obbligante può essere la coscienza, la società o il corpo professionale. Conseguentemente, variano anche la qualità e la forza delle sanzioni. In questo complesso di prescrizioni vogliamo isolare quelle che confluiscono nei codici di deontologia professionale. Cercheremo di comprendere che cosa significa essere un “buon” medico in senso deontologico. Ne risulterà anche una più chiara articolazione con la bontà etica e con quella che deriva dalle più alte aspirazioni morali ispirate dalla religione.
1. Dall’“etichetta” medica alla deontologia
Nella storia della professione medica è emersa precocemente la convinzione che fosse opportuno codificare non solo le conoscenze di patologia
26
e di terapia, ma anche le regole relative al comportamento che il medico deve tenere con il paziente. In occidente svolgono il ruolo di antenati gli scritti ippocratici di natura deontologica (Sul decoro, Sul medico, Precetti...).
Indicazioni sul comportamento corretto sono frequenti nei trattati medievali di medicina. Non mancano neppure abbozzi di una regolazione dei rapporti con gli altri medici, all'interno della professione. Lentamente si è formato un corpo di regole pratiche che costituiscono ciò che potremmo chiamare l’“etichetta” medica. Mentre l’ethos ippocratico, simboleggiato dal giuramento e ripensato in termini cristiani, continuava a costituire il punto di riferimento ideale della medicina occidentale, sulla base dell’“etichetta” medica si veniva a costruire, fin dall’inizio del XIX sec., un corpo precettistico che sarà a più riprese codificato nei codici deontologici.
Prima di discutere la nozione tecnica di deontologia, ne vogliamo fornire un’immagine diretta riferendoci all’opera che svolge indiscutibilmente la funzione di prototipo: la Medical Ethics di Thomas Percival (1740-1804). Il trattato, scritto nel 1794 e pubblicato nel 1803 24, si inseriva in un dibattito molto vivo nell’ambiente medico del tempo. Ben presto gli fu riconosciuta un’autorità indiscussa, consacrata successivamente dall’essere stato assunto a modello per il codice dell’American Medical Association del 1847. Il motivo del nostro particolare interesse per l’etica di Percival risiede nel fatto che questi, nel proporre ai medici il primo disegno organico di condotta professionale, faceva trapelare l’ideologia che diventerà tipica della professione medica moderna e che continua a sottendere la nozione stessa di deontologia.
Il materiale era distribuito in quattro sezioni, che trattavano rispettivamente della condotta del medico negli ospedali, del comportamento da tenersi nell’esercizio privato della professione, del rapporto dei medici con i farmacisti e dei doveri professionali in determinati casi che richiedono la conoscenza della legge. La sezione di maggiore interesse per la deontologia è la seconda: su di essa si fonderà appunto, mezzo secolo più tardi, il codice deontologico americano, il primo della storia della medicina. Gli obblighi di un medico vengono fatti risalire alle diverse
27
istanze obbliganti: il medico stesso in quanto persona, il rispetto dei colleghi, farmacisti e altro personale impegnato nella cura dei malati, e infine la legge. Quanto al primo aspetto, ad esempio, Percival considera il medico come un “gentleman”. Molte regole di comportamento vengono dedotte da questo carattere fondamentale. In quanto gentleman, il medico “deve unire la delicatezza con la fermezza, la condiscendenza con l’autorità”; in camera operatoria deve regnare un “silenzio decoroso”; il medico deve cambiare il grembiule tra un’operazione e l’altra; deve essere temperante, puntuale e ricevere “una regolare educazione accademica”. Gli aggettivi ricorrenti per qualificare il medico-gentleman sono: prudente, ragionevole, autoritativo ma umile, autocritico, colto. La condotta ideale che il medico doveva a se stesso in quanto gentleman si rifletteva ovviamente nel rapporto con i pazienti e con i colleghi.
La preoccupazione principale che traspare in questo primo corpo di norme deontologiche è quella di costruire un rapporto di fiducia con il paziente. A tal fine il medico deve dar prova delle virtù che fanno parte del patrimonio etico di qualsiasi persona — umanità, costanza, segretezza, delicatezza —; in più gli sono richiesti, nel rapporto con il paziente, alcuni comportamenti particolari: un ragionevole numero di visite; non abbandonare il paziente condannato; ammonire il paziente che sta soffrendo il fio del suo peccato (!); astenersi da previsioni fosche, eccetto quando il paziente debba predisporre la propria morte. Vengono anche prese in considerazione le norme per il trattamento economico: le tariffe devono essere commisurate alla condizione economica del paziente.
Un secondo polo attorno a cui si distribuiscono le regole è quello del rapporto con gli altri medici. Vengono dettagliatamente prese in considerazione le procedure da seguire nelle varie situazioni: il consulto con colleghi che hanno ricevuto una formazione accademica e con medici “selvaggi”; come subentrare a un altro medico nella cura del paziente; la salvaguardia della reputazione del corpo medico, astenendosi dalle critiche ai colleghi. Su questo ultimo punto Percival afferma testualmente: “L’Esprit de corps” è un principio di azione fondato sulla natura umana e, quando è debitamente regolato, è razionale e lodevole. Chiunque entri in una fraternità si impegna, mediante un tacito contratto, non solo a sottomettersi alle leggi, ma a promuovere l’onore e l’interesse della associazione nella misura in cui coincidono con la moralità e con il bene generale dell’umanità. Il medico, perciò, dovrebbe con ogni attenzione guardarsi da ciò che potrà recare ingiustizia alla rispettabilità in genere
28
della sua professione; e dovrebbe evitare quelle immagini che sono offensive per la facoltà nel suo insieme; tutte le accuse generiche contro la probità; e di indulgere allo scetticismo, simulato o per gioco, circa l’efficacia e l’utilità dell’arte terapeutica”.
Per Percival la buona condotta andava a vantaggio sia del medico e della professione, che del paziente. Studi recenti 25 hanno messo in evidenza che questo primo abbozzo di deontologia professionale si inserisce nel dibattito allora vivo tra i medici in Inghilterra e rispecchia la concezione conservatrice dell'Illuminismo medico (che Percival fosse permeato di ideali illuministici lo dimostra la sua corrispondenza con Voltaire, Diderot, D’Alembert). L’etica che Percival produce a nome del corpo medico va vista come una risposta al liberalismo di Adam Smith. A differenza di Smith, Percival si oppone alle tendenze individualistiche nell’organizzazione sociale e al vantaggio economico come spinta sociale motivante. Alla concezione economica liberale contrappone una professione che trascende l’interesse personale e si ispira a un ideale che solo un uomo di indirizzo morale superiore può seguire. In tal modo evita che all'interno del corpo medico si introduca il tarlo della competizione; ma allo stesso tempo rafforza la struttura corporativa della medicina. L’ideale etico e le norme che lo incarnano mostrano la loro funzionalità: dare alla medicina uno statuto professionale differente, sottratto alla logica del liberalismo economico. Il comportamento uniforme dei medici, secondo le regole che si sono liberamente imposti, diventa cosi un insuperabile strumento di integrazione professionale.
Dalla presentazione, benché sommaria, del progetto di Percival e dello spirito che lo anima, emerge l’orizzonte ideologico in cui si colloca la deontologia fin dai suoi primi inizi. La sua funzione è quella di sviluppare standards di condotta che permettano al medico di curare correttamente i malati, e allo stesso tempo di incrementare la dignità della professione. Tanto il tradizionale ethos ippocratico quanto l’etichetta che regola il comportamento dei medici tra di loro sono fusi in un progetto organico.
Le norme non sono dedotte da un’etica, religiosa o laica che sia, ma derivate da un corpo sociale intermedio tra lo Stato e l’individuo, e con cui il medico si identifica: il gruppo professionale. La codificazione
29
del comportamento serve agli interessi del gruppo; e indirettamente a quelli degli utenti dei servizi medici. Il mantenimento del codice è riservato al gruppo professionale stesso. Addirittura Percival esclude l’idea di un ricorso a sanzioni per coloro che si discostano dal comportamento normativo. Il potere inerente alla deontologia è quello della ragione: i medici hanno un solo modo razionale di comportarsi e, una volta mostrato in quella specie di rivelazione della ragione che opera il codice deontologico, lo seguiranno. Il compito del codice è dunque quello di essere la voce della ragione. Percival lascia trasparire in ciò la sua dipendenza dal pensiero illuministico.
Distaccandoci dal primo modello fornito dall’etica medica di Percival, possiamo a questo punto descrivere la deontologia in un modo più formale, che si avvicina quasi a una definizione. Essa comprende un insieme specifico di doveri (letteralmente significa appunto “scienza dei doveri”), ai quali sono legati i membri di una professione, diversi da quelli imposti dalla legge o derivanti dall’etica alla quale ognuno individualmente si riferisce. Sono i doveri che derivano dal fatto di esercitare una determinata professione 26. Quando la professione si organizza, tende a darsi uno statuto codificato, o almeno delle usanze che precisano i doveri dei membri. Le formulazioni deontologiche codificate, emanate dagli organi ufficiali della professione, godono di autorevolezza. È generalmente considerato legittimo il ricorso alle sanzioni (che possono andare dalle censure puramente morali fino alla sospensione o esclusione del professionista dall’album professionale), affinché i membri del gruppo rispettino i doveri che hanno accettato con la loro adesione. Tali formulazioni deontologiche sono regole che i professionisti considerano essenziali per il buon esercizio della professione comune. Sono, dunque, più che un semplice regolamento. Le si potrebbe chiamare uno “spirito”, che deriva da una percezione collettiva dell’attività svolta, del senso di questa attività e del suo articolarsi con l’organizzazione sociale. La deontologia non si definisce però riferendosi a concetti astratti. Essa tende a concretizzarsi, ha di mira i casi incontrati dal professionista nella pratica quotidiana. Con riferimento a simili casi, le prescrizioni deontologiche danno imperativamente soluzioni pratiche e precise, che definiscono i doveri del professionista. Nella forma di codici deontologici la deontologia assomiglia cosi un po’ a una casistica.
30
Ricorrendo a un'immagine, potremmo dire che la deontologia è analoga ai consigli che i fabbricanti pongono alla fine del depliant illustrativo allegato alle macchine che vendono. Quando questi foglietti sono ben fatti, vi si trova, dopo l’inventario dei pezzi della macchina e l’enunciato dei principi del suo funzionamento, un insieme di regole per l’uso, seguite dagli accorgimenti per la migliore utilizzazione possibile della macchina. Con ciò il produttore non fa altro che indicare come rispettare la natura della macchina, sulla base di esperienze e osservazioni del passato fornite dagli utenti stessi.
L’analogia ha certo bisogno di correzioni. Sarebbe improprio far derivare la deontologia unicamente dalla preoccupazione di efficienza utilitaristica. Essa si è sviluppata nel campo delle professioni liberali, che hanno per oggetto l’uomo e i suoi valori. Nel campo della medicina la deontologia si innesta sulla lunga tradizione umanistica ed è strettamente intrecciata con l’ethos ippocratico. Nel complesso, tuttavia, l’analogia con le “istruzioni per l’uso” è convincente. Essa evidenzia il carattere empirico delle norme deontologiche. Queste non equivalgono a una morale professionale, vale a dire a un insieme di precetti elaborati per deduzione da un’etica generale, considerando l’incidenza in un’attività professionale dei valori etici ai quali ci si riferisce. Sono piuttosto il frutto di una riflessione collettiva, stimolata dai problemi suscitati dalla professione, e che superano l’ambito dei regolamenti e della routine. Protagonisti della riflessione deontologica sono professionisti coscienti e critici, che intendono promuovere una prassi professionale efficiente e socialmente ineccepibile.
Quest’ultimo punto merita uno sviluppo: esso ci aiuta a identificare la funzione propria delle norme deontologiche. Queste mirano alla salvaguardia di alcuni valori, necessari in modo particolare nelle attività che fanno appello alla fiducia del cliente verso la persona del professionista. Per questo le professioni liberali sono cosi sensibili all’onore e alla dignità professionali. L’osservanza delle norme deontologiche è destinata a mantenere la fiducia nel corpo professionale, salvaguardandone la reputazione; si tratta, in ultima analisi, di una forma di autodifesa della professione stessa.
La deontologia, quindi, non è una morale. Le regole della morale possono, in modo contingente, essere incorporate alla deontologia professionale, dal momento che atti valutati come immorali dall’ethos dominante possono essere pregiudizievoli al professionista, e vanno perciò evitati. Tuttavia la deontologia non è, in sé, una specie di morale laica,
31
quel minimo comun denominatore etico che fornirebbe un luogo di incontro comune a tutti i membri della professione. È un equivoco che si verifica spesso a proposito della deontologia medica, quando si vuol vedere in essa una sintesi di quei principi etici che tutti i medici riconoscerebbero come obbliganti, qualunque siano le ulteriori specificazioni confessionali e personali. La deontologia medica è invece una realtà contingente, che varia anche con il tempo. Ne offrono una prova i codici deontologici. Non sono una realtà astorica, immutabile; devono essere, invece, costantemente revisionati, al fine di riflettere le variazioni della sensibilità etica generale e dell’organizzazione della sanità. Una breve scorsa all’origine e all’evoluzione di alcuni codici deontologici medici lo conferma.
2. I codici di deontologia medica
Il primo codice medico ufficiale è, in ordine cronologico, quello emanato dall'American Medical Association nel 1847. Ne abbiamo già parlato accennando al legame con l’opera di Percival. La portata innovativa di questa regolamentazione professionale del comportamento medico emerge solo se la ricollochiamo nel suo contesto storico. Gli anni ’30 e ’40 del XIX sec. hanno visto, in America un vivace confronto fra la medicina accademica e le tendenze contestative che confluivano nel “Popular Health Movement” 27. Questo non era che il fronte medico di un’agitazione sociale generale, fomentata dai movimenti femminista e operaio. Il movimento era un attacco radicale all’élite medica e una vigorosa affermazione della tradizionale medicina del popolo. “Every man his own doctor”: era il motto di un’ala estremista del “Popular Health Movement”. Per certe sue iniziative il Movimento per la salute confluiva negli obiettivi del movimento femminista: come per esempio le “Ladies Physiological Societies”, che impartivano semplici istruzioni di anatomia e igiene personale, sotto la spinta a “riappropriarsi del corpo”. Il movimento non rivendicava una maggiore quantità di cure mediche, ma prospettava piuttosto una cura della salute di tipo radicalmente differente.
32
Era una sfida alla medicina ufficiale, sia al modo in cui veniva praticata, sia al suo edificio concettuale: un vero e proprio progetto di “medicina alternativa” ante litteram.
All’azione destabilizzante del Movimento Popolare della Salute va aggiunta la concorrenza della medicina omeopatica e dei guaritori. Il centinaio di medici che si riunirono a New York nel 1846 per fondare l'American Medical Association si sentivano in stato di assedio. Si posero come scopo quello di riformare l’educazione medica negli Stati Uniti di sviluppare standards di comportamento che avrebbero migliorato la professione medica “regolare”. Ritenevano infatti essenziale distanziarsi dagli “irregolari”, e accreditarsi come unica istanza professionale cui competeva la cura della salute. Il codice etico che emerse l’anno seguente si inseriva dunque in un progetto esplicito di validazione della professione contro ogni concorrenza da parte dei corpi paralleli. La fiducia del pubblico doveva essere indirizzata esclusivamente verso i medici che avevano ricevuto la formazione accademica e si attenevano alle norme stabilite dal codice deontologico. La professione si univa in una crociata contro i guaritori di appartenenza settaria e contro i ciarlatani. Il codice stabiliva, a tal fine, che i medici regolari non dovessero accettare consulti con chiunque non avesse una licenza ufficiale per esercitare, approvata dall’organizzazione medica locale. Per rendersi conto di quanto fosse esclusivo il gruppo che cosi veniva a formarsi, basti pensare che prima del 1870 le società mediche regolari non accettavano come membri e proibivano consulti con medici donne e medici negri, e per la seconda metà del secolo con medici che accettassero una qualsiasi designazione settaria. L’osservanza delle norme del codice deontologico autoimpostosi dalle società mediche sortiva cosi anche un effetto secondario, ma non imprevisto: quello di organizzare i medici in un gruppo sociale e professionale compatto, omogeneo all’interno e chiuso all’esterno.
Dal punto di vista del contenuto, il codice deontologico del 1847 è suddiviso in tre parti, che riguardano rispettivamente: doveri dei medici verso i loro pazienti e obblighi dei pazienti verso i loro medici; doveri dei medici verso gli altri e verso la professione; doveri della professione verso il pubblico e del pubblico verso la professione. Nelle linee fondamentali il codice americano riprende le norme etiche di Percival. Se ne distacca solo in alcuni punti. Nelle regole per la condotta economica, per esempio. Mentre Percival raccomanda di discriminare tra pazienti di diversa disponibilità economica, il codice propone la tariffa a prezzo fisso.
33
Così rispetto al consulto con i medici senza preparazione accademica: mentre Percival lo considera possibile, il codice dell'AMA lo proibisce. Inoltre il codice pone restrizioni maggiori al segreto medico: non poteva essere altrimenti, volendo rafforzare la fiducia del pubblico verso la professione.
Il codice deontologico americano resta un prototipo, anche se fu riformulato in parecchie riprese (nel 1903, 1912, 1949, 1957). Numerosi altri codici, in altri paesi, sono sorti sulla sua scia. I governi nazionali se ne servirono per regolamentare la professione medica 28. Nei codici deontologici dei nostri giorni sono stati inclusi problemi di origine recente. L’accento cade in genere sui problemi dell’aborto, della retribuzione e del segreto professionale. I progressi e i cambiamenti sociali hanno richiesto la determinazione di linee di condotta su problemi particolari: i trapianti di organo (norme dell'AMA del 1968 e dichiarazione di Sidney della Associazione Medica Mondiale sulle precauzioni tecniche nel determinare la morte di un donatore d’organo); rianimazione e trattamento della malattie terminali (“Il medico e il morente”, AMA 1973); sperimentazione con soggetti umani e ricerche biomediche (Ass. Med. Mond., Helsinki 1964 - Tokyo 1975); l’aborto terapeutico (Ass. Med. Mond., Oslo 1970); “la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, disumani o avvilenti in relazione alla detenzione e alla carcerazione” (Ass. Med. Mond., Tokyo 1975).
L’Associazione Medica Mondiale, stabilitasi nel 1948, incoraggiò i medici a sviluppare degli standards internazionali di etica medica. Il codice internazionale fu adottato nel 1949. Superate ormai le precedenti regolamentazioni dettagliate di etichetta per i consulti e nei rapporti con gli altri medici, la cadenza dominante è quella del riferimento ai valori. Il comportamento del medico dovrebbe essere sostanzialmente ispirato alla “regola d’oro” (“fai agli altri ciò che vorresti che fosse fatto a te”), cosi come viene specificata dalla pratica. I problemi dell’aborto e dell’eutanasia vengono solo accennati, con riferimento alla responsabilità del medico di preservare la vita. L’afflato idealistico è trapassato anche nella revisione del codice deontologico americano del 1957: invece della casistica tipica dei codici deontologici, comprende “dieci principi”, di valore generale.
34
Per quanto riguarda direttamente l’Italia, l’organo competente per stabilire un codice deontologico è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Di recente ha provveduto a rivedere il codice precedente, che datava dal 1956. Il nuovo codice, pubblicato nel 1978, consta di cento articoli, che suddividono la materia in: doveri generali del medico, rapporti con il paziente, rapporti con i colleghi, rapporti con i terzi, enti pubblici e privati. Rispetto al codice precedente, sono state introdotte innovazioni, anche di notevole rilievo. Le innovazioni sono ovvie, qualora si tenga presente la natura particolare della deontologia e la sua differenza dall’etica. Inserendosi come cerniera tra il corpo professionale e la società, la deontologia deve cambiare con il cambiare di questo rapporto. Compito dei responsabili della professione è di favorire quei cambiamenti che mantengono inalterato il rapporto di fiducia degli utenti con il corpo professionale.
La novità più eclatante introdotta dalla nuova stesura del codice di deontologia medica italiano è la caduta del tradizionale rifiuto dei medici a partecipare a interventi abortivi: “L’interruzione della gravidanza è regolamentata con legge dello Stato” (a. 46). Dal momento che la normativa introdotta con la legge 194 prevede, a certe condizioni, la possibilità di praticare l’aborto, il corpo professionale medico rinuncia a porre obblighi deontologici ai suoi membri in quei casi. Infrazione deontologica (“gravissima”), in particolare se fatta a scopo di lucro, è solo la partecipazione ad aborti all’infuori dei casi previsti dalla legge (a. 47). Da notare, in merito all’interruzione della gravidanza, la volontà di limitare le funzioni del medico all’ambito strettamente sanitario, rifiutando la figura del medico-giudice: “Il medico non è tenuto ad esprimere giudizi su circostanze che esulano dalla necessità primaria della salute psico-fisica della donna”. Ricco di spunti innovativi è anche il capitolo che riguarda i rapporti con il paziente. Nella pratica comune questo rapporto è fortemente asimmetrico: al medico tutto il sapere e il potere, al malato la docile soggezione. Il nuovo codice presuppone un malato che prenda parte attiva al processo terapeutico. La verità gli è dovuta; se non direttamente a lui, la prognosi grave o infausta deve essere almeno comunicata alla famiglia. “In ogni caso la volontà del paziente, liberamente espressa, deve rappresentare per il medico un elemento al quale egli ispirerà il suo comportamento” (a. 30). Dal momento che i nuovi mezzi tecnici permettono di prolungare la vita biologica al di là dell’umano, i medici si impegnano a rinunciare all’accanimento terapeutico e a limitare la propria opera alla “terapia atta a risparmiare al malato inutili sofferenze” (a. 40).
35
3. Oltre la deontologia professionale
La deontologia professionale costituisce per i medici un motivo di fierezza. Amano vedervi una specie di blasone nobiliare, una garanzia dell’impegno etico che contraddistingue la loro professione. Non tutti condividono però tale entusiasmo; o, quanto meno, non rinunciano a considerare criticamente i limiti e le possibili distorsioni della deontologia medica. Essa si presenta come l’espressione della benevola dedizione del medico al bene del suo paziente e dell’umanità; ma può essere assunta a servizio di cause meno nobili, come potrebbe essere un progetto monopolistico. Nel saggio di Berlant già citato, il carattere monopolistico è fatto risalire all’etica medica di Percival, che ha preparato la strada ai codici deontologici. Il conservatore Percival scrisse infatti la sua etica in un’epoca in cui le corporazioni mediche inglesi, a struttura elitaria, erano sottoposte a un attacco democratico, particolarmente ad opera della concezione economica liberale. Come apologia delle corporazioni, l’opera di Percival era superba; come strumento per integrare la professione, insuperabile. Mentre creava solidarietà tra i medici, estendeva i controlli monopolistici del Royal College of Physicians alle nuove professioni di chirurghi e farmacisti. Era uno strumento per sopprimere la competizione tra differenti tipi di professionisti che avrebbe potuto essere esacerbata dall’apparire di un numero crescente di corporazioni professionali. L’etica medica americana, formalizzata nelle diverse stesure dei codici deontologici, favori la monopolizzazione ancor più di quella di Percival. Abbiamo già visto come sia servita a distinguere il gruppo dei medici accademici dagli “irregolari”, e ad accreditarlo presso il pubblico come l’unico corpo cui spettava di diritto la cura professionale della salute. Nelle varie edizioni del codice si rileva una fluttuazione circa il grado di controllo dell’associazione sulla condotta del singolo medico. Mentre il codice del 1847 non poneva come condizione l’affiliazione dell'AMA, ma si limitava a suggerire un certo numero di criteri etici per determinare i confini che legittimavano la professione, quello del 1903 richiedeva invece obbligatoriamente di diventare membri dell’associazione. Per evitare di cadere nei rigori della legge anti-trust, i controlli vennero successivamente allentati, per riemergere con il codice del 1949.
Neppure i critici più severi arrivano a sostenere che tutto sia monopolistico nell’ambito della deontologia medica. Tuttavia è difficilmente contestabile che le norme deontologiche, da mezzo per ordinare la condotta
36
dei medici, possono facilmente diventare un mezzo per legittimare i privilegi monopolistici della professione nei confronti dello Stato e del pubblico. In definitiva, tutte le misure volte a indurre nel pubblico la fiducia verso la professione possono risolversi nel senso della monopolizzazione. Esse creano infatti un rapporto paternalistico con il paziente, prevenendo l’organizzazione dei consumatori per una mutua auto-protezione. Mediante l’atomizzazione del pubblico in pazienti vulnerabili, il paternalismo si risolve nel trattare, da parte dei professionisti, con individui frammentati, invece che con gruppi con una propria forza contrattuale. Il potere del medico trova un alleato nelle fantasie di salvezza del paziente. Questi è incline a considerare ogni ostacolo tra sé e il medico come una minaccia personale; di conseguenza, accetta di buon grado il desiderio dei professionisti medici di non trattare con altre controparti che non siano il singolo paziente.
Un attacco più a fondo alla deontologia medica viene sferrato da quanti vi individuano uno dei capisaldi ideologici della “medicina liberale”. Nell’uso comune si intende per medicina liberale quella il cui esercizio obbedisce ai principi della libera scelta del medico da parte del malato, libertà di prescrizione medica, pagamento diretto degli onorari, segreto professionale. Nell’opinione pubblica la medicina liberale è più che un insieme di istituzioni in cui si organizza la cura della salute: è anche un concetto simbolico, con una determinata colorazione etica. La discussione in merito scivola facilmente dal livello dei fatti al confronto di Weltanschauungen: un appuntamento obbligatorio per ogni dibattito sul rapporto tra medicina e politica. I più ardenti difensori della medicina liberale si limitano a opporre un mito ornato di qualità (colloquio singolare, indipendenza, medicina umana) a un mito coperto di difetti che servono da deterrente (medicina statizzata, burocratizzata, servizio sanitario nazionale). Per gli oppositori, la medicina liberale non è che una mistificazione. Spogliata dei suoi paludamenti etici, essa non è che liberalismo economico applicato alla medicina, il modo di produzione capitalista trasportato in ambito sanitario. L’ideologia mistificatrice della medicina liberale è accusata di proteggere e mantenere un sistema che assicura alla maggioranza dei medici una situazione di classe privilegiata. Secondo Guy Caro, autore di una delle disanime più impietose della medicina liberale, essa si baserebbe su un’impostura: “Associando, sotto il concetto di medicina liberale, da una parte dei principi che condizionano in parte la qualità della medicina e suscitano con ciò la fiducia del malato nel suo medico, e dei principi, d’altra parte, che permettono al medico di controllare il livello
37
dei suoi redditi, i medici potevano far credere che gli interessi dei malati e quelli dei medici colludessero. Facendosi, come i proprietari di cui parla Emmanuel Mounier, “professori di virtù per difendere i loro interessi”, guadagnano su due campi: quello del loro livello di vita e quello della stima in cui erano tenuti” 29. Per gli oppositori della medicina liberale, il suo riferirsi ai principi deontologici servirebbe a mantenere la confusione tra la difesa del livello di reddito dei medici e quella della qualità della medicina; questa confusione farebbe parte delle armi dei conservatori dell’ordine sociale esistente per impedire i cambiamenti storicamente necessari.
Anche coloro che non si spingono cosi lontano nel valutare la deontologia medica tradizionale non possono mancare di rilevare le sue carenze circa i doveri sociali del medico. Essa infatti considera esclusivamente i doveri del medico nei confronti del malato che lo consulta, ma resta muta quando si tratta di prevenire la malattia o di occuparsi dei malati che, a causa di barriere economiche, psicologiche o sociali, non accedono al medico. Di fatto i doveri tradizionali del medico non concernono che il malato individuale, mai la comunità. Se si introduce il punto di vista della responsabilità sociale del medico, i punti qualificanti della medicina liberale subiscono forti limitazioni 30. La libertà terapeutica assoluta non può più giustificarsi: a parità di efficacia, il medico ha il dovere di prescrivere la medicazione meno costosa per il malato e per la società. Il segreto medico è in conflitto con una efficace politica sanitaria. Questa, infatti, ha bisogno di basarsi su dati certi riguardanti la morbidità, su inchieste epidemiologiche, sociologiche ed economiche. Salvo restando il diritto del malato alla sua privacy, il segreto medico non può essere considerato oggi un assoluto. L’organizzazione sociale della medicina richiede un difficile equilibrio tra un’indispensabile discrezione, la cui assenza porrebbe una barriera all’accesso del paziente presso il medico, e il bisogno di raccogliere i dati necessari all’elaborazione di una vera politica della salute. Anche l’altro pilastro della medicina tradizionale, il pagamento all’atto, non è più sostenibile. Il sistema di retribuzione tra il medico e il paziente era funzionale alla società liberale. Gli onorari erano, per principio, proporzionali al servizio reso, alla notorietà del medico e alla situazione finanziaria del malato. Questo sistema, perfettamente coerente, è stato reso caduco dall’evoluzione sociale. Il corpo medico ha accettato di
38
rinunciare al principio del pagamento all’atto e di entrare nel sistema assicurativo, con il rimborso forfettario degli atti medici. Un passo ulteriore è stato fatto con la creazione di un servizio sanitario nazionale. La nuova politica della salute, fondata su una concezione sociale della medicina, sconvolge l’ideologia liberale e mette in questione la deontologia professionale che su di essa si fonda. Le codificazioni tradizionali del comportamento medico — preghiere, giuramenti, codici deontologici — riposano, infatti, sul presupposto che i doveri del medico si strutturano sul rapporto diadico medico-paziente. La medicina sociale ha radicalmente rimesso in discussione proprio tale concezione. È diventato chiaro che gli aspetti sociali della prevenzione e cura delle malattie non possono essere adeguatamente trattati all’interno del rapporto medico-paziente. Il “modello cinese” del medico al servizio del popolo 31 costituisce certamente un’utopia per l’Occidente. La sua divulgazione ha contribuito, cionondimeno, a coagulare le richieste di un’alternativa alla medicina derivante dall’organizzazione capitalistica della società. La medicina sociale provoca uno spostamento di ottica che ha conseguenze decisive per l’etica: dalla cura alla prevenzione, dalla patologia localizzata alle cause strutturali che risiedono nelle condizioni di vita, dal servizio al singolo paziente all’obbligo verso tutti i cittadini. Non solo al singolo medico, ma alla professione in quanto tale si domanda di cambiare l’atteggiamento verso la società. Solo abbandonando la mentalità corporativistica i medici riescono a vedere il proprio ruolo all’interno di una più vasta organizzazione, che abbraccia tutti i professionisti della salute. Il servizio alla società ad essi richiesto si apre allora su un impegno etico molto più ampio di quello contemplato dai codici deontologici.
La rifondazione della deontologia su base sociale non è ancora avvertita in ambito medico. Le formulazioni fatte dai medici stessi, anche le più recenti, sono impregnate di paternalismo: è il medico che determina quale azione sia più conforme agli interessi sia del medico che del paziente. Al polo opposto, le “carte dei diritti del malato” sorgono su base rivendicativa: i consumatori dei servizi medici richiedono di essere presi in considerazione come soggetti nelle questioni che riguardano il loro benessere. In una situazione che si configura come di transizione, la deontologia medica ha ancora una sua utilità; ma in futuro dovranno essere raggiunte nuove frontiere etiche, in cui le prospettive unilaterali della deontologia saranno incluse in una prospettiva più ampia dell’interazione sociale.
39
Capitolo Terzo
IL RIFERIMENTO ALLA COSCIENZA NELLA PROFESSIONE MEDICA
Quando qualcuno nell’esercizio della sua professione si appella alla coscienza suscita istintivamente rispetto. La coscienza individuale nella gerarchia di valori del nostro universo culturale occupa il posto più alto. Ad essa si attribuisce la decisione ultima. Dalla coscienza dipende la qualità etica del comportamento: ciò che è in accordo con essa ha un valore morale positivo; l’infrazione del dettato della coscienza inquina la moralità anche di un atto in sé buono. Il ricorso alla coscienza è circonfuso da un’aura ancor più sacrale quando si tratta della professione medica, dal momento che il medico ha potere sulla vita di altri esseri umani.
La coscienza è, per sua natura, un’istanza insindacabile. Ciò non la sottrae però a qualsiasi forma di critica. In particolare, non può essere elusa la questione fondamentale: c’è veramente la coscienza dietro gli appelli alla coscienza? I “maestri del sospetto” ci hanno fatto aprire gli occhi sull’abisso esistente tra il linguaggio e la realtà. Non sempre siamo soggettivamente coscienti delle mistificazioni. Talvolta ci limitiamo a considerare le relazioni sociali apparenti, senza avvertire la realtà sociale di sopraffazione che nascondono. Oppure ci accontentiamo di ciò che le difese del pensiero cosciente lasciano filtrare, ignorando la realtà psichica repressa. Non soltanto chi è andato a scuola dal marxismo e dalla psicoanalisi è stato educato al sospetto sistematico. Anche l’uomo della strada ha imparato a diffidare delle parole altisonanti, a distinguere tra ciò che il linguaggio rivela e ciò che nasconde.
Le mistificazioni possono essere involontarie; per questo sono cosi pericolose. Specialmente quando coinvolgono la coscienza, il frutto più sublime e più fragile che l’educazione etica dell’umanità ha prodotto.
40
Corruptio optimi pessima: lo sapevano anche gli antichi.
Poiché dunque l’appello alla coscienza può dar adito a mistificazioni, grossolane o raffinate che siano, è opportuno sottoporre l’obiezione di coscienza in campo medico a una riflessione critica. Non al fine di screditare l’obiezione, o per scoraggiare il ricorso ad essa, ma piuttosto per mettere in evidenza le condizioni che la rendono autentica e credibile; dunque, in sostanza, per promuovere un’obiezione di coscienza di qualità etica ineccepibile.
Il nostro interesse non va alla casistica, bensì al processo psicologico-sociale dell’obiezione di coscienza in quanto tale. L’appellarsi alla coscienza è come un sasso gettato in acque stagnanti, una provocazione alla prassi comune. Lasciando le nostre riflessioni estendersi come il gioco dei centri concentrici sull’acqua, entreremo in un complesso di interrogativi inquietanti che concernono» l’esercizio della professione, le motivazioni del comportamento, l’esperienza religiosa. In sostanza, sottoporremo l’appello alla coscienza a una progressiva chiarificazione semantica a un triplice livello: deontologico, etico e religioso.
1. La coscienza come istanza etica
Per situarci d’emblée nell’ordine della coscienza etica pensiamo alla situazione che evoca l’accorata domanda: “Dottore, che decisione prenderebbe se si trattasse di sua figlia o di sua moglie?”. La domanda presuppone che, oltre alla coscienza professionale, esiste un’altra istanza. La cosiddetta “coscienza professionale” non è altro che l'ethos che caratterizza una determinata professione. A un’analisi ulteriore l'ethos professionale risulta dotato di una duplice rilevanza: giuridica ed etica. Il primo punto di vista costituisce il diritto professionale, strutturato come un insieme di prescrizioni di legge legate a una determinata professione. Esso specifica le obbligazioni di chi la esercita. Le infrazioni di tale normativa sono perseguibili penalmente. Ma l'ethos professionale non è ristretto a quanto può portare di fronte al giudice. C’è anche un insieme di doveri che dipende da un’altra fonte, quella che abbiamo chiamato l’istanza etica. Sono i doveri che costituiscono la deontologia di una professione. Oltre a questa coscienza professionale, esiste dunque un’istanza superiore, a cui si può far appello in situazioni eccezionali. Se
41
il medico è interpellato in quanto medico, può lasciarsi guidare dall'ethos deontologico; ma, interpellato in quanto uomo, e dovendo prendere una decisione “in coscienza”, dovrà ispirarsi a un altro ordine di valori.
La domanda da cui siamo partiti evidenzia alcuni tratti che connotano la coscienza morale. Questa è una relazione intrinseca dell’uomo con se stesso, grazie alla quale l’individuo può conoscersi in modo immediato e privilegiato, e perciò giudicarsi con sicurezza. L’accesso alla coscienza di un altro non può essere forzato; la coscienza non si apre dall’esterno ma solo dall'interno, per libera automanifestazione del singolo all’altro uomo. La sfera d’interiorità costituita dalla coscienza è avvertita come realtà superiore e privilegiata. In quanto organo per la veracità e l’onestà, conferisce alle azioni caratteristiche peculiari: le rende libere, responsabili; in una parola: morali.
In questa sommaria descrizione della coscienza si sarà riconosciuta la concezione che, dall'illuminismo in poi, rappresenta l’ideale più alto di civiltà nell’ambito della cultura occidentale. L’uomo emancipato è quello che ha superato l’“etoronomia” — sia quella parentale del bambino che quella sociale del primitivo — per accedere all’“autonomia”, vale a dire una condotta guidata dalla coscienza. Un’azione compiuta secondo coscienza suscita un rispetto che confina con la venerazione. Si può addirittura parlare di una “religione della coscienza” come caratteristica della cultura illuministica di cui siamo figli.
Nessuno si sognerebbe oggi di contestare il ruolo preminente attribuito alla coscienza nella gerarchia di valori. Prima però che la coscienza possa rivendicare i suoi privilegi di istanza inappellabile e suprema, deve rispondere ad alcune questioni della massima importanza. Quali sono le decisioni che vengono veramente prese in coscienza? Esistono validazioni in grado di accreditare o inficiare gli appelli alla coscienza? Come si forma e come si evolve la coscienza?
Iniziamo dall’ultima questione. Parlare di formazione della coscienza implica una prospettiva dinamica ed evolutiva, secondo la quale la coscienza non esiste come un elemento immutabile, simile ai tratti trasmessi tramite il meccanismo dell’eredità genetica. La coscienza esiste, piuttosto, in potenza; spetta all’educazione creare le condizioni per il suo sviluppo. La coscienza del bambino non si lascia comparare con quella dell’adulto. Gli adulti sono cosi lontani dal continente perduto dell’infanzia che stentano a rendersi conto che persino la nozione di “intenzionalità”
42
è acquisita. Per l’adulto la presenza di un’intenzione, pur non essendo sempre un fatto percettibile, è però un dato di cui occorre sempre tener conto per valutare la qualità di un’azione. Non cosi, invece, per il bambino. Gli studi di J. Piaget 32 hanno dimostrato che il pensiero infantile è per lungo tempo permeato di realismo, che comporta il primato dei dati percettivi su quelli rappresentativi. Il bambino deve percorrere un lungo cammino prima di giungere a scindere la presenza di un’intenzione dal risultato concreto dell’azione che essa suscita o guida, e a rendersi cosi conto che a una stessa intenzione possono corrispondere risultati diversi o, viceversa, che può verificarsi uno stesso risultato benché le intenzioni siano diverse. A Piaget dobbiamo l’ipotesi dell’esistenza di due moralità: una eteronoma o di costrizione, l’altra autonoma e fondata sulla cooperazione. Secondo la prima, che si ritrova nei bambini più piccoli, ciò che la regola o l’adulto comandano deve essere fatto e la disobbedienza è comunque un atto riprovevole; secondo la morale autonoma, che si impone più tardi sostituendosi — talvolta non interamente — alla prima, una regola ha quel valore che concordemente si decide di darle.
Affermando che la persona adulta e matura è solo quella che si lascia guidare nel suo agire da motivazioni di coscienza, si ottiene senza difficoltà il consenso generale. Non esiste invece un modello di sviluppo della coscienza che si imponga in modo indiscutibile. A titolo orientativo ci riferiamo a quello proposto da Charles Hampden-Turner, che si ispira alle teorie della personalità proposte dalla corrente nota come “psicologia umanistica” 33. Secondo questo modello, prima di giungere all’azione orientata alla coscienza si passa per numerose fasi, che possono essere cosi schematizzate:
― Orientamento di obbedienza (analogo alla moralità eteronoma di Piaget). L’azione è motivata dalla volontà di evitare punizioni o fastidi. Deferenza somma verso il potere; concezione oggettiva e non ancor soggettiva della responsabilità (Piaget lo chiama “realismo morale”: convinzione che commettere certi atti è cosa in sé cattiva e costituisce una colpa, indipendentemente da ogni considerazione del contesto psicologico che precede o accompagna il loro svolgersi).
― Orientamento egoistico strumentale. L’azione è orientata al soggetto stesso e ai propri bisogni: è giusta quella che li soddisfa. Questo atteggiamento
43
non esclude eventualmente l’orientamento a bisogni degli altri. Determinante in questa fase è la concezione che non esistano valori assoluti: ogni valore è relativo ai bisogni e alle prospettive del singolo agente.
― Orientamento al ruolo. La formazione della personalità individuale passa attraverso l’accettazione di un ruolo. Questa accettazione permette di prevedere le azioni degli altri e di adattarvi la propria condotta. Una condotta orientata al ruolo implica la conformazione alle immagini stereotipate della maggioranza e l’intenzione di adattarsi al giudizio sociale su ciò che è naturale per un certo ruolo. Prototipo di questo atteggiamento è il bambino adattato che, pur di piacere, compiace. In ognuno che sia passato attraverso il processo di socializzazione è presente il “bravo ragazzo”, teso a riscuotere l’approvazione altrui.
― Orientamento alla legge. È l’orientamento a mantenere l’autorità e l’ordine sociale come fine a se stesso. Ispira il comportamento di coloro che “fanno il proprio dovere”, ne sono fieri e appagati. La concordanza personale con quanto si presenta con le caratteristiche di “ordine” esaurisce le esigenze morali presenti a questo livello.
― Orientamento al contratto sociale. Il dovere è qui definito in termini di contratto. E presupposto che ci si sia resi conto che nelle norme e nei ruoli c’è un elemento arbitrario, che dipende da un accordo sociale. L’azione ispirata ad esso intende evitare di violare il volere o i diritti degli altri e vuol favorire la volontà e il benessere della maggioranza.
― Orientamento ai principi o alla coscienza. È il comportamento di chi, al di là dell’orientamento alle regole sociali effettivamente ordinate, si ispira a principi di libera scelta personale. A questo livello il principio direttivo delle azioni è la coscienza. Il giudizio che si basa sui principi e sulla coscienza è la forma più elevata di giudizio morale. È proprio della persona matura, che ha completato la formazione della propria coscienza.
L’obiezione di coscienza è un caso particolare, di origine conflittuale, del comportamento morale adulto, ispirato ai principi etici. Prima però di considerare questo caso particolare, completiamo il quadro della personalità dell’uomo eticamente maturo. La persona matura, che si ispira ai principi, non equivale al “dogmatico”. Utilizzando la distinzione messa in uso da Rokeach 34, diremo che, a differenza del dogmatico è dotata di un quadro mentale “aperto”, non “chiuso”. Ciò vuol
44
dire che la sua percezione abbraccia tutta la realtà, compresa l’intera gamma dei dilemmi. La sua è una percezione decentrata, capace di cogliere i bisogni degli altri, anche quelli che contraddicono i propri.
Grazie a una personalità tanto forte da non conformarsi alle aspettative di ruolo imposte dall’ambiente culturale, la coscienza adulta può affrontare la drammatica eventualità della situazione di conflitto. Può avvenire infatti che il soggetto etico si trovi nella situazione in cui l’orientamento ai principi e alla coscienza si oppone alle altre istanze. Non è una eventualità da presumere con troppa facilità. Normalmente le varie istanze si integrano abbastanza armonicamente, o quanto meno convivono; e solo una minima parte dei nostri atti morali fa appello diretto alla coscienza. Ma il caso eccezionale in cui l’orientamento alla coscienza si opponga agli altri orientamenti può crearsi. Allora la struttura etica è messa alla prova e il soggetto si trova di fronte a un dilemma: o sacrifica il riferimento alla coscienza, appoggiandosi a una delle altre motivazioni (secondo lo schema gerarchico che abbiamo proposto: esegue il comando che gli evita la punizione, si orienta secondo i propri bisogni, fa ciò che ci si spetta da lui, ciò che prescrive la legge, agisce secondo gli impegni che si è assunto verso la società); oppure investe tutto il suo potenziale morale sui principi, affrontando le conseguenze del conflitto. Le quali possono essere, in una tragica escalation: la soppressione del contratto sociale, lo scontro con il rigore delle leggi vigenti, la disapprovazione sociale per il non adempimento delle aspettative di ruolo, il disagio personale e, infine, la punizione. Due esempi luminosi di opposizione per motivo di coscienza, con la morte inflitta come epilogo, sono le vicende di Socrate e di Tommaso Moro.
La semplice menzione dei due simboli più noti, nella nostra cultura, della trascendenza della coscienza ci fa intravvedere quale straordinaria efficacia possa avere l’obiezione di coscienza. Il principio per amore del quale si è disposti a mettere in gioco ogni cosa sollecita negli altri una reazione di conferma, che travolge i contratti sociali, le leggi e le aspettative di ruolo; tale principio può diventare una nuova base per la convivenza civile, una nuova legge, un nuovo modello di ruolo. Non è retorica affermare che i progressi etici dell’umanità non sono avvenuti per accumulazione progressiva, come quelli scientifici, ma per salti qualitativi dovuti a coscienze singolari, come appunto quelle di Socrate e di Tommaso Moro (se i due esempi sembrano eccessivamente patetici per la tragica fine degli obiettori, si pensi come situazione emblematica a Francesco
45
d’Assisi, nudo di fronte al padre: è anche questa un’immagine fortemente espressiva della radicalità cui può portare la motivazione di coscienza).
La descrizione fenomenologica della motivazione di coscienza che abbiamo sviluppato come risposta alla domanda iniziale sulla formazione della coscienza ci offre gli elementi per discernere un'obiezione di coscienza da ciò che non lo è. Non è sufficiente che ci sia un atto di ribellione alle leggi e al contratto sociale perché si abbia obiezione di coscienza. La ribellione può manifestarsi tanto nella fase più formalmente etica quanto nelle fasi precedenti, in cui il comportamento si orienta ad altro che ai principi etici. Se la persona non si è maturata normalmente fino a raggiungere la capacità di un’azione orientata ai principi, non si può parlare di obiezione di coscienza. Quante persone raggiungono questo stadio? Il nostro narcisismo culturale, avvezzo a mettere il comportamento dell'homo sapiens su un piedistallo tanto più elevato di quello dell’animale, vorrebbe lasciarsi illudere che la motivazione di coscienza è l’atmosfera etica in cui si muove abitualmente l’umanità. Probabilmente la realtà è ben diversa. Pensiamo all’anestesia delle coscienze, al conformismo e all’adattamento generalizzato che costituiscono la triste base su cui poggiano tutti i regimi totalitari. Motivo di riflessioni non meno deprimenti ci offrono i risultati dell’esperimento di Stanley Milgram sull’acquiescenza all’autorità. I soggetti sperimentali ai quali fu ordinato di somministrare scariche elettriche a cavie umane (benché in realtà, all’insaputa dei protagonisti dell’esperimento, si trattasse di attori abili nel mimare il dolore), elevarono il voltaggio, su comando, fino a livelli mortali per la cavia. Soltanto pochissimi soggetti rifiutarono le direttive degli sperimentatori. Evitiamo di sollecitare conclusioni troppo ampie dall’esperimento, anche se è stato confermato da esperimenti analoghi condotti in Italia; una cosa, tuttavia, appare certa: non tutti, forse addirittura poche persone, sono capaci di ribellarsi. Se la capacità di opporre resistenza per motivo di coscienza fosse cosi diffusa come la fede nel valore della vita umana, i risultati degli esperimenti sull’acquiescenza agli ordini immorali sarebbero ben diversi (e non ci sarebbero stati né Auschwitz né l’arcipelago Gulag).
È facile passare da queste considerazioni al campo specificamente sanitario. I suoi operatori professano il principio dell’intangibilità della vita e svolgono un’attività volta a fini terapeutici; eppure si trovano spesso, di fatto, al centro di un campo di forze contrarie alla vita. Contrariamente alle attese, le obiezioni di coscienza non sono frequenti. Se
46
consideriamo con realismo quanto raramente il comportamento umano si orienti ai principi e alla coscienza, non troveremo nel fatto un motivo per stracciarsi le vesti. Del resto, in base alle osservazioni precedenti sappiamo di non essere in grado di inferire con certezza dal fatto in sé della ribellione ad attese di ruolo o a prescrizioni legali un’obiezione di coscienza. Per definizione la coscienza è autoevidente ed autoriferentesi: essa esclude perciò qualsiasi forma di diretta verifica dall’esterno. Un comportamento di ribellione potrebbe essere orientato a tutt’altro che alla coscienza. A livello sociale le questioni di coscienza sono circondate da un velo di agnosticismo: “ignoramus et ignorabimus”. La società infatti, pur considerando la motivazione di coscienza come il vertice supremo della moralità umana, si regge non sulla coscienza, bensì sugli altri ordini di moralità. Non sarebbe possibile una convivenza civile se l’unico ordine di riferimento fosse il dettato della coscienza individuale. Ciò ci permette di capire il carattere irritante che ha, a livello sociale, l’obiezione di coscienza. L’appello alla coscienza è un fatto anomalo che sembra sospendere altre forme di moralità che garantiscono la convivenza civile, in particolare l’ordinamento giuridico e il contratto sociale. Tanto più che la coscienza individuale è un’istanza che sfugge a qualsiasi controllo sociale (di cui le riserve nei confronti della disposizione che accompagna la legge del 1973 circa il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare, secondo cui una commissione deve giudicare le motivazioni di coscienza; la disposizione contraddice il concetto stesso di obiezione di coscienza).
Quali risorse restano alla società per difendere se stessa dalle obiezioni di coscienza spurie? La possibilità delle verifiche indirette. Il gruppo sociale, il quale non può rinunciare alla collaborazione dei suoi membri, per evitare che l’obiezione di coscienza sia solo la copertura di un disimpegno di comodo, può avanzare richieste di un impegno compensatorio. Cosi nel caso dell’obiezione di coscienza al servizio militare la comunità dovrà richiedere una equivalente e impegnativa prestazione civile (purché non diventi in pratica una forma di penalità). Quando poi l’obiezione cada su alcuni punti che il gruppo ritiene di valore sostanziale per la convivenza civile, la società, pur non potendo richiedere un’esecuzione contro coscienza, potrà esigere che si subisca la pena o si esca dal gruppo 35. È un’eventualità che, come abbiamo illustrato sopra, è insita nella nozione stessa di obiezione di coscienza.
47
Questi principi etici possono essere applicati ai casi di obiezione di coscienza che riguardano i medici nell’esercizio della loro professione; in particolare alla prestazione della loro opera per procurare l’aborto. Tutte le legislazioni dei paesi democratici che hanno varato normative in proposito hanno previsto la figura giuridica del medico obiettore di coscienza (alcune l’hanno estesa anche ad istituzioni sanitarie in quanto tali). Più che le concrete determinazioni di tali norme, ci interessa valorizzare il fatto in sé dell’obiezione prevista dal legislatore e la tensione tra la società legiferante e il medico obiettore che ciò presuppone. Si crea cosi uno spazio per l’inquietudine e l’interrogazione. Il gruppo sociale, ammettendo nella propria normativa, in maniera del tutto anomala, la possibilità dell’obiezione, confessa la propria insicurezza. Il patto sociale non è perfetto, se la coscienza di alcuni può essere prevedibilmente offesa da qualche norma e la legge stessa, che pur dovrebbe garantire l’armoniosa convivenza, si vede costretta a prevedere vistose deroghe. Ammettendo l’obiezione di coscienza, la società proclama implicitamente che si tratta di una situazione transitoria e di emergenza, che reclama di essere superata mediante una crescita qualitativa della moralità comune.
La tensione dialettica tra coscienza individuale obiettante e normative sociali apre inoltre uno spazio di interrogazione per colui che obietta. È la sua una vera obiezione di coscienza? Per essere tale non basta infatti che l’azione obbedisca a una qualsiasi convinzione, ma deve derivare da un principio fondamentale. Questo, a sua volta, non esiste isolato, ma fa corpo con tutto l’organismo etico dell’individuo. Non si può, se non a prezzo di una contraddizione insanabile, difendere un principio in una circostanza e poi rinnegarlo allegramente in tutto il resto della propria attività professionale. Oltre i casi di più smaccata ipocrisia, c’è tutta una gamma di incoerenze personali e istituzionali che attendono la seria verifica dell’obiezione di coscienza per essere messe in luce. Di fronte al tribunale della coscienza, si sa, ognuno è solo; ma l’essere il testimone della propria immoralità può essere una ben dura condanna, di quelle che si scontano a vita.
2. L’obiezione per motivi religiosi
L’obiezione di coscienza per motivi religiosi è uno dei casi in cui l’autorealizzazione etica dell’individuo tocca i vertici. È noto come storicamente
48
sia stato il protestantesimo a rivalutare l’obiezione di coscienza come espressione dello spirito cristiano; con la protesta in nome del Vangelo stesso il libero esame, mediato dalla coscienza individuale, ha spezzato la monolitica unità garantita dall’istituzione ecclesiastica. In ambito cattolico si è fatto a lungo resistenza al principio della libertà di coscienza. Tanto la concezione protestante quanto quella illuministica erano giudicate come un’indebita semplificazione dell’organismo etico, di cui fa parte essenziale il riferimento all’autorità. Il concilio Vaticano II ha ratificato un processo di rivalutazione della coscienza individuale avvenuto anche tra i cattolici. Con la dichiarazione Dignitatis humanae l’istanza dottrinale di vertice, il magistero, ha preso ufficialmente posizione a favore della libertà religiosa; la dichiarazione, pur non richiamandosi all’obiezione di coscienza, afferma i principi dai quali deriva il diritto all’obiezione.
I problemi suscitati dalla coscienza religiosa sono numerosi e delicati. Ciò che interessa il nostro assunto è la possibilità di un’obiezione di coscienza nella professione medica in nome di un’incompatibilità con i propri principi religiosi. Procederemo come abbiamo già fatto per le altre due istanze, quella deontologica e quella etica. Ciò che ne risulterà non sarà una casistica spicciola, ma piuttosto una specie di radiografia dell’obiezione stessa. Il nostro scopo è di mostrare quali sono le condizioni che garantiscono la consistenza interna e l’accettabilità sociale dell’obiezione religiosa.
Specifichiamo in primo luogo che l'appello alla propria coscienza religiosa può avere valenze diverse. In sé, esso dice riferimento alle istanze dottrinali e morali della comunità di fede religiosa a cui si appartiene (dal momento che una religione non è mai un fatto puramente individuale). Tuttavia il legame con la comunità e il suo apparato dottrinale-autoritario può essere di qualità molto diversa. L’autenticità e la profondità del legame ammettono una vasta gamma di possibilità. Per prendere gli estremi, si può andare dall’adesione nominale — a cui magari possono non essere estranei interessi materiali o vantaggi sociali —, all’identificazione sofferta (si pensi al caso di Galileo, preso nella morsa del contrasto tra la propria visione scientifica e la fedeltà all’autorità dottrinale della chiesa). Anche qui, come già nel caso dell’appello ai principi etici, la possibilità di una verifica obiettiva del grado di autenticità è esclusa a priori. La possibilità del “tartufismo” è purtroppo da mettere in conto, anche se non può essere una ragione sufficiente per accogliere con sospettoso pregiudizio qualsiasi riferimento a principi religiosi.
49
Solo il credente stesso può sapere se si riferisce unicamente alla struttura esterna del gruppo confessionale, oppure ne partecipa l’intima sostanza in modo personale; in altri termini: se la sua religiosità è pura appartenenza sociologica, oppure si fonda su un’esperienza religiosa.
Quando l’appello alla coscienza attinge le profondità esistenziali dell’esperienza religiosa personale, viene a qualificarsi come un momento che ha la stessa tessitura etica del comportamento motivato da principi individuali. L’esperienza religiosa in quanto tale è difficile da definire. Fa parte di una di quelle esperienze psicologiche che Abraham Maslow ha definito peak experiences; vale a dire esperienze di ordine superiore, che permettono all’individuo di compiere sintesi di coscienza improvvise, panoramiche e fuori dall’esperienza comune 36. Esperienze di questo tipo vengono sentite come auto-validanti, auto-giustificanti, recanti in sé il proprio intrinseco valore.
Secondo I.T. Ramsey, per intendere a quale tipo di situazioni fa riferimento l’esperienza religiosa bisogna unire insieme due fattori: “discernimento” e “impegno”. Il primo può essere illustrato con quelle situazioni, familiari alla psicologia della Gestalt, in cui “qualcosa scatta”, “il ghiaccio si spezza”, una persona “prende vita”; l’impegno è una risposta incondizionata a qualcosa “che è al di fuori di noi” 37. Si tratta, in ogni caso, di approssimazioni. Non può esistere una descrizione che metta in grado di capire un’esperienza senza farne l’esperienza.
L’esperienza è la sostanza della fede. Questa ha come unico parametro interno di autenticità l’esperienza religiosa, in quanto nasce da essa o tende verso di essa. Ciò non esclude il momento comunitario e la conseguente tensione tra spontaneità e normatività delle istituzioni. Ma i due termini devono essere lasciati coesistere dialetticamente; un modo costruttivo di risolvere la tensione non potrebbe essere quello di sopprimere uno dei due.
In che senso l’esperienza religiosa ha un’incidenza nella questione dell’obiezione di coscienza? Ci pare di poterlo indicare nel fatto che l’esperienza religiosa costituisce una fonte di motivazione etica. In quanto espressione di somma autorealizzazione umana (una realizzazione che
50
in alcune religioni storiche è esplicitata come dono connesso all’incontro con il “Tu” divino), l’esperienza religiosa è percepita dal credente come un’esistenza nuova, da cui deriva un’esigenza morale nuova. Cambia il suo essere, cambia il suo agire. Lo sboccio della novità, elemento comune ai vissuti esistenziali culminanti, è esigente. Nell’esperienza si esprime un’autorità superiore alla quale il credente non può — non vuole sottrarsi, perché con essa si identifica. Il comportamento etico dell’uomo religioso si fonda sull'autorità di Dio, come istanza irriducibile alle altre. È difficile definire in termini antropologici come sia determinata la coscienza dell’uomo che l’esperienza religiosa ha aperto a una dimensione nuova dell’essere. Non si tratta di “autonomia”, vale a dire la conquista che l’individuo post-illuministico ha strappato alle determinazioni sociali e che difende come “libertà di coscienza”; neppure si tratta dell’“eteronomia” della coscienza non emancipata. Bisogna ricorrere a un termine proposto da alcuni teologi: “teonomia”, della coscienza. Si tratta di un rapporto di “libera dipendenza” dall’istanza autoritaria suprema, un rapporto esperibile ma non descrivibile.
La descrizione delle coscienze normate dal loro rapporto con Dio ha un carattere astratto. Di fatto però noi abbiamo conosciuto l’esistenza di tali coscienze non per opera di speculazione; queste coscienze si sono storicamente mostrate. Pensiamo a Cristo di fronte a Pilato. Due universi etici polarmente opposti. Non è soltanto la qualità delle azioni che li fa divergere, ma, in radice, l’autorità etica a cui la loro coscienza fa riferimento. Cristo fa osservare a Pilato che non avrebbe autorità su di lui se non gli fosse stata data da chi gli sta sopra; il suo potere è mutuato da un organismo politico-sociale (nel caso, di oppressione imperialista!) che lo sostiene e lo giustifica. Di fronte a lui Gesù di Nazaret è un uomo di “un altro mondo” non solo metafisico, ma etico. Il suo potere non dipende da un’istanza gerarchica esterna: lo ha dentro di sé, in quel centro di esperienza esistenziale in cui è uno con Dio. Pilato, il detentore del potere, è eteronomamente determinato come uno schiavo; Gesù, il suddito, è teonomamente libero.
Considerazioni analoghe si potrebbero sviluppare in margine alla disputa tra Gesù e i sommi sacerdoti a proposito della sua autorità (cfr. Mc. 11, 27-33). I rappresentanti dell’istituzione religiosa, che avevano con l’autorità divina un rapporto basato sulla tradizione e sulla formalità legale e gerarchica, non potevano capire di dove venisse l’autorità di chi portava in sé la salvezza di Dio.
51
Gli ebrei, tuttavia, non escludevano a priori l’esistenza di esperienze di Dio che fondassero una nuova esigenza spirituale ed etica. Tutta la loro storia sacra, in particolare la vicenda dei profeti, stava a dimostrarlo. Per questo l’“obiezione di coscienza” dei primi discepoli di Gesù (“Se sia giusto davanti agli occhi di Dio obbedire a voi piuttosto che a Dio, giudicatelo voi stessi. Quanto a noi, non possiamo non rendere pubblico quanto abbiamo visto e ascoltato”: Atti 4, 19-20) fece particolare impressione sul sinedrio; e in seguito, dietro l’intervento di Gamaliele, espressione della saggezza spirituale del popolo di Dio (Atti 5, 34-39), fu deciso di rinunciare a perseguirli con la forza.
La coscienza religiosa, dunque, si modella essenzialmente sull’evento dell’esperienza religiosa, più che sul precetto. Ha bisogno anche del precetto come pedagogo; ma il precetto da solo è uno scheletro senza vita, un’armatura opprimente. La legge è solo pallida memoria dell’evento. La coscienza che si riferisce esclusivamente alla legge non conosce la creatività. Un ultimo elemento: l’autorità morale radicata nell’esperienza religiosa costituisce l’individuo nella sua unicità, ma non lo isola dalla comunità. Non crea degli “illuminati”, sganciati da qualsiasi riferimento al gruppo con cui condividono l’esperienza religiosa. La convinzione intima che si ha davanti a Dio è un diritto inviolabile, che assegna alla coscienza convinta un primato assoluto. Essa non è tuttavia l’ultima istanza. La carità fraterna è l’orizzonte più universale, che supera anche i diritti della coscienza. Paolo ha formalizzato questi principi intervenendo nella questione del diritto dei cristiani di mangiare la carne sacrificata agli idoli (1 Cor. 8). Il cristiano che ha incontrato il Dio vivente sa che gli idoli sono un nulla; in coscienza è perciò libero di mangiare la carne loro sacrificata. “Badate però — continua l’Apostolo — che questa vostra libertà non diventi pietra d’inciampo per i deboli... Peccando in tal modo contro i fratelli e offendendo la loro debole coscienza, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò carne in vita mia per non scandalizzare il mio fratello”.
Anche se rinunciamo ad applicazioni concrete, è facile intuire quale incidenza possa avere il riferimento alla coscienza religiosa nella prassi professionale. Può, ad esempio, un medico trovare nel proprio vissuto religioso — nella sua esperienza religiosa privata o in quella della comunità di fede di cui è parte — un motivo per obiettare in coscienza contro prestazioni richiestegli? Certamente sì. Tuttavia l’articolazione delle considerazioni precedenti ci autorizza a dire che l’obiezione di coscienza per
52
motivi religiosi deve essere trattata con estrema delicatezza. Essa mette in moto un insieme di gravi interrogativi circa la qualità e la profondità del vissuto religioso dell’individuo, il suo rapporto con l’istituzione religiosa, i diritti della verità e quelli della carità, le interferenze tra la coscienza del singolo e la legislazione sociale. La qualità etica e religiosa di un tale atto esige che sia trattato con il massimo rispetto, senza sollecitazioni subdole, senza pressioni indebite. Una delle acquisizioni etiche più indiscutibili su cui si basa la cultura umanistica è che l’uomo è fine, non mezzo. Questo principio acquista la sua massima forza quando è riferito a quell’atto che riconosciamo come più specificamente umano, vale a dire il comportamento motivato in coscienza, religiosa o laica che sia. L’obiezione di coscienza non deve essere strumentalizzata per qualsivoglia battaglia ideologica. Sarebbe una violenza fatta alla coscienza, un “peccato contro lo Spirito”.
In conclusione, possiamo sintetizzare l’intero sviluppo delle riflessioni affermando che l’obiezione di coscienza può essere tanto il più alto atto di moralità di una persona, quanto un atto situabile a livello premorale; l’obiezione di coscienza deve essere perciò il punto di partenza di un processo di discernimento soggettivo e di verifica indiretta da parte della società.
Con ciò non abbiamo dato una risposta diretta ai problemi concreti che si pongono. Ma un esame sereno e profondo delle implicazioni etiche dell’obiezione di coscienza, delle sue grandezze e delle sue miserie, è più costruttivo; è inoltre un bisogno urgente dell’ora presente, se vogliamo evitare che la passione di parte giunga a servirsi delle coscienze come mezzo. Nell’attuale crisi dei valori la coscienza va difesa come un bene assoluto: perché se il sale diventa scipito, con che gli si ridarà sapore?
53
Capitolo Quinto
LA FORMAZIONE ETICA DEL MEDICO:
UN BILANCIO DEI NUOVI ORIENTAMENTI
1. Una risposta alla crisi della medicina
L’erogazione dell’assistenza sanitaria è accompagnata da un’insoddisfazione che minaccia di diventare ormai strutturale. Non si tratta più di disfunzioni occasionali o isolate, ma dell’incapacità cronica della medicina moderna di rispondere alla domanda del consumatore. E il disagio aumenta. Lo si è visto nel nostro paese quando l’istituzione dei “tribunali dei diritti del malato” ha permesso alle voci degli utenti stessi di farsi udire direttamente. La raffica delle accuse non risparmia nessuno: primari e personale ausiliario, medici e infermieri, tutti legati insieme dal cemento costituito dalle carenze dell’iniziativa politica.
L’insicurezza serpeggia nel mondo medico, in quella parte almeno che si lascia mettere in discussione. Ci si domanda se non sia necessario intervenire con una profonda revisione della formazione che ricevono i medici. Cominciando da quella scientifica. Il curriculum medico è tra i più lunghi e sfibranti. Eppure, anche i migliori studenti, giunti al termine, si sentono sostanzialmente inadeguati per i compiti che li attendono. Il volume delle conoscenze biomediche raddoppia ogni venti anni; ciò che è apparso soltanto pochi anni fa nelle riviste di ricerca scientifica è già parte essenziale di quello che deve essere memorizzato in una formazione tipica. E per di più agli studenti di medicina non viene insegnato ad elaborare criteri per discernere il valore delle nuove acquisizioni. “La metà di tutto quello che vi viene insegnato oggi — è la battuta che circola nelle facoltà di medicina americane — è sbagliato; purtroppo, non sappiamo quale metà”. In discussione è soprattutto l’assunto epistemologico
54
di fondo che regola la scienza medica: una conoscenza sempre più analitica — to know more and more, about less and less — riesce ancora a cogliere il fenomeno umano, normale o patologico che sia? La scienza medica non rischia di smarrire il suo oggetto, vale a dire l’uomo malato?
Una discussione ancor più radicale investe quella parte della formazione che riguarda gli aspetti relazionali e interpersonali. Nell’ambito linguistico inglese gli aspetti del comportamento medico che sono rivolti al malato in quanto essere umano ricevono talvolta il nome di componente “umanistica” della medicina. “Come possiamo formare i medici ad essere più umanistici?”: questa domanda, che costituisce il fulcro di un recente congresso americano 38, lascia trapelare la preoccupazione per una medicina che sembra impoverirsi sul versante umano in misura proporzionale all’aumento dell’efficienza tecnica. Dal medico ci si aspetta un atteggiamento che sia una miscela di scienza e di umanità. La richiesta è tra le più ovvie e tradizionali. Oggi però non ci si limita ad auspicare che il medico coltivi, di propria iniziativa, anche questo lato della sua professione: si sente l’urgenza di provvedere alle carenze mediante un insegnamento adeguato. L’insegnamento dell’etica medica vuol essere appunto una risposta alla denunciata emorragia d’anima della medicina moderna.
Se l’esigenza è sentita ovunque, le realizzazioni invece sono lungi dall’essere omogenee. La maggiore fioritura di iniziative è avvenuta nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti. In poco più di un decennio l’etica medica è diventata una disciplina di tutto rispetto. Ormai non può più essere confusa con i corsi di “medical ethics” che talvolta venivano impartiti nelle facoltà di medicina americane, ma per trasmettere regole di “etichetta” medica. Gli studenti di medicina venivano socializzati nel loro nuovo ruolo, imparando come avere relazioni corrette con i professori, con i colleghi, e infine con i pazienti 39. Attualmente ai corsi di etica medica, con nuovi contenuti e finalità, arride negli USA
55
una larga popolarità, e non solo nelle scuole di medicina. La bioetica occupa il posto centrale dell’interesse che era tenuto negli anni ’60 dall’etica della guerra e dei diritti civili 40. Una quantità di iniziative di alto livello accademico affiancano l’insegnamento. Tra le più accreditate segnaliamo: il “Kennedy Institute of Human Reproduction and Bioethics”, presso PUniversità di Georgetown, cui si deve la pubblicazione dell’Encydopedia of Bioethics, in quattro volumi; l’“Institute of Society, Ethics and the Life Sciences”, il quale pubblica una rivista, l'Hastings Center Report, con bibliografia selezionata e annotata; il Journal of Medical Ethics, che ha iniziato ad apparire nel 1975 e si è subito imposto tra gli organi più autorevoli. Fin dai primi fascicoli della rivista sono apparsi periodicamente articoli che fanno il punto sull’insegnamento dell’etica medica nei diversi paesi: Svezia, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti. Sono state presentate esperienze pilota e tentativi originali di assicurare la formazione etica dei medici. Gli interrogativi volta a volta emergenti — perché introdurre l’etica medica nel curriculum dei medici e come insegnarla; a chi spetta impartire questo insegnamento; in che modo valutare l’abilità acquisita dallo studente — conducono l’interesse dell’osservatore verso alcune questioni focali che hanno una rilevanza non solo pratica, ma anche epistemologica. Attorno a queste organizzeremo di preferenza la nostra rassegna.
2. L’etica medica, tra ideologia e pragmatismo
Una certa resistenza a riconoscere all’etica il diritto di cittadinanza in medicina è motivata dal timore che venga turbato lo statuto di oggettività che la medicina pretende in quanto scienza. Tuttavia anche i più attardati ammiratori del positivismo ottocentesco non possono chiudere gli occhi sul fatto che la medicina non è solo scienza, ma anche prassi: non è volta solo a stabilire la natura della realtà, ma a cambiarla. Se per etica intendiamo un sistema inteso a regolare il comportamento umano, al fine di salvaguardare e realizzare determinati valori, il riferimento
56
all’etica in medicina è imprescindibile. Non è dall’etica in quanto tale che l’esercizio della medicina ha qualcosa da temere, bensì dal moralismo. Questo incombe quando un’ideologia impone norme di comportamento deducendole aprioristicamente da teorie relative alla natura dell’uomo e della società, e facendo in qualche modo violenza alla complessità dei fatti. Il timore dei medici che il campo del loro operare sia in qualche modo colonizzato da un’istanza esterna, unica accreditata a giudicare ciò che è bene o male, morale e immorale, conforme e no alla natura umana, spiega in parte perché i medici preferiscano privilegiare l’aspetto tecnico della loro professione rispetto a quello umano, e tendano a navigare lontano dagli insidiosi dibattiti sui principi etici, appellandosi al pragmatismo. Temono che l’etica sia il cavallo di Troia che introduce nella medicina la violenza dell’ideologia.
Concretamente, il pericolo può provenire sia dalle ideologie politiche totalitarie, sia dall’etica religiosa. Un progetto di medicina ideologizzata traspare nei paesi dell’Est più preoccupati dell’ortodossia marxista. Possiamo citare come esempio tipico la facoltà di medicina dell’università di Halle, nella Repubblica popolare tedesca. Nelle pubblicazioni accademiche della facoltà ritornano attacchi sistematici alla medicina borghese, cui viene contrapposta la medicina veramente “scientifica”, cioè quella che si basa sull’interpretazione marxista-leninista della realtà 41. L’etica marxista è incorporata sistematicamente nella medicina, ne determina le scelte e gli orientamenti.
Nei paesi occidentali il moralismo proviene piuttosto dall’imposizione di determinate etiche confessionali. Queste hanno da tempo appuntato la loro attenzione sui problemi che derivano dalla medicina moderna. Prima di prendere piede in modo cosi esuberante nelle facoltà di medicina di alcuni paesi, l’etica medica è stata una disciplina coltivata soprattutto nei luoghi di formazione dei pastori. Non mancano esempi di corsi impartiti nelle scuole rabbiniche 42; ma è soprattutto in ambito cristiano,
57
e più particolarmente cattolico, che all’etica medica è stata dedicata la maggiore attenzione 43. Questo tipo di etica medica è sostanzialmente una teologia morale applicata ai problemi sanitari. Non solleva nessuna difficoltà finché viene insegnata nel suo luogo proprio, cioè nelle scuole di teologia o di formazione pastorale. Ma in alcune facoltà di medicina a denominazione confessionale l’insegnamento dell’etica medica è stato introdotto obbligatoriamente per tutti gli studenti. Cosi nelle università cattoliche di Lovanio, di Roma e di Cork in Irlanda. Basandoci su un resoconto relativo a quest’ultimo caso 44, possiamo renderci conto dei problemi delicati che possono sopravvenire quando l’insegnamento di morale confessionale viene impartito in una facoltà di medicina. “L’etica medica — riferisce l’autore dell’articolo, responsabile del corso a Cork — è stata tradizionalmente vista dagli studenti come un’intrusione da tollerare in un rigoroso programma di studi ‘strettamente medici’, vale a dire quei corsi che contribuiscono direttamente a sviluppare l’abilità medica nel guarire e prolungare la vita fisica. Gli studenti erano soliti meravigliarsi che si pensasse all’etica medica come a un complemento, supplemento, o in qualsiasi modo a un contributo per la loro formazione come professionisti medici. L’insegnante di etica medica all’University College di Cork riconoscerà senza difficoltà che gli studenti sono generalmente scettici circa la necessità di un corso obbligatorio di etica medica”. L’impressione era rafforzata dal fatto che il docente fosse di solito un sacerdote cattolico: ciò faceva supporre che il corso si limitasse ad essere una reiterazione dell’insegnamento morale cattolico su problemi come la contraccezione, l’aborto, la sterilizzazione, l’eutanasia. “Gli studenti presupponevano implicitamente che, qualunque problema fosse discusso nel corso, dovesse in qualche modo, in ultima analisi, essere reso compatibile con l’insegnamento autoritativo della chiesa cattolica. Sulla base di questo presupposto, la possibilità per una riflessione aperta e critica sui problemi dell’etica medica erano spesso di fatto ridotte”. Nel caso di Cork per sbloccare l'atteggiamento diffidente degli studenti sembra siano state sufficienti alcune modifiche strutturali — come l’affidare il corso a un docente non ecclesiastico del dipartimento di
58
filosofia — e una ridefinizione degli obiettivi del corso. Questo si propone, infatti, esplicitamente di educare gli studenti a chiarire l’interdipendenza e allo stesso tempo a distinguere tra la valutazione medica e i giudizi etici; intende inoltre portare a riflettere sui rapporti che intercorrono tra legalità e moralità, nonché tra religione ed etica.
Anche dai resoconti di altre esperienze di insegnamento, sulle quali tuttavia non gravano a-priori di tipo confessionale 45, risulta che il corso di etica medica non può esimersi dall’affrontare i problemi di fondo relativi alla natura dell’etica e dell’articolazione tra i suoi due aspetti, valutativo e normativo. Se i problemi relativi al significato, ai metodi e ai modelli dell’etica — potremmo chiamare tutto questo ambito, per brevità, “meta-etica” — sono di pertinenza specifica della filosofia morale, la questione del rapporto tra l’etica empirica e l’etica normativa fa parte integrante di un corso di etica medica. Dal punto di vista normativo interessa stabilire come i medici “dovrebbero” agire nelle circostanze concrete, in armonia con i principi dell’etica, laica o religiosa. Quando sorgono conflitti tra differenti prospettive, diventa imprescindibile una chiarificazione meta-etica e un buon ancoraggio empirico. Ma soprattutto si rivela spesso risolutivo un approfondimento valutativo. Salute e malattia, infatti, sono variabili antropologiche suscettibili di indefinite variazioni culturali. Il medico non può elaborare in modo autonomo definizioni di vita e di morte, di salute e di qualità della vita, al di fuori dei luoghi dove si elaborano socialmente i significati. Ciò implica che oggi la medicina non può svolgere adeguatamente il suo compito senza un interscambio con le scienze dell’uomo. L’etica medica è il luogo appropriato di tale comunicazione. In essa confluiscono le acquisizioni della sociologia, della psicologia medica, dell’antropologia culturale; senza dimenticare l’apporto della linguistica e della letteratura. Un solo esempio, per illustrare quest’ultimo settore: il medico che ha assimilato la lezione di Susan Sontag sulla pregnanza semantica del cancro in quanto metafora di malattia mortale 46, vedrà i problemi della “verità al malato” in un’ottica più fedele al vissuto della malattia, cosi come è condizionato dal momento culturale.
59
3. L'insegnamento dell'etica medica: problemi metodologici
La vistosa tendenza attuale a moltiplicare i corsi di etica medica non deve far dimenticare che praticamente non è mai esistita una medicina che non fornisse ai nuovi medici un certo insegnamento etico. L’educazione medica è un processo che trasmette non solo un corpo di conoscenze oggettive e un repertorio di capacità cliniche, ma anche un apparato di atteggiamenti professionali. La professionalizzazione è un lungo e sottile indottrinamento attraverso il quale vengono comunicate scale di valori e atteggiamenti che caratterizzano all’interno e all’esterno il gruppo chiuso dei medici. L'habitus mentale che contraddistingue il medico viene assimilato, più che attraverso le forme esplicite di istruzione normativa (come la trasmissione delle norme codificate indispensabili alla pratica della medicina: dal giuramento di Ippocrate ai moderni codici di deontologia professionale), mediante una sorta di osmosi, nel contesto della frequentazione quotidiana. Ancor oggi il principale veicolo della formazione etica degli studenti di medicina è l’apprendistato diretto che avviene durante il curriculum degli studi. Lo studente, che passa anni a contatto con i suoi istruttori, gradualmente assume un insieme di precetti etici che riconosce come norme obbliganti.
Possiamo parlare di problemi metodologici e didattici solo quando si intende passare da questo tipo di insegnamento informale a quello esplicito. Questa è appunto la tendenza emergente oggi: è passato il tempo — si ripete — in cui l’etica medica poteva essere insegnata con l’esempio dei maestri e dei colleghi più anziani! Le questioni più delicate che si pongono quando si accede a questo livello formale, con la sua corrispondente rilevanza accademica, sono quelle relative alle finalità da attribuire all’insegnamento, ai modelli didattici, al metodo e alle possibilità di valutare l’apprendimento. Passiamo brevemente in rassegna i diversi problemi.
Quali scopi deve proporsi l’insegnamento dell’etica medica? Una commissione americana, creata per analizzare i problemi dell’insegnamento della bioetica, ha pubblicato un rapporto in cui vengono indicate le principali finalità 47. In primo luogo si tratta di mettere gli studenti in grado di saper riconoscere i problemi etici, distinguendoli dalle questioni puramente tecniche. La distinzione si rivela opportuna anche
60
quando il medico non sia coinvolto in prima persona nel processo della decisione. Se è cosciente delle diverse possibilità di risolvere i conflitti etici, potrà presentare i problemi al paziente in modo da permettere un’appropriata soluzione da parte del paziente stesso. Tuttavia il medico dovrà avere anche personalmente una certa preparazione che lo abiliti a sviluppare strategie per analizzare i problemi morali che si pongono in medicina e a mettere in riferimento i principi morali con i casi contingenti. Non ci si può aspettare che un medico risolva ogni problema etico in modo infallibile e all’istante; ma non può esimersi dall’essere preparato per il tipo di casi che incontrerà più frequentemente. Per quanto, infatti, la maggior parte delle decisioni vengano prese dal paziente o dal gruppo degli utenti delle cure mediche, alcune scelte etiche devono essere fatte da coloro che forniscono le cure (si pensi alla quantità di informazioni da trasmettere al paziente circa una particolare diagnosi; oppure all’infermiera che deve decidere se obiettare, per motivi etici, a un determinato trattamento). Per risolvere i conflitti intrapersonali e interpersonali che emergono, bisogna ricorrere a una decisione etica. Pur essendo le decisioni atti pragmatici di volontà, non sono necessariamente capricciose. L’intento dell’etica medica è appunto quello di elaborare teorie razionali per ottimalizzare le decisioni 48.
Quanto all’organizzazione dell’insegnamento, emergono due modelli principali: accentrare la materia attorno a una serie di problemi di grande spessore antropologico (la morte e il morire, la sperimentazione, la genetica, il controllo del comportamento, l’aborto...) 49; oppure dare al corso un’organizzazione tematica (la libertà, il consenso, benefici per il paziente e per la società, autonomia e autodeterminazione, la giustizia sociale, la verità nel rapporto medico-paziente). Il primo approccio permette
61
di mettere meglio a fuoco i problemi cosi come sorgono nel contesto medico; il secondo ha invece il vantaggio di rendere possibile un’analisi sistematica dei problemi etici e filosofici soggiacenti alla casistica specifica.
Più delicate sono le scelte che si impongono al docente di etica medica circa la didattica. Una prima questione riguarda l’obbligatorietà dell’insegnamento. Soltanto in un numero limitatissimo di facoltà di medicina i corsi sono stati resi obbligatori; per lo più si pensa che il lasciarli facoltativi incrementi la partecipazione attiva. Questo è infatti il problema principale della didattica dell’etica medica. L’apprendimento in questo campo non avviene allo stesso modo in cui si acquisiscono le altre nozioni che costituiscono il bagaglio professionale del medico. Lo stesso insegnamento cattedratico ha valore limitato. Va data la preferenza a quei veicoli che incoraggiano la partecipazione attiva degli studenti, i quali possono venir cosi coinvolti nell’interscambio che si instaura tra teoria etica e prassi medica. L’interpretazione tra teoria e pratica, vitale per ogni scienza, lo è in modo particolare quando si tratta di etica medica. Un’etica puramente teorica, infatti, è irrilevante per il medico in quanto medico; e un’etica esclusivamente pratica, cioè prescrittiva, non sfugge al pericolo del moralismo. È valido solo quell’apprendimento che è basato sull’esperienza e la partecipazione. Per favorire la partecipazione sono ampiamente sperimentati, oltre alle lezioni accademiche, anche seminari, “work-shop” residenziali durante il fine-settimana, discussioni di casi clinici, in cui il punto di vista dell’etica medica si integra con quello terapeutico.
Un problema connesso è quello della competenza necessaria per l’insegnamento dell’etica medica. All’insegnante si richiede una formazione tanto nelle scienze biologiche e mediche, quanto nelle discipline etiche. La commissione americana per l’insegnamento della bioetica ha raccomandato come standard minimo che il docente abbia una formazione professionale in almeno una di queste aree, e che sia un “amateur” competente nell’altra.
E infine: con quali criteri valutare le acquisizioni di etica medica da parte degli studenti? Le tre componenti della formazione medica — conoscenza, capacità e atteggiamento etico — non sono uniformemente accessibili allo studio. La trasmissione della conoscenza nozionale è la più facile da considerare: si comincia con l’essere ignoranti e si termina con l’essere informati. Le capacità che costituiscono la competenza clinica
62
sono più difficili da valutare; tuttavia esiste un certo consenso su ciò che può essere richiesto a uno studente di medicina per essere abilitato ad esercitare la professione. Ma il terzo fattore — il complesso di valori e atteggiamenti — è misterioso sia nella sua natura che nella sua trasmissione. Lo scienziato sociale si troverebbe in difficoltà se volesse studiare in modo rigoroso come l’etica medica è insegnata ed appresa. Cosi come è arduo trovare criteri sulla base dei quali valutare se è stata acquisita l’abilità a risolvere i problemi etici che sorgono nella prassi. Nelle riviste specializzate si possono trovare i primi tentativi di un confronto tra docenti 50. Le risposte più soddisfacenti si trovano solo però in quei progetti di ristrutturazione globale dell’insegnamento della medicina in cui l’etica medica viene inserita strutturalmente nel curriculum 51. In questi casi l’intensità e la qualità della partecipazione al programma formativo, che prevede un assiduo scambio di opinioni attraverso le quali gli studenti insegnano a se stessi a prendere decisioni etiche in modo responsabile, rendono praticamente superflua la verifica per mezzo di un esame.
63
Parte Seconda
LA MORALE MEDICA CRISTIANA
64
65
INTRODUZIONE
MEDICO E CRISTIANO: UN MESTIERE DIFFICILE
Anche il medico che si dichiara cristiano e vuol agire di conseguenza si trova oggi, come qualunque altro dei suoi colleghi, in una situazione critica. Il camice bianco non gode più del prestigio incondizionato che lo aureolava fino a un passato molto recente. Un’inchiesta recente, svolta presso i medici, riflette un’immagine di sé ancora salda. I medici intervistati si valutano per lo più gran lavoratori, aggiornati, convinti della propria missione anche se “guadagnano poco”. Ma questa immagine luccicante rischia di nascondere una realtà di grande insicurezza. Attorno ai medici c’è il gelo, quando non addirittura l’ostilità. Alcuni vorrebbero che, caduto il carisma, restasse la pura professionalità. Invece no: l’opinione pubblica non li considera come tecnici della salute, ma come carismatici mancati, come missionari che si son messi a fare i mercanti. L’accusa di speculare sui malati è una delle più pesanti, e anche delle più diffuse.
In realtà i medici sui quali a buon diritto può cadere questo sospetto (i “baroni” che usano le cliniche universitarie come feudo personale, i “cucchiai d’oro” specializzati in aborti, che magari ufficialmente risultano obiettori di coscienza, specialisti di gran fama che non esitano a chiedere cifre astronomiche per un consulto), sono un’esigua minoranza. Ma le odiosità provocate da tali clamorosi abusi di potere si riversano su tutta la categoria medica. Di qui l’immagine cosi diffusa del medico avido di guadagno e senza scrupoli sul modo di realizzarlo.
Il commercio della salute si scontra oggi con una coscienza nuova del diritto del cittadino all’assistenza sanitaria. Un passo decisivo in questo senso è stato compiuto con la legge che ha introdotto la riforma
66
sanitaria. Essa ha stabilito, per la prima volta nella storia d’Italia, che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Affinché il programma non resti una pura velleità, è necessaria una radicale trasformazione della “cultura della salute”. Già si abbozza la formazione di un vasto movimento d’opinione che investa l’ospedale, cosi come nel più recente passato è avvenuto per la fabbrica e per la condizione della donna. I malati, che molto spesso sono afflitti più dalla rabbia per il trattamento che ricevono che dai loro mali fisici, non vogliono più essere dei “pazienti”. Chiedono in primo luogo che cessi la violazione dei diritti umani.
In questo spirito è sorto, per impulso del Movimento federativo democratico, un “Tribunale per i diritti del malato”. Un tribunale che non vuol essere una struttura giudiziaria, bensì politica e morale. La rispondenza immediata della popolazione, che ha riversato sul tavolo dei promotori migliaia di denunce, ha rivelato una grande domanda di giustizia nel campo della salute. I fatti clamorosi di violazione dei diritti della persona che avvengono negli ospedali sono sufficientemente noti e pubblicizzati. Ma accanto a questi esiste una costellazione di sofferenze inutili, di umiliazioni e di oppressioni, che costituisce la via crucis del malato che deve passare per l’ospedale pubblico. Segregato dalla società civile, scopre di aver perso i diritti più elementari che gli spettano come cittadino e come uomo. Quando entra in ospedale, il suo lavoro, la sua cultura, i suoi desideri, i suoi oggetti, i suoi legami familiari non contano più nulla.
Con la rivendicazione del diritto alla salute tramonta un modello culturale imperniato sull’assistenzialismo, più o meno colorato di carità cristiana. Tramonta il mito dell’impunibilità e dell’ingiudicabilità del medico, che si sosteneva sulla rinuncia da parte della gente più debole a far valere i propri diritti. Anche l’arroganza connessa con il ruolo di terapeuta comincia a essere più tollerata.
Se la situazione è scomoda per qualsiasi medico, lo è in misura molto maggiore per chi vuol esercitare la professione da cristiano. Il credente medico più di ogni altro è in grado di avvertire che la credibilità della Chiesa in quanto annunciatrice della salvezza divina è legata strettamente a quanto la comunità cristiana opera a favore della salute dell’uomo. Oggi ne siamo coscienti più che in passato. L’attività terapeutica è stata il fulcro dell’opera messianica di Gesù. L’apologetica ha considerato i miracoli di Gesù solo per ricavarne argomenti con i quali dimostrare in modo incontrovertibile la sua divinità: è una visione riduttiva. Nella missione
67
di Gesù l’opera di guarigione non era un aspetto secondario dei suoi poteri messianici, ma il vero e proprio mezzo per proclamare, istituire e ampliare la nuova era, sotto la signoria di Dio. Questa stessa missione Gesù ha lasciato alla comunità cristiana. Per rimanere nell’esempio del suo Signore, la Chiesa deve adottare la stessa “parzialità” di Dio, cosi come si è espressa nella parola e nella vita di Gesù: privilegiando coloro che vengono scartati, integrando quelli che vivono la malattia come esperienza di segregazione, facendo dei “piccoli” il centro della nuova comunità dei tempi messianici. E come non inserire oggi i malati nella categoria spirituale dei “piccoli”, quando in una società costruita sul culto dell’efficienza coloro che non corrispondono al modello ideale (handicappati, anziani, malati cronici, invalidi) vengono inesorabilmente sospinti ai margini della collettività?
Il medico cristiano, che vuol operare coerentemente come discepolo di Gesù, si trova inserito in quest’orizzonte profetico creato dall’appello alla diakonia, al servizio, rivolto a tutta la comunità. La sua professione gli pone tuttavia dei particolari doveri, che non si limitano alla morale evangelica. Come ogni professionista, è obbligato in primo luogo a rispettare specifiche norme deontologiche, che derivano, dal fatto di esercitare una professione nella società e per la società. La funzione di quelle norme è di garantire un rapporto di fiducia: il “cliente” ha bisogno di sapere a quali regole si atterrà il professionista nel rapporto interpersonale. Questa garanzia è particolarmente importante quando ci si espone molto sul piano personale (per esempio, quando si confidano segreti: per il rapporto di fiducia è indispensabile sapere che il professionista si impegna a non divulgarli). Nel caso del medico, il malato affida addirittura il proprio corpo, se stesso. Per questo la professione medica è stata quella che per prima ha sentito il bisogno di imporsi norme di comportamento.
Lo ha fatto fin dall’antichità classica mediante il giuramento di Ippocrate. Gli Ordini dei medici provvedono oggi a elaborare e ad aggiornare i loro codici deontologici, che contengono i doveri del medico verso i pazienti, verso i colleghi nella professione, verso lo Stato e la società.
Sul piano pratico, in Italia ogni medico, per esercitare, deve essere iscritto all’Ordine dei medici, il quale si impegna a far rispettare il proprio codice di comportamento. Di fatto, però, le sanzioni previste per i trasgressori vengono raramente applicate. L’uomo della strada non riesce a scrollarsi di dosso l’impressione di trovarsi di fronte a una corporazione che difende i suoi diritti e privilegi. Ma anche quando il codice deontologico
68
fosse tenuto in alta considerazione e fatto rispettare, esso potrebbe garantire al massimo la correttezza professionale, insufficiente a risolvere delicate questioni di coscienza. Per districarsi nei casi di conflitto tra valori è necessario l’orientamento che viene dalla riflessione etica.
È stata una preoccupazione costante della morale cristiana applicare i principi che la ispirano ai problemi della salute e della vita fisica. Si è sviluppata una morale medica specifica, che è oggetto di insegnamento nelle poche facoltà di medicina delle università cattoliche. In America, dove si preferisce parlare di “etica medica”, questa disciplina è coltivata anche nei centri di studio non confessionali. Non c’è medico che, un giorno o l’altro, non si sia imbattuto in qualcuno dei problemi tipici della morale medica: proseguire o arrestare le cure di rianimazione? procedere o no alla sterilizzazione? la vita della madre o la vita del bambino? si o no all’aborto? dire o tacere la verità al malato?
Anche la migliore morale medica ha però dei limiti rilevanti. È costruita su casi astratti e lascia fuori il vissuto personale, l’angolatura particolare che le vicende del corpo assumono per il fatto di essere inserite in un’esistenza individuale. Senza che sia infranto formalmente nessun caposaldo della morale, il trattamento del malato può diventare una ruota che stritola la dignità della persona, causa sofferenze e umiliazioni, provoca addirittura alterazioni della personalità.
Il fronte su cui il medico cristiano è chiamato a schierarsi è quello di una medicina per l’uomo intero. La medicina scientifica, pur con i suoi meriti indiscutibili, è viziata da un presupposto positivista. Per ricondurre la malattia a qualcosa di obiettivo, da spiegare sulla base delle leggi fisico-chimiche che regolano i fatti della natura, ha escluso la considerazione dell’uomo malato. Tutti i caratteri storici e personali della malattia sono messi tra parentesi: il malato interessa solo quando è ridotto a un “caso” clinico. La medicina non è organizzata intorno all’uomo malato, ma intorno alla malattia, o piuttosto all’organo malato. Lo si può vedere dal modo come è disposto l’ospedale: le malattie vengono suddivise per reparto come le merci in un supermercato; e i medici, passano di letto in letto come tecnici a una catena di montaggio, si dedicano a scoprire le cause del guasto per riparare l’organo malato.
Oggi negli ambienti più sensibili della medicina si sente il bisogno di superare quella concezione meccanicista della malattia. L’oggetto proprio della medicina non sono i singoli organi che non funzionano, ma l’uomo malato, inteso come una totalità. La tradizione filosofica cristiana
69
ha espresso questo punto di vista parlando dell’uomo come persona. Il contributo che il medico cristiano può portare al rinnovamento in profondità della medicina è proprio la proposta di una “medicina della persona”, nel senso dell’antropologia cristiana. Più che una prassi medica accanto alle altre, la medicina della persona è uno spirito con il quale la medicina deve essere praticata. Include la tecnica, pur non limitandosi ad essa; presuppone l’apertura alla conoscenza antropologica moderna, ma non vi si identifica. L’antropologia cristiana ha una propria, irriducibile, specificità.
Essa porta nella prospettiva della “totalità” un punto di vista più ampio, che colloca l’uomo nell’ascolto di una chiamata. Il medico cristiano lo ha imparato da Gesù, il terapeuta. Il quale, nel calore dell’incontro interpersonale, curava uomini malati, non riparava macchine organiche; e al tempo stesso collocava la vita degli individui nell’orizzonte del Regno di Dio.
70
71
Capitolo Primo
LA MORALE MEDICA COME DISCIPLINA TEOLOGICA
1. Profilo storico della morale medica cristiana
Con notevole anticipo rispetto al costituirsi nelle facoltà di medicina di una disciplina specificamente dedita allo studio dei risvolti etici della prassi sanitaria, la dottrina morale cattolica ha elaborato una trattazione organica di questi stessi temi. Già negli anni ’50 la morale medica è riconosciuta come disciplina teologica, le è riservato un insegnamento accademico, dispone dì una serie di manuali e produce pubblicazioni e riviste specializzate.
Il principale fattore di sviluppo di questa disciplina va ravvisato nella preoccupazione pastorale. Attualizzando il mistero di insegnamento e di salvezza di Gesù Cristo stesso, il magistero ecclesiastico impartisce direttive religiose ed etiche dettagliate; offre così una guida autorevole alla coscienza dei fedeli, affinché si uniformino alla volontà salvifica di Dio in ciò che concerne la difesa e l’incremento della vita. Anche la disciplina del diritto canonico ha contribuito nell’ambito della chiesa cattolica allo sviluppo di una morale medica molto analitica. Essa ha prodotto, infatti, delle normative dettagliate relative all’amministrazione di alcuni sacramenti in momenti critici dell’esistenza umana, per i quali si è resa necessaria un’esatta conoscenza medica: la definizione della morte per l’amministrazione dell’“estrema unzione”; conoscenze embriologiche per l’amministrazione del battesimo, anche intrauterino (con trattazioni specifiche di Sacra embryologia...); casistica di patologia sessuale per le cause di nullità matrimoniale.
Le principali fasi dello sviluppo storico della morale medica cattolica possono essere individuate in una sequenza che vede, in un primo tempo,
72
la costituzione della teologia morale come disciplina autonoma, all’inizio dell’epoca moderna. Nella Summa moralis di S. Antonino, vescovo di Firenze (1383-1459), che esercitò un grande influsso fino al XVII secolo (si contano venti edizioni complete, dal 1477 al 1740!) troviamo una prima sintesi dottrinale di morale medica. Nel tomo terzo tutto il titolo settimo — “De statu medicorum” — tratta “de officio, vitiis, ac salariis medici”. Troviamo elencati i problemi relativi alla competenza del medico, all’assistenza dei morenti, alla moralità dei rimedi prescritti, all’aborto. Parallelamente al costituirsi della medicina legale, ad opera di Paolo Zacchia (le Quaestiones medico-legales sono del 1621), vengono pubblicate opere di medicina pastorale ed etica medica, benché non si possa parlare ancora di una disciplina autonoma. A esemplificazione: il Ventilabrum medico-theologicum di M. Boudewyns (1666) sui casi che più frequentemente si presentano al medico; il De ortu infantium di Th. Raynaudus (1637), sulla moralità del parto cesareo e altre circostanze relative alla nascita, ecc. Nell’insieme, le Institutiones theologiae moralis di S. Alfonso de’ Liguori forniscono le soluzioni morali più seguite nei problemi dibattuti, fino al rinnovamento della morale verso la metà del nostro secolo.
La medicina pastorale propriamente detta si forma nel corso del XIX secolo e fiorisce fino alla metà del XX. Il suo scopo è di fornire ai sacerdoti le conoscenze mediche necessarie allo svolgimento del loro compito pastorale, e ai medici cattolici i principi morali e le direttive precise a cui attenersi nella casistica concreta relativa a sterilizzazione, aborto, contraccezione, rianimazione, trapianti di organo. La medicina pastorale si è occupata di questioni relative alla difesa della vita (aborto, operazioni chirurgiche, uso dei medicinali) e all’area del sesto comandamento (uso della sessualità e matrimonio), nonché dei comandamenti della chiesa, relativamente alle regole del digiuno e dell’astinenza. La “summa” più autorevole di medicina pastorale è costituita dall’opera, in sei volumi, di A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Pastoral Medizin, 1948-1952, completa e innovativa nel suo impianto, tanto da affrontare anche questioni relative al trattamento psichiatrico e psicoterapeutico.
Lo sviluppo rapido della medicina dopo la seconda guerra mondiale ha fatto sorgere problemi inediti di etica medica. Ad essi ha offerto una tempestiva risposta il pontefice Pio XII, in una nutrita serie di discorsi e allocuzioni a medici e scienziati 54. Le soluzioni morali da lui proposte,
73
rivolte di per sé solamente ai fedeli della chiesa cattolica, hanno spesso trovato udienza anche al di là dei confini ecclesiali, in quanto riflettevano il più sovente l’ethos umanitario proprio della medicina ippocratica. Il dialogo con l’etica laica era favorito dal fatto che la sapienza cristiana relativa agli obblighi circa la vita veniva fondata più sulla “legge naturale” che sulle sacre Scritture.
La struttura dottrinale propria della chiesa cattolica si riflette anche nella morale medica. Il peso del magistero papale — e in particolare del Sant’Uffizio — si è fatto sentire in tutte le questioni più cruciali. Tra il 1884 e il 1902, per esempio, il Sant’Uffizio rispose a numerose domande circa l’aborto, ed eliminò alcune eccezioni che non erano state espressamente condannate. Così pure le encicliche Casti Connubii (1930) e Humanae vitae (1968) presero posizione dettagliatamente sulla contraccezione e condannarono tutti i metodi contraccettivi, salvo quelli naturali. Benché fosse generalmente riconosciuto che l’insegnamento nell’area dell’etica medica non rientra nella categoria dell’insegnamento infallibile, l’autorevolezza magisteriale concludeva, in pratica, i dibattiti ed escludeva le opinioni divergenti dei moralisti. Lo spirito della Humani Generis (1950) ― secondo cui, dopo un pronunciamento pontificio su un argomento controverso, i teologi non possono più dibatterlo liberamente — ha gravato anche sulla morale medica. Anche le direttive religiose ed etiche promulgate più di recente dalla gerarchia di alcuni episcopati — citiamo, a titolo di esempio, le Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Facilities dei vescovi americani del 1971, relativamente alla contraccezione, alla sterilizzazione, alla masturbazione per analisi dello sperma, all’inseminazione artificiale e alla gravidanza ectopica — tendono a presentarsi alla coscienza del fedele come legge apodittica, che impone decisioni uniformi nei casi concreti e domanda solo di essere messa in atto senza eccezioni 55. Simili direttive mirano a modellare la convinzione personale
74
dei cattolici sui problemi dibattuti e a influenzare la posizione delle istituzioni sanitarie cattoliche, affinché rifiutino pratiche quali l’aborto o la sterilizzazione.
Un’altra caratteristica specifica della morale cattolica è il suo riferimento alla “legge naturale”. Da un punto di vista teologico, si riconosce che la natura umana, insieme alla ragione, costituisce per il cristiano una fonte di conoscenza etica. Metodologicamente la teologia cattolica dell’epoca preconciliare vuol coniugare armonicamente fede e ragione, sacra Scrittura e legge naturale. Secondo la teoria tomista, a cui si riferiscono i manuali di morale medica, la legge naturale è la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna, vale a dire al piano della sapienza divina che dirige ogni azione verso la meta finale, secondo la natura propria di ogni creatura. Essendo l’uomo una creatura razionale, la legge naturale per l’uomo comporta il regolarsi secondo ragione. In armonia con questa impostazione, la ragione è capace di giungere a formulare i principi e le prescrizioni universalmente validi della legge naturale. Di qui il carattere statico dei principi e delle loro applicazioni. Dal momento che la qualità etica di azioni che attentano alla vita e all’integrità dell’uomo — quali l’aborto, la contraccezione, la sterilizzazione, l’eutanasia, ecc. — deriva, per una deduzione logica, dai principi generali, non ci si può aspettare modifiche rilevanti delle valutazioni morali. Condanne e prese di posizione su nuovi problemi si riducono, per lo più, alla riproposizione dei principi generali, che vengono semplicemente applicati ai casi particolari.
Nei manuali degli anni ’50 la trattazione casistica è spesso preceduta da un breve sommario dei principi che regolano la morale medica cattolica. I più importanti sono: il diritto alla vita, come diritto naturale e inalienabile (di conseguenza, l’uccisione diretta di un innocente, di propria autorità, è sempre male); il principio di totalità (il bene del tutto è il fattore determinante nei confronti delle parti, per cui si può disporre delle parti a vantaggio del tutto; nell’antropologia cristiana bisogna inoltre tener presente la finalità spirituale della persona, per cui il singolo organo è subordinato non solo al bene del corpo, ma al bene della persona); il principio del duplice effetto, nelle azioni che hanno due o più effetti, compreso uno cattivo (è il principio chiamato in causa per giustificare
75
la possibilità dell’uccisione indiretta, dell’aborto indiretto, o della cooperazione materiale indiretta. Le condizioni requisite sono: che l’atto sia in sé buono o moralmente indifferente; l’intenzione dell’individuo deve essere buona; ci deve essere un motivo proporzionatamente grave per porre l’azione). Per quanto riguarda la sessualità e la procreazione, le facoltà sessuali devono essere usate secondo la finalità intesa da Dio creatore e rispecchiata dalla natura. Il fine degli organi e delle funzioni sessuali è duplice: la procreazione e l’unione nell’amore. Ogni loro uso, in cui positivamente si interferisca per impedire o frustrare la finalità intrinseca dell’atto, è immorale. Di qui la condanna, costantemente ripetuta in tutti i documenti magisteriali, della contraccezione e della sterilizzazione contraccettiva.
2. Nuovi orientamenti
L’interesse teologico-pastorale per i problemi dell’etica medica, già in pieno sviluppo negli anni ’50 e ’60, ha prodotto una ricca messe di saggi e manuali, che si consultano ancor oggi con qualche profitto. La stagione post-conciliare ha portato però un profondo rinnovamento anche in questo settore, come già in altri ambiti del pensiero e della prassi della chiesa. L’“aggiornamento” della morale medica cattolica è dovuto, in maniera eminente, all’opera di Bernhard Häring 56. Nella sua Etica medica (Roma 1972) raccoglieva la ricca eredità della riflessione precedente. La situava però nel nuovo contesto, costituito dai progressi della medicina e della biologia, da una parte, e dai nuovi sviluppi della teologia cattolica durante e dopo il Vaticano II, dall’altra. “Non diamo risposte una volta per tutte, né risposte già pronte per tutti i nuovi problemi. Dobbiamo oggi impegnarci lealmente per restare fedeli alla nostra eredità con le esigenze dei tempi nuovi, soprattutto nel dialogo interdisciplinare”, proclamava P. Häring nell’introduzione. Come criterio fondamentale per valutare i problemi attuali della professione medica e del paziente assumeva la libertà e l’integrità della persona umana.
Uno sviluppo ulteriore viene con Medicina e manipolazione (Roma, 1976). La manipolazione medica, comportamentale e genetica veniva inserita
76
nell’insieme delle manipolazioni insidiose che minacciano quasi ogni settore della vita moderna; senza però ignorare le possibilità offerte di liberarci da condizionamenti sfavorevoli allo sviluppo del genere umano. “Che cosa significa la manipolazione nella e per la storia della libertà e della liberazione?”, si domandava il teologo moralista. I criteri per il discernimento dei limiti etici della manipolazione venivano cercati nello spirito della teologia della liberazione.
L’ultimo sviluppo della riflessione di Häring sulla morale medica cristiana si trova nel terzo volume della sua nuova sintesi di morale: Liberi e fedeli in Cristo (Roma 1981), che si apre appunto con un’articolata trattazione della “bioetica”. In questo contesto Häring adotta un’angolatura che conferisce alla morale della vita fisica un maggiore spessore teologico. La sua preoccupazione non è quella di fornire soluzioni morali “allargate” ai problemi tradizionali, e tantomeno compromessi, bensì di acquisire la giusta prospettiva, operando scelte evangeliche di valore e di senso. Colloca la promozione e protezione della vita, la salute e la terapia, la morte e il morire nel contesto del più ampio dovere, che incombe ai cristiani g a tutti gli uomini di buona volontà, di unire le forze per la costruzione di un mondo più sano. “Tutta la redenzione è un’opera di risanamento, di guarigione. Di conseguenza tutta la teologia, e segnatamente la teologia morale, ha un’essenziale dimensione terapeutica. Cristo, il Salvatore, è anche Medico, Colui che guarisce. Egli è venuto a guarire la persona singola nelle sue relazioni, ma ha pure proclamato il Regno, un regno che abbraccia tutto, e quindi anche un mondo sano in cui vivere. I cristiani sono, in Cristo, dei terapeuti, della gente che fa opera di guarigione. Essi hanno la missione di guarire se stessi, di guarirsi gli uni gli altri e di lavorare uniti per la creazione di un mondo più sano” 57. L’etica medica si configura così come una parte dell’etica sociale, cioè della nostra corresponsabilità nel mondo e per il mondo.
L’opera di P. Häring rappresenta in modo emblematico il rinnovamento avvenuto all’interno della monolitica morale medica dell’epoca preconciliare. Le principali caratteristiche della nuova riflessione possono essere ricondotte al superamento del concetto teorico di “legge naturale” e al diverso tenore dell’insegnamento autoritativo del magistero. Quanto al primo aspetto, la teoria della legge naturale è stata sottoposta alla critica di favorire un certo fisicalismo morale, che identifica l’aspetto morale dell’atto umano con l’aspetto fisico dell’atto. Teologicamente, mentre cadeva
77
nel dibattito conciliare la teoria delle “due fonti” della rivelazione e prevaleva la concezione storico-salvifica (cfr. D.V., 2-6), diventava difficile giustificare una terminologia che potesse indurre a intendere la “natura”, con le sue leggi, quale sorgente autonoma di moralità. La teologia veniva provocata a un “ressourcement” storico-salvifico da un tratto caratteristico della cultura contemporanea: la maggiore coscienza storica, che accentua la crescita, lo sviluppo, l’elemento individuale e contingente.
Un fermento di novità ha toccato l’aspetto formale della morale medica cattolica, vale a dire il fatto che fosse autoritativamente insegnata dal magistero gerarchico. Il consenso unanime si è infranto con le reazioni discordi alla Humanae Vitae: ci sono stati teologi che hanno rivendicato il diritto al dissenso rispetto a insegnamenti morali specifici, non garantiti dall’infallibilità magisteriale. Su questioni particolari — la contraccezione, la sterilizzazione, la masturbazione per analisi seminali, l’inseminazione artificiale — emerge un pluralismo impensabile per la manualistica preconciliare. Anche nei documenti magisteriali va registrata qualche novità. Accanto a quelli che, come in passato, sono emanati con l’intenzione di chiarire, con l’autorità del magistero autentico, punti controversi e di guidare la coscienza dei fedeli (come, ad es., la Dichiarazione sull’aborto procurato, emanata il 18.11.1974 dalla Congregazione per la dottrina della fede, o la dichiarazione della stessa Congregazione sull'Eutanasia, del 5.5.1980), compaiono anche documenti pastorali, finalizzati a sensibilizzare i fedeli su nuovi problemi relativi alla vita e alla salute.
Di tal genere sono due documenti, dovuti rispettivamente alla conferenza episcopale tedesca e a quella francese, relativi alla morte e al morire nelle condizioni culturali attuali e ai problemi etico-pastorali che ne derivano 58. La comunità cristiana, attraverso la voce dei suoi pastori, si mobilita per rispondere all’interpellazione che deriva dalla disumanizzazione strutturale del morire. Anche la morale medica cristiana identifica in tal modo il suo compito nel contribuire a servire l’uomo migliorando la qualità della vita.
78
79
Capitolo Secondo
FONDAMENTI ANTROPOLOGICO-TEOLOGICI
DELLA MORALE MEDICA CRISTIANA
1. La salute nella storia della salvezza
Malattia e salute nella prospettiva dell’alleanza
Uno dei punti qualificanti dell’insegnamento e della prassi messianica di Gesù è il superamento della concezione biblica del legame tra malattia e peccato personale. Accenniamo solamente ad alcuni passi biblici, che dovrebbero essere esaminati dettagliatamente nel loro contesto: la malattia di Saul (1 Sam. 16,14); punizione del servo cupido di Elisei, colpito da lebbra (2 Re, 5,27); malattia e guarigione del re Ezechia (2 Re, 20, 1-11); a proposito del re Joram (2 Cr. 21, 11-19); malattia e morte di Alcimo, che aveva preteso di abbattere il muro di separazione tra l’atrio degli israeliti e quello dei pagani (1 Mac. 9, 54-56); malattia e morte dell’empio Antioco IV Epifane (2 Mc. 9, 11-12); malattia mortale del re Nabucodonosor (Dn. 4, 28-30). Oltre che nelle precedenti narrazioni, il rapporto tra malattia e peccato personale è stato affermato anche da testi poetici (tra gli altri Sal. 31 (32), 3-5; 37 (38), 4; Sir. 38, 15; Gb. 22, 5-14, che esprime la tesi degli amici di Giobbe, difensori della dottrina ufficiale del giudaismo). Le affermazioni sulla malattia come punizione del peccato, già ufficialmente categoriche nella Bibbia, sono state successivamente raccolte ed elaborate fino all’esasperazione negli ambienti religiosi giudaici. Se già gli amici di Giobbe interpretavano un caso di malattia secondo le regole: “Nessuna punizione senza colpa” e: “Dove c’è il patire c’è stato prima il peccato”, in seguito il giudaismo portò agli
80
estremi questa concezione. I giudei devoti affermavano che Dio vigila affinché peccato e punizione corrispondano alla regola: “misura per misura”. Così la gravità della punizione cresce con la gravità del peccato: le più grosse catastrofi che possono capitare ai singoli o alla comunità hanno per presupposto i più gravi peccati. Così non solo si presumeva di sapere quale disgrazia facesse seguito a determinati peccati, ma si poteva anche risalire dalla sventura di un uomo al suo peccato! La malattia diventata un segno per riconoscere la colpa. Gli ebrei al tempo di Gesù erano impregnati di queste concezioni. Nella guarigione del cieco nato ritroviamo in modo evidentissimo le tracce delle teorie dei rabbini. “Maestro — domandano i discepoli di Gesù — chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco?” (Gv. 9,2). Gesù recide alla radice questa problematica, tipicamente di scuola: “Non ha peccato, né lui, né i suoi genitori”. Ugualmente rifiuta di credere che le vittime di Pilato e gli uomini schiacciati dal crollo della torre di Siloe siano stati puniti dalla disgrazia per loro particolari peccati (Lc. 13, 1-9). L’insegnamento di Gesù è categorico: se la malattia è un segno, non lo è necessariamente di una colpa personale, e perciò non è lecito inferire dalla malattia o disgrazia a un peccato antecedente 59. Il quale, del resto, non offre un’opportunità per la vita religiosa. Ogni incontro di Gesù rifiuta con decisione la teoria della malattia come conseguenza di un peccato personale; ma non rifiuta con la stessa radicalità la prospettiva religiosa che vede nella malattia un segno della situazione dell’uomo davanti a Dio. È tipico, a questo proposito, il racconto della guarigione del paralitico (cfr. Mt. 9, 1-8). Perdono dei peccati e guarigione del corpo sono associati, senza per questo avallare le idee relative alla malattia come punizione. Resta dunque una certa relazione tra la sofferenza fisica e il peccato, anche quando si rinuncia a legarli come causa ed effetto. La teologia ha cercato di far luce su questo punto oscuro introducendo la nozione di peccato originale. Il dolore sarebbe la conseguenza non del peccato personale, bensì del peccato che tutta l’umanità ha compiuto mediante i progenitori. Nel linguaggio religioso popolare ricorre abitualmente questo tipo di “spiegazione”. Non è opportuno affrontare qui la questione del rapporto tra malattia e peccato originale, che appartiene alle nozioni più radicalmente rimesse in questione dai teologi e dagli esegeti. Un approccio del problema più consono alla terminologia biblica e più accessibile alla mentalità moderna
81
consiste nel considerare la malattia nella prospettiva dell’alleanza tra Dio e il suo popolo 60.
La prima osservazione che siamo portati a fare è che Israele ha, sì, accettato le categorie culturali che vedevano nei mali un intervento della divinità, ma le ha integrate nella sua idea della vita di fede come un rapporto di vassallaggio, che obbliga reciprocamente un signore — in questo caso Dio, Jahvé — e un suddito — il popolo d’Israele —, Alleanze di questo tipo venivano stipulate mediante formulari fissi, dei quali faceva parte una minuta elaborazione di benedizioni e maledizioni condizionali. Vale a dire, di benedizioni o maledizioni che seguiranno se ii parte- ner si atterrà o, al contrario, non si atterrà alle clausole stipulate. Valga come esempio particolarmente eloquente il c. 28 del Deuteronomio. Nei testi biblici in cui si parla di malattia come punizione la malattia non è isolata, ma ricorre insieme ad altre calamità, quali la carestia, le cavallette, i nemici, ecc. E anche là dove la malattia ricorre da sola, è sempre la prospettiva di fondo dell’alleanza che bisogna presupporre.
Per entrare nella prospettiva biblica è importante rendersi conto che benedizioni e maledizioni non vanno considerate come premi e castighi estrinseci, usati pedagogicamente per tenere il partner umano nell’alleanza, ma sono parte integrante dell’alleanza stessa. L’alleanza infatti è finalizzata alla “salvezza” dell’uomo, e questa, in quanto salvezza per l’“uomo”, non è disincarnata, ma lo investe nella sua dimensione terrena, corporea, concreta. Per questo la terra, la sicurezza dai nemici, la salute del corpo, il cibo e il vestito fanno parte della salvezza, sono la salvezza accordata da Jahvé al suo popolo. Finché Israele resta fedele al suo Dio non può che partecipare della salvezza, e quindi della terra promessa, della salute, della longevità, del benessere.
Evidentemente questa prospettiva non risolve tutti i problemi, anzi ne pone di particolarmente acuti. La sofferenza del giusto resta un enigma che non trova spiegazione adeguata in uno schema di natura giuridica, fosse pure quello dell’alleanza. Se le benedizioni sono intrinseche all’alleanza, lo scriba e il rabbino non vedevano come potessero venir meno, qualora non si fosse peccato contro Dio infrangendo così l’alleanza. Apparterrà agli scrittori sapienziali e ai salmisti di inquadrare il problema posto dalla sofferenza del giusto e di risolverlo, non rinunciando ai principi generali dell’alleanza, bensì approfondendoli. Il vertice di questa riflessione sarà raggiunto dal libro di Giobbe. L’importante è che il problema
82
della sofferenza del giusto, che emotivamente tende ad accaparrare tutta l’attenzione, non offuschi il disegno di fondo dell’alleanza. Salute e malattia acquistano un senso religioso in quanto Israele è in relazione di alleanza con Dio. Esse entrano a far parte integrante del disegno di salvezza, come ne fanno parte la vita e la morte. Malattia, morte e peccato appaiono come realtà comunicanti e congiuranti contro l’uomo, dalle quali Dio lo libererà mediante la storia della salvezza che ha messo in atto. È appunto la prospettiva della storia della salvezza che permette alla malattia di svolgere la funzione di segno della condizione dell’uomo in alleanza con Dio. La malattia dice relazione non solo all’uomo e al suo bisogno di salvezza, ma anche al piano di Dio che offre la salvezza. Come l’esilio e la schiavitù, essa appare come la realtà provvisoria, la cui sparizione sarà il segno dei temi nuovi. Il significato religioso della malattia è legato non solo a un passato di peccato, ma anche a un avvenire di salvezza. Numerosi testi biblici ci parlano della malattia precisamente come della realtà che dovrà essere abolita all’apparizione dei tempi escatologici, che saranno anche tempi di guarigione. Nel mondo nuovo, inaugurato dalla nuova alleanza (cfr. Ger. 31, 31-34), la malattia sarà soppressa: non ci saranno più né ciechi, né sordi, né muti, né zoppi (“lo zoppo salterà come un cervo”: Is. 25,8; 65,19). In questi passi profetici la guarigione è messa in rapporto con la liberazione, l’abbondanza, la pace; anzi, la guarigione è adoperata come metafora per indicare la salvezza completa e perfetta. Se la parola di Dio è una parola per la vita, nella prospettiva della storia della salvezza bisogna considerare in modo privilegiato il momento in cui l’alleanza tra Dio e l’uomo ha stretto il suo nodo definitivo. Nell’esistenza umana e nella parola di Gesù si è reso manifesto qual è la vita che Dio intende per l’uomo. Solo una riflessione sul mistero della salvezza nella sua maggiore densità, vale a dire nella pasqua del Cristo, ci mostrerà come la sofferenza fisica possa cambiare di segno ed esprimere anch’essa, paradossalmente, la grande benedizione con cui Dio ha benedetto l’umanità.
L’attività terapeutica di Gesù
Che la morale cristiana si costruisca a partire dalla vita e dall’insegnamento di Gesù sembra ovvio. Ogni insegnamento morale che si voglia cristiano cerca di agganciarsi a quella dottrina e a quella prassi. Il problema
83
sorge quando confrontiamo le diverse accentuazioni, o addirittura le differenti interpretazioni di ciò che è essenziale nel cristianesimo. Troviamo così che nel mistero di Cristo alcuni accentuano prevalentemente la passione e la morte, vista come l’agire definitivo in ordine alla salvezza: con le sue sofferenze, col sangue e con la croce, Gesù ha redento gli uomini dal peccato. Altri invece sottolineano la prassi liberatrice di Gesù, che ha condotto una lotta contro il male in tutte le sue espressioni, nelle sue conseguenze come nelle sue cause. La differenza di prospettiva è particolarmente evidente quando si parla del malato in riferimento a Cristo. Alcuni privilegiano la prospettiva che converge sulla croce, ritenendo che la sofferenza fisica collochi il malato in una situazione di particolare partecipazione alla passione di Cristo. Di qui l’identificazione abituale della malattia con la croce. Di qui, anche, le esortazioni ad accettare la malattia come modo di continuare a soffrire con Cristo e di cooperare alla salvezza del mondo. Ma dopo le prospettive per la liturgia e la teologia dalla riconsiderazione del valore di salvezza proprio della risurrezione, anche la teologia morale non può più esimersi dal considerare il mistero del Cristo nella sua integralità. Il Cristo ci ha salvato compiendo la sua pasqua. Se consideriamo la salvezza come un evento connesso con l’intera vicenda personale del Cristo che compie la sua pasqua nella condizione umana, il raggio degli avvenimenti che portano e significano la salvezza si estende prima e dopo la croce. Gesù ha operato la salvezza dell’uomo non solo perdonandolo, ma dandogli vita in modo sovrabbondante; egli doveva non solo riparare una colpa, ma dare una nuova vitalità all’uomo. E la trasformazione dell’uomo non avviene senza l’azione dello Spirito nel cuore, quello Spirito che è dato da Gesù risorto. È tutta la vita di Gesù, culminante nella risurrezione, che è salvezza, comunicazione di vita nuova.
In particolare, l’attività terapeutica di Gesù non appare più marginale, o destinata soltanto a fornire carte di credito per l’annuncio della parola: essa fa parte integrante dell’opera della salvezza. Questa è, del resto, la conclusione cui ci conduce la considerazione dei dati biblici 61. Essi documentano a sufficienza che le guarigioni hanno costituito una parte importante del ministero di Gesù. L’evangelista Matteo così riassume l’attività di Gesù in Galilea: “Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando
84
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e sanando ogni malattia e infermità del popolo. E giunse la sua fama in tutta la Siria, e gli portarono tutti i malati oppressi da varie malattie e tormentati, indemoniati, lunatici e paralitici, ed egli li guarì” (Mt. 4, 23-24). Anche se qui si tratta di un sunto del redattore, non viene infirmato il carattere storico della testimonianza secondo la quale Gesù svolse un’attività terapeutica a favore di tutti, guarendo da ogni specie di infermità.
Non solo l’universalità, ma anche l’abbondanza delle guarigioni è l’ambiente indispensabile per capire il Gesù dei vangeli. Ci colpisce la sproporzione numerica tra le polemiche guarigioni riferite dall’AT. e le tante riportate dal NT. Perché questa profusione improvvisa di miracoli? Il motivo è il momento particolare della storia della salvezza (il kairós) rappresentato dalla venuta di Gesù Cristo. Per capire il senso delle guarigioni miracolose di Gesù è illuminante il quadro costruito da Luca per dare solennità all’inaugurazione del ministero di Gesù. Il giovane rabbi prende la parola nella sinagoga di Nazaret. Legge dal profeta Isaia (61, 1-2) quanto si riferisce all’attività del messia nell’anno della salvezza universale: “Lo Spirito è sopra di me; per questo mi ha consacrato, mi ha mandato a predicare ai poveri la buona novella, ad annunziare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi il recupero della vista, a mettere in libertà gli oppressi, a promulgare un anno di grazia del Signore”. Gesù commenta la citazione profetica dicendo semplicemente: “Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia” (Lc. 4, 21). L’anno giubilare ebraico (Lv. 25, 8-18. 23-55), con cui è raffigurata la salvezza escatologica, è iniziato; il grande sabato della fine dei tempi è arrivato. Le guarigioni di Gesù in giorno di sabato, così scandalose per i legalisti, volevano appunto alludere a questo grande anno sabbatico. Le guarigioni, con il loro numero e la loro prodigiosità, hanno precisamente il compito di essere segno dei nuovi tempi che sono arrivati. In quanto segno sono un avvenimento indicativo di qualche cosa; l’elemento straordinario attira l’attenzione e la dirige sulla realtà nascosta, il regno di Dio, appunto, che sta venendo. Le guarigioni taumaturgiche di Gesù sono l’annuncio e l’inserzione nel tempo d’un ordine nuovo, quello escatologico e definitivo, inaugurato dai tempi messianici.
Quando i profeti annunciavano il regno futuro, ne descrivevano la venuta attraverso una serie di segni: la consolazione, l’abbondanza, la pace la guarigione (Is. 61, 1-3; Mic. 4, 1-4; Ger. 33, 6; Is. 35, 5-6). Come l’esilio e la schiavitù, la malattia appare come la realtà provvisoria, la
85
cui sparizione indicherà la venuta dei tempi nuovi. Con la guarigione sarà benedetto il popolo che entra nell’area dell’alleanza definitiva. Le malattie hanno, in generale, quella funzione di segno che Gesù attribuisce in particolare alla cecità del cieco nato: “Né lui, né i suoi genitori hanno peccato, ma è così affinché si manifestino in lui le opere di Dio” (Gv. 9, 3). La cecità ci appare qui come l’occasione nella quale Dio manifesta la realtà e la potenza della grazia nel quadro della missione di Gesù. La malattia non è spiegata: essa è là per essere vinta dall’intervento travolgente del Dio fedele all’uomo. Questa è l’interpretazione che Gesù dà esplicitamente della fioritura di guarigioni attorno alla sua persona. Rispondendo alla domanda perentoria della delegazione del Battista: “Sei tu quello che deve venire?”, Gesù rimanda ai segni messianici ben conosciuti dai lettori della Bibbia: “Andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, ai poveri è annunciata la buona novella” (Mt. 11, 2-6). Per amore di chiarezza Luca, riportando lo stesso episodio, aggiunge: “In quel momento egli guarì molte persone da malattie, da infermità e da spiriti maligni e restituì la vista a molti ciechi” (Lc. 7, 21). L’elemento più caratteristico in queste guarigioni è che esse non vogliono essere un semplice ristabilimento della salute come equilibrio organico, ma espressione della venuta d’un ordine nuovo, in cui il male non ci sarà più. Per questo le guarigioni sono così spesso collegate con il perdono dei peccati. È un segno che Dio, attraverso il suo Spirito, riprende possesso di tutta la creazione che gli si è alienata.
Il perdono dei peccati ha dunque lo stesso significato della guarigione. Questa concretizza il perdono (cfr. soprattutto Mc. 2, 1-12); ma l’uno e l’altro insieme attestano la venuta dei tempi nuovi in cui gli uomini sono guariti e perdonati, liberati e saziati. Le guarigioni di Gesù sono un vero atto di salvezza, la conseguenza necessaria della nuova alleanza: dopo aver dato all’uomo un cuore nuovo, ecco che Dio “fa nuove tutte le cose” (Ap. 21, 5). Anche questi segni della salvezza partecipano alla tensione tra “già” e “non ancora” che è propria del momento attuale della storia sacra. Se, da un lato, Cristo ha vinto la morte (e la malattia) nella propria risurrezione, dall’altro è chiaro che non l’annienterà definitivamente che alla sua parusia (cfr. 1 Cor. 15, 26). I vangeli stessi ci aiutano a non interpretare in modo trionfalistico i segni del regno. Sottolineano che tali segni si realizzano in un contesto così sprovvisto di potenza, che possono diventare tanto occasione di scandalo, quanto occasione
86
di fede (Mt. 11, 6). Le guarigioni operate da Gesù non sono destinate a inaugurare in modo glorioso un’era di felicità sulla terra, sul tipo dei miti millenaristici, ma solo a porre dei segni della presenza del Figlio dell’uomo e della prossimità del regno. Il Figlio dell’uomo non realizza la sua missione terrena trionfalmente. Si comporta precisamente in quel modo umile e inglorioso con cui Isaia aveva tracciato il destino del “servo sofferente di Jahvé” (Is. 42, 1-7; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13; 53, 12). La missione di Gesù è stata una missione salvatrice condotta nella debolezza umana pienamente abbracciata. Gesù guarisce, ma lo fa caricandosi della miseria umana. A tal punto, che il “segno” decisivo non saranno le guarigioni delle malattie, ma il “segno di Giona” (cfr. Mt. 12, 38-40), cioè la croce e la risurrezione.
Gesù e il male fisico
Nella vita di Gesù possiamo individuare due risposte alla provocazione del male fisico: quella del profeta-terapeuta che guarisce per annunciare e instaurare l’ordine nuovo, e quella del servo di Jahvé che trasforma il dolore facendone un momento della salvezza. Tra i due atteggiamenti è possibile una sintesi superiore, dialettica, alla luce del mistero pasquale nella sua interezza. Se consideriamo l’opera di Gesù dal punto di vista del mistero pasquale, dobbiamo tener presenti gli elementi che costituiscono la categoria biblica della pasqua. Li possiamo sintetizzare in questa espressione: da una situazione di morte (schiavitù, peccato, alienazione), per opera di Dio, scaturisce una vita nuova. Questo è il significato della prima pasqua: un passaggio dalla schiavitù in Egitto e dalla condizione di “non-popolo” alla condizione di “popolo di Dio”, grazie all’intervento travolgente e gratuito di Jahvé (cfr. Dt. 7, 7-8). Gli stessi elementi ritroviamo nella pasqua di Gesù, quella che darà origine all’alleanza nuova e definitiva. Solidarizzatosi con gli uomini, egli ha voluto operare, per sé e per tutti, un passaggio dallo stato di lontananza da Dio — che il linguaggio biblico descrive come “secolo presente”, sotto il potere di satana — alla condizione di perfetta alleanza con Dio, cioè di “figli di Dio”, sempre secondo il linguaggio della Bibbia. Ma la pasqua di Gesù non è stata opera di potenza folgorante: egli ha accettato la condizione umana di impotenza di fronte al male e l’ha vissuta senza deflettere minimamente dal dono di sé al Padre e ai fratelli. Il valore di salvezza umana
87
di Gesù — che raggiunge l’apice nella passione e nella morte — consiste nel fatto che diventa espressione dell’amore fedele al Padre e agli altri uomini: un amore tanto più radicale, quanto è più totale la debolezza in cui si esprime, fino a quel vertice di fedeltà e di debolezza proclamato dal grido di Gesù morente: “Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito” (Lc. 23, 46). In risposta a questa fedeltà “Dio ha costituito signore (Kyrios) e messia” questo Gesù crocifisso dai suoi (cfr. At. 2, 36) e lo ha reso sorgente di spirito e di vita nuova per tutti (cfr. 1 Cor. 15, 45). In questo senso preciso le sofferenze di Gesù e la croce sono state redentrici.
Il dinamismo pasquale della vita del Cristo rende ragione di ambedue gli atteggiamenti di fronte al male fisico: la lotta a oltranza di Gesù terapeuta e l’accettazione di Gesù quale servo di Jahvé. Gesù ha voluto lottare contro il male, perché la salute è una delle “benedizioni” della nuova alleanza e il suo recupero è uno dei segni della vicinanza del regno, anzi del fatto che il regno è già presente nel mondo come lievito nella pasta (Mt. 13,33). Ma ha lottato senza adottare un atteggiamento di titanismo, bensì nella debolezza umana. Ha impedito però che il male lo allontanasse dal Padre; ne ha fatto anzi il mezzo per dimostrare un amore fedele a oltranza, assumendo il dolore nella sua vicenda pasquale. Con ciò Gesù ha vinto realmente il male fisico nel suo aspetto più pericoloso, cioè quello di bloccare il progetto esistenziale umano nella sua maturazione in senso personale e sociale. Per quanto il credente può lanciare, con S. Paolo, la sfida: “Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?” (1 Cor. 15,55). Il male fisico non deve esistere e un giorno, nel regno — anticipato ora nel corpo glorioso di Gesù — non esisterà più. Se esiste ancora — in quanto la “consumazione” non è ancora venuta — esso è vinto, perché può diventare espressione di amore fedele in colui che non si lascia sviare dal suo atteggiamento di dedizione di se stesso, sul modello di quello di Gesù. Non è facile sintetizzare l’atteggiamento di Gesù di fronte al male fisico in una espressione. Se prendiamo in considerazione la dialettica pasquale, non possiamo parlare semplicemente di lotta contro il male o semplicemente di accettazione: rischieremmo di deformare il messaggio biblico, mutilandolo. Quel che è certo è che nella vita di Gesù trova espressione concreta e visibile quella “costanza” (hypomoné) nella quale i primi cristiani hanno individuato, a livello morale, la novità cristiana nel mondo 62. Questa novità
88
sono chiamati a vivere, anche quando sono colpiti dalla malattia, coloro che si sono messi alla sua sequela.
2. La fede che guarisce
In tutte le società arcaiche il potere sul corpo è di pertinenza del sacro e l’uomo di religione amministra poteri terapeutici che riguardano tanto il corpo che l’anima. Alla religione è riconosciuta un’efficacia terapeutica ovvia, dal momento che mette in contatto con l’onnipotenza divina. La guarigione nell’ambito dell’esperienza religiosa è assunta tipicamente nella categoria del miracolo. Nel quadro di riferimento proprio dell’esperienza religiosa, il miracolo — inteso non solo nel senso tecnico dell’apologetica, ma in generale quale segno dell’irruzione del divino nell’ambito dell’umano — non è un evento straordinario, bensì assolutamente ordinario. Nella cultura occidentale, parallelamente allo sviluppo dell’idea di “natura” e di un “ordine naturale” in cui si sviluppano i fenomeni, ha prevalso l’accezione del miracolo come avvenimento eccezionale, che esula dalla normalità prevista dalle leggi note all’uomo. L’apologetica cristiana si è inserita in questa prospettiva e ha utilizzato il miracolo come argomento contro il razionalismo, per dimostrare in maniera inconfutabile, proprio perché basata sulla ragione stessa, che il miracolo configura una infrazione delle leggi della natura ad opera della causa soprannaturale.
L’approccio apologetico delle guarigioni che avvengono nell’ambito dell’esperienza religiosa manifesta palesi carenze. Deve prendere in considerazione, anzitutto, un numero molto ristretto di guarigioni straordinarie, quelle cioè che, secondo i criteri scientifici, non possono essere attribuite a cause “naturali”. L’interesse si concentra su alcune poche guarigioni straordinarie incontestabili (per l’argomentazione apologetica è sufficiente, al limite, dimostrare l’esistenza di un solo miracolo indubitabile!). Si evita accuratamente tutto ciò che cade sotto il sospetto di isteria o di suggestione, eliminando in tal modo tutto il settore, così importante dal punto di vista del vissuto esistenziale, delle affezioni funzionali o psicosomatiche. Fra le guarigioni miracolose si ritengono solo quelle che si riferiscono a malattie organiche certe, evidenti, giudicate inguaribili da
89
numerosi medici; la guarigione stessa deve essere caratterizzata da istantaneità o da stupefacente rapidità. L’ufficio medico di Lourdes è noto per la rigidità con cui seleziona le guarigioni che aspirano a farsi riconoscere come miracoli. Solo poche pretese guarigioni miracolose resistono al vaglio degli eminenti medici preposti a quel comitato; e tra queste molte vengono poi scartate successivamente dai vescovi responsabili del giudizio canonico. Questa concezione è soggetta a una critica teologica. È responsabile, infatti, di un impoverimento della categoria antropologico-religiosa del miracolo, se lo confrontiamo con il senso che ha nella Bibbia 63.
Già nell’A.T. l’elemento distintivo del miracolo non sta nel carattere prodigioso e stupefacente, bensì nel potere di rivelazione — vale a dire, Dio che si manifesta nelle sue opere — che esso contiene. Il vero miracolo è Dio stesse che si rivela in ciò che fa per l’uomo. In alcuni momenti, tuttavia, l'esperienza del rapporto tra Dio e l’uomo, nell’alleanza, si intensifica; e la religiosità popolare riconosce nei segni teofanici, o miracolosi, questa presenza più intensa. Anche il N.T., specialmente il vangelo di Giovanni presenta il miracolo ricorrendo alla categoria di “segno”, riferito alla presenza salvifica di Gesù come messia, che si propone alla fede del credente.
Un risultato positivo della difesa da parte della chiesa delle caratteristiche apologetiche delle guarigioni miracolose è stato quello di acuire lo spirito critico e di tenersi a distanza dai pericolosi estremismi delle sètte. Nell’ambito delle sètte, anche a denominazione cristiana, l’uso della fede per ottenere guarigioni miracolose è degenerato spesso in macchinazioni di fanatici ed estatici, con grossolano disprezzo di fattori corporali, uso di violente suggestioni primitive, attraverso le quali si suscita un legame di schiavitù col guaritore, fanatici tentativi di esorcismi, confinanti con la superstizione 64. Un valore quasi tipico ha assunto la “Christian Science”. La fondatrice, Mary Baker, personalmente debole di salute e sofferente, si interessò di magnetismo e di omeopatia, insieme alla meditazione della Bibbia. Andò sempre più convincendosi che non sono le medicine a guarire, ma la fede dell’infermo, perché tutte le malattie hanno
90
la loro causa in un turbamento dello spirito. Nel 1875 pubblicò un libro, Science and Health, che divenne normativo per i suoi seguaci; l’anno seguente fondò la “Christian Science Association”, da cui si sviluppò in seguito una chiesa. Gli “scientisti” non hanno sacerdoti o pastori, ma soltanto dei lettori, che durante le riunioni leggono la Bibbia e il libro della fondatrice, e infermieri, detti practitioners, che guariscono gli infermi col loro “metodo mentale”. La dottrina scientista, di tendenza panteista, insegna che l’unica realtà è lo spirito di Dio. Il peccato, la materia e la morte non sono reali, bensì illusioni che diventano potenze solo per l’uomo che dimentica Dio e sprofonda nei godimenti materiali del sensi. Le malattie si devono curare togliendo queste illusioni dalla mente dell’uomo.
Una concezione così radicale non corrisponde al “sensus fidei” sottostante alla pratica della preghiera per la guarigione, costantemente tenuta viva specialmente nel cristianesimo popolare. La fede nella guarigione in risposta alla preghiera come fatto normale nella vita del credente (secondo le promesse di Cristo in Mc. 16, 17-18 e Gv. 14, 12) si è sempre coniugata con un rispetto delle cause seconde. Ciò ha premunito dal diffondersi di atteggiamenti miracolistici e pratiche aberranti, in cui il superamento del razionalismo medico diventa sfida alla ragione, disprezzo dei fattori corporei, e i carismatici difficilmente si distinguono dai ciarlatani.
Di recente un forte impulso a riscoprire la componente terapeutica della fede è venuto dal movimento carismatico 65. Esso ha le sue radici nel pentecostalismo: non tanto quello originario, sorto in America agli inizi del secolo, colorato di settarismo e incline alle manifestazioni spettacolari, bensì quello più moderato sviluppatosi negli ultimi decenni, disposto a restare nelle chiese e ad animarle dall’interno. A partire dagli anni ’70 il movimento pentecostale, o rinnovamento nello Spirito, è diventato un fatto ecclesiale considerevole anche all’interno della chiesa cattolica, coinvolgendo tanto la base quanto la gerarchia.
Una delle pratiche più singolari riproposta dal movimento è appunto quella della guarigione mediante l’imposizione delle mani e la preghiera. Punto di riferimento ideale è la comunità cristiana primitiva, delle cui pratiche carismatiche siamo abbondantemente informati dagli Atti degli Apostoli. I primi cristiani, a loro volta, si rifacevano alla prassi di Gesù stesso, nel cui ministero profetico le guarigioni sono state uno dei principali “segni
91
dei tempi” messianici (cfr Lc. 4, 16-22). Il ministero della guarigione fa parte del mandato missionario di cui è investita la chiesa (Lc. 9, 1-2; 10, 8-9).
L’ambito terapeutico della fede si estende ad esperienze umane che trascendono la guarigione medica o il miracolo apologetico. Il fatto antropologico che è toccato dalla forza guaritrice della fede è, più che la malattia in senso clinico, quel “mal-essere” come fenomeno globale che investe il corpo, la psiche e lo spirito dell’uomo 66. La guarigione è un processo che comincia dall’interno per riflettersi sul corpo malato. Ha inizio con l’intimo risanamento spirituale, vale a dire con l’esperienza di essere stati afferrati da Gesù e posti nella vita stessa della famiglia di Dio. Questa conversione è come una nuova nascita, ed equivale al battesimo nello Spirito Santo. Dalla certezza della presenza della salvezza nella propria esistenza scaturisce una forza nuova per affrontare i mali della vita, presente e passata. Qualsiasi esperienza di rifiuto, oppressione, non-amore può essere guarita, comprese le ferite provocate dalle esperienze passate (la “guarigione delle memorie”). I carismatici amano parlare della potenza terapeutica della pace di Gesù. Quando la coscienza è piena d’amore, di gioia, di pace, di pazienza, di bontà, di benevolenza, di fede, di dolcezza, di padronanza di sé (cioè di quelli che Paolo in Gal. 5, 22 chiama i “frutti dello Spirito”), possiede una forza di guarigione contro ogni male, compresi quelli fisici.
In questo tipo di guarigioni un ruolo decisivo gioca la comunità. Essa assicura un ambiente di amore e di sollecitudine, in vista del sostegno
92
fraterno del singolo. Allora la guarigione arriva al suo pieno sviluppo, fino ad essere cioè guarigione delle relazioni. Credendo in sé e negli altri, accettandosi e sentendosi accettato, il credente è motivato a sperare non solo in un semplice ristabilimento della salute, ma in una vita qualitativamente diversa. L’imposizione delle mani, che ha luogo durante la preghiera, esprime simbolicamente la comunione cristiana intorno a chi soffre e aiuta a visualizzare l’energia terapeutica che circola nella comunità. La pratica della guarigione attraverso la preghiera apparirà meno singolare qualora si consideri l’uomo nella reale unità psico-fisica-sociale della sua esistenza. Se già, come qualcuno ha osservato, il cinquanta per cento di ogni psicoterapia consiste in un rapporto diretto e caloroso col paziente, come si può sottovalutare l’effetto psico-somatico di un’esperienza come quella che assicura il gruppo di preghiera? L’attenzione si sposta così all’altro elemento antropologico fondamentale della morale medica cristiana: la comunità e il ruolo che essa svolge nella guarigione.
Prima, tuttavia, di parlare della funzione terapeutica della comunità, un ultimo accenno ad alcuni problemi etici connessi con il ricorso alla fede e alla preghiera per la guarigione 67. È necessario, in primo luogo, che la pretesa di guarire con la fede non si risolva in un danno della salute. Il principio classico del primum non nocere, come imperativo etico di chiunque svolge un compito terapeutico, è del tutto pertinente anche in questo campo. La salute, o addirittura la vita, possono essere minacciate quando si dilaziona o si tralascia l’intervento medico. Le cure religiose possono essere complementari o addizionali alle cure mediche, ma non sostitutive, se non si vuole perpetrare gravi danni fisici. Ciò è avvenuto quando, per esempio, casi di anoressia mentale o di isteria sono stati trattati come possessioni diaboliche e sottratti alla competenza medica, con pregiudizio della salute. E anche con pregiudizio della fede, che viene accusata di incrementare atteggiamenti oscurantisti.
Un secondo problema etico che si pone al medico è quello dell’interferenza tra le proprie convinzioni circa le guarigioni per fede e quelle del paziente. I pregiudizi possono essere tanto in un senso, come nell’altro. Chi non crede nel potere terapeutico della fede può vedere i guaritori religiosi o come sinceri e disinformati, o come coscientemente ingannatori e interessati; nell’uno come nell’altro caso, tenderà a dissuadere dal farvi ricorso. Chi crede nelle guarigioni religiose e le pratica, invece, tenderà
93
a comunicare agli altri questa sua personale convinzione, e magari a far del proselitismo. In ogni caso l’onestà richiede che si sappia distinguere tra ciò che si conosce come rispondente a verità, e ciò che si spera o si crede che sia vero.
Tra i poteri che ha la malattia uno dei più temibili è quello di separare l’individuo colpito dalla comunità di appartenenza. Nei contesti culturali religioso-sociali l’esclusione è collegata con la rappresentazione della malattia come punizione di una colpa. Il mondo greco ha espresso questa convinzione con un mito legato alla figura di Filottete, protagonista di uno dei drammi più umani di Sofocle. Il grande arciere era stata morso durante la guerra dal serpente che stava a guardia del sacrario della dea, nell’isola di Crise. La ferita si rivelò inguaribile. Il poveretto, in preda ad atroci dolori, gridava in maniera tanto angosciosa che i suoi lamenti demoralizzavano l’esercito greco. Ma il ferito Filottete era più che un elemento di disgregazione dell’efficienza bellica: era un segnato degli dei. Con la sua presenza di malato contaminava la spedizione. Se era respinto dall’Olimpo, bisognava respingerlo anche dalla comunità degli uomini. Mettersi dalla parte di colui che gli dei avevano colpito avrebbe significato sfidare la divinità. Perciò, su consiglio di Ulisse, Filottete fu abbandonato nell’isola di Lemno 68. Non solo nella cultura greca la malattia e la disgrazia erano punizioni per l’offesa recata a forze sacre e terribili. Anche nel mondo biblico la malattia viene interpretata come segno di una rottura nei rapporti tra Dio e l’uomo. Il Vecchio Testamento considera la malattia quasi esclusivamente come giudizio punitivo di Dio per i peccati. Solo con Gesù, come abbiamo visto, viene contestata l’equiparazione della malattia a segno di colpa personale.
La malattia e la disgrazia pongono colui che è colpito al di fuori della comunità dell’alleanza. Giobbe, seduto sul letamaio, ne esprime simbolicamente la condizione all'interno del popolo di Dio. Finché non sarà guarito, non potrà essere reintegrato. I lebbrosi non erano cacciati via dal consorzio civile per motivi igienici. Quel che premeva era esprimere in modo netto che la comunità dei santi prendeva le distanze da chi portava nella carne il segno del giudizio di Dio.
94
La tendenza alla segregazione si acutizza in alcuni movimenti religiosi al tempo di Gesù. Già i farisei tendevano a escludere dalla comunità escatologica tutti coloro che non osservassero alla perfezione la Torah. Gli esseni portavano alle estreme conseguenze i principi della loro matrice farisaica. Escludevano dalla loro comunità indegni e imperfetti; e non tolleravano nelle assemblee liturgiche coloro che fossero affetti da imperfezioni fisiche. Diceva testualmente la regola della comunità: “Tutti coloro che sono colpiti nella carne, storpiati ai piedi o alle mani, zoppi o ciechi o sordi o muti o visibilmente imperfetti nel fisico; ovvero un vecchio decrepito che non sa reggersi in piedi nella comunità riunita, costoro non possono venire a porsi in mezzo all’assemblea degli uomini del Nome, perché i santi angeli sono nella comunità” 69.
In contrasto marcato con queste concezioni risalta l’opera di Gesù. Egli ha rifiutato di realizzare la comunità messianica del “resto di Israele” basandosi sul principio della emarginazione. Fu scandaloso, provocatorio e perturbatore lo spettacolo di Gesù che rifiutava le tipiche pretese farisaiche ed esseniche di realizzare il “santo resto” per esclusione e si rivolgeva di preferenza proprio a coloro che venivano messi ai margini delle comunità dei perfetti. Il suo annuncio era di una grazia senza limiti e senza condizioni; predicava Dio cerne padre dei deboli e dei perduti, benevolo verso i peccatori (cfr. Lc. 15, 7-10). E guariva tutti (cfr. Mt. 4, 23-24; Mt. 14, 34-35). Quel “tutti”, più che in senso quantitativo e statistico, va preso nel senso che Gesù guariva malati di ogni sorta, di tutti gli ambienti, senza discriminazioni preliminari. Proprio questo era scandaloso per i suoi avversari, e doveva essere recepito come un’audace infrazione delle regole di purità religiosa 70. Lasciarsi toccare da quelle folle innumerevoli ed eterogenee era un’abominazione dal punto di vista dei farisei e degli esseni. Gesù esprimeva in tal modo che esercitava il suo ministero presso il popolo intero, e non a beneficio di alcuni privilegiati o specialisti della vita religiosa. La prassi messianica di Gesù era
95
basata sull’integrazione, e non sulla segregazione. Nei sistemi sacrali in cui vige la distinzione puro/impuro, la comunità si difende dalle tendenze disgregatrici escludendo chi non corrisponde alle esigenze legali di purezza. Ha bisogno, in un certo senso, di impuri ai suoi margini, per mantenere compatto l’organismo comunitario. È un principio che sopravvive alla caduta della mentalità sacrale: anche nelle società basate sull’efficienza avviene un’emarginazione o eliminazione di coloro che sono sotto lo standard competitivo.
L’opera messianica di Gesù avviene nella comunità ed è diretta alla comunità. È la base su cui si costruisce il popolo di Dio dei tempi escatologici. “Nella missione e nel messaggio di Gesù Cristo la sua opera di guarigione non era una conseguenza secondaria, ma il vero e proprio mezzo per proclamare, istituire e ampliare la nuova èra, sotto la signoria di Dio. L’attività terapeutica del Cristo non era in primo luogo un’azione privata tra l’uomo e Dio, una prova spirituale individuale e una ricompensa per il malato, bensì un “segno efficace”. Le guarigioni non erano unicamente segni efficaci in cui Cristo e il guarito fossero i soli attori, bensì segni a cui tutti i presenti prendevano parte, non ultimi quelli che deridevano. Erano segni efficaci pubblici” 71.
I miracoli di guarigioni non avvengono solo “di fronte” al pubblico. “Tra di voi” ha un carattere più pregnante: essi, il pubblico, sono il malato che è curato. Il malato rappresenta la loro malattia, l’esclusione è il sintomo. Le guarigioni operate da Gesù sono giudizio e risanamento della comunità in cui avvengono. La malattia di un individuo è una forza di crisi, espressa dall’emarginazione, che offre a tutto il gruppo una possibilità di bene o di male. È un’opportunità di grazia che termina in un nuovo equilibrio, vale a dire un legame comunitario rinsaldato. Gesù che guarisce è quello stesso che, risorto, ai discepoli di Emmaus e agli apostoli in riva al lago dopo la pesca si rivelerà come Maestro nella condivisione (cfr. Lc. 24, 13-35 e Gv. 21, 1-14).
Facendo memoria dell’attività terapeutica di Gesù, la comunità cristiana si interroga sulla propria funzione nel campo della sanità. Il punto di partenza della sua azione è la constatazione che anche oggi, sotto nuove forme, la malattia opera come elemento disgregante dei legami sociali. Gli sviluppi del servizio sanitario hanno portato a privilegiare le strutture pubbliche, in primo luogo l’ospedale. Quando pensiamo al malato, l’immagine che ci viene spontanea evocare è quella del degente all’ospedale,
96
separato dalla famiglia e dalla società, inserito in una struttura di assistenza che si occupa di lui finché non può essere restituito alla sua vita normale. Parallelamente al progresso dell’intervento pubblico, si son venute atrofizzando le strutture terapeutiche tradizionali, vale a dire la famiglia e i vicini. Anche se ricoverato in un ospedale attrezzato ed efficiente, e perfettamente accudito, il malato si sente un isolato, penosamente rigettato ai margini della collettività. Ciò soprattutto quando la malattia si stabilizza e non ci sono più speranze di remissione. Oggi ci si rende conto che la soluzione ai problemi più gravi della sanità esige una risposta comunitaria e il potenziamento dell’interdipendenza. Così per il problema degli anziani, della malattia mentale (per la prevenzione e la guarigione di queste malattie le relazioni personali sono indubbiamente il fattore più importante), degli handicappati.
Il principio che segretamente ispira il rinnovamento della presenza ecclesiale nel settore della sanità è proprio il recupero di quell’aspetto delle guarigioni di Gesù che faceva di esse una parabola della famiglia di Dio dei tempi messianici, in cui gli emarginati sono integrati. Il rinnovamento del rito dell’unzione degli infermi, voluto dal Concilio (L.G. 11; S.C. 73) e realizzato dalla congregazione per il culto divino (1972), va in questo senso 72. Le norme teologico-pastorali che precedono il rito lo inseriscono in un ampio contesto di gesti e iniziative pastorali che tendono al pieno reinserimento del malato nella comunità, in netto contrasto col processo di emarginazione. La comunità si stringe solidarmente attorno al malato che difende la vita per poter continuare a donarla. Questo è il significato antropologico ed ecclesiale del sacramento degli infermi. Non “estrema unzione”, rito del passaggio cruciale attraverso la morte, come era diventato in pratica; bensì evento che attualizza la dimensione comunitaria del piano di Dio per la vita. La comunità cristiana abbraccia il fratello per trasmettergli la forza di Colui che ha vinto le potenze distruttive che disgregano la persona umana e la spingono ai margini delle società. Tale gesto fraterno è destinato a servire alla vita. Forse alla vita del corpo; certamente serve alla vita nello Spirito d’amore. Questo sacramento chiede pertanto d’essere celebrato quando il malato si trova nel pieno della lotta per la vita — non è quindi, di per sé, il sacramento dell’agonia, che di questa lotta è l’ineluttabile conclusione —; esso rivela inoltre tutto il senso quando è celebrato in forma comunitaria, così come in più parti si va sperimentando.
97
Il servizio che la comunità dei credenti in Gesù può rendere a coloro che la malattia emargina, al fine di integrarli con gesti religiosi, non si esaurisce nella celebrazione del sacramento dei malati. Anche la visita e la comunione frequente contribuiscono a rinsaldare i legami con la comunità. Le istruzioni contenute nel rituale per il sacramento dell’unzione e per la cura pastorale degli infermi raccomandano: “Tutti i cristiani devono far propria la sollecitudine di Cristo e della Chiesa verso gli infermi. Cerchino quindi, ognuno secondo le possibilità del proprio stato, dì prendersi cura premurosa dei malati, visitandoli e confortandoli nel Signore e aiutandoli fraternamente nelle loro necessità”. Nella comunità cristiana la preghiera comune resta il modo fondamentale per esprimere la solidarietà e per stringere i legami. Nella preghiera dei fedeli durante la liturgia domenicale una vera comunità, oltre al ricordo dei malati in generale, saprà indicare alla sollecitudine dei fratelli quelli in particolare che la malattia ha messo in grave stato di necessità.
Un modo di tradurre in pratica il nuovo senso di solidarietà con i malati che si instaura all’interno della comunità cristiana può essere l’attività di volontariato. Il volontariato è di casa nella chiesa. Basti pensare al servizio ai poveri e ai malati svolto dalle conferenze di S. Vincenzo. Negli ultimi anni, tuttavia, il volontariato è diventato di particolare attualità. Una polemica sulla dialettica “pubblico”-“privato” ha portato a proposte estreme e unilaterali: o tutta l’attività assistenziale allo Stato, o tutta alla libera iniziativa. Il volontariato è diventato in tal modo il pomo della discordia per coloro che pensavano in termini di alternativa. Negli anni ’70 si è avuta una vera e propria campagna di opinione contro ogni espressione che non fosse rigidamente statale e un’azione di emarginazione nei confronti degli interventi di volontariato. Attualmente tende ad affermarsi un’immagine più articolata del “sociale”, che supera la diatriba e valorizza il pluralismo. La comunità cristiana si trova in prima linea nella ridefinizione del volontariato socio-assistenziale 73. Esso costituisce un superamento dell’eccesso di burocratizzazione della vita quotidiana, una proposta di nuova qualità della vita, una riorganizzazione soggettiva del rapporto lavoro-tempo libero. Per la soluzione di alcuni problemi sociale acutissimi (si pensi ai drogati, agli handicappati, agli anziani, all’umanizzazione delle strutture ospedaliere...) il volontariato fornisce
98
una risposta originale e insostituibile. L’attività volontaristica apporta inoltre un correttivo alla mentalità di Welfare State, che conduce alla progressiva deresponsabilizzazione della popolazione e al vertiginoso dilatarsi della spesa pubblica in servizi socio-sanitari gestiti dagli enti statali. Attraverso il proprio coinvolgimento, i cittadini vengono rieducati al senso di responsabilità. Anche la legge che ha introdotto in Italia la riforma sanitaria ha sancito il diritto del volontariato come uno dei soggetti abilitati a concorrere all’attuazione della riforma stessa.
Oggi, quindi, il dibattito si sposta dalla validità dell’esistenza del volontariato ai suoi aspetti e modalità; in particolare, all’articolazione dell’intervento volontaristico con il lavoro del personale delle istituzioni e alla formazione dei volontari. L’ingenuità e lo spontaneismo di chi fa un’opera di volontariato tanto per fare qualcosa non sono ammissibili nel campo della sanità, dove si interferisce continuamente con i più delicati problemi posti dalla sofferenza.
99
Parte Terza
ALCUNI PROBLEMI DI BIOETICA
100
101
Introduzione
IL RICHIAMO ATTUALE A UN’ETICA IN CAMPO BIO-MEDICO
Fra le istanze normatrici del comportamento relativo alla saluti e alla malattia l’etica si distingue per una propria specificità, che la differenzia tanto dai parametri che si riferiscono all'ethos tradizionale, quanto da quelli deontologici. L’etica, in quanto sistema inteso a regolare il comportamento umano al fine di salvaguardare e realizzare valori, ha il suo Sitz im Leben nell’azione; e l’azione sanitaria è quanto mai intessuta di riferimenti ai valori. Si rivolge, infatti, all’uomo nei suoi vissuti esistenziali più pregnanti, come sono la nascita, la morte, la decisione riproduttiva, la crisi della malattia e la ricerca della salute; investe il campo della vita sociale, in cui va necessariamente collocata la malattia; tocca i confini in cui l’uomo si pone di fronte alla natura in quanto “homo faber”, con crescenti poteri tecnologici di intervento su quello che è il dato naturale. L’etica ha come suo compito di situare l’azione sanitaria nell’orizzonte delle scelte di fondo.
La linea di incontro tra la prassi medica e l’etica si è andata sempre più ampliando. Fino a un’epoca recente la morale medica era associata ad alcuni casi-limite: l’aborto, l’eutanasia, i trapianti di organo, la sterilizzazione, la fecondazione artificiale. Oggi è praticamente tutta la medicina che richiede un quadro etico di riferimento. Aumentano, infatti, vertiginosamente le conoscenze di ordine bio-medico (si calcola che, al ritmo attuale, tale patrimonio ogni venti anni praticamente si raddoppiai, ma si fa sempre più lontano il consenso su un modello antropologico che permetta di discriminare tra ciò che è proprio dell’uomo e ciò che non lo è più. Parallelamente, la tecnologia applicata alla medicina accresce la capacità di intervento. La vita può essere interrotta non solo all'inizio
102
(aborto) o alla fine (eutanasia), ma manipolata in mille maniere: manipolazione del patrimonio genetico (“ingegneria genetica”), sperimentazione sugli embrioni, embrio transfert, trapianti di organi di ogni genere, naturali e artificiali, interferenza sul processo naturale del morire (accanimento terapeutico e distanasia). Gli stessi confini tra ciò che è proprio della ricerca e sperimentazione biologica, e ciò che appartiene al campo della terapia medica, tendono a sfumare. La questione della liceità, tradizionalmente posta nei confronti di alcune pratiche mediche, viene straordinariamente ampliata: oggi ci troviamo a domandarci non solo che cosa si può fare e che cosa no, ma se è lecito fare tutto ciò che la tecnologia biomedica è in grado di fare 74.
L’ampliamento dell’etica medica è avvenuto anche su altri fronti. La sua portata si è estesa al di là del rapporto interpersonale (one-to-one) quale si stabilisce tra il medico e il paziente. Le azioni attuali dell’uomo, per gli effetti cumulativi delle rotture di equilibrio, hanno gravi conseguenze per le generazioni future. La nuova coscienza ecologica ci ha reso consapevoli che anche verso le forme di vita non umana l’uomo ha una grave responsabilità. Siamo in grado di vedere diritti dove l’etica tradizionale non li aveva considerati: diritti dell’ambiente, degli animali, delle piante. L’agire responsabile deve essere allargato anche a questo ambito di fenomeni vitali. Anche altre professioni, oltre a quella medica, sono coinvolte dagli interrogativi etici: il personale infermieristico e paramedico, i professionisti della medicina preventiva e dell’igiene mentale, gli assistenti sociali ed altri “social workers”. Lo spostamento, infine, della prospettiva dai doveri del medico ai diritti del malato, ad opera del movimento che ha portato anche nell’ambito della sanità il dibattito sui diritti civili, ha ulteriormente modificato il quadro di riferimento dell’etica medica tradizionale 75.
In conseguenza delle numerose trasformazioni, si preferisce oggi sottolineare la novità dell’approccio dando a tale riferimento ai valori il nome di “bioetica”. Secondo la definizione che ne dà l’autorevole Encyclopedia of Bioethics, la bioetica è “lo studio sistematico della condotta umana nell’area delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto
103
questa condotta è esaminata alla luce dei valori e dei principi morali” 76. Ha una portata più ampia, rispetto all’etica medica, in quanto include i problemi in rapporto ai valori che insorgono in tutte le professioni sanitarie (oggi, in primo piano, quelle relative al trattamento dei disturbati mentali e “sociopatiti” in genere); si estende alla ricerca biomedica e comportamentale; abbraccia un vasto raggio di problemi sociali, come il controllo demografico; si estende al di là della vita e della salute umana, includendo i problemi dell’ambiente. Gli interessi delle bioetica si estendono ulteriormente se consideriamo la cura della salute in senso ampio, come ricerca del pieno sviluppo umano bio-psico-socio-spirituale, secondo la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “lo stato di completo benessere corporeo, mentale e sociale, e non solo l’assenza di malattia e infermità” 77.
Emerge la tendenza a vedere nella bioetica una risposta alla crisi attuale della medicina e alla richiesta di un esplicito riferimento della prassi bio-medica a valori e fini propri dell’uomo. Soprattutto nei paesi anglosassoni nell’ultimo decennio si è verificata un’espansione considerevole dell’etica medica o bioetica, che è stata introdotta come disciplina nel curriculum della formazione dei medici. Alla bioetica arride negli USA una larga popolarità, anche al di fuori delle scuole di medicina. Occupa il posto centrale dell’interesse che negli anni ’60 spettava all’etica della guerra e dei diritti civili 78.
La richiesta attuale di una “bioetica”, come disciplina in cui si travasa il malcontento verso la pratica medica corrente e l’esigenza di una sua riumanizzazione in profondità, costituisce lo sfondo su cui passiamo ora a considerare alcuni problemi, antichi e recenti, di morale medica. La rassegna non ha pretese di esaustività; mira piuttosto a una certa esemplarità. Intendiamo, cioè, mostrare come la morale cristiana, sollecitata dalle dimensioni antropologiche mutevoli in cui si pongono i problemi sanitari, cerchi nel suo sviluppo una via del giusto mezzo tra conservazione del patrimonio tradizionale e innovazione. L’equilibrio è reso possibile dalla costante preoccupazione di rimanere fedeli all’uomo.
104
1. Sperimentazione e manipolazione genetiche
In una scena, meritatamente celebre, del film 2001: Odissea nello spazio il regista Kubrick aggancia con un’immagine l’uomo dei viaggi spaziali a quello preistorico: una clava lanciata in aria da un cavernicolo diventa un’astronave... Ci vorrebbe la stessa genialità per creare un’immagine che evochi la distanza vertiginosa e insieme la continuità tra i piselli dell’orto dell’abate Mendel e i laboratori fantascientifici in cui la biologia molecolare ricombina frammenti di DNA. Poco più di un secolo è trascorso da quando venivano scoperte le leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari. Ma in pratica soltanto nell’ultimo decennio è avvenuta l’accelerazione, grazie alla quale la genetica è diventata una frontiera per l’umanità, fonte di grandi speranze e di altrettanto grandi timori. Proprio come l’energia nucleare. L’accostamento ha fatto la fortuna dell’espressione “la bomba biologica”.
La scienza dell’eredità, tenuta a battesimo dal paziente ricercatore moravo, non ha mostrato subito le potenzialità di cui era dotata. Come quegli alunni considerati sottodotati dagli insegnanti, che sembrano scaldare i banchi per anni, finché un giorno escono dal bozzolo in maniera folgorante. Le scoperte di Mendel, riconosciute solo all’inizio del sec. XX, sono apparse portatrici di conseguenze pratiche solamente per i fondatori dell'eugenismo. Questo è stato concepito come un progetto di migliorare la razza umana mediante un controllo della procreazione, favorendo la trasmissione dei caratteri ereditari auspicati e impedendo la riproduzione di quelli giudicati negativi. Il dizionario Larousse del XX secolo, pubblicato nel 1928, attribuiva come finalità alla “nuova scienza” dell’eugenismo quella di “eliminare gli. indesiderabili” e di “conservare e perfezionare gli elementi sani e robusti”. Le basi scientifiche dell’eugenetica erano tutt’altro che solide. È bastata, tuttavia, la sola patina di scientificità perché nel periodo tra le due guerre mondiali programmi eugenetici fossero intrapresi dal governo nazista in Germania, che si servì dell’eugenismo per giustificare la sua criminale politica razzista, e da progetti realizzati nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti (con la stessa inconsistenza scientifica e nullità di risultati, ma con il totalitarismo nazista in meno). Gli errori del passato hanno gettato il discredito sui programmi eugenetici autoritari, inequivocabilmente condannati anche dal punto di vista morale, per la minaccia che costituiscono ai fondamentali diritti della persona.
105
Se le scoperte di Mendel sono la preistoria e l’eugenismo la storia antica (il miglioramento della razza mediante l’eliminazione dei tarati non era, del resto, ciò che si faceva correntemente a Sparta? Con risultati molto meno brillanti, a quanto ci dice la storia della civiltà, di quelli ottenuti ad Atene...), la storia moderna della genetica comincia con l’identificazione del modo in cui si trasmettono i cromosomi e la scoperta, realizzata da Watson e Crick nel 1953, della struttura molecolare del DNA. Gli anni seguenti furono segnati dal progressivo paziente studio del modo in cui il “messaggio” ereditario, contenuto del DNA dei cromosomi sotto forma di una successione di geni, poteva essere tradotto in proteine. Si trattava però ancora di conoscere il processo come avviene in natura, senza mettervi le mani. La “manipolazione” segna l’ultima tappa del progresso della genetica: e siamo cosi all’attualità, anzi al futuro prossimo già cominciato.
Sono passati appena dieci anni — i primi lavori di questo genere sono del 1973 — da quando gli scienziati hanno messo a punto una tecnica per introdurre all’interno del patrimonio ereditario di una cellula un frammento di DNA estraneo, ottenuto mediante sintesi chimica. Tecnicamente si parla di “DNA ricombinato”. Si tratta di molecole di DNA costruite al di fuori delle cellule viventi, che vengono congiunte a segmenti di DNA, al fine di farli replicare in una cellula vivente. Innocui giochetti di laboratorio per scienziati di temperamento faustiano? Il profano ha difficoltà a capire la portata di questa intrusione dell’uomo nell’infinitesimamente piccolo. Impadronirsi della chiave del meccanismo con cui si trasmettono i caratteri ereditari significa poter smontare la catena del DNA e pilotarne la ricostruzione a volontà. In pratica, l’elica del DNA (quel lunghissimo filamento che contiene le istruzioni di crescita per ogni organismo) viene tagliata per inserire altri frammenti, con informazioni diverse, che modificano lo sviluppo della cellula. È un lavoro di microchirurgia, in cui il bisturi viene sostituito da enzimi che attaccano e incidono il DNA, mentre dei batteri trasportano i geni scelti per la ricombinazione.
Come un bambino entrato in possesso di un gigantesco meccano, lo scienziato si è lanciato in un’audace esplorazione delle infinite possibilità che si aprono. Incroci tra le piante più diverse, nonché tra cellule vegetali e cellule animali; creazioni di specie animali giganti o di nuove specie vegetali, come grano capace di crescere nel deserto... L’ingegneria genetica sembra essere l’Eldorado dell’èra tecnologica, la terra promessa
106
stillante latte e miele che risolverà il problema dell’alimentazione per tutta l’umanità. Oppure, cambiando scenario, può essere la causa di una catastrofe immane. E allora l’ingegneria genetica diventa un incubo. Un incubo, in questo caso, creato non dal sonno della ragione, bensì dalla ragione tecnica nel suo esercizio più vigile ed efficace.
Subito dopo aver messo a punto i procedimenti descritti, un allarme si è diffuso nell’ambiente degli scienziati. Nel luglio 1974 un gruppo di specialisti lanciava con una lettera aperta un appello all’autoregolazione e gli esperimenti di ingegneria genetica venivano congelati da una moratoria. Ma nella conferenza di Asilomar, in California, tenutasi nel 1975, veniva decisa la ripresa dei lavori. In seguito le regolamentazioni e le misure precauzionali prese dai governi si sono succedute con un ritmo discontinuo: a restrizioni e severi controlli hanno fatto seguito edulcorazioni permissive. Le paure possono essere ricondotte a ciò che succede all’“apprendista stregone”: mette in moto un processo che poi non sa più controllare. Il pericolo paventato è che le manipolazioni genetiche portino alla creazione e moltiplicazione di germi patogeni nuovi, come potrebbe essere la produzione di batteri mutanti resistenti agli antibiotici. Dai laboratori d’ingegneria genetica potrebbero allora diffondersi malattie nuove, non trattabili con i mezzi medici in nostro possesso, epidemie di cancri, mostruosità di ogni genere... Dall’Eldorado alla discesa agli inferi! Questi scenari apocalittici irritano profondamente gli scienziati. È vero che sono per lo più parto di fantasia; ma è possibile che sia altrimenti, quando manca un’informazione precisa del lavoro che gli scienziati genetici stanno facendo nel chiuso dei loro laboratori, e soprattutto manca la possibilità di un controllo pubblico? Può darsi che gli allarmi siano ingiustificati; ma quando l’allarme creato dalle minacce incombenti per le manipolazioni dell’energia nucleare ha raggiunto un livello così drammatico, non c’è più disponibilità ad aprire un nuovo fronte di preoccupazioni.
Per conquistarsi l’opinione pubblica, l’ingegneria genetica si presenta sotto l’aspetto utilitaristico. Mentre la risposta al problema della fame è ancora a livello di progetto, sembra invece più vicina quella che riguarda la salute. Le bio-tecnologie hanno raggiunto infatti risultati considerevoli in campo terapeutico. Gli scienziati sono in grado di utilizzare organismi microscopici, come i batteri, per far loro fabbricare sostanze specifiche, dominando e dirigendo la loro capacità di realizzare reazioni chimiche tra molecole organiche estremamente complesse. Si possono così
107
produrre sinteticamente vaccini o sostanze come l’insulina, l’interferone, le gonadotropine. La coltura delle “cellule trasformate” costituisce, in teoria, una fonte inesauribile di molecole proteiche. La bio-tecnologia si apre qui sulla bio-industria, suscitando comprensibili appetiti nelle case farmaceutiche.
Il campo delle manipolazioni genetiche, con le sue applicazioni di bio-tecnologia e di bio-industria, richiede urgentemente che sia preso in considerazione il punto di vista dell’etica. La posizione della morale cattolica si muove tra l’accettazione e l’ammonimento alla prudenza. Non c’è, infatti, fondamentalmente una preclusione di principio al dominio dell’uomo sulla natura. In linea con tutta la tradizione ebraico-cristiana, si può vedere nel progetto scientifico di comprendere i meccanismi della riproduzione della cellula e di intervenire in essi una forma di obbedienza al comando di dominare la terra e di sottometterla. Come afferma Berhard Häring, la “manipolazione” non è un sinonimo di peccato: essa può avere anche un significato accettabile, come cambiamento pianificato della natura biologica a servizio dell’uomo. Ma il compito di dominare la terra non è disgiunto dalla responsabilità di “custodirla”. In questa prospettiva possiamo rileggere il discorso che Giovanni Paolo II ha tenuto all’UNESCO nel giugno 1980. Non soltanto — ha richiamato il papa ― la ricerca scientifica e l’applicazione tecnologica devono avvenire nel pieno rispetto delle norme morali; ma la scienza deve essere accompagnata e controllata dalla saggezza che appartiene al patrimonio permanente dell’umanità. A questo punto dell’evoluzione la saggezza è necessaria non per vivere meglio, ma per sopravvivere. E ciò è vero non solo in riferimento alla bomba atomica, ma anche alla bomba biologica.
2. Le tecnologie riproduttive
Lo stato dell’arte: inventario (provvisorio) delle tecniche
Non è costume dei ricercatori e degli scienziati parlare del loro lavoro come sono disposti a fare registi o scrittori a proposito delle opere che hanno in gestazione. Ciò che avviene nei laboratori di biologia, non diversamente da laboratori di altro genere, è coperto dalla discrezione,
108
quando non addirittura dal segreto professionale o di Stato. Almeno finché i risultati non sono stati conseguiti: allora vengono dati in mano alla grande orchestrazione dei mass media; ... ed è subito festa! Ciò è avvenuto per Louise Brown, la prima bambina nata per fecondazione artificiale nel luglio 1978, grazie al paziente lavoro degli inglesi Edwards e Steptoe. Successivamente è stata la Francia a festeggiare la nascita di Amandine (febbraio 1982): l’anno dopo è toccato all’Italia sottolineare con un grande concerto di opinioni ed emozioni contrastanti la registrazione all’anagrafe del suo primo cittadino — Alessandra, di Napoli — concepito per fecondazione extracorporea.
Al di fuori delle celebrazioni ufficiali non si parla molto delle pratiche di laboratorio per la manifattura dei bambini. Ed è comprensibile: gli interessati preferiscono tenere lontano la pubblicità indiscreta. A poco a poco, tuttavia, l’informazione ha raggiunto il grande pubblico; sappiamo che la tecnologia applicata alla riproduzione ci ha permesso di raggiungere frontiere che fino a ieri erano impensabili, e ci permettiamo di fantasticare su quelle che saranno infrante domani. La sterilità è vinta, proclamando i bollettini di guerra della scienza medica, rinforzata dal contingente scelto dei biologi della riproduzione. La sterilità femminile, anzitutto: se un’ostruzione degli ovidutti impedisce la fecondazione, la cellula ovulo può venir prelevata, fecondata a cielo aperto, lasciata in coltura per il periodo in cui sosterebbe nell’ovidutto; a questo punto l’embrione multicellulare può venir inserito nell’utero della madre. La sterilità che dipende dall’uomo — un’evenienza molto più frequente di quanto l’orgoglio maschile sia disposto a concedere, ma dimostrata da incontrovertibili ricerche epidemiologiche — se non è curabile, è però rimediabile mediante il ricorso alla fecondazione artificiale. Omologa, quando l’inseminazione è fatta con lo sperma del marito, eterologa quando si ricorre a un donatore (A.I.D.). Decine di migliaia di bambini sono nati già in questo modo: concepiti nel seno della loro madre, dotati per metà del patrimonio genetico della madre e per metà di quello di un anonimo donatore di sperma.
Qualcuno ha calcolato che esistono oggi «trentasei modi di nascere», che trascendono i pregiudizi biologici o genetici, lo spazio, il tempo e anche la morte, oltre che il normale legame tra procreazione, sessualità e corpo umano. La tecnica complica ulteriormente le già intricate «vicende dell’amore e del caso», e le farse biologiche si rivelano non meno appassionanti di quelle basate su equivoci e tradimenti. La figura più
109
macabra è quella del «figlio dell’aldilà», cioè la possibilità che un uomo generi un figlio dopo la propria morte. Un gioco da niente, in realtà, per gli attuali tecnocrati della riproduzione o «biocrati», come li ha chiamati Leach. Lo sperma del donatore, infatti, può essere congelato e conservato a tempo indefinito, senza perdere la sua capacità fecondante; può quindi essere usato per la fecondazione artificiale anche dopo la morte del suo proprietario. Una pratica che va acquistando una certa diffusione è quella di conservare il proprio sperma prima di essere sottoposto a un trattamento di chemio o radioterapia per tumore al testicolo, con esito di sterilità. Anche in questo caso si tratta, in qualche modo, di un «figlio dell’aldilà»: anche se il donatore non è morto, è morta tuttavia la sua capacità riproduttiva.
La dissociazione della procreazione dalle costrizioni spazio-temporali sembra battere in breccia qualsiasi forma di sterilità, sia dell’uomo che della donna. La fecondazione in vitro risolve i problemi della donna che non può concepire per occlusione delle tube ovariche; la donazione dell’ovocita da parte di un’altra donna rimedia alla sterilità dipendente dalla mancanza di ovaie o di ovulazione. La prima rappresentazione di quest’ultima variante della tecnologia riproduttiva è avvenuta di recente negli Stati Uniti: il medico ha praticato l’inseminazione con lo sperma del marito della donna sterile; dopo cinque giorni l’ovulo fecondato è stato prelevato e impiantato nell’utero della ricevente, che ha portato a termine la gravidanza (la padronanza acquisita nella somministrazione di ormoni permette di preparare a ricevere un embrione anche una donna sterile, e perfino in menopausa: si sfalda un’altra barriera «naturale» alla fecondità). Coloro che non battono ciglio di fronte al dono dello sperma non vedono perché il dono di un ovulo dovrebbe essere condannato moralmente. Portare il figlio concepito da un’altra è pur sempre più di un’adozione, per la simbiosi che si crea durante i mesi della gestazione.
Una donna può donare a un’altra un ovulo da fecondare o un embrione («embryotransfer»); ma può anche portare per lei il figlio che la madre legale non può o non vuole portare. Si delinea così la figura della «madre portatrice», che conduce a termine la gestazione di un bambino per procura. Per amore o per denaro. I mercanti seguono infatti a ruota i conquistadores delle nuove frontiere medicotecnologiche. La riproduzione può diventare un business. Una coppia può affidare, dietro lauto compenso, a una «madre portatrice» l’embrione risultante dalla fecondazione in provetta dei propri gameti, chiedendole una specie di affitto dell’utero.
110
Ma che succede se il bambino alla nascita viene rifiutato sia dai committenti, sia dalla portatrice, perché, mettiamo, è idrocefalo o malformato? Oppure se la donatrice, convertitasi alla maternità durante i nove mesi della gestazione, rifiuta di cedere il «suo» bambino? Queste farse biomediche perdono tutta la loro macabra comicità quando si consideri che non si tratta di astratte possibilità, ma di precise cause giudiziarie in corso.
L’esplorazione dell’arsenale tecnologico applicato alla riproduzione non è ancora terminata. Dobbiamo menzionare almeno un’altra possibilità, anche se finora non sembra sia stata tradotta in atto. Se si taglia in due un embrione formato per fecondazione in vitro, la impiantazione di una sola metà di questo ammasso cellulare porta alla formazione di un bambino normalmente costituito. L’altra metà — un gemello identico al primo — può essere congelata, per essere impiantata successivamente, magari in seno a un’altra coppia di genitori (che situazione ideale per gli studiosi che usano il metodo gemellare per risolvere l’annosa questione di quanto nel comportamento dipende dalla dotazione genetica e quanto dall’educazione e dall’ambiente!). Tralasciamo di addentrarci nei meandri delle possibilità offerte dalla clonazione, quando i progressi tecnologici l’avranno resa possibile anche per i mammiferi superiori e per l’uomo. Anche senza il figlio decalcato, copia genetica esatta del genitore, abbiamo già materiale sufficiente per riflettere sulle molteplici implicazioni della tecnologia applicata alla riproduzione.
Reazione emotiva o giudizio etico?
È bene o male, dal punto di vista morale, ricorrere alle nuove tecniche bio-mediche per ottenere esiti di riproduzione così lontani dalle modalità naturali? Qualunque sia l’orientamento ideologico della persona a cui si rivolge la domanda, la risposta, positiva o negativa, non tarderà ad arrivare. L’interpellazione è forte, e difficilmente si rinuncia a inquadrare un fenomeno così vistoso nel proprio universo di valori. Eppure una conquista di un maturo giudizio etico in questo campo non è cosa semplice. Succede frequentemente che, dietro l’apparenza di un giudizio etico, si debba riscontrare in realtà nient’altro che una presa di posizione emotiva, sorretta dalla propria Weltanschauung. Ai due poli estremi possiamo trovare, da una parte una «fede» nella scienza, considerata come
111
la risposta efficace a tutte le miserie umane; una fede che sconfina volentieri nell’entusiasmo acritico. Ogni nuova realizzazione viene salutata come un «miracolo della medicina», che fa indietreggiare ulteriormente la barriera dell’impossibile. Una tale fede implicita è rintracciabile anche sotto la patina di freddezza con cui amano presentarsi gli scienziati. All’altro estremo troviamo la diffidenza astiosa verso l’intrusione degli uomini di scienza nell’ambito del «naturale». Per rafforzare l’intoccabilità della natura e dei suoi processi, alcuni la rivestono col carattere di sacralità. Quando, per fare un esempio, un teologo francese parla della fecondazione artificiale come del «frutto di una menzogna iniziale, adulterio consumato con tecniche veterinarie», dà prova non solo di integralismo, ma anche di reazione umorale sotto forma di giudizio etico. Tanto le posizioni più violente di rifiuto, quanto quelle di accettazione incondizionata di ogni nuova tecnologia, lasciano trasparire in filigrana una «mistica» implicita: quella della natura e della biologia come limite che non si può valicare senza peccare di «hybris», ovvero la mistica del Grande Progresso Illimitato, di cui parla E. Fromm.
Il diverso atteggiamento di fondo si rispecchia anche nella funzione che si attribuisce alle regole morali applicate alle tecnologie riproduttive. Da esse ci si può aspettare che fungano da diga contro l’irrompere dell’arbitrio e l’agire irresponsabile; oppure che diano esse stesse impulsi positivi alla ricerca e alla sperimentazione, promuovendo l’opera di umanizzazione implicita nella scienza stessa. La «facies» dell’etica cambia sostanzialmente, quando si attribuisca alle regole morali una finalità di contenimento oppure di promozione dell’opera dello scienziato. Nel primo caso tenderà a prevalere un’impostazione casistica che vorrà entrare nei dettagli per porre freno con precisi dettati comportamentali ai veri o presunti straripamenti della scienza; nel secondo, l’accento cadrà di preferenza sui valori da promuovere, lasciando all’uomo di scienza l’autonomia e la responsabilità per le sue scelte comportamentali.
Rimanendo ancora nell’ambito del «non detto» veicolato dal discorso etico sulle nuove possibilità riproduttive, è opportuno tener presente che i termini stessi con cui viene designato questo settore bio-medico connotano un giudizio etico. Il termine «manipolazione» è il più carico di connotazioni negative. Anche se la manipolazione, intesa come cambiamento pianificato della natura, può avere un significato accettabile o anche buono, nell’uso che ne fanno alcuni la manipolazione, come osserva B. Häring, è «una parola nuova per dire peccato». Se si chiamano manipolazioni
112
questi interventi bio-medici, li si colora a priori di un sospetto di illeceità morale.
Al contrario, la designazione di «terapie dell’infertilità» copre tali metodiche col mantello di Esculapio, facendo ricadere su di esse l’aura di accettabilità morale riservata a tutto ciò che è finalizzato alla guarigione. La formalità terapeutica permette di considerare in una luce diversa taluni aspetti pratici dei procedimenti bio-medici. Così, ad esempio, le riserve dei moralisti cattolici sulla modalità di raccolta dello sperma tendono a estinguersi quando l’atto masturbatorio è considerato all’interno di un progetto terapeutico globale. Il beneficio della «terapia» non può essere, però, esteso a tutto l’insieme degli interventi presi in considerazione: in alcuni casi si tratta chiaramente della realizzazione di un desiderio, quando non addirittura di un capriccio. Anche il fatto di considerare la sterilità una «malattia» e il rimedio dell’infertilità un’opera terapeutica, solleva alcuni problemi dal punto di vista antropologico. Le conseguenze per la medicina, se si proponesse di rispondere a tutti i desideri e le convenienze della popolazione, sarebbero di grande portata, tanto sul piano della politica sanitaria, quanto su quello della deontologia medica. Il medico, trasformato in prestatore di servizi, si troverebbe inevitabilmente preso nell’ingranaggio commerciale che regola la domanda e l’offerta.
Una terza categoria generale, usata per designare questa vasta gamma di interventi bio-medici, è quella di «tecnologie riproduttive». Anch’essa veicola implicitamente un giudizio etico, e precisamente quello soggiacente alla nozione stessa di tecnologia. Nell’ambito culturale dell’Occidente, profondamente compenetrato dell’umanesimo greco della techne e dalla spiritualità biblica del «Dominate e soggiogate la terra», le azioni riconducibili alla tecnologia godono, di per sé, di una considerazione positiva. In seno al cristianesimo ecclesiale, da questo punto di vista, non sono mai stati coltivati atteggiamenti sospettosi verso la scienza medica, come invece troviamo in alcuni gruppi settari come i Testimoni di Geova. La nozione filoso fico-teologica di «natura» quale criterio etico («è buono ciò che è conforme alla natura o alla naturalità dell’atto»), non ha escluso l’intervento correttivo sulla natura stessa. Oggi tuttavia la valenza etica positiva di ciò che è espressione di tecnologia si è incrinata. O piuttosto: siamo diventati più consapevoli dell’ambivalenza della tecnologia, che può anche rivolgersi contro l’uomo. L'homo faber, maggiorato in homo technologicus, sente più fortemente che la tentazione
113
a «giocare a fare Dio» è carica di minacce per l’umanità. Preferiscono parlare di tecnologie riproduttive coloro che vogliono evitare designazioni condizionate da connotazioni rigide, a vantaggio di quel processo di discernimento critico che è proprio dell’etica.
La nostra riflessione si arresta qui, alla soglia degli sviluppi argomentativi formali che costituiscono la prospettiva dell’etica vera e propria. Per accedere a questo livello è necessario dapprima individuare e rendere inoperanti i falsi giudizi etici, veicolati dai modelli culturali e semplici legittimazioni di questi ultimi. È opportuno anche diventare consapevoli della pregnanza semantica dei termini che si usano, nonché delle valutazioni morali implicite che contengono. Ai medici e agli scienziati questo lavoro filosofico può forse venire a noia; ma tutto lascia credere che una buona filosofia sia il sale che impedisce alla tecnica di corrompersi, perdendo il punto di riferimento costituito dalla qualità umana dell’uomo.
3. La fecondazione artificiale
Perché riesce difficile parlare con obiettività e distacco dell’inseminazione artificiale? Da che cosa deriva quella frequente dismisura, nel minimizzare o nell'ingigantire le implicazioni antropologiche di questa pratica, che tradisce un senso di disagio anche in chi abitualmente ha un approccio scientifico dei problemi umani? Una ragione potrebbe essere il fatto che la fecondazione artificiale aggancia un mondo di fantasmi e di paure che ci abita inconsciamente, quelle suscitate da un progresso tecnologico che sembra procedere verso la manipolazione totale dell’uomo (non a caso A. Huxley ci introduce nel suo allucinante «migliore dei mondi» facendoci passare per la fabbrica dell’uomo in provetta). Oppure il disagio è provocato dall’avvertire che si tratta di una di quelle pratiche mediche altamente sofisticate che riguardano solo un’infima minoranza della popolazione, e che, per di più, si muovono in senso contrario agli orientamenti generali di politica sanitaria. Non è da escludere neppure che si possa essere intimamente inquietati anche dalla condanna quasi unanime che cade sull’inseminazione artificiale, tanto da parte delle istanze morali confessionali, quanto dall’opinione pubblica 79.
114
Se tante e tali riserve — psicologiche, etiche, legali, sociali ed economiche — pesano sull’inseminazione artificiale, non sarebbe consigliabile lasciare questa pratica alla marginalità clandestina attuale? La politica dello struzzo in questo caso non è di nessun profitto. La pratica si va infatti diffondendo e tende a coinvolgere un numero crescente di persone 80; le «banche di sperma» esistono ormai anche nel nostro continente: dopo le prime apparizioni in U.S.A. e Giappone, si moltiplicano ora in Francia, Belgio, Danimarca, Rep. Federale Tedesca. Gli ambienti scientifici cominciano a rivolgere attenzione all’argomento. Alla “inseminazione artificiale e riproduzione umana” è stato dedicato il congresso di sessuologia tenuto a Lovanio nel 1973. Se ne è occupato di recente anche il congresso internazionale di medicina legale e medicina sociale (Digione, maggio 1977).
Un dibattito più ampio, che coinvolga anche l’opinione pubblica, sembra a questo punto auspicabile. È necessaria anzitutto una più precisa informazione, che sappia fare il vaglio tra i diversi tipi di intervento, discernendo tra quelli lucrativi, quelli di indicazione eugenetica e quelli che rimangono propriamente nell’ambito di una terapia dell’infertilità maschile.
Ai fini di un approccio costruttivo del tema, è necessario scegliere preliminarmente l’angolatura giusta. Il dibattito è compromesso quando si addita nell’inseminazione artificiale il caso tipico dell’intervento arbitrario dei tecnocrati della biologia e della medicina — i “biocrati”, come li ha chiamati G. Leach in un libro di successo —, occupati a condurre giochetti irresponsabili sul materiale biologico umano. La maggior parte dei medici che praticano l’A.I.D. si muovono nell’ambito tradizionalmente riservato alla medicina, vale a dire quello terapeutico, con l’unica particolarità che le risorse fornite dal progresso tecnologico offrono oggi un
115
campo di intervento molto più ampio che in passato. Alcuni di questi operatori sanitari regolano la propria prassi con norme deontologiche molto esigenti. Il loro non è, cioè, un cinico intervento volto a desacralizzare la riproduzione umana, bensì un intervento terapeutico valutato coscienziosamente. Tra la deontologia e l’etica esiste tuttavia un’articolazione complessa, che implica la considerazione di altre istanze oltre a quelle della coscienza professionale e morale del medico. È vero, in altri termini, che l’operato del medico deve lasciarsi guidare esclusivamente dalla considerazione dell’interesse del malato. Ma l’interesse del malato ha appunto una portata più ampia della semplice conservazione della vita fisica. Qui si inseriscono gli interrogativi che dovrebbero essere oggetto di una discussione allargata. L’offrire a una donna la possibilità di vivere la maternità biologica fa parte del servizio alla vita che è compito del medico? E ancora: come si articola l’interesse dell'individuo con quello della società?
L’inseminazione artificiale, in quanto atto medico ad alta incidenza di implicazioni psicologiche e sociali, è un luogo privilegiato per una rifondazione dell’etica medica 81. La medicina non può limitarsi ad assumere le norme etiche da istanze esterne come prodotti preconfezionati. Gli operatori sanitari non sono chiamati a fornire eslcusivamente la tecnica, mentre in altra sede altri ne elaborerebbero il senso e lo “spirito”. È corretta solo quella prassi medica che è una prassi riflettuta. Ci sembra che queste considerazioni teoriche trovino un’illustrazione particolarmente chiara nell’esperienza in corso al «Centre d’étude et de conservation du sperme humain» (CECOS), all’ospedale Bicètre di Parigi, sotto la direzione del dott. Georges David 82. La proponiamo come un modello esemplare di pratica dell’inseminazione in un contesto deontologico che si apre su un orizzonte etico.
116
Nell’organizzazione pratica il CECOS non si discosta in modo rilevante da analoghi centri di prelievo, conservazione e utilizzazione di sperma umano, correntemente noti col nome di «banche di sperma». Ad esse si rivolgono donne potenzialmente feconde per avere le dosi di sperma necessario per l’inseminazione. Questa viene di solito effettuata dal ginecologo presso cui la donna è in trattamento. Ciò che varia, spesso sostanzialmente, da una banca di sperma all’altra sono le condizioni poste dalle équipes responsabili. Mentre alcune accettano indiscriminatamente qualsiasi indicazione — specialmente le organizzazioni a dichiarato fine di lucro —, altre si riservano di discriminare tra le richieste e di procedere all’inseminazione solo a certe condizioni. Dal momento che quasi in nessun paese l’inseminazione artificiale è regolata da una legislazione apposita 83, queste norme deontologiche, che i vari operatori si impegnano ad osservare per decisione autonoma, hanno una funzione primaria di autodifesa professionale. Esse costituiscono una carta di garanzia fornita dai diversi centri operativi.
Le garanzie deontologiche del CECOS sono di tutto rispetto. Esso limita l’applicazione del metodo a una sola indicazione: la sterilità maschile; questa, per di più, deve essere stabilita come irreversibile nelle condizioni terapeutiche attuali. Rifiuta perciò anche l’indicazione del rischio genetico paterno, che pur è presa in considerazione da équipes molto esigenti. A più forte ragione rimangono escluse indicazioni che confinano con lo stravagante o il morboso.
Come i centri che operano in modo più responsabile, il CECOS non sottovaluta le risonanze psicologiche dell’inseminazione presso i due coniugi. L’A.I.D. infatti, soprattutto per la presenza del donatore anonimo, è molto di più che un gesto ginecologico praticato di nascosto. Implica perciò una preparazione e un’esecuzione in condizioni ben precise. A tal fine il CECOS raccomanda l’incontro con uno psicologo collegato al centro stesso. Tale incontro preliminare non è obbligatorio e non costituisce un “esame” sanzionato da un’autorizzazione o da un rifiuto dell’inseminazione (la responsabilità dell’indicazione è lasciata essenzialmente
117
al ginecologo, il cui ruolo al CECOS non è limitato all’esecuzione puramente tecnica, ma è concepito come una partecipazione a un lavoro comune). Il colloquio con lo psicologo vuol essere piuttosto un momento formale di coscientizzazione dei coniugi, che devono essere avvertiti dei problemi psicologici in cui verranno a trovarsi a seguito del singolare intervento. Naturalmente il CECOS garantisce il segreto, ad ogni livello del processo: sia circa l’origine del bambino nato da una inseminazione, sia circa l’identità del donatore.
La scelta del donatore per una coppia tiene conto dei caratteri morfologici e dei gruppi sanguigni. Il principio non è tanto di cercare un’omologia con il marito, quanto di evitare l’introduzione di un carattere ereditario che non esiste in nessuno dei coniugi. In ciò il CECOS si distanzia dai gruppi che operano obbedendo a criteri eugenetici, o addirittura... estetici!
Ma ciò che costituisce il nucleo centrale e caratterizzante della deontologia del CECOS sono i due principi seguenti: il dono dello sperma non può essere che gratuito; il dono si fa da coppia a coppia.
La non retribuzione costituisce un’innovazione rispetto alla prassi attuale delle banche di sperma, le quali solitamente ricorrono alle prestazioni dietro compenso (i clienti sono per lo più studenti di medicina). La commercializzazione, che già suscita forti riserve quando si tratta del sangue o di organi corporei, è del tutto inappropriata nel caso dello sperma. La gratuità è destinata a sottolineare il valore singolare di questo prodotto umano. Non si tratta di rinverdire concezioni mitologiche; basta la biologia a dirci che in esso, più essenzialmente che in qualsiasi organo, è inscritta la storia di un individuo. Trasmettere lo sperma è un gesto che supera la portata di qualsiasi dono d’organo; significa — letteralmente — “dare la vita”.
Se escludiamo il guadagno, quale può essere il motivo che spinge un uomo ad una prestazione così anomala? Non ci si espone in tal modo a dipendere da individui psichicamente contorti e malsani? Invece di abbassare la standard della motivazione, il dott. David, principale ispiratore del CECOS, lo innalza ulteriormente mediante il secondo principio. Esige che il dono dello sperma sia fatto da un uomo sposato, con il consenso della moglie; e che questa coppia abbia già dei figli. Diverse ragioni lo inducono a porre questa condizione, destinata a ridurre ulteriormente il numero dei donatori. Egli considera lo sperma non come la proprietà esclusiva dell’uomo, bensì come il bene comune della coppia. Domandare
118
l’accordo della coppia per il dono è ottenere la garanzia d’una riflessione comune e di uno scambio all’interno della coppia, prima di una decisione che non deve essere presa alla leggera; vuol dire avere la garanzia che gli aspetti presi in considerazione non saranno solo quelli maschili. La condizione, poi, che la coppia donatrice debba avere già figli propri vuol garantire, pragmatisticamente, la fecondità dello sperma e, idealmente, dare all’atto della donazione una motivazione etica che lo depuri da ogni ambiguità. Idealmente, infatti, il dono dello sperma diventa il dono di una coppia che ha la felicità di avere dei figli a una coppia privata di questa felicità. “La situazione di genitori — afferma il dott. David — permette alla coppia di affrontare con più maturità i differenti problemi che si pongono. Tale situazione è suscettibile anche di far meglio comprendere quanto può essere legittima la richiesta della coppia sterile, grazie alla conoscenza vissuta di ciò che rappresenta la presenza di un figlio”. Il dono deriverebbe, insomma, dalla generosità di una coppia felice, equilibrata, cosciente della parte che hanno i figli nel loro equilibrio e nella loro felicità. Questa situazione può avere inoltre un riflesso psicologico importante per la coppia ricevente. La transazione tra coppia e coppia, a un livello così elevato di motivazioni, attenua sostanzialmente il sottofondo di adulterio che si profila all’orizzonte della inseminazione artificiale.
A questo punto si può considerare sufficientemente illustrato l’assunto secondo cui le norme deontologiche poste da una prassi medica cosciente e responsabile si articolano organicamente col mondo dei valori di cui occupa l’etica. La deontologia pone il presupposto per gli interrogativi specificamente etici. La coscienza professionale dell’operatore sanitario non si sostituisce alla coscienza morale di chi fa ricorso alla sua prestazione. Costui resta l’unico responsabile della qualità morale delle proprie azioni. Le norme deontologiche stabiliscono uno standard operativo che si riflette a favore tanto del medico quanto del cliente. Il medico, ponendo delle condizioni imprescindibili, salvaguarda la propria credibilità e fidatezza personale (quanto mai necessarie in un settore così pieno di insidie come quello dell’inseminazione artificiale). Il cliente, a sua volta, è sospinto dalle esigenze deontologiche del medico a una verifica critica delle proprie motivazioni, a una considerazione dei rischi, a una ricerca di alternative; in una parola, a una crescita della qualità etica del suo gesto.
La coppia che chiede l’inseminazione ha già fatto presumibilmente un lungo cammino; un altro tratto ne deve ancora fare. Perché l'inseminazione
119
abbia qualche chance di inserirsi organicamente nel progetto di vita della coppia, questa deve aver già “fatto il lutto” della propria infecondità. Ciò implica il superamento dei sensi di colpa (l’infecondità come punizione è legata a fantasmi ancestrali; se ne trovano tracce anche nel mondo biblico), del complesso di inferiorità e dei risentimenti del coniuge infecondo. Positivamente, alla coppia che si accinge all’inseminazione artificiale è richiesta una solida unione e una vita sessuale soddisfacente. Se la fecondazione artificiale, infatti, supplisce alle carenze biologiche, non può surrogare quell’intesa sessuale che garantisce il legame di coppia.
Si può affermare, con una certa dose di paradosso, che, dal punto di vista psicologico ed etico, è pronta ad affrontare la fecondazione artificiale solo quella coppia che ha accettato la sterilità, colmando il suo vuoto con un supplemento di generosità e d’amore e facendone un luogo di creatività umana. Quell’uomo e quella donna sono pronti, a questo punto, all’avventura di una maternità e paternità reali, pur senza quei presupposti biologici che abitualmente l’accompagnano.
Quando queste condizioni si trovano riunite, il giudizio dei moralisti sulla fecondazione artificiale si fa più possibilista. P. Pohier, nel caso in cui si realizzi il dinamismo affettivo ed etico sopra esposto, si spinge fino a una franca accettazione dell’inseminazione: “Se un uomo e una donna si amano e non possono avere figli, è una disgrazia. Ma essi possono, malgrado tutto, a partire da materiale genetico estraneo, ‘fare’ un figlio che sarà lo stesso unicamente il loro, tenuto conto di ciò che essi doneranno: l’essenziale di se stessi e l’essenziale per lui. Per me, l’immoralità sarebbe impedire loro di ‘fare’ quel figlio sotto pretesto che essi non possono trasmettere i loro cromosomi” 84.
Sul fronte dei possibilisti si schierano anche alcuni psicologi che hanno seguito da vicino le coppie candidate all’inseminazione. Sembra che la situazione sia molto più sfumata e, in generale, meno pericolosa di quanto si è portati a credere. La conclusione di G. Semenov-Ségur, psichiatra consulente del CECOS, è che l’inseminazione sembra convenire soprattutto a coppie con una maturità sufficiente che abbiano esperienza di una vita comune e un impegno autentico nel loro desiderio di procreare insieme. L’inseminazione offre i mezzi per inserire il bambino nella problematica della coppia in modo più stretto dell’adozione. Essa fa partecipare i genitori, con tutte le loro risorse affettive, al progetto, alla
120
gestazione, alla nascita, ai primi mesi di vita, in quei momenti cruciali in cui si tessono i legami più profondi e sicuri 85.
Cerchiamo di tirare le fila del discorso. Abbiamo preso in considerazione una prassi ben precisa di inseminazione artificiale, quella del CECOS diretto dal dott. David, con la sua deontologia specifica. Di qui le considerazioni si sono aperte spontaneamente sul processo psicologico ed etico che una tale prassi esige presso coloro che sono coinvolti nell’inseminazione artificiale, donatori e riceventi. Ne è emerso l’alto significato umano che può avere il “fare un figlio” ricorrendo all'A.I.D. Siamo lontani dalla fredda ingegneria genetica del “bambino in provetta”. Non si può escludere l’eventualità di interventi medici che, isolando e amplificando l’elemento tecnico dell’azione umana, conducono a una manipolazione arbitraria. La finalità dell’inseminazione nella prassi medica che abbiamo considerato è però un’altra: si vuol mettere le risorse tecniche a servizio di un atto specificamente umano, compensando le carenze naturali. Questo processo prende avvio ed è sostenuto dal “desiderio” che circola nella coppia. “Volere un figlio”, in quanto espressione della pulsione libidica fondamentale, è una lava incandescente che trasporta il meglio e il peggio delle persone coinvolte.
Il medico, al quale la coppia, frustrata fisiologicamente, si rivolge per aiuto, non si erige a giudice del “desiderio”. Chi potrebbe responsabilmente assumersi un tale compito? Ponendo, in nome della deontologia, alcune condizioni, il professionista sanitario favorisce il processo di depurazione e di crescita del desiderio stesso. L’istanza deontologica non esaurisce le condizioni di moralità; anzi, ponendo una barriera alle soluzioni di facilità, innalza il livello della decisione, la libera dalle ambiguità istintuali, la confronta con le esigenze di una morale illuminata.
È per questo che ritroviamo, alla fine delle nostre considerazioni, le esitazioni che ci turbavano all’inizio. Ora però non sono provocate da fantasmi irrazionali o da tabù ancestrali. Gli interrogativi che ci poniamo, dopo esserci confrontati con una prassi esigente e responsabile, sono quelli che accompagnano un’azione morale di grande importanza. Per un desiderio di maternità-paternità autentico, non esiste un’alternativa, che sia all’altezza del desiderio stesso, alla inseminazione artificiale? Ha la coppia la forza psicologica e morale di prendere una decisione
121
in contrasto con i modelli, le norme e le pratiche sessuali della società contemporanea? Il segreto deposto in seno a quel nucleo familiare sarà sentito dalla coppia come un cemento o come una bomba a orologeria? E ancora: quali sono i limiti che l’organizzazione sociale, chiamata a sostenere i costi di un intervento così specialistico, può porre al desiderio privato, in nome di una politica sanitaria centrata su altri obiettivi?
L’inseminazione artificiale, quando è praticata con la ponderatezza e la riflessività che convengono a un atto così grave, è capace di suscitare interrogativi inquietanti che non riguardano solo i protagonisti dell’intervento bensì la società intera, per l’impatto che una tale pratica ha con le concezioni antropologiche tradizionali. Nello iato che si crea tra sessualità e fecondità, si apre uno spazio per interrogarsi su che cosa significhi, oltre la dimensione biologica, essere “padre” e “madre”. Motivo più che sufficiente perché l’inseminazione artificiale esca dalla clandestinità per un dibattito pubblico.
4. La sterilizzazione
Motivi di attualità
La sterilizzazione, tanto maschile che femminile, è un capitolo classico della morale medica. Saldamente radicato nei principi portanti della dottrina morale cattolica, sembra resistere invariato alle fluttuazioni del tempo e alla trasformazione dei costumi. Eppure i dibattiti che si sono moltiplicati da quando la sterilizzazione è diventata un tema di attualità non sono inutili. Possiamo dire che nell’insieme risultano più chiare le implicazioni umane — culturali, sociali, antropologiche — di tale pratica. Rivisitare quel capitolo ci servirà a renderci conto come la stabilità della morale cattolica non significa rigidità, e la fedeltà ai princìpi può essere coniugata con un vero servizio all’uomo. I motivi per riprendere in considerazione la sterilizzazione non mancano. Innanzi tutto la sua diffusione. Si continua a ripetere che è il mezzo di controllo delle nascite più usato nel mondo. Secondo statistiche attendibili, cinque milioni e mezzo di coppie vi hanno fatto ricorso in Europa nel 1977. In Gran Bretagna e in Scandinavia la sterilizzazione è assicurata dal servizio sanitario nazionale; in numerose altre nazioni viene autorizzata di volta in volta. Le cifre
122
aumentano vertiginosamente quando ci spostiamo in altri continenti. Dieci milioni di sterilizzazioni negli Stati Uniti, tre milioni in America Latina, un milione in Canada, mezzo milione in Africa; in India e in Cina, sempre nel 1973, rispettivamente 35 e 22 milioni di coppie si sono fatte sterilizzare. Complessivamente nel mondo, a quella data, il numero di interventi di sterilizzazione si sarebbe aggirato intorno agli 80 milioni.
Sono cifre che amano produrre coloro che sono preoccupati che l’Italia non resti indietro nella corsa verso il metodo anticoncezionale “più sicuro e più innocuo”. In questi termini, appunto, è stata ampiamente reclamizzata la sterilizzazione anche da noi in un momento di particolare fervore verso tale pratica. La congiuntura è stata offerta dalla nuova situazione giuridica venutasi a creare con l’abrogazione delle norme che la vietavano. Si è assistito non solo a una serie di prese di posizione favorevoli per principio, ma anche a una vera e propria campagna promozionale. La sterilizzazione è stata nobilitata in tutti i modi: per la sua sicurezza e praticità, per il senso di responsabilità che dimostrano coloro che vi si sottopongono, per la sua “modernità” (con foto sui giornali di illustri “sterilizzati volontari”, che offrivano sorridendo un modello identificatorio). L’opera di promozione non è indietreggiata neppure di fronte alle forme commerciali più volgari del lancio pubblicitario: ci sono stati dei centri di sterilizzazione che hanno offerto l’intervento gratis ai primi dieci iscritti... Tuttavia la sterilizzazione non sembra aver trovato un terreno favorevole in Italia. Oltre alla resistenza riconducibile al peso della questione morale, agisce quella di tipo culturale. Nella valutazione comune la sterilizzazione è considerata come un metodo di regolazione delle nascite da paese del Terzo Mondo. È possibile anche che influiscano ancora dei fantasmi dell’epoca nazista, quando la sterilizzazione era stata adottata a servizio dei deliri razzisti degli “ariani”. Benché né il progetto di nobilitazione, né la diffusione della pratica abbiano avuto successo, il dibattito recente ha portato a una maturazione a diversi livelli: giuridico, antropologico, deontologico ed etico. Proponiamo un giro d’orizzonte, tra bilancio e prospettiva.
Sterilizzazione e ordinamento giuridico
Il dibattito sulla sterilizzazione è stato occasionato in Italia da un vuoto legislativo creatosi improvvisamente con l’abrogazione dell’art. 552
123
del Codice penale. L’articolo prevedeva pene per “chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione”. Faceva parte di quel gruppo di “delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe”, puniti dal fascismo perché contrari alla politica espansionista del regime. L’abrogazione è stata prevista e attuata dalla legge 192, che regola l’interruzione volontaria della gravidanza. AH’indomani dell’entrata in vigore della legge, nel maggio 1978, i giuristi cominciarono a dibattere se, a seguito dell’abrogazione, la sterilizzazione fosse diventata giuridicamente irrilevante. Non si è ancora giunti, a tutt’oggi, a un parere unanime. Alcuni opinano che l’abrogazione della norma che puniva la sterilizzazione come reato autonomo abbia sottratto la pratica dalla competenza del codice penale, e che quindi non debba più essere considerata reato; altri ritengono invece che, caduta la norma speciale, la sterilizzazione rientri nella disciplina penale comune. Nella fattispecie, la sterilizzazione resterebbe compresa tra gli artt. che puniscono le lesioni personali dolose. Si tratta dell’art. 582 (che colpisce “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente”) e 583, che considera la lesione personale “gravissima” se dal fatto deriva la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare. Tra i giuristi non c’è consenso sull’estendibilità alla sterilizzazione delle norme che puniscono le lesioni personali dolose. Si avverte l’esigenza di uscire da questo stato di incertezza con una normativa chiara, che definisca una volta per sempre il problema. È già stato presentato una prima volta un progetto di legge per la cancellazione definitiva dal nostro ordinamento del reato di sterilizzazione. Il dibattito si sposta allora dallo “ius conditum” allo “ius condendum”. Una legge che permetta la sterilizzazione è costituzionalmente legittima? Il parere di alcuni giuristi cattolici 86 è negativo. Si fa valere il principio costituzionale della tutela dell’integrità fisica contro ogni forma di menomazione permanente, anche consensuale. Viene invocato l’art. 5 del Codice civile: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”. Il principio su cui si basa tale norma è la salvaguardia del bene dell’integrità fisica anche contro gli atti con cui l’individuo stesso potrebbe comprometterla. Il diritto all’integrità non è, come quello alla vita, “assolutamente indisponibile”: è solo “relativamente indisponibile”. Di
124
conseguenza, l’individuo non può disporre del proprio corpo quando ciò comporti un’autoinvalidazione permanente, a meno che ciò non sia richiesto da una causa sanitaria. La norma cade, infatti, nel caso di un intervento chirurgico-terapeutico necessario. Dal momento che la legge parla esplicitamente di una diminuzione “permanente”, rimane giuridicamente lecita una sterilizzazione consensuale reversibile. Questo dettaglio della normativa vigente ha avuto quanto meno l’effetto positivo di stimolare la chirurgia a mettere a punto metodiche meno demolitrici, in vista di una sterilizzazione efficace ma reversibile.
Se dalle ragioni di ordine costituzionale si passa a quelle di opportunità, i giuristi cattolici sono ancor più compattamente schierati contro la sterilizzazione. Il pericolo paventato è quello che si creino brecce nella difesa rigorosa dei beni primari della vita e dell’integrità fisica. In periodo di crisi dei valori si sente necessario rafforzare i principi personalistici, senza creare deroghe. Tuttavia anche i giuristi più rigorosi, pur essendo contrari alla sterilizzazione irreversibile, ritengono eccessivamente severo applicare nel caso della sterilizzazione le sanzioni previste dall’art. 583, che puniscono la lesione personale “gravissima” con la reclusione da 6 a 12 anni. In ogni caso è perciò auspicabile una nuova norma nel Codice penale.
I medici e la sterilizzazione: problemi deontologici.
Il diffondersi della domanda di sterilizzazione ha posto i medici dì fronte a delicati problemi professionali. Questa pratica, presentata come la più innocua misura anticoncezionale, comporta serie conseguenze, che nessun medico coscienzioso può ignorare. Più che le complicazioni cliniche, ciò che preoccupa il medico coscienzioso sono i risvolti psicologici della sterilizzazione. Ci sono uomini e donne che, una volta sterili, entrano in crisi, sfasciano matrimoni, finiscono sul divano dell’analista. Scavando in profondità, si trovano spesso equivoci o ambivalenze emotive nei confronti dell’intervento cui sono sottoposti. Anche se biologicamente la sterilizzazione non è una castrazione, tuttavia può essere vissuta come tale da alcuni soggetti. Inoltre Patteggiamento psicodinamico profondo verso la rinuncia alla fertilità può non corrispondere a quello conscio: di qui conflitti e squilibri psichici.
Se vuol evitare di incrementare i meccanismi autodistruttivi, il medico si trova costretto a vagliare le richieste di sterilizzazione per scoprire
125
le controindicazioni. La sterilizzazione è sempre controindicata quando è guidata da motivazioni psicopatologiche. C’è gente che si offre al bisturi nell’illusione di risolvere problemi che invece il bisturi non risolve: dopo l’intervento il problema resta, e per lo più se ne aggiunge un altro, derivante dalla menomazione. Nessuna sterilizzazione può risolvere, per esempio, quelle forme di ansia nevrotica connessa con la responsabilità del procreare.
Non basta l’analisi della personalità di colui che richiede la sterilizzazione: è necessaria un’analisi della coppia. Qual è il coniuge che vuole la sterilizzazione? Come si situa nel rapporto di coppia rispetto all’altro coniuge? C’è pericolo di plagio, o quanto meno di una scelta non libera? Negli Stati Uniti, dove la pratica della sterilizzazione è molto diffusa, i medici hanno sentito la necessità di una difesa in termini giuridici contro le sterilizzazioni non volute. Seguendo una prescrizione del Dipartimento di Stato per la Salute, l’Educazione e la Previdenza sociale, i medici fanno sottoscrivere ai richiedenti un documento di assenso, in cui sono anche indicati i rischi e si informa che la pratica è irreversibile. Più difficile è premunirsi contro la responsabilità morale nei confronti di scelte in cui la libertà esiste formalmente ma non psicologicamente. È utile ascoltare la testimonianza di un autore che pur si dichiara favorevole all’estensione della sterilizzazione: “Dal punto di vista emotivo, una donna può credere di voler essere sterilizzata dopo i 9 mesi di una gravidanza che forse è stata faticosa e difficile. È però possibile che, più tardi, la stessa donna rimpianga la decisione. Una ricerca ha indicato che parecchie donne, le quali avevano chiesto una sterilizzazione post partum, rifiutavano di farsi operare quando, dopo qualche tempo, si presentava loro l’opportunità di farlo” 87.
Le generiche raccomandazioni a procedere con prudenza non bastano. Dovendo tener conto delle possibili ripercussioni negative e delle controindicazioni di ordine psicologico, il medico si trova di fronte a un compito che supera le sue competenze. Si rende necessaria la stretta collaborazione con esperti della psiche, assistenti sociali, professionisti della relazione d’aiuto. La sterilizzazione cessa così di essere un intervento strettamente medico per diventare un problema umano, nel senso più estensivo della parola.
126
Un nuovo orizzonte antropologico
La sterilizzazione non è un banale intervento chirurgico per eliminare una fecondità non desiderata. In quanto connessa con la generatività, essa interseca l’universo di valori, simboli e aspirazioni della paternità/maternità. La possibilità della sterilizzazione provoca una trasformazione degli stereotipi sessuali. Faceva parte dello stereotipo femminile che la donna portasse non solo il peso della maternità, ma anche quello della contraccezione. Di fatto nel campo della contraccezione la donna è stata sempre penalizzata, sia prima che dopo l’evento degli antifecondativi. I mezzi contraccettivi, tanto meccanici che chimici, sono stati abitualmente sperimentati e fatti usare dalla donna. Oggi la possibilità della sterilizzazione anche per l’uomo crea un diverso equilibrio nella coppia. Non è più ovvio che debba essere la donna ad addossarsi il peso e i rischi della contraccezione. Tanto più che l’informazione — o la “propaganda” — medica decanta la vasectomia maschile come un mezzo contraccettivo estremamente sicuro ed esente da rischi. In queste condizioni le responsabilità nei confronti della contraccezione sono ben bilanciate nella coppia. La donna può chiedere all’uomo di farsi sterilizzare, senza che questi possa addurre pretesti di ordine sanitario. Emerge allora che la resistenza degli uomini a sottoporsi a sterilizzazione chirurgica è radicata in un modello culturale che identifica la virilità con la “potentia generandi”. Il modello è visibile macroscopicamente nelle culture extra-europee, dove ancora la prolificità è considerata un bene fondamentale. È il motivo che ha portato al fallimento programmi nazionali di planning familiare basati sulla sterilizzazione in India. Ma il modello della potenza maschile resa visibile dalla numerosa figliolanza è presente anche nell’area latino-mediterranea. Per affermarsi come fenomeno di massa la sterilizzazione dovrebbe essere preceduta da una revisione dei modelli culturali. Questi non sono immobili, ma neppure assolutamente plastici. Ce se ne rende conto soprattutto quando si pretende di trapiantarli da una cultura all’altra: il risultato è spesso un violento fenomeno di rigetto. A voler credere al film semidocumentario di J. Sanjinés, “Sangue di Condor”, così è avvenuto in Bolivia. C’è stato un periodo in cui gli ostetrici americani, operanti in quel paese all’insegna del Corpo della Pace, sterilizzavano a loro insaputa le partorienti indigene. Verosimilmente non per odio razziale, ma nell’intento di trasferire nelle aree di sottosviluppo economico la limitazione demografica adottata nel loro ambiente culturale. Ne è nata una campagna
127
nazionale per costringere le autorità ad arrestare quei programmi, culminata con l’espulsione dei “civilizzatori”. Al di là dell’episodio in sé, a noi interessa il suo valore simbolico. Esso ci presenta la sterilizzazione come un intervento che ha delle vaste risonanze antropologiche-culturali, perché connesso con la rappresentazione ideale che ogni sesso fa di se stesso, con i ruoli rispettivi dell’uomo e della donna e con i valori che strutturano le diverse culture. Tanto più i valori della vita sono tenuti in alta considerazione, tanto più disumana appare l’eliminazione deliberata della facoltà generativa. Ma anche nell’area del mondo occidentale, dove la secolarizzazione e l’edonismo consumista hanno spento da tempo ogni mistica della propagazione della vita, la sterilizzazione non è accettata senza resistenza, almeno nella misura in cui sconvolge i ruoli sessuali tradizionali. La spinta “umanistica” verso la sterilizzazione volontaria, proclamata da alcuni come il mezzo più ovvio per risolvere i problemi demografici mondiali e quelli della “qualità della vita”, è contrastata da concezioni antropologiche che hanno preso corpo nei modelli culturali tradizionali.
Il punto di vista etico
È buona prassi della teologia morale iniziare la trattazione di un argomento con delle distinzioni. Per quanto questo modo di procedere possa essere talvolta irritante, non si può negare che contribuisca alla chiarezza. In merito alla sterilizzazione, la morale cattolica ha avuto cura costantemente di distinguere le varie modalità: terapeutica, contraccettiva, eugenetica e penale. Sono tipi fenomenologicamente distinti; anche la valutazione dal punto di vista etico va differenziata. Per quanto riguarda il primo caso, la chiesa cattolica ha tenuto costantemente una linea di apertura. La sterilizzazione è stata considerata come una forma di mutilazione e ad essa sono stati applicati i princìpi che regolano questa casistica. Anzitutto il principio della “totalità”: si può rimuovere un organo per salvare la vita, ovvero a vantaggio di tutto l’organismo. Secondariamente il principio secondo cui gli organi della generazione esistono per il bene della specie e non possono essere semplicemente subordinati al bene dell’individuo. Nella casistica concreta il principio della totalità è modificato dal principio del doppio effetto; di conseguenza, le operazioni di sterilizzazione sono permesse solo quando l’interferenza con la funzione generativa è un effetto non voluto o “indiretto”; la sterilizzazione
128
“diretta”, al fine di eliminare la capacità generativa, non è permessa. I moralisti cattolici che difendono più rigidamente questa linea richiedono, per poter ammettere la sterilizzazione, che l’infermità sia grave e definitiva, e che l’intervento sterilizzante sia necessario come unico rimedio efficace; si richiede inoltre che l’intenzione sia esclusivamente terapeutica, e non contraccettiva 88.
Per quanto riguarda la sterilizzazione a fini contraccettivi, la morale cattolica ha tenuto una linea costante di netto rifiuto. Le dichiarazioni magisteriali vanno dalla condanna del S. Uffizio del 1940, alle prese di posizione di Pio XII, fino alla “Humanae vitae” (“È parimenti da escludere, come il Magistero della Chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto dell’uomo che della donna”). L’ultimo intervento ufficiale, in ordine di tempo, è un documento inviato dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi degli Stati Uniti. Vi si ribadisce che la sterilizzazione, il cui unico effetto immediato sia quello di rendere la facoltà generativa incapace di procreare, “rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della fede” 89.
La riflessione dei moralisti cattolici ha esplicitato le ragioni antropologiche e teologiche di questo costante “no” alla via della sterilizzazione, riconducendole ai principi personalistici che sottendono la morale cattolica relativa alla vita fisica. Come afferma esplicitamente la “Humanae vitae”, la considerazione della persona è il motivo che guida la Chiesa nel difendere la morale coniugale nella sua integrità; lo scopo è quello di contribuire all’instaurazione di una civiltà veramente umana, dove l’uomo non abdichi alla propria responsabilità per consegnarsi a dei mezzi tecnici che impoveriscono il patrimonio delle sue forze psichiche e morali. La norma etica, con la sua intransigenza, viene a svolgere, in definitiva, una funzione di argine protettivo a vantaggio dell’uomo, contro quanto di fatto lo mutila e lo coarta, anche se si presenta sotto l’aspetto seducente della permissività.
Il fronte dei moralisti cattolici, sostanzialmente compatto finché ci si limiti a enunciare i principi, si frastaglia quando si passa a considerare il vissuto concreto che può indurre a prendere la decisione di far ricorso alla sterilizzazione chirurgica. Alcuni giungono ad ammettere alcune forme
129
di sterilizzazione contraccettiva: non per lassismo, ma per coerenza con alcuni princìpi morali comunemente accettati. Il più importante è quello della “totalità”, comunemente invocato, come abbiamo visto, a giustificazione della sterilizzazione terapeutica. La “totalità” è estesa da alcuni moralisti fino a includere la salute psichica, oltre che quella fisica, e quindi quei rapporti coniugali che costituiscono il contesto del benessere psicosessuale. È rappresentativa in questo senso la posizione di P. Häring. Egli ritiene, coerentemente con l’insegnamento del magistero cattolico, che la sterilizzazione vada respinta quando è praticata nel rifiuto di portare a termine la vocazione procreatrice; ma quando il principio della “paternità responsabile” sia rispettato, egli prevede la possibilità di ricorrere alla sterilizzazione chirurgica, al fine di garantire delle relazioni coniugali serene, vitali per la stabilità del matrimonio e la salute dei coniugi 90. Così la sterilizzazione è permessa per salvare la “totalità” del matrimonio. Mediante questo allargamento del principio della “totalità” la morale cattolica si apre a un’istanza di quella evangelica (rappresentata da teologi di rilievo come Barth e Thielike), che privilegia l’aspetto “unitivo” della sessualità umana rispetto alla funzione riproduttiva.
Altri moralisti percorrono un cammino diverso. Così, ad esempio, Chiavacci preferisce esplorare le possibilità operative che offre il “principio di carità”. Questo principio ha portato a una radicale revisione di un capitolo tradizionale dell’etica medica, vale a dire quello dei trapianti d’organo. Si è diffusa di recente la prassi, esperita dalla coscienza cristiana comune come buona, del trapianto d’organo da donatore vivente. In questi casi la rinuncia alla propria integrità fisica non potrebbe essere giustificata semplicemente invocando il principio di “totalità” che regola la casistica relativa alle mutilazioni. È necessario che questo sia trasceso, considerando non solo il bene dell’organismo, ma il bene della persona anche nella sua dimensione spirituale. Allora anche una mutilazione può acquistare un valore etico positivo, se fatta per proporzionati motivi di carità e in vera libertà. Non si potrebbe ricorrere al “principio di carità” per giustificare alcuni casi di sterilizzazione contraccettiva, quando sussiste l’impossibilità pratica o psicologica di ricorrere a metodi efficaci di contraccezione? 91.
Due altre modalità di sterilizzazione meritano un breve accenno: quella eugenetica e quella penale. È ancora possibile ascoltare proposte di un
130
ricorso alla sterilizzazione per difendere la società da portatori di tare ereditarie (si tratta anche in questo caso, paradossalmente, di un ricorso al pincipio di “totalità”, dove però è il bene della società nel suo insieme che viene invocato per giustificare il sacrificio della libertà individuale). Gli avvocati di questo tipo di interventi sono però poco numerosi e ancor meni autorevoli 92. La mancanza di base scientifica ha discreditato, presso i più, gli argomenti per la sterilizzazione eugenetica. Dal punto di vista etico c’è unanimità nel rifiutare la sterilizzazione obbligatoria, in quanto violazione dei diritti della persona e precedente pericoloso 93.
Un nuovo paragrafo nella sterilizzazione eugenetica è stato aperto di recente dalla possibilità di avere informazioni genetiche precise mediante la diagnosi prenatale. La consulenza genetica ha rivoluzionato l’atteggiamento tradizionale dei genitori verso i bambini non nati. Uno studio su un numero significativo di coppie che vi hanno fatto ricorso ha registrato, dopo la diagnosi positiva di disordini genetici nel feto, la duplice decisione di aborto e di sterilizzazione. Nonostante che il consulente consigliasse prudenza, specialmente nei confronti della sterilizzazione, nessuna della coppie che avevano chiesto la consulenza preferì rimanere capace di generare bambini 94. La prima generazione di genitori nella storia che può disporre della conoscenza di malattie genetiche mediante diagnosi prenatale si trova affrontata a decisioni cruciali. Lo stato di acuta sofferenza in cui li getta la diagnosi infausta rischia di impedire che la decisione venga presa con saggezza, dopo un’adeguata ponderazione degli aspetti morali della situazione.
Un’ultima osservazione sulla sterilizzazione penale. È una forma di castrazione con cui vengono colpiti talvolta i colpevoli di reati sessuali che costituiscono un pericolo permanente per la società. Il magistero della chiesa cattolica non ha mai condannato questo tipo di sterilizzazione. La “Casti connubii” (1930) esclude esplicitamente dalla condanna della sterilizzazione la castrazione del reo. I moralisti che accettano la sterilizzazione penale la giustificano considerando l’effetto contraccettivo come
131
“indiretto”, dal momento che ciò che è direttamente inteso è la punizione. Oggi il clima culturale è generalmente ostile a queste misure repressive. Alcuni medici vi si oppongono per motivi deontologici, perché vi vedono una perversione del ruolo proprio del medico. Anche i moralisti cattolici tendono a sottrarre il loro sostegno alla sterilizzazione penale. Auspicano anzi che la chiesa si faccia in questo campo coraggiosa tutrice dei diritti della persona, nello spirito della “Gaudium et Spes” che, condannando ciò che viola l’integrità della persona umana, menziona esplicitamente le mutilazioni.
Per concludere la panoramica sulla problematica attuale della sterilizzazione con un’annotazione di tendenza, rileviamo che, mentre l’opposizione alla sterilizzazione obbligatoria è sempre più viva, aumenta la pressione culturale verso la sterilizzazione volontaria. La rivendicazione del diritto, conclamato dalle femministe e da altri movimenti, a disporre del proprio corpo, spiana la strada a interventi distruttivi della propria capacità generativa. A chi propone la sterilizzazione generalizzata come metodo spiccio ed efficacie per arginare i problemi demografici, la comunità cristiana risponde con un rinnovato appello alla coscienza e alla responsabilità dei singoli. Chi annuncia che la vocazione dell’uomo è quella di essere figlio di Dio, non può rassegnarsi a vedere trattati gli esseri umani come animali da cortile.
5. Transessualismo e identità sessuale
Quando Giovanni Paolo II nei suoi discorsi del mercoledì ha cominciato, commentando il racconto della creazione nella Genesi, a parlare della sessualità come dono che correda essenzialmente il corpo umano, le sue parole hanno suscitato vasto eco anche nella stampa non religiosa. Il recupero teologico della realtà fisica dell’uomo, la celebrazione dello splendore architettonico del corpo nella sua differenziazione sessuale, suonavano come una innovazione audace, che spazzava via una consolidata tradizione di moralismo platonicheggiante, nella cui prospettiva i valori dello spirito venivano presentati come antitetici alla materialità della carne. Affermava il papa: “Non c’è rottura e contrapposizione tra ciò che è spirituale e ciò che è sensibile, tra ciò che umanamente costituisce la persona e ciò che è determinato dal sesso: ciò che è maschile e femminile...
132
L’uomo mediante la sua corporeità, la sua mascolinità e femminilità, diventa segno visibile della Verità e dell’Amore”. E ancora: “Il cerchio della solitudine dell'uomo-persona si rompe perché il primo uomo si sveglia dal suo sonno come maschio e femmina... La femminilità ritrova se stessa di fronte alla mascolinità, mentre la mascolinità si conferma attraverso la femminilità. Proprio la funzione del sesso, che è costitutivo della persona (e non soltanto attributo della persona) dimostra quanto profondamente l’uomo con tutta la sua solitudine spirituale, con l’unicità e irrepetibilità propria della persona, sia costituito dal corpo come lui e lei. La presenza dell’elemento femminile, accanto a quello maschile e insieme ad esso, ha il significato di un arricchimento per l’uomo in tutta la prospettiva della sua storia, ivi compresa la storia della salvezza” 95.
La novità della teologia del corpo e della sessualità proposta dal pontefice è più nella forma che nella sostanza. Tutti i suoi elementi qualificanti, infatti, si ritrovano nell’insegnamento della Gaudium et Spes sul significato “personale” dell’amore umano, o possono essere dedotti da esso (cfr. G.S. n. 49).
La situazione culturale del nostro tempo domanda però con urgenza una rivisitazione tanto antropologica quanto etica della differenziazione sessuale dell’uomo e della donna. La dottrina tradizionale della chiesa, come anche le concezioni basate sul senso comune, subiscono una forte provocazione da fatti di costume che sovvertono i clichés cui siamo abituati. La revisione dei ruoli maschili e femminili ha sconvolto vistosamente ciò che spetta all’uomo e ciò che compete alla donna nella vita pubblica, nella famiglia, nella divisione del lavoro. I comportamenti sessuali devianti dalla norma, che in passato venivano repressi o tutt’al più tollerati, a condizione che non emergessero in pubblico, ora rivendicano il diritto all’esistenza e all’accettazione sociale. Non si contano le iniziative intese a promuovere un “orgoglio omosessuale”. I travestiti nelle strade esercitano una prostituzione aggressiva e disinibita. Più di recente anche i transessuali hanno cominciato a condurre campagne per il riconoscimento giuridico e sociale della loro condizione.
La crisi dell’identità sessuale sembra un tratto emergente della nostra civilizzazione. Anche se i tragici dilemmi di un transessuale non riguardano che una minoranza numericamente trascurabile, il significato proprio
133
all’essere uomo o all’essere donna è una questione esistenziale fondamentale, a cui nessuno può sfuggire. E proprio questo significato sembra essersi messo a traballare.
Che cosa è maschile e che cosa è femminile? Che cosa significa per l’essere l’umano possedere un corpo sessuato? È ancora possibile tracciare una linea decisa tra il normale e il patologico? Qual è il cammino abituale, e quali le possibili deviazioni, del processo che porta alla differenziazione sessuale? Cercheremo un orientamento tra i molteplici aspetti della crisi cominciando col rispondere a questa ultima domanda.
La conoscenza scientifica dell’identità sessuale
L’essere uomini o l’essere donne è una realtà che compenetra tutto il nostro essere individuale e sociale. Non esiste mai un essere umano generico, che sia poi soltanto successivamente qualificato come maschio o come femmina. L’appartenenza a un sesso o all’altro (oppure — come vedremo — a un sesso ambiguo o distorto) si agglutina talmente con il nostro “io” più profondo, che non ci è possibile immaginarci senza identità sessuale. Anche nell’esperienza dell’altro l’identità sessuale è tra i primi dati percettivi e tra i più tenaci nel ricordo: potremo aver dimenticato tutto di una persona incontrata fugacemente — il nome, l’età, l’aspetto — ma tuttavia sapremo ancora se era un uomo o una donna.
Secondo l’antropologia ingenua, il dimorfismo sessuale è la condizione normale e naturale. Tendiamo a pensare che esistono due sessi, polarmente opposti senza gradazioni, ognuno con una sua specifica morfologia, con i propri attributi psicologici, con stereotipi di comportamento e una “naturale” attrazione per gli individui del sesso “opposto”. Consideriamo inoltre l’appartenenza a un sesso come un fatto immutabile, una verità eterna. Questa modalità di pensiero affonda probabilmente le sue radici nel fatto che la mente umana trova comodo percepire per contrasto. Il pensiero bipolare è la forma più primitiva di pensiero logico. La classificazione bipolare soddisfa il nostro bisogno di ordine ed elimina dall’esperienza le zone indistinte e confuse. La nostra tendenza a concepire l’umanità suddivisa tra uomini e donne è indubbiamente giustificata dal punto di vista pragmatico, ma è inadeguata a una comprensione scientifica. Solo recentemente si è cominciato ad apprezzare la complessità del nostro sesso biologico. Ci si è resi conto che in differenti culture
134
si trovano concezioni divergenti circa l’identità maschile e femminile. La stessa distinzione biologica tra maschi e femmine è molto più complessa della definizione tradizionale basata sulla configurazione dei genitali esterni.
Un contributo decisivo è venuto dai tentativi effettuati dagli scienziati per aiutare persone del sesso ambiguo e transessuali ad adattarsi agevolmente a un sesso o all’altro 96. Sappiamo oggi che si diventa maschi o femmine in fasi successive, e che nei momenti critici dell’acquisizione dell’identità può avvenire una deviazione dalla norma che si configura come patologica. Le teorie tradizionali sulla maschilità e femminilità, sia ingenue che filosofiche e aprioristiche devono confrontarsi con i dati sperimentali e clinici derivanti da più discipline: genetica, embriologia, endocrinologia, neurologia, psicologia medica e clinica, antropologia culturale e sociologia. Grazie a queste conoscenze interdisciplinari, è possibile oggi tracciare l’itinerario che segue la differenziazione sessuale dell’uomo e della donna dal concepimento alla maturità.
L’appartenenza a un sesso, l’essere cioè persona sessuata e percepirsi tale, è designata scientificamente come “identità di genere”. Tale identità è la persistenza della propria individualità maschile o femminile (ambigua o ambivalente), come esperienza di percezione sessuata di se stessi e del proprio comportamento: l’essere “io” del mio corpo di uomo/donna 97. Altra espressione tecnica è quella di “ruolo di genere”, corrispettiva all’identità di genere. Indica tutto quello che una persona fa o dice per indicare agli altri o a se stesso l’appartenenza personale a un sesso.
La crescita dell’essere umano verso l’acquisizione di un’identità di genere compiuta non comporta solo uno sviluppo di potenzialità presenti fin dal concepimento, ma anche simultaneamente un processo di differenziazione che tende al dimorfismo: uomini e donne hanno diversa morfologia,
135
diverse funzioni endocrine, diverse strutture nervose periferiche e centrali. La differenziazione sessuale si attua normalmente attraverso un programma, nel quale la funzione di elemento pilota è assunta successivamente da fattori diversi. Lo si può immaginare come una corsa a staffetta, nel corso della quale la funzione di determinare il sesso biologico passa da un elemento all’altro. Al momento della fecondazione il sesso è stabilito dalla configurazione cromosomica: XX per la donna e XY per l’uomo. La morfologia sessuale si dispiega successivamente con eventi che sopravvengono durante lo sviluppo fetale. La presenza di ovaie o testicoli determina il sesso gonadico. La differenziazione è diretta, a questo punto, dagli ormoni prodotti dalle gonadi, responsabili rispettivamente di una dominanza di androgeni o di estrogeni. Gli ormoni svolgono un ruolo determinante per lo sviluppo dell’apparato riproduttivo interno: sembra anche che creino differenze nella sensibilità del cervello per la circolazione degli ormoni sessuali. Le differenze cerebrali medieranno poi il comportamento sessuale adulto. La situazione ormonale prenatale esercita, dunque, durante i giorni critici dello sviluppo cerebrale, un’influenza determinante sulle vie neurologiche, le quali, a loro volta, influenzano il dimorfismo comportamentale.
Con la formazione dei genitali esterni si crea il presupposto perché nella differenziazione sessuale intervenga anche la componente sociale. Alla nascita, infatti, si è attribuiti al sesso maschile o femminile sulla base della configurazione dei genitali esterni. Per l’uomo, a differenza di quanto avviene per gli animali, esercita un’influenza determinante la storia biografica post-natale. L’attribuzione di un sesso o dell’altro condiziona il comportamento dei genitori verso il neonato. Il sesso biologico acquista, a questo punto, una connotazione marcatamente culturale: la differenziazione prosegue secondo il tracciato delle prescrizioni culturali che definiscono il comportamento secondo i ruoli di genere. Ingenuamente tendiamo a rappresentarci l’acquisizione dell’identità di genere come una inevitabile estensione del sesso biologico. La conoscenza scientifica dell’identità sessuale ci porta invece a concludere che molto di ciò che consideriamo come inerente intrinsecamente alla maschilità e alla femminilità è il risultato di ruoli culturalmente accettati. Sono istruttivi, in tal senso, gli studi di J. Money sui bambini ai quali alla nascita è stato assegnato un sesso diverso da quello cromosomico, a causa di un’ambiguità morfologica dovuta all’ermafroditismo. Essi crescono con un’identità di genere conforme al sesso loro assegnato, piuttosto che in accordo con
136
il loro sesso biologico 98. Il comportamento secondo il ruolo sessuale si acquisisce mediante un processo imitativo, basato sul riconoscimento delle differenze sessuali. La differenziazione sessuale di genere e di ruolo avviene in modo predominante mediante la relazionalità. Attraverso modelli reali o fantastici, dalla nascita alla pubertà il bambino si identifica con il genitore del suo stesso sesso, e si complementarizza con il genitore dell’altro sesso. Nell’ambito del nucleo familiare l’identificazione e la complementarietà avvengono con i propri genitori; crescendo, vengono al aggiungersi modelli al di fuori della famiglia. Per la stabilizzazione dell’identità sessuale il periodo determinante sembra essere quello della prima infanzia, a partire dal momento dell’acquisizione del linguaggio: dai 18 mesi ai 3-4 anni.
Anche le altre fasi della crescita esercitano un influsso sull’identità psicosessuale. Da sempre si è considerata con particolare attenzione la crisi della pubertà. Dal punto di vista endocrinologico, gli ormoni causano una maturazione dimorfica del corpo, accentuando le differenze con l’altro sesso. Si ha così una modificazione dell'immagine fantasmatica che l’adolescente ha del proprio corpo. Il riconoscimento sociale assume una grande importanza; per conquistarselo l’adolescente prende molta cura di accentuare nella presentazione sociale del proprio corpo i caratteri del proprio sesso. L’erotismo della pubertà costituisce, per così dire, il tetto dell’edificio dell’identità di genere: le immagini erotiche della pubertà confermano l’identità che si era precedentemente manifestata e modellano l’orientamento sessuale, come normale oppure distorto da parafilia. L’adolescenza è, infine, il tempo in cui l’innamoramento completa il processo di acquisizione dell’identità sessuale. Il sentirsi accettato e amato, nel proprio corpo, nel proprio sesso, dissipa i residui conflittuali precedenti e rafforza definitivamente la propria identità come uomo o come donna.
137
Le turbe dell’identità e dell’orientamento sessuale
Il cammino per il quale si giunge ad essere un uomo o una donna, a riconoscersi e a comportarsi come tali, è lungo e insidioso. Le turbe dell’identità sessuale possono essere radicate tanto nella differenziazione che ha luogo nella vita intrauterina, quanto nella nascita e nella vita postnatale. La responsabilità risale, rispettivamente, a difetti genetici (anomalie cromosomiche); a un’alterata produzione di ormoni durante i periodi critici dello sviluppo fetale (nell’ermafroditismo si verificano, di conseguenza, incongruenze anatomiche nella morfologia dei genitali esterni); a un’errata attribuzione di sesso alla nascita; o, più semplicemente, all’educazione. Per queste persone la conquista della propria identità sessuale diventa un problema arduo, con strascichi di molta sofferenza. Tanto più precoce è l’allontanamento dal modulo normale dello sviluppo, nelle tappe decisive della differenziazione, tanto più gravi e irreversibili sono le conseguenze.
Nell’insieme della popolazione sono comparativamente pochi gli individui che mostrano una discordanza significativa tra il sesso biologico, la loro identità o orientamento sessuale, e il comportamento connesso con il ruolo. Le turbe principali possono essere ricondotte al transessualismo, travestitismo ed omosessualità; le diverse forme di parafilia costituiscono variazioni patologiche nella scelta dell’oggetto sessuale.
Il caso più radicale è quello del transessuale. È una persona la cui identità di genere è in conflitto col proprio sesso biologico, compresa la morfologia genitale esterna. Il transessuale si sente una donna intrappolata in un corpo maschile (parliamo dell’uomo perché il caso contrario ― del transessuale biologicamente donna che abbia una identità maschile ― è statisticamente molto più raro). Sempre più numerosi sono i transessuali che non si rassegnano a questa situazione e intraprendono il viaggio che li faccia approdare al sesso che sentono come la loro “vera natura”. Dopo il trattamento ormonale, che modifica i caratteri sessuali secondari, alcuni si spingono fino ad alterare chirurgicamente la propria anatomia, per risolvere radicalmente l’incongruenza. L’operazione è solo l’elemento più spettacolare del cambiamento di sesso. Per armonizzare la discordanza tra biologia e identità di genere sono necessarie una quantità di trasformazioni relative agli stereotipi comportamentali dell’uno o dell’altro sesso.
Anche il travestitismo è una turba dell’identità sessuale maschile, quasi
138
mai femminile 99. Si manifesta nella tendenza coatta a identificarsi col sesso opposto e a vestirne gli abiti. Il travestito autentico ha una specie di duplice identità: le due parti si alternano con nome e identità propria, con gli abiti, la voce e il portamento adatti. Non nega affatto la sua identità maschile, ma ha bisogno di alternarla con la personificazione di quella femminile, con il sentimento ludico dì “giocare” un altro ruolo.
La variazione dell’identità più nota e diffusa è l’omosessualità. Spesso l’identità di genere vera e propria non è propriamente in causa: l’omosessuale non ha dubbi circa la propria identità, ma orienta il proprio interesse erotico verso persone dello stesso sesso. Quando tuttavia l’omosessuale, oltre a convogliare l’interesse erotico verso gli uomini, assume comportamenti effeminati e ama identificarsi con il sesso femminile, i confini con il travestitismo e con il transessualismo diventano fluidi.
Tra le turbe dell’orientamento sessuale vanno elencate quelle particolari condizioni psicosessuali per cui la persona è eccitata da stimoli inusuali e socialmente e moralmente inaccettabili. Comunemente vi si ravvisa delle “perversioni”; con linguaggio neutro, medicalmente si preferisce parlare di “parafilia”: sadismo e masochismo, esibizionismo, voyeurismo, pederastia, necrofilia ecc.
In che misura l’orientamento sessuale delle persone dipende da una specie di determinismo naturale? La scelta di un partner sessuale è un elemento dell’apprendimento del comportamento sessuale adeguato, che si acquisisce mediante il processo di socializzazione, oppure esiste un meccanismo biologico che stimola il nostro erotismo? La ricerca scientifica negli animali ha appurato che gli ormoni possono svolgere un ruolo di organizzazione neurologica nel creare la scelta dell’oggetto sessuale. Ma la connessione tra livelli ormonali e orientamento sessuale nei soggetti umani è molto più problematica (anche se è attendibile che gli ormoni fetali che organizzano le strutture fetali dismorfiche possono anche influenzare l’organizzazione delle strutture cerebrali che concernano i comportamenti sessuali). Nell’essere umano gioca un ruolo importante lo sviluppo dell’identità e dell'orientamento sessuali che avviene dopo la nascita.
139
Lo confermano i risultati della ricerca clinica relativa all’omosessualità, che tra le turbe dell’orientamento sessuale è la più studiata. Risulta inoppugnabile che i genitori giocano un ruolo determinante per quanto riguarda la salute psicosessuale del bambino e i suoi sentimenti di adeguatezza sessuale. Tuttavia non c’è evidenza che siano i genitori a “creare” un bambino omosessuale. Nelle modalità dell’esistenza umana c’è sempre qualcosa che dipende dalla libertà e dalla decisione personale.
Orientamenti dell’etica cristiana
Il corpo umano ha uno stampo sessuale. Quando lo si è voluto negare, si è solo riusciti a colpevolizzare le persone, per l’inevitabile emergenza della sessualità in tutte le espressioni della vita, ivi compresa l’esperienza religiosa. Nascondendo l’importanza del sesso nelle rappresentazioni artistiche, coprendo di vergogna i genitali (le “pudenda”, le “parti vergognose”...), non si è riusciti a produrre, per lo più, che una fissazione morbosa. Le varie espressioni di puritanesimo repressivo, ai limiti della nevrosi, si sono molto spesso alleate con la mentalità cristiana. Eppure la gioia di vivere, che nasce da una piena accettazione del proprio corpo, anche nella sua specificazione sessuale, non è contraria al cristianesimo. La riflessione cristiana sull’uomo comincia, secondo l’esempio fornito da Giovanni Paolo II, con il primo uomo e la prima donna nudi nell’Eden, quale simbolo visivo del dono divino della sessualità.
Oggi però sappiamo, meglio che in passato, che la sessualità, oltre che un dono, è anche un compito. Si giunge ad essere uomini e donne attraverso un itinerario che riserva talvolta esiti imprevisti. La identità e l’orientamento sessuale sono largamente basati sulle caratteristiche sessuali biologiche, ma non ne sono interamente determinati in modo obbligante. Nell’ambito del compito di “dover essere” ciò che per natura si “può essere”, si aprono i problemi dell’etica. Anche la morale cristiana è provocata dal sapere scientifico sulla sessualità umana e dai problemi di coscienza di molti individui a una presa di posizione.
In primo luogo: è lecito cambiare sesso, come pervengono a conseguire i transessuali? Questa formulazione riflette da vicino il modo in cui il problema dei transessuali è visto dall’opinione pubblica. Sulla loro vicenda grava il sospetto di un intervento capriccioso, quasi una sfida alla natura e alla società, nonché l’insinuazione che il passaggio da un
140
sesso all’altro sia, in definitiva, a servizio della prostituzione. La scelta è vista in funzione del piacere, senza considerare la sofferenza lacerante che molto spesso accompagna il transessuale nella ricerca della propria identità sessuale. Il transessuale, da parte sua, vive la sua decisione non come un cambiamento arbitrario, bensì 'come l’adeguamento del corpo al profilo psicosessuale che sente come proprio.
La richiesta di intervento medico per la riassegnazione del sesso — con la terapia ormonale e, come ultima tappa, con l’intervento chirurgico ― solleva per il sanitario problemi deontologici ed etici. L’opera medica in questo caso travalica l’ambito terapeutico tradizionale. Il medico non può limitarsi semplicemente ad assecondare la richiesta, senza sottoporla a un certo vaglio per appurare la qualità della motivazione, oltre che le conseguenze sanitarie e psicologiche dell’intervento. Benché la legislazione italiana con la legge del 14.4.1982, n. 164, non consideri più tali interventi chirurgici come mutilazione perseguibili penalmente 100, i medici sono per lo più ostili; l’opinione pubblica condanna come aberrazioni o eccentricità i cambiamenti di sesso. In tale contesto i transessuali sono rinviati al sottobosco della medicina abusiva (e abborracciata: perciò, spesso, con danni gravi all’organismo) e della speculazione.
Per una serena valutazione morale bisogna far perno sull’identità sessuale, stabilizzata al momento della pubertà. Non è su questa che si può agire, perché l’identità, una volta stabilita, non è più in grado di subire cambiamenti. L’incongruenza con il sesso biologico può essere livellata solo operando sul versante somatico 101. Qualora ciò — per motivi medici, sociali o psicologici — non fosse possibile, rimane la frustrazione beante, a cui si può dare una risposta solo per la via della sublimazione.
La visione cristiana della sessualità, come momento della chiamata divina, è sufficientemente dinamica per integrare le conoscenze scientifiche moderne circa il processo di acquisizione dell’identità sessuale. I racconti biblici della creazione non giustificano nessun fissismo su cui possa far leva la visione ingenua della maschilità e femminilità. Tuttavia non
141
bisogna dimenticare il carattere specifico dell’etica religiosa biblica, compendiato nel concetto di “alleanza”. Nella morale dell’alleanza l’essere uomo o donna non sono beni in sé. Sono piuttosto luoghi della “vocazione”, destinati a far parte del dialogo della salvezza.
Contro la tendenza, tipica del soggettivismo moderno, a sganciare l’individuo dalla normativa insita nella natura, l’etica cristiana ripropone costantemente il valore della “legge naturale”. È con questo metro che la chiesa cattolica continua a condannare l’omosessualità e le varie forme di parafilia 102.
Il diffondersi di un’etica sessuale che assume come parametro valutativo dei comportamenti sessuali il modello del piacere, ha fatto cadere i criteri tradizionali. Se il sesso è stato troppo a lungo soggetto a restrizioni, non ne segue che d’ora in poi debba essere vissuto senza restrizioni di alcun genere. Qualsiasi concezione filosofica della sessualità si assuma, ne derivano restrizioni. Il cristianesimo ha per lo più fatto proprio e proposto il modello di una sessualità normata dalla finalità riproduttiva. La sensibilità personalistica di oggi invita piuttosto ad aprirsi al modello comunicativo. Questo sposta l’accento dagli aspetti fisici della sessualità, in quanto finalizzata alla generazione di una nuova vita, ai ruoli interpersonali, all’espressione delle emozioni (il sesso come linguaggio che esprime tenerezza, rispetto, ammirazione, e ovviamente come espressione di amore), comunicazione e condivisione del piacere.
Adattando questo modello — che integra, e non sostituisce quello riproduttivo — la risposta alla domanda etica di che cosa è “normale” e che cosa è “perverso” nel sesso diventa più difficile. Difficile, ma non impossibile; né tantomeno irrilevante. È necessario tributare il giusto apprezzamento alla diversità e alla complessità degli orientamenti sessuali, senza rinunciare però a riferirsi alla “normalità” in armonia con il tipo ideale di sessualità umana a cui si aspira.
Un contributo peculiare dell’antropologia cristiana va ravvisato nell’ambito della revisione dei comportamenti legati agli stereotipi sessuali. Lo stereotipo maschile e il suo corrispettivo femminile sono la definizione che la società offre di quel che significa essere uomo o essere donna;
142
rappresentano il generale consenso, nell’ambito di una comunità culturale, sui ruoli assegnati agli uomini e alle donne, ai bambini e alle bambine 103. La miopia che pervade ogni comunità culturale, differenziandola dalle altre, inclina a far considerare gli stereotipi che ci sono familiari come “normali”, e a respingere i comportamenti che divergono come aberrazioni o come folklore. Inoltre gli stereotipi tendono, come indica il nome stesso, a una certa rigidità. La resistenza al cambiamento si ottiene mediante un processo di ideologizzazione delle differenze dei ruoli. Essi vengono fatti risalire alla “natura”, oppure, più radicalmente, alla volontà di Dio. Anche per ciò che concerne la maschilità e la femminilità, la teologia cristiana ha dato il suo contributo per “naturalizzare” e “divinizzare” le diversità che invece hanno un’origine soltanto culturale 104. Il messaggio cristiano, così come è stato vissuto da Gesù, contiene una potenzialità rivoluzionaria che soltanto oggi, nel contesto dei rapidi mutamenti e dell’appassionata ricerca di ruoli sessuali che non opprimano, bensì si integrino reciprocamente, possiamo appurare appieno. Gesù, “inconfondibile nel suo tempo e nel suo ambiente” nel modo di realizzare la propria maschilità e di concepire la femminilità 105, costituisce un’apparizione storica singolare. Ha distrutto l’androcentrismo del mondo antico, fonte di un’ostilità globale contro il femminile; è stato egli stesso l’epifania di una maschilità non animosa, riconciliata con la femminilità prima di tutto nella propria persona, e poi con quella delle donne. È questo il modello con cui l’antropologia cristiana della sessualità è chiamata a confrontarsi. Forze irresistibili si nascondono dentro al presente tumulto che sconvolge la concezione tradizionale della sessualità, forze nuove nella lunga storia dell’umanità. Per l’originale messaggio di Gesù, rimasto a lungo nascosto sotto il moggio, l’èra presente è un “kairós”, un tempo opportuno della grazia.
143
6. La regolazione delle nascite
Il rifiuto della contraccezione
La morale cattolica non è disponibile a inversioni di rotta, semplicemente per essere al passo con i tempi o per amore di consensi: lo dimostra, tra l’altro, il costante rifiuto ad avallare pratiche contraccettive. La valutazione etico-sociale di tali pratiche nella cultura dell’Occidente ha conosciuto diverse vicissitudini. Nel mondo antico la filosofia e la medicina greco-romana non hanno dimostrato praticamente interesse per la moralità della contraccezione. Il cristianesimo invece ha proposto una rigida etica sessuale, di cui faceva parte la condanna della contraccezione. In realtà la condanna cadeva globalmente su un insieme di pratiche che avevano finalità abortive-contraccettive-magiche, difficilmente isolabili e riconducibili alle nostre classificazioni. La comunità cristiana delle origini ha considerato peccaminoso tale ricorso ai pharmakeia (cfr. Gal. 5, 20; Apoc. 9, 21; 21, 8; 22, 15), opponendosi alle tendenze dell’epoca).
La disputa dottrinale contro lo gnosticismo indusse i custodi dell’ortodossia cristiana a cercare un alleato nella filosofia stoica. Da questa il cristianesimo mutuò la norma etica della conformità alla “legge di natura”. Nel caso della sessualità, gli stoici consideravano secondo natura solo il rapporto mirante alla procreazione, non al piacere; le pratiche contraccettive erano perciò condannate per principio come un’offesa alla natura. Il pensiero cristiano si perfezionò ulteriormente in occasione della polemica antimanichea, condotta in prima persona da S. Agostino. L’ideologia manichea, che vedeva nella procreazione il sommo male, favoriva la contraccezione. Ad essa Agostino contrappose un’etica matrimoniale che giustificava il rapporto sessuale proprio in considerazione del bene della prole. In tal modo alla fine dell’antichità aveva preso forma completa il pensiero cristiano che condannava ogni forma di contraccezione. Vi confluivano l'ethos ebraico — che riconosceva nella prole una benedizione divina —; l’alta spiritualità neotestamentaria, culminante nella concezione sacramentale del matrimonio; il rifiuto del dualismo manicheo; la dottrina stoica della legge naturale. La cristianità medievale non apportò modifiche a tale concezione. Anzi, l’ostilità della chiesa alle pratiche contraccettive fu rafforzata dalle norme del diritto canonico, dall’insegnamento dei teologi (cfr. Tommaso d’Aquino, De malo 15, 2), e dall’azione educativa
144
dei confessori. La rottura intervenuta con la riforma protestante non infranse tale unanimità: anche i riformatori condannavano la contraccezione.
L’opinione etica tradizionale ha cambiato di segno solo in epoca relativamente recente. Per lungo tempo, nonostante il vivace dibattito provocato da Th. Malthus sul problema demografico, la mentalità medica e l’opinione pubblica rimasero ostili alla contraccezione. Ma anche quando questa ottenne l’appoggio dell’etica umanista dell’Occidente, l’atteggiamento della chiesa cattolica non mutò. Una trasformazione vistosa si verificò invece nelle chiese protestanti. A cominciare dalla confessione anglicana (conferenza di Lambeth del 1930), i pastori e teologi delle diverse chiese accettarono il principio del controllo della natalità da parte dei cristiani mediante il ricorso a metodi contraccettivi. Nella chiesa cattolica il magistero ha continuato a riproporre invariabilmente la condanna tradizionale. Nei termini dell’enciclica Casti connubii di Pio XI (1930) essa suona: “Ogni uso del matrimonio nell'esercizio del quale l’atto è privato da un’azione dell’uomo del suo naturale potere di procreare la vita, viola la legge di Dio e della natura”.
La problematica più recente
L’ultima occasione, in ordine di tempo, in cui il supremo magistero della chiesa cattolica è intervenuto sulla regolamentazione delle nascite è l’enciclica Humanae Vitae di Paolo VI (1968). La rilevanza di questo documento è in relazione con gli sviluppi nel frattempo avvenuti nel pensiero teologico relativamente al matrimonio e alla fecondità. La lunga diffidenza nei confronti della sessualità coniugale — praticamente riscattata solo dal fine procreativo nella visione agostiniana — ha ceduto il posto a una considerazione positiva del rapporto in sé, a prescindere dalla sua finalità procreativa. Questa prospettiva, implicita già nella concezione canonistica del “debito coniugale”, è stata assunta ed ha avuto la più autorevole consacrazione dal concilio Vaticano II. “Il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione, ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità” (Gaudium et spes, 50). Il rapporto sessuale nel matrimonio, dunque, non mira solo al concepimento di una nuova vita, ma anche a manifestare e a promuovere l’amore coniugale.
145
Un secondo principio entrato nella teologia cattolica è quello noto come “paternità responsabile”. Anch’essa ha un antecedente nella dottrina tradizionale, che indicava come fine del matrimonio la procreazione e l’educazione dei figli. L’educazione religiosa della prole introduceva un principio qualitativo come prioritario rispetto a quello semplicemente quantitativo. In termini più attuali, il senso di “responsabilità” nel mettere al mondo dei figli è stato acutizzato dal diffondersi delle preoccupazioni per l’esplosione demografica e dalle restrizioni che la vita urbanizzata provoca alle dimensioni della famiglia nei paesi ad alto sviluppo industriale. Anche il principio della paternità responsabile è stato ufficialmente consacrato dal Vaticano II: “I coniugi (nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla) adempiranno il loro dovere con umana e cristiana responsabilità, e con docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio stato di vita, tanto nel loro aspetto materiale che spirituale ... Questo giudizio in ultima analisi lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi” (Gaudium et spes, 50).
La posizione della chiesa cattolica in merito alla generazione non può essere identificata con il cliché che la vuole promotrice a ogni costo di una famiglia numerosa, o “natalista” a oltranza, proclamando la “provvidenzialità” di ogni nascita. Pur difendendo la fecondità come valore, tanto su un piano umano che in un’ottica religiosa, la chiesa ha progressivamente fatto emergere la legittimità, anzi la necessità di una regolazione delle nascite. Nel linguaggio dei documenti ecclesiastici si parla di “paternità responsabile”. Il senso di responsabilità può domandare sia una promozione della natalità, sia una contrazione della natalità stessa, a seconda del contesto sociale in cui la coppia si trova inserita. La regolazione delle nascite non è contro l’ordine morale, bensì è richiesta dall’ordine morale stesso.
Sulla base di queste acquisizioni dottrinali, diversi teologi cattolici ritennero che si potesse procedere a una parziale accettazione della contraccezione, quando questa fosse a servizio di un progetto di paternità responsabile e servisse a rafforzare l’unione dei coniugi. Il dibattito fu alimentato dall’apparire della “pillola”, ovvero della contraccezione ormonale, che induceva una infecondità nella donna inibendone il processo ovulatorio. Per un decennio nell’ambito della teologia cattolica si dibatté
146
vivacemente sull’accettabilità o no della contraccezione ormonale. Nella commissione pontificia creata per approfondire tutti gli aspetti della questione di delineò una maggioranza, guidata dall’eminente moralista J. Fuchs, a favore dell’accettabilità morale di questo metodo di regolazione della fecondità. Tuttavia l’enciclica Humanae Vitae (25/7/1968) di Paolo VI ripeté la condanna di ogni pratica contraccettiva nei termini usuali. Venne affermato il principio tradizionale della non interferenza con fini contraccettivi nel decorso nel normale atto coniugale — “La Chiesa insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto per sé alla trasmissione della vita” —, in forza dell’unione naturale tra il significato procreativo ed unitivo dell’atto stesso. L’enciclica ribadì che sono vie non lecite di regolazione delle nascite: l’interruzione del processo generativo; la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto nell’uomo che nella donna; la contraccezione: ovvero, “ogni azione che, o in previsione dell’atto coniugale o nel suo compimento o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga come scopo o come mezzo di rendere impossibile la procreazione” (nn. 12-15).
I “metodi naturali” di regolazione delle nascite
Una vistosa deroga al rifiuto di ogni forma di contraccezione è costituita dall’accettazione di metodi che si fondano sul ricorso ai periodi naturalmente infecondi.
Il principio era già stato posto da Pio XI nella Casti connubii, in cui stabiliva che non si dovesse ritenere che agivano “contro l’ordine naturale delle cose i coniugi che usano del loro diritto, benché per cause naturali o di tempo o di qualsiasi difetto non ne possa scaturire una nuova vita”. Pio XII nei discorsi vertenti sull’etica medica prese esplicitamente posizione e favore del metodo Ogino-Knaus, che negli anni ’50 era il solo metodo naturale noto. “L’avvantaggiarsi della sterilità temporanea naturale, nel metodo di Ogino-Knaus, non viola l’ordine di natura, poiché le relazioni naturali rispondono alla volontà del Creatore. Quando questo metodo è usato per motivi seri proporzionati esso si giustifica moralmente” (Al VII Congresso Intera, di Ematologia, 12/9/58, in Pio XII: Discorsi ai medici, p. 708; vedi anche il discorso all’Unione Cattolica Ostetriche, 29/10/59, pp. 166-172). La formulazione più completa della dottrina cattolica è quella che si trova nella enciclica Humanae Vitae di
147
Paolo VI: “Se per distanziare le nascite esistono seri motivi, derivanti o dalle condizioni fisiche o psicologiche dei coniugi, o da circostanze esteriori, la chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni generative per l’uso del matrimonio nei soli periodi infecondi ... La chiesa è coerente con se stessa sia quando ritiene lecito il ricorso ai periodi infecondi, sia quando condanna come sempre illecito l’uso dei mezzi direttamente contrari alla fecondazione, anche se ispirati da ragioni che possono apparire oneste e gravi. In realtà, i due casi differiscono completamente tra di loro: nel primo caso i coniugi usufruiscono legittimamente di una disposizione naturale; nell’altro caso essi impediscono lo svolgimento dei processi naturali” (n. 16).
La chiesa cattolica non è isolata nel promuovere e raccomandare i metodi naturali di regolazione della fertilità. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità dedica un interesse crescente ai metodi che si propongono di determinare il periodo fertile, in vista di una regolazione della famiglia con metodi naturali 106. Ciò che qualifica la posizione della chiesa non sono preoccupazioni di ordine sanitario ed ecologico, bensì una coerente visione teologica, con la sua implicita antropologia. Questa è costruita attorno alla categoria di “persona”, come soggetto chiamato al dialogo della salvezza con Dio, fonte di dignità inviolabile e di responsabilità.
Una seconda nota dominante della dottrina cattolica sulla paternità responsabile, organicamente articolata nel rifiuto della contraccezione e nell’accettazione dei “metodi naturali” per il controllo della fecondità, è il richiamo costante alla “legge naturale”. Le diverse concezioni che postulano la nozione di legge naturale presuppongono che certe cose siano giuste o sbagliate, buone o cattive, per loro propria natura; e che, di conseguenza, quelle buone siano obbliganti, mentre quelle cattive sono proibite. La moralità insita nella natura delle cose non è conosciuta per via rivelativa, bensì mediante il lume della ragione, da parte di ogni adulto normale. Da punto di vista teologico, la teoria della legge naturale riconosce nella ragione e nella natura umana una fonte di saggezza etica, in armonia con quella fornita dalla rivelazione biblica e accessibile alla fede. Secondo la formulazione scolastica, particolarmente in S. Tommaso, la legge eterna ha il fondamento nella natura di Dio e costituisce
148
il piano secondo cui la sapienza divina conduce tutte le cose verso un fine, in conformità con la propria natura. In base alle strutture ontologiche della natura umana, dotata di razionalità, la ragione è capace di giungere a principi universalmente validi e alle prescrizioni della legge naturale.
Malgrado una certa disaffezione — o addirittura un’aperta ostilità ― da parte di alcuni teologi cattolici verso la dottrina della legge naturale (vi influiscono: il declino della sintesi scolastica; il favore per un’etica a indirizzo personalistico o situazionista; la prospettiva biblico-evangelica, che sottovaluta il potere della ragione nello stabilire ciò che bene o male, e privilegia la S. Scrittura come fonte di conoscenza della volontà di Dio), il magistero della chiesa cattolica ha continuato ininterrottamente a riferirvisi, specialmente nelle questioni di bioetica. La Humanae Vitae, in particolare, riposa sul presupposto di un ordinamento intrinseco dell’atto coniugale alla procreazione, che non può essere frustrato senza contraddire alla volontà del Creatore: “Paternità responsabile comporta un più profondo rapporto all’ordine morale chiamato oggettivo, stabilito da Dio e di cui la retta coscienza è la vera interprete. L’esercizio responsabile della paternità implica dunque che i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio, verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia di valori. Nel compito di trasmettere la vita, essi non sono quindi liberi di procedere a proprio arbitrio, come se potessero determinare in modo del tutto autonomo le vie oneste da seguire, ma, il contrario, devono conformare il loro agire all’intenzione creatrice di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi atti, e manifestata dall’insegnamento costante della Chiesa” (H.V., 10). L’ordine morale oggettivo si radica, nella prospettiva cattolica, nel rispetto della natura biologica e dei dinamismi interni della sessualità umana: “In rapporto ai processi biologici, paternità responsabile significa conoscenza e rispetto delle loro funzioni: l’intelligenza scopre, nel potere di dare la vita, leggi biologiche che riguardano la persona” (ibi).
Sono così tracciati i confini entro cui si muove la morale cattolica in tema di regolazione delle nascite: rifiuto della contraccezione intesa come possibilità arbitraria di frustrare l’atto coniugale, intervenendo nel suo dinamismo o nelle sue conseguenze; rispetto della natura dell’atto stesso, lasciando però all’intelligenza umana la capacità di riconoscere e di utilizzare il naturale ritmo di fecondità e infecondità, in vista di una procreazione responsabile; opzione per i “metodi naturali” di regolazione delle nascite, senza che ne risulti privilegiato nessuno in particolare,
149
purché non violentino la naturalità biologica e siano conformi alle esigenze della dignità umana. Un motivo antropologico che rinforza tale scelta può essere individuato nel fatto che i metodi naturali favoriscono il dialogo tra i coniugi, domandano la responsabilizzazione di ambedue i partners, non presentano controindicazioni dal punto di vista igienico ed ecologico, e incrementano la conoscenza del proprio corpo da parte della donna.
7. La Boxe
Una vasta risonanza nella stampa e nell’opinione pubblica ha avuto l’intervento dell’Associazione medica mondiale, nel corso della sua XXXV assemblea tenutasi a Venezia nell’ottobre 1983, con cui i medici hanno preso posizione in merito alla boxe. Tema della giornata di studio dell’assemblea era l’etica medica. In quel contesto venne presentata una risoluzione che auspica l’interdizione della boxe e raccomanda che vengano nel frattempo assunte misure precauzionali per limitarne la nocività.
La voce che si leva da un organismo che rappresenta le organizzazioni mediche di tutto il mondo non poteva essere ignorata. Le valutazioni dell’A.M.M. hanno rinfocolato la già vivace polemica sulla boxe. Ma hanno diritto i medici a intervenire sullo sport della boxe? In nome di quale istanza la condannano e ne propongono l’abolizione? La virulenza stessa della polemica tra abolizionisti e antiabolizionisti dimostra che in merito alla boxe non esiste unanimità di consensi. La valutazione etica varia a seconda dei valori ai quali ci si riferisce. Inoltre, gli interessi personali possono insinuarsi a contaminare il giudizio etico. Per i pugili questa attività sportiva è molto appagante in senso narcisistico: venendo per lo più da ambienti sociali segnati dall’emarginazione e dalla privazione, tendono a banalizzare il rischio e i danni con i quali pagano la scalata al successo.
Per il mondo che gravita attorno alla boxe sono gli interessi economici che turbano la serenità della valutazione morale. Un diffuso quotidiano ha reso visivamente — non saprei dire se deliberatamente o no ― questo aspetto del problema della boxe. La pagina che riportava la presa di posizione del congresso medico di Venezia era divisa simmetricamente in due parti: quella superiore condannava la boxe, mentre quella
150
inferiore reclamizzava un incontro pugilistico in televisione, sponsorizzato da una marca di liquori, e invitava alla «Grande Notte della Boxe»... A livello di massa, l’accettabilità morale della boxe è confusa con l’attrazione e l’entusiasmo che essa esercita sullo spettatore, al quale fornisce la possibilità di vivere proiettivamente la propria aggressività repressa.
Sulla condanna morale della boxe non c’è un consenso sociale, che si basi su valori condivisi da tutti. È emblematica, in questo senso, la reticenza della morale cattolica. Si possono registrare, è vero, posizioni di singoli moralisti che valutano severamente la boxe in quanto sport. Così G. Perico, partendo dal presupposto che la violenza è l’anima del pugilato e che la tendenza insita nel combattimento stesso è quella di danneggiare l’avversario, giunge a una conclusione molto critica; si limita tuttavia alle «forti riserve», senza spingersi fino alla condanna. Pur disapprovando la boxe, non la considera un comportamento inequivocabilmente proibito per il cristiano, in quanto azione contrastante col comandamento di non uccidere o col supremo valore della carità. Le posizioni dei singoli moralisti mostrano una certa oscillazione, accentuata dal fatto che manca in materia una presa di posizione ufficiale del supremo magistero ecclesiastico; nell’insieme, tuttavia, la boxe non è considerata un’attività per natura sua incompatibile con lo standard morale che si richiede a un cristiano.
Si assumeranno, dunque, i medici il compito di condannare moralmente la boxe, quando la Chiesa non ha voluto farlo? Proibiranno le associazioni mediche ai loro iscritti di collaborare in quanto medici alla realizzazione di incontri pugilistici, dichiarando questa attività come incompatibile con la professione medica? Se tale incompatibilità fosse riconosciuta e compromettesse l’immagine del medico di fronte alla società, sarebbe possibile ricorrere alla proibizione per motivi deontologici. Come avviene con l’aborto e la tortura, tanto per intenderci. Di fatto, nessun codice deontologico vieta la partecipazione del medico agli incontri pugilistici. Esiste, per contro, una commissione medica della Federboxe. Anche se i poteri del medico a bordo ring sono rigorosamente limitati — non può intervenire di propria iniziativa, ma solo se chiamato dall’arbitro — in qualche maniera offre di fatto una certa copertura alle riunioni pugilistiche e la sua presenza fornisce un comodo alibi. Probabilmente è questa implicita chiamata in correo del medico che assiste agli incontri, quando muore un pugile, che ha suscitato il progetto di condanna dell’Associazione medica mondiale. La complicità, ovviamente, è solo morale,
151
senza rilevanza giuridica: la boxe è infatti — come è stato notato — l’unico sport in cui, se qualcuno rimane ucciso, a chi è responsabile di questa morte non arriva comunicazione giudiziaria.
Se dunque i medici non prendono posizione contro la boxe in nome di una valutazione etica con cui la giudicano immorale, né elevano contro di essa una barriera di norme deontologiche, che valore rimane alla dichiarazione della massima assemblea mondiale? Il medico, oltre che alla legislazione e ai principi della morale a cui personalmente aderisce, ispira il suo comportamento professionale a un «ethos» caratteristico. Senza diventare una «super-morale», che faccia cadere giudizi da una cattedra etica più alta di quella della religione e della filosofia, l’ethos medico ha trovato nel riferimento costante alla promozione della vita un’ispirazione che ha guidato i comportamenti professionali, talvolta distaccandosi dalla comune sensibilità morale dell’epoca.
Lasciandosi guidare dal principio della promozione della vita, che fa corpo con il senso della professione medica stessa, il medico può trovarsi schierato su posizioni che magari non hanno il supporto della sensibilità comune, e forse neppure quello di un’argomentazione di filosofia morale stringente. Tale sembra essere il caso della boxe. Il preambolo della dichiarazione di Venezia è sintomatico. Senza menzionare come referenti principi filosofici o religiosi, si richiama al dato di fatto incontrovertibile che la boxe è uno sport pericoloso per la vita e l’incolumità fisica: «contrariamente agli altri sport, lo scopo fondamentale della boxe è quello di infliggere un danno corporale all’avversario. La boxe può provocare la morte e avere una pericolosa incidenza sulle lesioni cerebrali croniche». Tanto basta al medico per sentire e dichiarare l’inconciliabilità della pratica della boxe con quello che è lo scopo che persegue con la sua professione, e quindi la sua inaccettabilità dal punto di vista medico.
Ci vorrà certamente del tempo prima che questa sensibilità compenetri la sensibilità comune: ancor più tempo perché, smantellati gli interessi economici colossali che girano attorno alla boxe, si possa eventualmente arrivare a misure politiche di abolizione o radicale modifica. I medici avranno fatto, nel frattempo, qualcosa di più che una solenne dichiarazione per sgravio di coscienza: avranno portato un contributo, attingendo dall’eredità del proprio ethos professionale più tradizionale, a far maturare le coscienze su un aspetto particolare della difesa della vita.
152
8. La morte inflitta
Due modalità particolari della fine della vita meritano una considerazione a sé: la morte inflitta dall’autorità giudiziaria e la morte che il suicida infligge a se stesso. La loro rilevanza per la professione medica è solo indiretta; tuttavia portano un sostanziale completamento al quadro dei diritti dell’uomo concernenti la vita fisica e alla dottrina morale cattolica relativa alla tutela della vita. Esaminiamo i due problemi separatamente.
La pena di morte
A livello di insegnamento ufficiale della chiesa non è mai stata messa in discussione la legittimità della pena di morte inferta dall’autorità pubblica. Benché la dottrina non possa beneficiare di una positiva validazione fondata sull’autorità della Bibbia (i testi dell’Antico Testamento che prevedono la pena di morte per alcuni tipi di reato dipendono in queste normative dal comportamento sociale dalla cultura del tempo; nel Nuovo Testamento, poi, non abbiamo nessun riferimento specifico alla pena di morte), la tradizione cristiana ha costantemente accettato il principio della pena di morte, nel caso in cui sia considerata necessaria per il bene comune. L’argomento del “bene comune” è presente già nelle summe teologiche medievali. Tommaso d’Aquino, ad esempio, sostiene: “Si aliquis homo sit periculosus communitati et corruptivus ipsius propter aliquod peccatum, laudabiliter et salubriter occiditur, ut bonum commune conservetur... hominem peccatorem occidere potest esse bonum, sicut occidere bestiam: peior enium est malus homo bestia, et plus nocet” (S. Th., II-II, 64, 2). Il “potere della spada” teorizzato dalla concezione teologico-giuridica della cristianità medievale prevedeva esplicitamente la pena di morte, che doveva però essere inflitta dal “braccio secolare”. Esiste una prescrizione risalente all’anno 1210, motivata dalla contestazione di questo punto della dottrina cattolica da parte dei Valdesi, che obbliga i Valdesi che vogliono convertirsi ad ammettere il diritto del potere secolare di comminare la pena di morte.
Il pensiero cristiano ha fatto lungamente resistenza al movimento di opinione illuministico che avrebbe portato, in breve volger di tempo, a sopprimere la tortura e a limitare l’applicazione della pena di morte. Lo prova, tra l’altro, la condanna all’indice del libro di Cesare Beccaria,
153
Dei delitti e delle pene, nel 1776, due anni dopo la pubblicazione. Là dove Beccaria confutava la pretesa di considerare la pena di morte un “diritto”, cioè qualcosa che potesse aver a che fare con la legge, la chiesa vedeva una minaccia al potere dello stato.
A livello di magistero ufficiale, nessuna diretta revisione di tale insegnamento è avvenuta negli ultimi tempi. Allusioni ad esso, in obliquo, si ritrovano nei documenti pontifici che condannano l’aborto specificando sempre che la sua malizia dipende dal fatto che con l’aborto viene ucciso “un innocente”. Nell’enciclica Casti connubii (1930) si afferma che il diritto di uccidere un feto non può spettare neppure all’autorità pubblica; il diritto all’esecuzione capitale (jus gladii), infatti, può essere esercitato solo contro i colpevoli (in solos reos).
La teologia morale cattolica ha fatto per lo più eco alle posizioni della dottrina ufficiale. I moralisti accettano, in astratto, il principio della liceità della pena di morte; in concreto, considerano di buon grado il fatto che la pena capitale sia praticamente scomparsa in quasi tutti i paesi, come un addolcimento dei costumi sotto il segno dell'umanitarismo.
Per completezza vanno però registrate alcune voci isolate tra i teologi, che auspicano che la dottrina ufficiale della chiesa si evolva, fino a prendere esplicitamente posizione contro la pena di morte. Come tutti gli oppositori della pena di morte, questi esponenti del pensiero cattolico considerano non probanti gli argomenti con cui se ne prospetta l’utilità sociale. A loro avviso, alla pena capitale non può essere riconosciuto né un valore esemplare, né retributivo (nel senso della vindicatio, cioè del ripristino dell’ordine violato), né difensivo per l’ordine sociale, né tanto meno correttivo o “medicinale” nei confronti del reo. Ma soprattutto l’avversano perché la considerano contraria allo spirito dell’insegnamento di Gesù. Nello spirito del Regno di Dio, quando l’ordine è violato non si restaura facendo cadere il rigore del giudizio sul reo, ma moltiplicando il bene. L’atteggiamento di Gesù nei confronti dell’adultera (cfr. Giov. 8, 1-11), condannata alla lapidazione dalla legge, ma salvata dal messia affinché impari a vivere secondo l’amore, è la fonte del “diritto evangelico” per le creature nuove del Regno. Annunciando questa possibilità la chiesa si distanzia dalla logica degli ordinamenti giuridici con cui viene regolata la convivenza civile. La sua prospettiva è quella della profezia, in dipendenza da quella vita nuova di cui Gesù è il profeta.
La possibilità di un’evoluzione della dottrina della chiesa, nel senso di riconoscere l’inconciliabilità tra l’accettazione della pena di morte e
154
lo spirito del Vangelo, deriva dal principio teologico stabilito dal Vaticano II, secondo cui la comprensione della rivelazione cresce con “l’esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali” (Dei Verbum, 8). La comprensione che i cristiani hanno oggi della persona e dell’insegnamento di Gesù — soprattutto del suo messaggio di non violenza —, nonché la testimonianza vissuta di molti suoi discepoli, potrebbero portare a rinnovare una dottrina ecclesiastica tradizionale, nel senso di una evoluzione nella continuità. Nel frattempo ambedue le opinioni ― tanto quella di coloro che considerano la pena di morte armonizzabile con lo spirito cristiano, tanto quella di coloro che lo escludono — rimangono moralmente probabili.
Il suicidio
Anche il suicidio è una morte inflitta: non è il potere giudiziario che la decide e l’eseguisce, ma il vivente stesso che la commina a se stesso. Alcuni fattori hanno contribuito a dargli un rilievo di attualità, tanto agli occhi degli studiosi del comportamento umano, quanto a quelli dei moralisti cristiani. L’analisi del comportamento suicidiario con gli strumenti analitici offerti dalla psicologia e dalla sociologia ha sconvolto gli approcci esclusivamente filosofico-etici, facendo emergere dimensioni di questo comportamento che sfuggivano alle valutazioni aprioristiche. In particolare, la possibilità di prendere una decisione “razionale” di commettere il suicidio è tutt’ora oggetto di animato dibattito. Un altro importante motivo di attualità va ricercato nelle trasformazioni culturali relative al morire, a seguito delle quali il por fine deliberatamente alla propria vita, come mezzo estremo per sottrarsi a trattamenti medici disumanizzanti, ha acquisito una nuova legittimazione nell'opinione pubblica. Rinviando al capitolo sull’eutanasia la trattazione dei limiti da riconoscere al diritto del paziente di rifiutare il trattamento, ci limitiamo qui a considerare unicamente i casi in cui positivamente e deliberatamente il paziente terminale ricorre al suicidio per affrettare la conclusione del suo processo vitale.
Il pensiero dell’etica cristiana sul suicidio va differenziato, a seconda che si consideri il principio astratto o l’aspetto esistenziale-concreto delle persone che prendono tale decisione. Dal punto di vista formale, il suicidio è sempre proibito. Questo è il messaggio che la costante lettura esegetica
155
ha tratto dalle fonti che trasmettono la rivelazione ebraico-cristiana. La Bibbia contiene il racconto di alcuni suicidi commessi da personaggi della storia santa, talvolta senza una particolare enfasi di condanna morale (Saul e il suo scudiero si trafiggono con la propria spada per non cadere in mano ai nemici: 1 Sam. 31, 3-5; Ahitofel si impicca dopo il fallimento del suo intrigo politico: 2 Sam. 17, 23; Sansone fa crollare il tempio addosso a sé e ai Filistei: Giud. 16, 23-31; il sacerdote Razis viene addirittura lodato, perché “scelse generosamente di morire piuttosto che cadere in mani criminali e subire oltraggi indegni della sua nascita”: 2 Macc. 15,42). Tuttavia la tradizione ebraico-cristiana è unanime nel ritenere che il suicidio è contro la volontà di Dio. Ci si riferisce, sia alla volontà positiva espressa dal comandamento “non uccidere” (Es. 20,23) o dalla punizione per chi versa il sangue umano (cfr. Gen. 9, 5-6: nell’uno come nell’altro caso, la proibizione di attentare alla propria vita è vista come inclusa nella proibizione generale, che non è accompagnata da specificazioni), sia alla volontà di Dio implicita nel fatto stesso della vita. La vita è concepita teologicamente come un dono; il “comandamento” di vivere — cioè, di volere la vita — è contenuto nel fatto stesso di essere stato posto in vita. La sovranità di Dio sulla vita del singolo fonda in tutta la tradizione religiosa monoteistica la proibizione del suicidio. Nei termini della morale dell’alleanza, caratteristica della rivelazione ebraico-cristiana, il suicidio sottrae unilateralmente, per iniziativa umana, un partner al dialogo della salvezza.
A queste argomentazioni di natura religiosa, accessibili solo a chi si muove nell’universo della fede, vanno aggiunte quelle di tipo tradizionale, elaborate sia dai teologi che dai filosofi dell'Occidente. In tale prospettiva il suicidio è proibito dagli obblighi che l’individuo ha verso gli altri e la comunità: è l’argomentazione che Tommaso d’Aquino mutua da Aristotele: ogni essere umano è parte di un gruppo sociale; uccidendo se stesso, l’individuo priva la communitas delle proprie risorse e offende gli altri membri del gruppo (cfr. S. Th. II-II, 64, 5). Il suicidio è dunque ingiusto in quanto viene ad essere una “iniuria communitati”.
Un altro argomento che si ritrova nelle discussioni sulla moralità del suicidio è la sua condanna in nome degli obblighi verso se stesso. Nella medesima trattazione S. Tommaso si appella anche al fatto che la vita è un bene naturale, che la persona ha un istinto naturale per la vita, e che perciò abbiamo l’obbligo di preservare la nostra vita. La proibizione del suicidio viene così radicata nella “legge naturale”.
156
Nelle formulazioni dottrinali più recenti il suicidio è condannato in quanto azione “contro la vita”. Così nella Gaudium et spes del Vaticano II il suicidio volontario è elencato insieme agli altri comportamenti contro la vita; nel loro insieme sono valutati come “vergognosi”; di essi il documento conciliare afferma che “mentre guastano la civiltà umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano, che quelli che li subiscono; e ledono grandemente l’onore del Creatore” (n. 27). Gli obblighi verso se stessi, verso gli altri membri della comunità e verso la sovranità di Dio, che rendono immorale il suicidio, vengono così fusi in una visione unitaria.
Quando dal livello astratto o dei principi si passa alla considerazione del suicidio nella sua fattualità concreta, ci si imbatte nella valutazione del carattere morale delle persone che commettono il suicidio. Mettere fine alla propria vita può essere — nelle circostanze in cui può venirsi a trovare una persona — un atto umano, o addirittura lodevole? La tradizione occidentale, sia quella religione che quella filosofica, ha condannato i suicidi, valutando il loro atto come non riscattabile da alcun motivo nobile. Anche il suicidio per la tutela di valori superiori — come quello di alcune donne che, secondo i racconti agiografici, si sono date volontariamente la morte per evitare un’offesa alla loro virtù — non ha riscosso l’approvazione di tutti gli autorevoli scrittori cristiani dell’antichità. Alcuni hanno inneggiato alla loro virtù eroica; altri, come S. Agostino, le hanno presentate come modelli da non imitare. Le disposizioni ecclesiastiche che privavano i suicidi di riti e onori funebri normalmente attribuiti ai defunti avevano un intento pedagogico, volendo inculcare la riprovazione morale del suicidio.
Oggi la conoscenza delle radici socio-psicologiche del suicidio ha attutito la durezza del comportamento verso i suicidi; anche la valutazione morale di fondo in alcuni casi è soggetta a ripensamento. La sensibilità contemporanea è particolarmente provocata da alcune forme di suicidio che rappresentano una rinuncia alla vita per motivi idealisti-altruistici, fino quasi a configurare una specie di “suicidio d’amore”. Particolarmente apprezzato è il comportamento di chi fa del proprio sacrificio della vita un’arma di lotta politica, nel senso della liberazione degli oppressi. In tale chiave vanno letti gesti dimostrativi clamorosi, come il suicidio di Jan Palach in Cecoslovacchia, dei bonzi in Vietnam o dei prigionieri politici in Irlanda, mediante lo sciopero della fame a oltranza. I criteri morali con cui valutare questi suicidi sono quelli che trovano applicazione
157
nella lotta violenta: perché di questa si tratta, anche se la violenza è rivolta verso se stessi, piuttosto che verso gli altri.
Un capitolo aperto di particolare attualità è quello relativo all’obbligo di prevenire il suicidio. Si dibatte se esista il dovere morale si salvare la vita di un altro essere umano contro la sua volontà. In questi casi entrano in conflitto due specie di obblighi: quello di difendere la vita e quello di rispettare la libertà; mentre il primo giustifica l’intervento, il secondo richiede la non interferenza (nel caso che sia moralmente certo che la decisione suicidiaria sia presa in effettiva libertà, non sotto costrizione). Solo poche voci isolate propongono la libertà di commettere il suicidio come condizione per salvaguardare la dignità umana. In genere l’Occidente ha dato la preferenza al primo obbligo: in passato mediante le argomentazioni religiose che abbiamo prima passato in rassegna; oggi prevalentemente con motivazioni secolari, ivi compreso il principio giuridico secondo cui il diritto alla vita va inteso come un diritto “assolutamente indisponibile”, tutelato dallo Stato anche contro la volontà dell’individuo.
Con particolare mitezza si tende oggi a valutare i tentativi di suicidio di persone che intendono sfuggire ai dolori intollerabili e ai trattamenti disumani in certe condizioni di malattie terminali. In tutti questi casi non sussiste, dal punto di vista della morale cristiana, alcun valido motivo per riformulare il giudizio da portare sull’illeceità di ogni attentato contro la propria vita. La funzione che può avere nel contesto attuale tale riaffermazione cristiana è quella di portare a riflettere, in termini positivi, sul significato profondo dei gesti suicidiari. Essi possono essere letti come una disperata invocazione perché si presti attenzione alle persone in stato di sofferenza estrema, si offra aiuto, si condivida solidarmente. La prevenzione del suicidio in termini cristiani non ri riduce a misure costrittive (come l’alimentazione forzata o il controllo istituzionale). Si estende piuttosto alla modifica di quelle forme più generali di malessere, le cui radici vanno fatte risalire all’organizzazione della convivenza sociale, che possono condurre a giudicare la propria vita come invivibile.
158
9. L'eutanasia
La chiesa e il diritto a morire umanamente
Tra le numerose singolarità che ha assunto il morire oggi, acquista un particolare rilievo l’impegno della chiesa per assicurare il diritto a una morte “umana”. Per la sua propria natura e funzione, infatti, la chiesa sembra chiamata a un altro compito: quello di adoperarsi per rendere possibile una morte “religiosa” ai credenti. Di fatto, per lungo tempo, è stato così. L’azione dei ministri della chiesa e dei religiosi aveva come principale connotazione la funzione pastorale, in armonia con una visione antropologica soprannaturale, che vede l’uomo come destinato alla vita eterna e attribuisce al momento della morte un valore incomparabile. La morte fissa infatti per sempre la sorte spirituale dell’uomo: questo il motivo del particolare interesse, tanto dottrinale che pratico, che la chiesa ha sempre avuto per la morte. La preparazione alla morte ha costituito, fino a un’epoca molto recente, un cardine della predicazione e della devozione privata. Il cristiano viveva per morire, e moriva per la vita eterna. Il sacerdote era lo specialista della morte, in quanto cerniera tra la vita terrena nel corpo e “l’altra vita”. L’ars moriendi, come genere letterario, ha goduto un’estrema diffusione e popolarità dalla fine del Medioevo fino all’epoca moderna inoltrata. La “buona morte” che il credente si augurava e che i ministri della chiesa intendevano facilitare, era la morte “cristiana”. In armonia con la morte di Gesù, essa era vissuta nella prospettiva del Regno di Dio (del paradiso), come momento di suprema unione con Dio, in un atteggiamento penitenziale, nonché nell’abbandono filiale alla volontà del Padre (cfr. Mt. 26, 42; Lc. 23, 46).
Senza rinnegare questa prospettiva, oggi vediamo però piuttosto la presenza della chiesa su un fronte nuovo: quello della difesa e della promozione della qualità “umana” della morte. Ciò presuppone un giudizio antropologico-etico che qualifica le modalità culturali che ha assunto oggi la morte come “disumane”. Il giudizio di valore non è riferito solo alle distorsioni che subisce l’essere umano, nella sua natura e nel suo destino, quando è amputato di ogni riferimento alla trascendenza e allo spirito. Anche in un orizzonte laico e immanentistico il morire è diventato disumano, cioè violento e deformato; risulta “innaturale” anche se lo si valuta col metro di un’antropologia non religiosa. L’ampliamento delle possibilità
159
terapeutiche, grazie all’uso sistematico della tecnologia da parte della medicina moderna, non è senza ambivalenza. In regime di medicalizzazione intensiva, si è modificata la durata della morte. I progressi della medicina continuano ad allungare il processo del morire. Al limite, esso tende a dipendere dalla volontà del medico, che deve decidere se mettere in atto, tenere in funzione o arrestare le complesse apparecchiature della rianimazione artificiale. Il morente non è più che un povero oggetto privo di volontà, e spesso di coscienza. Il personale ospedaliero può prevedere l’ora della morte, ma la regola a cui si attiene è quella della dissimulazione. La conoscenza completa e condivisa della propria sorte da parte del malato grave è un caso eccezionale. I segni della morte sfuggono al malato; i medici e le infermiere, che sono in grado di interpretarli, preferiscono nasconderglieli. Il morente non ha più uno “status” sociale. L’assistenza tecnologica prolunga l’esistenza dei malati, ma non li aiuta a morire.
Gli interrogativi etici e antropologici che si affastellano sulla fase terminale della vita sono stati così riassunti in una dichiarazione della conferenza episcopale tedesca: “Quando deve essere combattuta ed evitata la morte, anche a un prezzo elevato? Quando è nostro compito di familiarizzarci con essa, di confrontarci con essa e di accettarla? Quali conseguenze ha tale discussione per una morte degna dell’uomo e per l’assistenza ai morenti? Tali domande si modificano alla luce della fede cristiana? Che senso conserva ai nostri giorni “l’arte del morire” della tradizione cristiana, quella che chiamavamo l'ars moriendi?.” (Morte degna dell’uomo e morte cristiana, 1978).
Le questioni tradizionalmente considerate dalla morale medica relativamente alla fine della vita sono acuite dalla situazione medico-culturale attuale. Il compito della chiesa è quello di riaffermare i principi acquisiti, destinati a guidare l’azione in momenti comprensibilmente carichi di pathos e quindi facilmente esposti alle prevaricazioni dell’emotività. Il “no” inequivocabile all’eutanasia è il pilone portante della tradizionale difesa della vita terminale da parte della morale cattolica. La condizione attuale del morente domanda di procedere oltre, estendendo l’attenzione alle nuove articolazioni che assume la minaccia alla qualità umana della morte. In questo senso va intesa la presenza della chiesa sul fronte umanistico di un “diritto alla morte”.
160
Il rifiuto dell'eutanasia attiva
Per eutanasia attiva — o positiva — si intende l’azione con cui, di propria iniziativa o su richiesta dell’interessato, si pone fine a una vita umana. Storicamente il termine godette di una sinistra popolarità quando fu formulato come punto programmatico del progetto sanitario nazista di eliminare le “vite senza valore” (lebensunwerte Leben ). Oggi ricorre nel contesto delle modificazioni che ha assunto il morire per i progressi della medicina. Le deformazioni del processo naturale hanno portato alcuni a parlare di “distanasia”, per contrapporvi l’“eutanasia” come programma correttivo. Secondo la recente Dichiarazione della S. Congregazione per la dottrina della fede in merito all’eutanasia (5.10.1980), “nella società moderna, nella quale non di rado sono posti in causa gli stessi valori fondamentali della vita umana, la modificazione della cultura influisce sul modo di considerare la sofferenza e la morte; la medicina ha accresciuto la sua capacità di guarire e di prolungare la vita in determinate condizioni, che talvolta sollevano alcuni problemi di carattere morale. Di conseguenza, gli uomini che vivono in un tale clima si interrogano con angoscia sul significato dall’estrema vecchiaia e della morte, chiedendosi conseguentemente se abbiano il diritto di procurare a se stessi o ai loro simili ‘la morte dolce’, che abbrevierebbe il dolore e sarebbe, ai loro occhi, più conforme alla dignità umana”.
Dopo aver specificato che per eutanasia si intende, in senso stretto, “un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore”, l’autorevole documento ripete la condanna, in linea con la costante tradizione della morale cattolica, di interventi di tale natura. “Niente e nessuno può autorizzare l’uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimarlo, imporlo, né permetterlo. Si tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di un’offesa alla dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l’umanità. Il documento prosegue precisando che ragioni di ordine affettivo ― come il dolore prolungato e insopportabile — possono indurre qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri. In tali casi la responsabilità personale può essere diminuita o perfino
161
non sussistere; tuttavia l’errore di giudizio della coscienza — fosse pure in buona fede — non modifica la natura dell’atto omicida, che in sé rimane inammissibile per la morale cattolica. Anche se ci a deve astenere dal giudicare coloro che, in casi limite, siano stati indotti dalla compassione a porre fine a una vita ritenuta intollerabilmente penosa, l’annuncio della chiesa rimane immutato.
Per questo motivo la chiesa è ostile a ogni tentativo di legittimare l’eutanasia mediante un testo di legge o dichiarazioni etiche provenienti da alte personalità. In un documento dei vescovi francesi viene messo in evidenza che dietro la domanda di eutanasia proveniente dal malato c’è sempre una richiesta angosciata di aiuto e di affetto, un bisogno di calore umano e soprannaturale. Il documento prosegue: “l'alleviate il mio dolore e ascoltatemi” del malato è una domanda difficile da soddisfare. È più facile lasciare il malato alla sua solitudine e lasciarlo soffrire finché le sue sofferenze diventino intollerabili, intollerabili a lui e a quelli che lo circondano, e allora mettere fine alla sua vita. Una società che legittimasse l’eutanasia sarebbe senza dubbio una società che cerca di sfuggire a uno dei suoi doveri più elementari: quello della fraternità umana, con i più poveri tra i suoi membri. Per dei credenti l’accettazione dell’eutanasia significherebbe senza dubbio la paura di vivere questo mistero della presenza umana al morente, simbolo della Presenza stessa di Dio” (Problemi etici posti oggi dalla morte e dal morire, 1976).
La lotta contro il dolore
La compassione che induce alcuni a spingersi fino ad acconsentire alla morte di un altro essere umano, è provocata per lo più dalla visione delle sofferenze che accompagnano certe malattie allo stadio terminale. Quando la morale cattolica ha stabilito come punto invalicabile l’intangibilità della vita umana, non ha esaurito il suo compito. Per rendere possibile una morte “umana”, bisogna che il dolore sia contenuto entro limiti sopportabili. La resistenza al dolore è una variabile culturale, oltre che individuale. Dipende dal livello di motivazione, dal significato che si attribuisce al dolore, nonché dall’atteggiamento sociale. Ora, è difficilmente contestabile che la civilizzazione tecnologica occidentale ha creato un clima in cui l’attribuzione di un senso al dolore è resa più ardua. Di conseguenza, la soglia psicologica di tolleranza del dolore si abbassa.
162
Se guardiamo la situazione come si presenta dal punto di vista medico-sanitario, non notiamo un interesse a lenire le sofferenze del malato equiparabile a quello rivolto al prolungamento della vita. Mentre il rifiuto dell’eutanasia è un punto qualificante della deontologia medica fin dal giuramento di Ippocrate, l’impegno medico sul piano della lotta alla sofferenza è rimasto in qualche modo marginale nei progressi della medicina. Come osserva il documento dei vescovi francesi, “il problema dell’attenuazione delle sofferenze del malato, in realtà, è molto complesso e non basta, per risolverlo, una larga somministrazione di analgesici. La sofferenza umana non è, infatti, un puro fenomeno fisiologico: essa è nutrita dall’apprensione di vedere crescere il dolore e dall’angoscia di colui che si sente gravemente minacciato nel suo corpo. È per questo che per alleviare la sofferenza è richiesto di saper maneggiare i trattamenti (medicazioni che vanno dall’aspirina alla morfina, interventi chirurgici, irradiazioni...), ma anche di calmare l’ansietà o l’angoscia del malato. Ciò implica una relazione personale con lui. Ora, la relazione col malato grave è angosciante per il personale curante, tanto più se la morte è prossima o la sofferenza ribelle ai trattamenti” (Problemi etici posti oggi dalla morte e dal morire).
Per quanto riguarda il trattamento del dolore, i punti essenziali della dottrina morale cattolica comprendono: liceità ma non obbligatorietà del ricorso ai mezzi atti a lenire il dolore; liceità del ricorso ad analgesici che portano anche alla perdita della coscienza, purché questo mezzo sia giustificato da un intento terapeutico; accettazione di trattamenti antalgici che hanno come effetto secondario quello di abbreviare la vita, purché motivi veramente gravi lo giustifichino. Quanto al primo punto, la dottrina cristiana valorizza il dolore, soprattutto quello degli ultimi momenti della vita, attribuendogli un denso significato antropologico e salvifico. Senza tuttavia farne un idolo, perché non è il dolore in sé che purifica e salva, ma solo la grazia che produce l’amore. Spesso è stata indebitamente attribuita al cristianesimo la coltivazione malsana del dolore. Il “dolorismo” può essersi appoggiato al cristianesimo, ma non ne è un suo figlio legittimo. Sarebbe soprattutto illegittimo motivare con argomentazioni religiose l’eventuale dimissione del personale sanitario di fronte al compito di contenere il dolore e addolcire la fine dei pazienti. La posizione cristiana è quella di un giusto equilibrio tra il feticismo del dolore, che lo fa considerare come il valore supremo, e la fobia di esso, che lo identifica con il non-valore assoluto. Se è vero che il dolore costringe
163
l’uomo a porsi nuovamente le questioni fondamentali del proprio destino, della propria posizione nei confronti di Dio e degli altri uomini, della propria responsabilità individuale e collettiva, del senso del proprio pellegrinaggio terreno (cfr. Pio XII, Ai partecipanti al Symposium sulle malattie delle coronarie, 9.5.1956), d’altra parte è anche possibile costatare che il dolore aggrava lo stato di debolezza e di esaurimento fisico, ostacola lo slancio dell’anima, logora le forze morali e può fornire l’occasione di nuove colpe (cfr. Pio XII, Ai partecipanti al IX Congresso della Società Italiana di Anestesiologia, 24.2.1957). Il principio a cui si ispira la morale cattolica suona, nella formulazione di Pio XII: “Il paziente desideroso di evitare o di calmare il dolore può, senza inquietudine di coscienza, avvalersi dei mezzi trovati dalla scienza”. Dal punto di vista pratico, vanno tenuti presenti le indicazioni del documento della S. Congregazione per la dottrina della fede: “Non deve meravigliare se alcuni cristiani desiderano moderare l’uso degli analgesici, per accettare volontariamente almeno una parte delle loro sofferenze e associarsi così in maniera cosciente alle sofferenze di Cristo crocifisso (cfr. Mt. 27,34). Non sarebbe tuttavia prudente imporre come norma generale un determinato comportamento eroico. Al contrario, la prudenza umana e cristiana suggerisce per la maggior parte degli ammalati l’uso dei medicinali che siano atti a lenire o a sopprimere il dolore, anche se ne possono derivare come effetti secondari torpore o minore lucidità. Quanto a coloro che non sono in grado di esprimersi, si potrà ragionevolmente presumere che desiderino prendere tali calmanti e somministrarli loro secondo i consigli del medico”. (Dichiarazione della S. Congregazione per la dottrina della fede: Eutanasia 5.5.1980).
L’uso intensivo degli analgesici pone dei problemi morali che sono già stati affrontati da Pio XII nel discorso del 24.2.1957, che costituisce una esaustiva trattazione dei quesiti religiosi e morali concernenti l’analgesia. Un primo problema è la liceità, dal punto di vista della morale cristiana, dei trattamenti che conducono alla privazione totale o parziale della coscienza di sé. Per quanto riguarda la soppressione o diminuzione della coscienza e dell’uso delle facoltà superiori, Pio XII applica gli stessi principi che regolano la soppressione del dolore. La narcosi risulta così “permessa dalla morale naturale e compatibile con lo spirito del Vangelo” quando è volta a un fine terapeutico: “preservare l’equilibrio psichico e organico, evitare il suo violento sconquasso, costituisce per il chirurgo e per il paziente un importante obiettivo, che la narcosi soltanto permette di ottenere”.
164
Un caso particolare è costituito dall’uso degli analgesici presso coloro che sono afflitti da malattie incurabili, quando l’attenuazione dell’intollerabile dolore probabilmente si effettuerà a spese della durata della vita, che ne viene raccorciata. Nell’insegnamento morale di Pio XII, “se tra la narcosi e l’abbreviamento della vita non esiste alcun nesso causale diretto, posto per volontà degli interessati o per la natura delle cose (il caso sarebbe, se la soppressione del dolore non potesse essere ottenuta che con l’abbreviazione della vita); e se al contrario la somministrazione dei narcotici cagiona per se stessa due effetti distinti, da un lato l’alleviamento dei dolori, dall’altro l’abbreviamento della vita, è lecita; bisogna ancora vedere se vi è tra i due effetti proporzione ragionevole, e se i vantaggi dell’uno compensano gli inconvenienti dell’altro”. Entro questi limiti, e se, nelle date circostanze, ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri religiosi e morali, la soppressione della coscienza per mezzo dei narcotici è permessa dalla morale cristiana al medico e al paziente: “l’ideale dell’eroismo cristiano non impone, almeno in modo generale, il rifiuto di una narcosi d’altronde giustificata, sia pure all'avvicinarsi della morte: tutto dipende dalla circostanze concrete. La risoluzione più perfetta e più eroica può trovarsi tanto nell’accettazione che nel rifiuto” (Pio XII, ibi). L’intera questione è ripresa ed esposta più incisivamente dallo stesso Pontefice in un’allocuzione del 9.9.1958: “Se il moribondo acconsente, è permesso utilizzare con moderazione narcotici che ne allevieranno le sofferenze, ma porteranno anche a una morte più rapida; in tal caso, però, la morte non è direttamente voluta, ma è inevitabile, e motivi proporzionati autorizzano misure che ne affrettano la venuta”.
Il documento dei vescovi francesi aggiunge, dopo il richiamo della posizione morale tradizionale, delle considerazioni relative alla pratica cosiddetta di “deconnessione”, vale a dire l’uso di droghe che precipitano totalmente nell’incoscienza. Tali interventi sono qualcosa di intermedio tra il trattamento analgesico del dolore e l’eutanasia: viene provocata non la morte fisica, in quanto arresto delle funzioni organiche, ma una parte di essa, cioè lo spegnimento della coscienza. “Tali pratiche sono, in realtà, la confessione di un fallimento: significano che il personale curante non è riuscito ad alleviare il malato da sofferenze e angosce intollerabili per lui. Parlare di tali pratiche richiede molta prudenza: da una parte, perché la questione è delicata; dall’altra per non aumentare senza valida ragione il malessere e il senso di colpevolezza dei sanitari che le usano: è molto angosciante per essi rinnovare giorno dopo giorno fino alla morte
165
le perfusioni che mantengono il malato nell’incoscienza. A parer nostro, oggi queste pratiche non dovrebbero essere né legittimate, né condannate. Non legittimate, perché le ricerche intraprese in alcuni centri mostrano che dovrebbe essere possibile alleviare la sofferenza del malato senza giungere a tali decisioni. E neppure condannate, perché oggi, considerata la mancanza di formazione del personale curante e l’organizzazione attuale dei centri ospedalieri, la deconnessione resta senza dubbio in certi casi la soluzione meno disumana” (Problemi etici posti oggi dalla morte e dal morire).
La verità al morente
Gli atteggiamenti nei confronti del malato terminale si agglutinano intorno a due modelli prevalenti: quello che tende a nascondergli la prognosi e la realtà della fine imminente, e quello invece che favorisce l’esplicita informazione del paziente. Mentre il primo modello è diventato caratteristico del personale sanitario, il secondo è promosso da quanti considerano il bene del malato in una prospettiva più ampia del solo prolungamento della vita fisica. Tradizionalmente l’opzione per la franca comunicazione della verità è stata rappresentata dai ministri della religione. Oggi anche dal campo delle scienze dell’uomo si alzano vive perorazioni a favore di un rapporto comunicativo col morente. Numerose ricerche empiriche, condotte da sociologi, antropologi culturali e psichiatri, hanno dimostrato infatti gli effetti psicologici negativi del silenzio e dissimulazione sistematici nei confronti dei malati terminali. Per promuovere una migliore igiene mentale le scienze del comportamento si sono accinte a elaborare programmi di formazione del personale sanitario, sulla base delle conoscenze che si vanno acquisendo del processo psicologico del morire, al fine di provvedere un’assistenza totale al malato, anche quando non sussistono più speranze di vita.
Quest’opera può essere vista, dal punto di vista cristiano, come un indispensabile complemento dell’assistenza spirituale, che è compito della pastorale. La morale cristiana opta per la consapevolezza, e quindi per la comunicazione interpersonale che la rende possibile. Coerentemente alla sua visione antropologica, il cristianesimo considera la morte come il momento di massima realizzazione della libertà e della responsabilità umana; riconosce perciò al morente il diritto di conoscere la verità sul proprio
166
stato, nella misura in cui voglia effettivamente conoscerla. Il problema della “verità” al malato grave non equivale però a quello di un partito preso aprioristico per una brutale comunicazione che “non c’è più niente da fare”. La veracità non esaurisce le esigenze della verità, in senso cristiano. Queste comprendono in primo luogo l’amore, e quindi anche il rispetto dell’altro. La verità “umana” può domandare la gradualità, ed emerge solo all’interno di un dialogo. “Il problema fondamentale, quando la malattia prende fatalmente la via della morte, sta nella verità da dire al morente. Al riguardo, dire la verità non vuol dire fare delle dichiarazioni senza tatto e intempestive sullo stato del malato. Non consiste neppure nella diagnosi o nella prognosi circa il momento preciso della morte. Si tratta qui della capacità di colui che assiste di stabilire col paziente una relazione tale che questi sia in grado di chiedere informazioni sulle sue condizioni e di trarre le opportune conseguenze” (Conferenza episcopale tedesca: Morte degna dell’uomo e morte cristiana).
Il servizio ai morenti che svolge chi si ispira alla fede cristiana si radica in un clima di speranza: una speranza che va oltre la conclusione della vita terrena, nel legame di solidarietà reso possibile dall’amore fraterno.
10. L’assistenza ai morenti
La caduta di un tabù
La morte è diventata loquace. La novità non riguarda il discorso sulla morte che fanno la filosofia, la teologia e la letteratura. Da sempre infatti questi campi della riflessione antropologica hanno privilegiato la morte come luogo specificamente umano. Negli sviluppi più recenti di queste discipline si nota, anzi, una tendenza più accentuata per la vertigine dell’alto mare: il discorso si estremizza 107. Sarebbe del tutto fuori
167
posto sollevare contro questa preferenza a comprendere l’uomo partendo dalla sua morte l’accusa di «tanatolatria»? Checché ne sia, non è la morte libresca quella che ora ci sorprende con un’improvvisa loquacità. È piuttosto la morte reale, quella che si presenta dietro la maschera funeraria del morente in sala di rianimazione, irto di aghi, di sonde, di fleboclisi. I protagonisti di questo discorso nuovo sono i cultori delle scienze dell’uomo: antropologi, storici della cultura, sociologi, psicologi. La morte di cui parlano è quella che incontriamo nella nostra vita quotidiana. O piuttosto, quella che non incontriamo più. Perché la caratteristica di questa morte è di essere scomparsa dall’orizzonte della nostra esperienza.
Le vicende del discorso sulla morte nella nostra cultura hanno degli aspetti paradossali. Uno è proprio il fatto che la grande proliferazione attuale di opere scientifiche sulla morte sia cominciata come protesta contro una specie di congiura del silenzio, come denuncia di un tabù che aveva praticamente finito con l’allontanare la morte dal contesto quotidiano di vita dell’uomo occidentale. Per amore di chiarezza forniamo alcuni dati bibliografici come punti di riferimento essenziali.
Agli inizi degli anni ’50 troviamo alcune opere che danno avvio a una letteratura non più generale, ma specializzata: una storia e una sociologia della morte, non più un discorso antropologico sulla morte. Pionieri di questa tendenza sono, in Francia, lo storico della cultura E. Morin e il sociologo R. Caillois 108. Alla metà della stessa decade l’antropologo inglese G. Gorer denunciava, con piglio provocatorio, che la morte aveva sostituito il sesso come principale tabù della nostra civilizzazione 109. Mentre la letteratura continuava imperterrita il suo discorso sulla morte come principale vissuto umano — basti pensare al ruolo della morte “sudicia” di Sartre —, nei costumi dell’uomo contemporaneo la morte subiva un graduale processo di emarginazione. “La morte — riassume uno storico del costume — è diventata un tabù, una cosa innominabile e, come una volta il sesso, non bisogna nominarla in pubblico. Nel XX secolo la morte ha rimpiazzato il sesso come principale interdizione. Una volta si diceva ai bambini che nascevano sotto un cavolo, ma essi assistevano alla grande scena degli addii, nella camera e al capezzale del morente. Oggi i bambini sono iniziati, fin dalla più giovane età, alla fisiologia
168
dell’amore e della nascita, ma quando non vedono più il nonno e domandano il perché, si risponde loro in Francia che è partito in viaggio molto lontano e in Inghilterra che riposa in un bel giardino in cui spunta il caprifoglio. Non sono più i bambini che nascono nei cavoli, ma i morti che scompaiono tra i fiori” 110.
Il posto riconosciuto alla morte nella vita sociale e l’atteggiamento del singolo di fronte ad essa hanno subito una trasformazione stesa quanto la civilizzazione industriale. Nel modello di comportamento che ha sostituito quello borghese-romantico del culto dei defunti la morte è evacuata e il lutto interdetto. Malgrado le resistenze che si notano nelle zone rurali e nei gruppi in cui le credenze religiose sono ancora tenaci, il nuovo modello sembra estendersi in modo inarrestabile, come l’industrializzazione e la secolarizzazione. Raccoglie dapprima l’adesione della classe intellettuale e borghese, per diffondersi poi nelle classi medie negli strati popolari.
Il nuovo costume sociale nei confronti della morte ha fatto le sue prime prove negli Stati Uniti d’America, nel periodo successivo alla prima guerra mondiale. Di là il modello è passato all’Europa nord-occidentale. E precisamente in America questo atteggiamento inedito di fronte alla morte assume le caratteristiche macroscopiche che permettono di osservarlo meglio. Già nel 1948 il romanziere inglese Evelyn Waugh aveva caricaturizzato i moderni costumi funerari americani, lasciandoci una descrizione, d’un humor insuperabile, del cimitero di Los Angeles, l’idillico Forest Lawn, dove la morte è mimetizzata da prati, fontane e musica diffusa 111.
Dopo le prime infrazioni del tabù della morte, altri hanno contribuito a far conoscere nei dettagli i nuovi costumi americani: la preparazione dei corpi da parte dei morticians, l’esposizione nelle funeral homes, i riti di ultimo addio, con il morto presentato come dormiente, dopo che ogni segno della morte è stato eliminato da un abile maquillage. Jessica Mitford ha lanciato l’espressione “the American Way of Death” 112, che da allora è rimasta affibbiata ai rituali di nuovo conio.
Due ricercatori, B.G. Glaser, e A.L. Strauss, hanno arricchito la nuova vena di pubblicazioni sulla morte con due opere originali. Nella prima,
169
dedicata alla coscienza del morire 113, hanno mostrato come, nelle società industriali, il morente non sente più venire la morte. Nel loro studio viene preso in considerazione il modo in cui l’équipe medica comunica col malato senza speranza. La conoscenza completa e condivisa della propria sorte è un caso eccezionale, mentre tende a generalizzarsi la dissimulazione.
In un’opera successiva i due autori hanno preso in considerazione il “tempo del morire” 114. Ne risulta che l’atteggiamento davanti alla morte è cambiato non solo per l’alienazione del morente, ma anche per la variabilità della durata della morte. I progressi della medicina non cessano di allungare il processo del morire. Al limite, esso tende a dipendere dalla volontà del medico. Il morente non è più che un povero oggetto privato di volontà, e spesso di coscienza.
Nella traiettoria di questa ricerca si situa il volume collettivo The Dying Patient 115, una raccolta di quattordici studi. L’analisi dell’opera ci permette di fere osservazioni di notevole interesse. Anzitutto l’abbondante bibliografia americana raccolta alla fine — circa 340 titoli, per lo più posteriori al 1959 — ci autorizza a concludere che il tabù della morte è stato infranto proprio da quella società da cui aveva incominciato a diffondersi. Le pubblicazioni citate riguardano gli studi di sociologia, etnologia, psichiatria e psicologia. Se ci limitiamo a quest’ultima, una verifica del crescente interesse per la morte ci è offerta dalla pubblicazione annuale dei Psychological Abstracts. Il numero dei lavori schedati sotto la voce Death si aggira intorno alla media annuale di 10 dal 1948 al 1964; poi salta improvvisamente a 34 nel 1965, 68 nel 1968 e 54 nel 1969. Nell’indice del 1970 ben 147 lavori di psicologia sono dedicati alla morte.
Un’altra conclusione a cui ci conduce il volume in questione è che ormai gli occhi di quanti hanno interesse per la sorte dell’uomo sono aperti senza illusione sulla grande miseria delle morti solitarie e trascurate. Gli intellettuali e i cultori delle scienze dell’uomo, che erano stati finora complici della congiura del silenzio, ora si ribellano all’evacuazione della morte dalla nostra civilizzazione. Non mettono più in discussione i nuovi riti funebri della società americana, spesso guardati con sufficienza nel recente passato. Si riconosce loro, al contrario, una certa legittimazione per l’aiuto che offrono ai sopravvissuti nel travaglio del lutto 116.
170
In un certo senso i nuovi riti sono un compromesso tra le manifestazioni solenni di una volta, animate da una speranza escatologica, e l’eliminazione pura e semplice del corpo, senza riti e senza lutto, così come ora è praticata soprattutto in Inghilterra e tende a diffondersi nell’Europa industrializzata. Secondo gli autori che hanno collaborato a questa pubblicazione, la società americana, mentre sta trovando una soluzione per i problemi psicologici e sentimentali sollevati dai funerali e dal lutto, continuerebbe invece a ignorare la miseria del morire nelle presenti condizioni. Se “the death” è O.K., “the dying” non lo è affatto. L’assistenza tecnica prolunga l’esistenza dei malati, ma non li aiuta a morire. Gli autori convengono nell’affermare che si impone un’alternativa: o prolungare la vita nelle condizioni umilianti e vergognose della pratica attuale, oppure riconoscere il diritto a cessare a un certo punto questo prolungamento. In via di fatto ora la decisione dipende unicamente dal medico. La decisione stessa viene ad essere un compromesso tra quattro ordini di considerazioni: il rispetto per la vita, che spinge il medico a prolungare gli interventi; l’umanità, che tende ad abbreviare la sofferenza; la considerazione dell’utilità sociale dell’individuo; l’interesse scientifico del caso. I medici saranno sollevati dal loro peso solo quando si sarà trovato uno statuto per i morenti che rispetti i loro diritti in quanto esseri umani.
Gli studi ai quali abbiamo fatto cenno si accostano alla morte considerando il fenomeno prevalentemente nella sua rilevanza sociale. Dobbiamo a questo punto fare il nome di uno psicologo che ha avuto il merito indiscusso di iniziare il filone di ricerca al quale ci stiamo riferendo. Si tratta di Herman Feifel. Egli ha puntato il suo interesse sugli atteggiamenti, verbalmente espressi, delle persone che la morte concerne più da vicino: persone anziane, malati gravi, personale medico. Il suo primo studio data dal 1959 e costituisce un punto di riferimento fondamentale nello studio della psicologia della morte. In quell’anno pubblicava i contributi di un simposio dell'American Psycological Association dedicato al significato della morte 117.
171
Dopo di allora con numerose opere — di cui in nota citiamo le più importanti — ha contribuito come pochi altri a far cadere le resistenze che pesavano sullo studio della morte. Egli personalmente ha dovuto sperimentare le odiosità che si riversano su chi infrange un tabù. Ma ormai la via è aperta. Soprattutto è ormai recepito che cercar di conoscere gli atteggiamenti umani all'avvicinarsi della morte non è un malsano sadismo, ma un’opera umanitaria.
Tra i principali risultati delle ricerche di Feifel segnaliamo la sua conclusione secondo cui la paura di parlare della morte è un atteggiamento socialmente imposto. Una volta avviata la conversazione, i morenti ne ricavano un vero beneficio. Per quanto riguarda le correlazioni tra prospettive religiose e atteggiamenti d’ansietà e di calma all'avvicinarsi della morte, Feifel è del parere che esistano polarità più fondamentali, eventualmente rafforzate da temi religiosi. Così l’uomo ansioso trova nella sua religione nuove ragioni d’ansietà, mentre l’uomo fiducioso vi troverebbe di che giustificare la sua fiducia.
Un singolare seminario interdisciplinare
La rassegna precedente aveva per scopo di situare nel contesto della produzione analoga l’opera di cui vogliamo riferire in dettaglio: On Death and Dying, della dottoressa Elisabeth Kübler-Ross. Il volume è apparso nell’originale già nel 1969. La comparsa quasi simultanea delle traduzioni francese e italiana, indice di un risveglio di interesse nei nostri paesi europei per questa problematica, ci offre l’occasione di parlarne per esteso 118.
Il libro ha alle spalle un lavoro di quattro anni, svolto in un ospedale di Chicago. Gli inizi risalgono al 1965 e sono raccontati dall’A. stessa (pp. 31 ss.). Alcuni alunni del seminario di teologia di Chicago si rivolsero all’A., una psichiatra svizzera sposata a un americano, perché li aiutasse
172
in un lavoro sulle “crisi della vita umana”; tra le diverse crisi essi avevano scelto il morire. L’idea elementare della dottoressa Kübler-Ross era stata quella di chiedere a dei malati inguaribili di parlare del proprio approssimarsi alla morte; gli aspiranti pastori li avrebbero ascoltati per imparare da questi singolari maestri qual è lo stato d’animo e quali sono i bisogni dei malati allo stadio terminale. Il procedimento, così audace e originale, aveva un precedente, del quale l’A. riferisce in un altro scritto più ricco di materiale autobiografico 119. Trapiantata di fresco negli Stati Uniti e gravata da difficoltà linguistiche, si era trovata, per di più, durante uno stage di psichiatria, con un carico di sessanta malati considerati come schizofrenici cronici e incurabili. Decise di mettersi al loro ascolto, ponendo loro domande elementari sulle esperienze che avevano passato durante i loro lunghi anni di soggiorno all’ospedale. Ora, questo semplice ascolto si era rivelato una risorsa terapeutica insperata: la quasi totalità dei malati ne avevano tratto beneficio, così da poter essere rimessi in circolazione.
In tal modo, dunque, gli schizofrenici avevano insegnato alla psichiatra quale senso avesse l’essere schizofrenici; forse poteva avvenire la stessa cosa per i morenti. Questa l’intuizione soggiacente al lavoro. Ma quando E. Kübler-Ross decise di passare all’azione, dovette sperimentare le resistenze da parte dell’ambiente ospedaliero a questo approccio diretto. I medici e le infermiere dichiaravano di voler difendere i loro pazienti da esperienze traumatiche; di fatto mostravano di essere gli strumenti più efficaci per il mantenimento del tabù della morte 120. Malgrado l’iniziale opposizione, l’iniziativa poté essere avviata; ben presto, anzi, conobbe un tale successo che nel volgere di pochi anni il numero delle interviste registrate si elevava all’ordine delle centinaia e il seminario, da iniziativa informale di quattro studenti, diventava un corso ufficialmente riconosciuto tanto dalla facoltà di teologia quanto dalla scuola di medicina: “un seminario che doveva cominciare come un esperimento per molti finì per essere veramente un’esperienza di vita” (p. 34). Il bilancio che tira l’A. stessa dopo quattro anni di attività è dei più lusinghieri: “Il nostro
173
seminario interdisciplinare sullo studio dei malati vicini alla morte è ora un corso accettato e ben noto, frequentato settimanalmente da una cinquantina di persone di diversi ambienti e discipline, spinti da motivazioni diverse. È forse uno dei pochi casi in cui il personale ospedaliero si riunisce informalmente e discute tutti i bisogni e l’assistenza del malato da diversi punti di vista. Nonostante il crescente numero di studenti, il seminario ricorda spesso le sedute di una terapia di gruppo, in cui i partecipanti parlano liberamente delle proprie reazioni e fantasie in relazione al malato e apprendono così qualcosa circa le motivazioni personali e il proprio comportamento. Studenti di medicina e di teologia ne riconoscono l’importanza accademica e hanno scritto seri articoli su questo argomento. In breve, esso è divenuto parte del curriculum di molti studenti che incontrano i malati inguaribili all'inizio della loro carriera, con lo scopo di essere preparati ad assisterli con minori difese quando ne avranno la responsabilità” (p. 292).
Ma vediamo come funziona il seminario. Quando c’è un malato disponibile, viene avvicinato dalla psicologia o dal cappellano, che gli espongono lo scopo e il metodo dell’incontro. Gli si parla di un gruppo interdisciplinare di personale ospedaliero desideroso di apprendere dal malato, in particolare dai malati gravi e vicini alla morte. Quando il malato è d’accordo (e uno degli aspetti più sorprendenti di questa esperienza è proprio l’adesione quasi unanime dei malati alla proposta) e il medico ha dato il permesso, il malato viene condotto nella sala delle interviste appositamente arredata. Uno specchio unidirezionale nella parete rende possibile al pubblico di vedere e di sentire, pur permettendo un rapporto di intimità con l’intervistatore. Una volta nella sala delle interviste, la conversazione fluisce con facilità. Dopo ogni seduta, riaccompagnato il malato nella sua camera, il seminario continua. Vengono verbalizzate le reazioni spontanee; si discutono le risposte, tanto quelle emotive che quelle intellettuali. Soprattutto si concentra l’attenzione sulle risposte del malato agli intervistatori, per cercare di comprendere in modo psicodinamico quanto ha voluto comunicare.
Tutte le interviste sono registrate su nastro e restano a disposizione di studenti e insegnanti. Alla fine di ogni trimestre ogni studente scrive una relazione su un argomento di sua scelta. Nel suo libro E. Kübler-Ross riporta per esteso alcune di tali interviste, tenute tutte da lei, talvolta con la collaborazione del cappellano dell’ospedale. È un materiale estremamente suggestivo. L’A. ci rende avvertiti che il resoconto verbale è
174
solo lo scheletro dell’intervista: “La parte che non si può partecipare al lettore è l’esperienza che si fa durante un dialogo del genere: parecchie comunicazioni non verbali che avvengono continuamente tra malato e medico, fra medico e cappellano, o fra malato e cappellano; sospiri, occhi umidi, sorrisi, gesti della mano, espressione vuota, sguardo attonito o mani tese: tutte comunicazioni di un’importanza che spesso supera le parole” (p. 203). Da questo punto di vista non sapremmo trattenere la nostra ammirazione per la sensibilità di cui dà prova la dottoressa Kübler-Ross. È dotata da un’empatia che le rende possibile interpretare il linguaggio simbolico, verbale e gestuale, con cui i malati esprimono le loro reazioni più profonde all’approssimarsi della morte. Uno degli scopi dichiarati della sua opera è proprio quello di sensibilizzare i familiari di malati vicini alla morte e il personale ospedaliero alle comunicazioni implicite dei malati in fin di vita (cfr. p. 161).
Un leitmotiv di tutto il libro è che, per capire ciò che un malato grave sta passando e quali sono i suoi bisogni, è necessario che il malato si faccia maestro e che tutti gli altri accettino di imparare da lui. I malati hanno difficoltà sempre più forti nel comunicare i loro bisogni quando si avvicinano alla morte. Le ragioni di tali difficoltà sono esaminate dall’A. in un capitolo preliminare, dedicato alla “paura della morte”. In parte già le conosciamo dalla letteratura precedente. Dipendono tanto dalle trasformazioni avvenute nel nostro inconscio, quanto dai cambiamenti sopravvenuti nelle modalità concrete del morire. Sono passati i tempi in cui un uomo poteva morire in pace e con dignità nella propria casa, circondato dai suoi familiari. “Oggi morire è per molti aspetti più spaventoso, cioè più solitario, più meccanico, più disumanizzato; qualche volta è difficile perfino determinare tecnicamente il momento in cui è avvenuta la morte” (p. 16).
Numerose perorazioni per un morire più umano sono state elevate da alcuni anni a questa parte. È forse motivo di stupore che esse provengano dai cultori delle scienze dell’uomo, mentre ce la saremmo aspettate dai moralisti e dai politici. È un fatto, comunque, che la situazione attuale è denunciata a chiare lettere come intollerabile e disumana. Mancava invece un’iniziativa concreta e lucida come quella della dottoressa Kübler-Ross, che tendesse a fornire un aiuto terapeutico e cominciasse col mettersi all’ascolto dei bisogni del malato in fase terminale. La tecnica medica, concentrando tutto il suo intervento sulla vita fisica, trascura le sofferenze psicologiche. Non è da escludere che dietro questo affidare tutto
175
il nostro sapere e potere alle macchine ci sia un tentativo di rimuovere l’angoscia nei confronti della morte. Il personale ospedaliero identifica il proprio compito con la battaglia per la vita; ma evita in tal modo di prendere in considerazione i bisogni della persona. Proprio a questa tendenza reagisce il seminario di cui ci occupiamo. In contrapposizione a un ostinato, miope e forse ansioso prolungamento del funzionamento dell’organismo, difende la qualità e la dignità della vita, inclusa la sua fase terminale. Mette in discussione l’opportunità di infierire con tecniche raffinate sul morente, quando questi è pronto a distaccarsi da questo mondo e non ci sia più alcuna ragionevole speranza: “Con fleboclisi e trasfusioni sufficienti, vitamine, energetici e psicofarmaci, con trattamenti psicoterapeutico e sintomatico, molti malati del genere possono vivere un ulteriore periodo di tempo. Io ho sentito più maledizioni che parole di apprezzamento per il tempo guadagnato e ripeto la mia convinzione che un malato ha il diritto di morire in pace e dignità. Non si dovrebbe utilizzare per soddisfare i nostri bisogni, quando i suoi desideri sono opposti ai nostri” (p. 197). Il primo interesse del seminario va dunque allo scoprire quali sono i bisogni del morente.
A scanso di equivoci va detto che un tale intervento terapeutico non si propone di essere una versione secolare della preparazione alla ‘ 'buona morte”. Il discorso sull’approssimarsi della morte avviene con malati che non sono realmente moribondi nel senso classico della parola, ma piuttosto malati “condannati”, che si vuol aiutare a vivere, piuttosto che a vegetare in modo disumano. Il seminario non è il luogo in cui comunicare elegantemente la sentenza fatale. L’A. è formale a questo proposito: “Non sempre dichiariamo esplicitamente che il malato è realmente vicino alla morte. Cerchiamo di intuire i principali bisogni dei malati, di prendere coscienza delle loro forze e debolezze, e di determinare, dalla loro comunicazioni aperte o tacite, quanta voglia abbia un malato di affrontare a un certo momento la realtà” (p. 59).
Al famoso problema “se dire o no la verità” al malato grave è dedicata una trattazione in cui, abbandonato ogni apriorismo, si lascia parlare l’esperienza maturata in tanti incontri profondi con i malati. E. Kübler-Ross ritiene che generalmente il problema è mal posto: La domanda non dovrebbe essere: “Lo dico al malato?”, bensì: “Come posso condividere col malato quanto so?” (p. 48). La priorità spetta dunque alla ricerca di canali di comunicazione.
La maggior parte dei malati gravi, del resto, sa che sta per morire. Il malato lo intuisce dalla mutata attenzione, dal modo nuovo e diverso
176
con cui la gente lo avvicina, dalle voci abbassate o dal fatto che il personale lo evita, dal volto in lacrime di un parente o dal sorriso forzato di un familiare che si sforza di nascondere i suoi sentimenti. Quando si possiede la capacità della Kübler-Ross di interpretare il linguaggio simbolico, dalla comunicazione non verbale ai disegni dei bambini, si scoprirà che tutti i morenti parlano della propria morte. “Essi fingeranno di non sapere quando il dottore o un parente non è capace di parlargli della loro vera condizione, e accoglieranno con gioia qualcuno che voglia parlarne, ma permetta loro di stare sulle difensive finché ne avranno bisogno” (p. 48).
Chi si trova in quella situazione critica ha soprattutto bisogno di condividere con un altro essere umano. Invece proprio allora si sentono respinti nel limbo dell’incomunicabilità. A respingerli è l’incapacità personale di coloro che li attorniano a sopportare il confronto con una malattia senza speranza e con la morte. I medici forse più degli altri, afferma l’A.: “Questi medici, se interrogati, ci diranno che i loro malati non vogliono sapere la verità, che non la chiedono e che credono a tutto. Infatti i medici sono molto sollevati quando non devono affrontare la questione e spesso non si rendono affatto conto di aver provocato loro tale risposta da parte dei malati” (p. 43).
Inoltre è il caso di chiarire che accondiscendere al bisogno del malato di parlare della propria situazione non equivale a uccidere in lui la speranza. C’è infatti speranza e speranza. La speranza della persona che se la cava è del tutto differente dalla speranza del morente. Chi gli sta accanto deve imparare ad ascoltare qual è la speranza del malato, e non proiettare su di lui le sue proprie speranze. La Kübler-Ross ha il carisma di portare il malato ad esprimere la propria speranza. In tutte le interviste riportate nel libro la nota della speranza risuona come dominante: va dalla speranza che si scopra un trattamento efficace a quella di essere accolto da Dio, dalla speranza di conservare la propria dignità fino all’ultimo a quella di avere il tempo sufficiente per sistemare la situazione dei propri cari.
Ciò che bisogna soprattutto evitare è di dare al malato un numero concreto di mesi o di anni. Prima di tutto perché l’informazione è per lo più errata; in secondo luogo perché ciò costituisce un intervento violento sul diritto del malato e dar corpo alla propria speranza. Chi sta accanto al malato senza paura di guardare in faccia la fine non deve essere considerato come un disfattista che boicotta la linea di difesa dell’équipe
177
curante. Certamente non si schiera tra i disfattisti la dottoressa Kübler-Ross, la quale sostiene che “non si dovrebbe mai cedere le armi a proposito di nessun malato, inguaribile o no”. Ma la sua convinzione non si traduce in quell’accanimento terapeutico con cui il corpo medico infierisce sul malato ridotto cosa inerte, bensì in una calda presenza aperta alla comunicazione: “Quel malato conserverà il suo barlume di speranza e continuerà a considerare il medico come un amico, che gli sarà vicino fino alla fine. Non si sentirà trascurato o abbandonato nel periodo in cui il medico lo considera al di là di ogni possibilità di cura” (p. 159).
Qual’è dunque, in sintesi, il senso dell’attività che la Kübler-Ross ha scelto alPinterno dell’ospedale e che promuove col suo seminario? Ci piace esprimerlo con le stesse parole semplici e immediate con cui lei stessa lo comunica a un malato nel corso di un’intervista: “Molta gente ha idee diverse su quello che noi facciamo qui. La cosa che mi interessa di più è parlare con persone malate o con pazienti inguaribili. Per riuscire a capirli un po’ di più. Per insegnare al personale ospedaliero come possiamo aiutarli meglio, e l'unico modo in cui possiamo insegnarlo è fare del malato il nostro maestro” (p. 121).
Il suo fine non è dunque di costituire un’équipe di specialisti per malati vicini alla morte, quanto piuttosto di sensibilizzare tutto il personale ospedaliero e di prepararlo a conoscere i bisogni del malato. Non prende posizione contro la tecnologia applicata alla medicina, ma vorrebbe vederla congiunta all’arte delle relazioni interumane; il risultato sarebbe un modo umano e globale di curare il malato. E il malato, considerato come persona investita di una dignità inalienabile, si riapproprierebbe del suo diritto di vivere la propria morte da protagonista.
Le fasi del morire
Un contributo peculiare di E. Kübler-Ross alla ricerca psicologica sul vissuto del morente è la determinazione di alcune fasi che ogni morente attraverserebbe nel corso del processo che lo porta alla morte. Premettiamo che, dal punto di vista scientifico, tale classificazione solleva delle riserve 121. Essa appare, infatti, piuttosto di ordine intuitivo e rimane
178
approssimativa; pur disponendo della descrizione degli stadi del morire, continuiamo ad ignorare con quale frequenza e rappresentatività le diverse fasi sono attraversate. Malgrado queste carenze, la classificazione merita attenzione per il suo valore antropologico. Il vissuto delle fasi getta una luce sul senso di alcuni atteggiamenti del malato grave che sconcertano il personale ospedaliero e l’ambiente familiare. Quando non vengono compresi li si accoglie con risposte inadeguate o del tutto non pertinenti, che caricano di sofferenza supplementare la tragedia della morte.
Dal momento in cui viene annunciata la probabilità di una morte prossima si identificano cinque fasi. La prima è quella del rifiuto e dell’isolamento. Quasi tutti i malati senza speranza intervistati hanno dichiarato che la loro prima reazione alla consapevolezza di avere una malattia mortale è stata l’incredulità. “No, non è possibile. Non io. Non ancora”. Il rifiuto ansioso che segue la presentazione della diagnosi, specialmente se l’informazione è data prematuramente o all’improvviso, è per lo più temporaneo. Ha la funzione di paraurti e permette al malato di guadagnare il tempo necessario per mettere in funzione difese meno radicali. Le difese sono necessarie, perché l’annuncio della morte è una ferita brutale a quel narcisismo che ci fa credere immortali. Di solito il rifiuto è una difesa temporanea, ma non è escluso che alcuni malati, i quali non si riconoscono la forza di guardare la morte, lo tengano in piedi sino alla fine. Tutt’al più tradiranno la loro angoscia nel linguaggio simbolico, che solo un’attenta lettura saprà interpretare.
Per lo più, però, alla prima fase fa seguito una seconda, quella della rivolta: “Perché io?”. I sentimenti che l’accompagnano sono quelli della collera, dell’invidia e del risentimento. La rivolta proietta i sentimenti rabbiosi in tutte le direzioni, da Dio alla famiglia e al personale curante. Gli esiti di questa esplosione rischiano di essere tragici. Le persone sulle quali si riversa la ribellione del malato possono risentirsene personalmente. Il malato difficile sarà allora evitato. Rifiuta gli altri e provoca a sua volta rifiuto; eppure è il più disperato di tutti.
Kübler-Ross riferisce come il seminario abbia contribuito spesso in modo decisivo a sbloccare queste situazioni. L’intervista ha permesso al malato di esprimere i motivi della sua rivolta e al personale assistente di capire quale fossero il vero bersaglio dell’ira e del risentimento. Il malato poté essere capito senza essere giudicato, e senza che le sue scortesie fossero recepite come offese personali. Può essere d’aiuto al personale assistente il consiglio di considerare gli scoppi di aggressività come un
179
indiretto omaggio a chi rappresenta la salute e la vita, cioè i beni che i malati stanno per perdere per sempre. D’altra parte un malato rispettato e compreso, cui si dedichi attenzione e tempo, di cui si tolleri la collera razionale o irrazionale, uscirà più facilmente dallo stadio della rivolta.
Come terza fase incontriamo spesso quella del patteggiamento. È una specie di compromesso con cui il malato che si sa condannato cerca di strappare una dilazione. “Se nel primo periodo non siamo stati capaci di affrontare la triste realtà e nella seconda fase siamo stati in collera con la gente e con Dio, forse possiamo riuscire a fare una specie di accordo che possa rimandare l’inevitabile evento” (p. 97). Pazienti difficili diventano improvvisamente molto sottomessi (“Mi si accordi uno o due anni ancora... Seguirò alla lettera tutte le prescrizioni”). È soprattutto in campo religioso che avviene la maggior parte dei patteggiamenti: Dio si sente promettere una vita al servizio della chiesa in cambio di un ripensamento nella sua decisione inappellabile...
Quando il malato incurabile non può più negare la sua malattia e ha esperimentato l’inanità della rivolta e del patteggiamento, è molto probabile che si abbandoni alla depressione. A questa fase è dedicata un’analisi molto accurata. Vengono distinti due tipi di depressione. Una è “reazionale” ed è legata ai nodi di problemi esistenziali che il malato si sente incapace di risolvere. Si tratta spesso di difficoltà economiche, oppure della sistemazione di bambini o di persone vecchie e sole che dipendevano da lui. Se un’assistente sociale o un cappellano si prendono cura di questi problemi, la depressione che il malato ha sviluppato come reazione della sua impotenza sparisce abbastanza in fretta. Il secondo tipo di depressione, che l’A. chiama “preparatoria”, è legata alla considerazione delle perdite che incombono. È uno stato d’animo orientato al distacco e che prepara ad esso: si comincia nella tristezza a ripensare ai buoni aspetti del passato o a prendere disposizioni per arrestare i progetti o gli impegni. È una depressione che potremmo qualificare come un mesto ritiro dei remi in barca. La nostra reazione spontanea verso le persone tristi è generalmente quella di cercare di incoraggiarle. Questo può essere un modo utile di accostare il malato quando si tratti del primo tipo di depressione. Ma se la depressione è un modo di preparare all’imminente perdita di tutto ciò che si ama, può essere benefica per il morente. Senza di essa il malato non riuscirebbe a distaccarsi dalla vita in stato di accettazione e di pace. La presenza del visitatore che cerca di distrarre dai pensieri tetri in questa fase si rivela contraria al bisogno del malato.
180
La quinta ed ultima fase è quella dell’accettazione. È il momento del “Nunc dimitte”. “Se un malato ha avuto il tempo sufficiente ed è stato aiutato a superare le fasi sopra descritte, raggiungerà uno stadio nel quale non sarà né depresso né arrabbiato per il suo “destino”... L’accettazione non deve essere scambiata con una fase felice. È quasi un vuoto di sentimenti. È come se il dolore se ne sia andato, la lotta sia finita e venga il tempo per “il riposo finale prima del lungo viaggio”, come l’ha definito un malato” (p. 129). Le fasi precedenti possono essere interpretate globalmente come meccanismi di difesa, messi in atto in periodi di tempo diversi per difendersi dal fatto più traumatico della vita. L’abbandono di questi meccanismi coincide con l’entrata nella fase dell’accettazione. E. Kübler-Ross non ci offre elementi statistici per dire quanto sia frequente il morire in questo stato d’animo; né lascia trapelare un giudizio di valore per proclamare questa morte come ideale. Si limita ad affermare che l’assistenza che presta ai malati è volta a rendere possibile a tutti il raggiungimento di questa fase. La chiama decathexis, cioè graduale distacco dove non c’è una comunicazione bilaterale. I morenti sembrano scivolare in uno stato che non conosce più la paura né la disperazione, in cui il bisogno di cibo diventa minimo e la coscienza dell’ambiente circostante svanisce nell’oscurità. L’A. lo paragona alla condizione della prima infanzia, a cui l’avvicina anche il bisogno gradatamente crescente di aumentare le ore di sonno. “Così, forse, alla fine dei nostri giorni, quando avremo lavorato e dato, goduto e sofferto, ritorneremo allo stadio nel quale iniziammo e il cerchio della vita si chiuderà” (p. 136): è la sua interpretazione filosofica della fenomenologia del morire, al di là di quanto può osservare dalla prospettiva psicologica. Ma le terapie di sostegno dei morenti non hanno bisogno di fondarsi su una visione filosofico-religiosa particolare. Lo psicologo può personalmente pensare che il suo compito sia quello di oleare quelle porte che gli antichi immaginavano di bronzo, perché non cigolino aprendosi sul nulla. Ciò non pregiudica affatto il valore altamente umanitario della sua opera.
Il problema centrale dell’assistenza ai morenti, un problema allo stesso tempo etico e psicologico, è quello di individuare il momento del trapasso dalla resistenza all’accettazione. Non deve avvenire troppo presto, in una rassegnazione che equivale a dimissioni; ma neppure troppo tardi, quando il desiderio terapeutico di prolungargli la vita contrasta col desiderio del malato di morire in pace. “Se noi non sappiamo distinguere queste due fasi, ai nostri malati facciamo più male che bene, saremo frustrati
181
nei nostri sforzi e renderemo la loro morte un’ultima dolorosa esperienza” (p. 130). Queste parole valgano a richiamarci la gravità del compito e la maturità che esso richiede. È opportuno tenerlo presente, perché alcune espressioni di E. Kübler-Ross potrebbero trarci in inganno, facendosi credere che si tratti di un compito di tutta facilità (“Ci meravigliamo sempre nel costatare quanto una seduta possa sollevare un malato da un peso tremendo e ci domandiamo perché sia così difficile per il personale e per la famiglia intuire i bisogni dei malati, dato che spesso non occorre altro che una domanda aperta”, p. 296). Nessuno può fare economia del discernimento e della simpatia necessari per avvicinare un altro essere umano nel santuario più intimo della sua esistenza.
Il momento supremo della presenza al morente può assumere l’essenzialità ieratica di un gesto: il tener la mano in silenzio. A questo silenzio al di là delle parole E. Kübler-Ross dedica i passi più ispirati del suo libro. In lei è rimasto indelebile il ricordo di una giovane donna, di cui aveva capito il bisogno di comunicare malgrado il suo rifiuto ostinato di ammettere la propria morte; un giorno la malata, tenendole la mano, le aveva detto: “Lei ha delle mani così calde. Spero che sarà qui con me quando io diventerò sempre più fredda” (p. 57). Nello stadio dell’accettazione non c’è altro da fare che restare al capezzale del morente tenendogli la mano. È l’estremo modo di presenza all’altro. Un tener la mano che ha valore di sacramento.
“I morti sono la preda dei vivi”. L’espressione aveva in bocca a Sartre un significato filosofico. Oggi il potere dei vivi sui morti ha una traduzione empirica, dalle molteplici componenti sociali, mediche e di costume. Il vivente non può rinunciare ai poteri che la vita gli attribuisce sui morti. Ma può anche far uso del potere più bello, che è quello di accompagnare il morente il più lontano e il più a lungo possibile. Alcuni psicologi oggi lo rivendicano, valorizzando la capacità terapeutica della transazione verbale. Per altri operatori sociali, ma soprattutto per i medici, la loro testimonianza è uno stimolo a ripensare il proprio servizio alla vita nel suo stadio terminale.
182
183
Parte Quarta
SCHEDE BILIOGRAFICHE
184
185
INTRODUZIONE
Anche queste schede, come quelle che concludono il volume Antropologia cristiana, intendono offrire un aiuto allo studente, orientandolo nella selva rigogliosa delle pubblicazioni concernenti la bioetica. Senza alcun tentativo di sistematicità, vengono recensite opere di varia natura e di diverso valore. La proposta di tali schede in questo contesto va oltre l’intento informativo, fino a ipotizzare che la loro lettura possa sortire un esito formativo. Non certo nel senso che il recensore pretenda di insegnare come si legge un libro...! Nella recensione, piuttosto, il recensore è costretto a mettere in mostra i suoi personali criteri di lettura, i suoi schemi mentali, le sue preferenze e idiosincrasie, senza poter escludere l’esibizione dei propri limiti. Questa dimensione personale del discorso può essere salutata come un utile pendant alle pagine precedenti, dedicate a una riflessione sistematica sulla bioetica. Nelle schede bibliografiche l’autore, presentandosi come lettore, si espone di più, mostrando la forza e la debolezza del suo pensiero nel momento del suo farsi. La visione sistematica diventa qui work in progress. Dal confronto lo studente può trovare uno stimolo a non giurare in verbo magistri; uno stimolo anche a percorrere la propria strada, pur rifacendo le stesse letture. Proprio questa dimensione così contingente e personale della riflessione può rivelarsi formativa per lo studente che si accosta alla bioetica, almeno tanto quanto la visione d’insieme. La formazione etica, infatti, non mira a costituire agglomerati di pensiero conformista, ma piuttosto ad animare l’individuo a “educarsi” — nel senso etimologico di “e-ducere”: tirar fuori —, sviluppando la propria percezione dei valori e dell’essere.
186
187
O.M.S., La salute e i diritti dell’uomo, Il Pensiero Scientifico, Roma 1978, pp. 216.
Negli Stati Uniti la chiamano “bioetica”. È un argomento di pubblicazioni, di insegnamento universitario, di dibattiti appassionati. Da quando i progressi delle scienze mediche hanno creato la possibilità di interventi radicali sulla vita e sulla morte, si è resa sempre più necessaria un’opera di discernimento etico. Perché non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è utile per una vita più umana. Le barriere che pone la morale tradizionale — confessionale o secolare — sono fragili. Sottoposte a sfida continua da parte di una scienza ancora ubriaca di miti prometeici (e non ricondotta al senso del limite dalle poche cassandre che minacciano una “nemesi medica”), hanno bisogno di alleati per resistere alla pressione della manipolazione totale. Il migliore alleato è anche più ovvio: l’opinione pubblica. È necessario far circolare informazioni, allargare il dibattito, coinvolgere la popolazione nei problemi posti dai progressi della medicina. È quanto si propone un documento redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità circa “La salute e i diritti dell’uomo”. Pubblicato già in inglese e in francese, viene ora presentato al pubblico italiano grazie a una lodevole iniziativa dell’editrice “Il Pensiero Scientifico”. Il sottotitolo specifica: “Con particolare riferimento ai progressi in biologia e in medicina”. Nella delibera dell’OMS da cui ha presi avvio lo studio era più esplicito il senso di allarme creato da tali progressi; vi si parlava di “protezione della persona umana e della sua integrità fisica e intellettuale alla luce dei progressi in biologia, medicina e biochimica”. Di fatto il documento prende in considerazione alcune delle situazioni in cui gli interventi biomedici hanno gravi implicazioni nei diritti dell’individuo. È certamente un’acquisizione importante e irrinunciabile considerare la salute come un diritto (uno degli ultimi ad essere affermato nelle Costituzioni della maggior parte dei paesi del mondo); ma non va dimenticato che questo diritto possiede dei limiti, e che può entrare in conflitto con altri diritti, in particolare con il diritto fondamentale della libertà. Questa angolatura costituisce la specificità del documento dell’OMS e lo differenzia da altri analoghi, come il “Codice internazionale di Etica Medica” della World Medical Association. Non abbiamo qui né un codice deontologico, né un codice etico, ma una presa di posizione sui rischi potenziali che il progresso medico può portare per ciò che concerne i diritti fondamentali dell’uomo. La problematica presa in considerazione non è esaustiva,
188
tuttavia ampia quanto basta. Gli interrogativi toccano l’inizio della vita (interruzione artificiale della gravidanza, utilizzazione di feti umani per la ricerca), la facoltà riproduttiva (sterilizzazione, castrazione, contraccezione, fecondazione artificiale), la sperimentazione sull’uomo, la morte, le questioni di politica sanitaria (protezione dai fattori di rischio ambientali, misure obbligatorie per la difesa della salute). La posizione del documento non è normativa, ma problematica. Riconosce esplicitamente che “i problemi etici non sono suscettibili di una soluzione universale” e che “uno stesso problema viene visto sotto differenti luci in diversi paesi, a seconda delle idee etiche e religiose dominanti». Il suo intento è quello di favorire una migliore circolazione di esperienze e un confronto a livello internazionale, perché i governi possano tenerne conto nel promulgare le leggi. L’edizione italiana del documento accoglie questo spunto, cominciando con l’aprire un dibattito relativo alla situazione italiana. La seconda parte del volume presenta infatti numerosi saggi circa i diritti della donna e del bambino, l’ingegneria genetica, la sperimentazione umana, la psicochirurgia, la protezione ambientale e la prevenzione nell’ambiente di lavoro. Nella situazione nuova creata in Italia dal varo della riforma sanitaria si crea ora la possibilità per tutti i cittadini di rompere i meccanismi di delega e di partecipare attivamente alla determinazione dei contenuti dei programmi sanitari. Il documento dell’OMS può costituire un utile strumento per una crescita di coscienza civile e per una maturazione della riflessione etica.
189
G. Quaranta, L’uomo negato, Nuova Guaraldi, Firenze 1980, pp. 113.
È difficile presentare e valutare questo libro in quanto libro, cioè semplicemente come produzione culturale di pensiero. Il discorso che apre investe direttamente il lettore, attuale o potenziale utente di una struttura ospedaliera, provocando un’immediata identificazione con “l’uomo negato”. La domanda sul “che fare?” emerge fin dalle prime pagine, dando allo scritto un’esplicita colorazione politica. La stessa fascetta di copertina, presentandolo come “il libro che ha ispirato i tribunali per i diritti del malato”, lo inserisce in un contesto che ne condiziona inevitabilmente la precomprensione. Il libro di Quaranta si sottrae così a una lettura neutra, diventa un libro di parte. Tale vuol essere, senza ambiguità: un libro di parte. Dove la parte, però, sia quella del malato. Forse l’autore non rifiuterebbe per il suo libro neppure la qualifica di pamphlet, se con tale termine si vuol designare lo scritto polemico che affronta argomenti scomodi e mette di fronte agli occhi di tutti la spazzatura che ci si ostina a voler nascondere sotto il tappeto. Non è un segreto per nessuno, infatti, che la condizione del malato ospedalizzato è gravata da una quantità di sofferenze inutili, che si aggiungono a quelle della malattia. Come mai — si domanda Quaranta — per curare un essere umano lo si deve ferire nella sua identità?
“L’uomo negato” è quello a cui vengono sottratti i diritti abitualmente riconosciuti alla persona umana: e questa è la sorte che sovrasta colui che, non godendo di particolari privilegi, venga a trovarsi invischiato nelle strutture ospedaliere. I procedimenti terapeutici ai quali viene sottoposto compiono un’opera di devastazione dell’identità. Da soggetto diventa inspiegabilmente un oggetto. “Dal momento in cui una struttura sanitaria mi accoglie tra le sue braccia, certamente per tentare di guarirmi, succede che, senza che nessuno lo voglia, senza che ci siano cattive volontà, il mio lavoro, la mia cultura, il mio stesso corpo, per quello che la malattia me ne lascia, i miei desideri, le mie idee, i miei diritti, i miei affetti non contano più e svaniscono nel nulla. Mi è difficile anche tenermi legato ad alcune piccole cose alle quali attribuisco un valore particolare per mantenere la mia identità. Se sto in corsia, i pochi oggetti che posso tenere mi danno la misura di quello che mi è rimasto”. Basta questa citazione per restituire la “vis” polemica del libro e l’approccio con cui si considerano i diritti del malato. Questi non vengono dedotti
190
da principi etici o da istanze umanitarie. Carte dei diritti del malato in tal genere ne esistono in quantità, e anche autorevoli. Basti citare, per tutti, il documento emanato di recente dall’organizzazione Mondiale della Sanità su “La salute e i diritti dell’uomo”, relativo ai conflitti che sorgono, a seguito dei progressi della medicina e della biologia, tra il diritto alla salute e altri fondamentali diritti dell’uomo, come la libertà. Quaranta segue un altro procedimento. Ricorrendo a una serrata analisi psicosociale, smonta, pezzo per pezzo, il meccanismo che fabbrica l’uomo negato. Il sociologo americano Talcott Parson gli fornisce gli strumenti per comprendere come il sistema sociale dominante instauri un controllo sulla malattia, attribuendo al malato un ruolo che neutralizza le spinte verso la devianza. Ci si imbatte così nel potere tra i più rilevanti nella nostra società, che consiste nell’attribuire o nel negare a un soggetto il ruolo di malato.
La rivendicazione fondamentale di cui Quaranta si fa portavoce è quella del ruolo di protagonisti che spetta ai malati, al fine di restituire la qualità umana alle istituzioni sanitarie. Le soluzioni tecniche — anche una politica sanitaria più efficace e maggiori investimenti economici — non bastano. Il sistema sanitario può essere cambiato solo da un sovvertimento che assomigli a una “rivoluzione culturale”. Il movimento dei diritti del malato acquista così una notevole rilevanza etica e antropologica, che lo accomuna alle iniziative che hanno portato a sopprimere i manicomi e a inserire gli handicappati nella società. Ha una portata ancora maggiore, perché virtualmente tutti i cittadini vi sono interessati. Come la dinamica istituzionale della malattia è un fenomeno socio-culturale di massa, così il movimento di liberazione che parte dalla condizione di malato investe praticamente tutti, almeno nell’ambito delle classi subalterne.
A questo punto il fuoco del discorso si incentra sulla possibilità di trovare spazi concreti in cui il malato possa reagire a quel fenomeno culturale che I. Illich ha chiamato “espropriazione della salute”, per acquistare il ruolo di attore e protagonista. Quando i malati non sono trattati esclusivamente come individui da curare, si possono inserire come forza sociale viva nel quadro di una trasformazione della qualità della vita. È quanto dire che il problema sanitario si innesta direttamente sul politico, purché si intenda l’azione politica in senso ampio. Per liberarsi dal- l’incubo di un sistema istituzionale antiumano non basta una generica mozione degli effetti: è necessaria la lotta contro gli abusi. Ciò implica l’uso del potere e l’individuazione delle controparti. Quaranta è formale
191
nel derivare dalla propria proposta politica la richiesta che “si apra con la classe medica e con i suoi collaboratori una vera e propria controversia di massa, diretta a far maturare, ma anche a imporre, un consenso perché il quadro socio-culturale della malattia venga radicalmente cambiato”. I tribunali del diritto del malato, nati dalla proposta, si stanno verificando come lo strumento politico adeguato a ottenere il cambiamento.
Chi porta in questa lotta la propria sensibilità di credente non può che trovare una consonanza profonda tra la propria visione dell’uomo e della società e l’impegno di chi cerca una soluzione ai problemi della salute al di fuori dello schema del profitto. Il passaggio da una mentalità prevalentemente assistenzialistica a un atteggiamento politico — in altri termini: dall’accentuazione del dovere di carità da parte di chi presta un servizio di assistenza all’ottica centrata sul diritto del malato e sugli strumenti per rivendicarli — può presentare qualche difficoltà. Ma tra i due atteggiamenti non c’è contraddizione, né nello spirito del Vangelo, né in una considerazione personalistica dell’uomo.
192
G.P. Cabanel, Médicine libérale ou médicine nationalisée? Dunod, Paris 1979, pp. 237.
Il problema della salute è uno dei nodi centrali dell’economia politica in tutti i paesi ad alto sviluppo industriale. Le spese per la salute aumentano ovunque in modo esponenziale, qualunque sia il sistema di distribuzione dei servizi adottato. Il dilemma è quello di conciliare la qualità del servizio con la sua efficacia ed economicità. La difficoltà del problema è costituita dal fatto che l’economia politica applicata alla salute deve tener conto di numerose variabili che trascendono l’ambito tecnico di questa disciplina. La salute e la malattia sono infatti delle realtà sociali, che riflettono ogni minima variazione culturale. Qualsiasi decisione politica in campo sanitario deve necessariamente tener conto della situazione demografica e delle trasformazioni della patologia, senza escludere i cambiamenti che intervengono nella scala dei valori umani (basti pensare alle trasformazioni che intervengono in tutto il quadro sanitario quando la salute viene fatta equivalere, secondo la definizione data dall’OMS, al “completo benessere fisico, psichico e sociale”). D’altra parte, una politica della salute conduce inevitabilmente a delle scelte, a seconda degli orientamenti prioritari verso certe classi di età, verso determinate patologie o finalità sociali. Una politica sanitaria equivale quindi a un progetto di società. Per questo il dibattito sulla salute deve tener presente, oltre agli aspetti tecnici dell’economia politica, anche i valori morali che sottendono tutto il campo della salute. Ciò spiega come mai i sistemi sanitari concretamente in atto nei diversi paesi siano così impregnati di elementi ideologici.
L’opera che presentiamo è stata redatta nella piena consapevolezza del vasto orizzonte di problemi che abbraccia la politica sanitaria di un paese. L’autore — medico, docente universitario e parlamentare, ispiratore di una politica di immunizzazione e modernizzazione delle strutture ospedaliere della regione dell’Isère, di cui è deputato — si è proposto come obiettivo remoto quello di suggerire un insieme coerente di riforme dell’assistenza sociale in Francia; tuttavia in quest’opera prende una certa distanza dai problemi contingenti del suo paese. Presenta un dossier in cui vengono passate in rassegna le soluzioni che hanno dato ai problemi della salute alcune grandi nazioni del mondo: “sette politiche attraverso il mondo”, specifica il sottotitolo del libro. È uno sguardo d’insieme che dà spessore alle scelte della politica sanitaria di un singolo paese.
193
I paesi presi in considerazione sono quelli emergenti sulla scena mondiale: Stati Uniti, Russia e Cina; in Europa: Svizzera, Repubblica federale tedesca, Inghilterra e Svezia. I sette sistemi sanitari sono presentati nelle loro linee essenziali; delle differenti risposte al problema della salute pubblica sono discussi vantaggi e inconvenienti. La scelta dei modelli non è casuale. Ognuna delle organizzazioni sanitarie presentare ha una logica propria, una interna coerenza che si armonizza con l’ideologia politica del paese in questione. La Svizzera è il prototipo del liberalismo europeo: la sua medicina liberale ha raggiunto un’alta qualità e la sua industria farmaceutica un’efficienza invidiabile. La Repubblica federale tedesca ha organizzato anche la salute secondo i principi dell’economia sociale di mercato: una larga garanzia sociale contro la malattia lascia tuttavia sussistere una grande libertà per le professioni sanitarie. La Gran Bretagna (il cui National Health Service è l’unico esempio, tra i paesi occidentali, di un’assistenza sanitaria che ha avuto origine da un progetto unitario e radicale di riforma) e la Svezia costituiscono due esempi di nazioni in cui l’intervento dello Stato si è spinto quanto più lontano poteva senza violare i limiti posti dai principi della vita democratica. Negli Stati Uniti il sistema sanitario è il riflesso dei principi fondamentalmente liberali che governano il paese: la priorità data alla scienza e alla tecnica ha condotto alle più grandi scoperte sul piano medico, ma il servizio sanitario è carente dal punto di vista della protezione sociale e rende possibile l’esistenza di ineguaglianze e ingiustizie. Russia e Cina rappresentano due esempi eminenti della scelta socio-politica antitetica a quella del liberalismo: il sistema sanitario è gestito dallo Stato. La politica sanitaria in questi paesi non obbedisce alla logica delle progressive trasformazioni riformiste, bensì presuppone un sovvertimento rivoluzionario di tutta la compagine sociale. L’indiscutibile merito di questi modelli di nazionalizzazione totale della medicina è quello di presentarci dei sistemi sanitari in cui il primato spetta alla prevenzione e all’educazione sanitaria della popolazione.
L’analisi sinottica dei diversi sistemi sanitari si conclude con un tentativo di bilancio, che offre molti spunti di riflessione. L’interesse di Cabanel è rivolto naturalmente alla situazione francese; ma i problemi che egli agita non mancano di attualità anche per noi italiani.
Una prima conclusione che emerge dal confronto dei sette sistemi sanitari è che la salute pubblica riposa su una scelta politica. L’incentivo al dibattito è offerto oggi, specialmente nei paesi occidentali, dai gravissimi problemi finanziari posti dal costo crescente della salute; tuttavia una
194
risposta adeguata si può trovare solo quando la salute è considerata, oltre che come problema finanziario, come problema eminentemente politico (intendendo la politica nel senso più nobile di organizzazione della vita comune). Gli interrogativi a cui ogni sistema sanitario deve rispondere testimoniano che la salute riguarda l’insieme della società: qual è la parte del reddito nazionale da destinare alla sanità? bisogna preferire una medicina di punta o una medicina di massa? la medicina nazionalizzata sarebbe più efficace di una medicina liberale?
Quest’ultimo interrogativo riassume efficacemente le scelte socio-politiche antitetiche preliminari a ogni riforma settoriale. Cabanel l’ha scelto come titolo del suo libro. Il dossier ricorda a più riprese come le strutture tradizionali dei paesi occidentali siano scosse e i medici stessi sembrino disposti a rimettere in discussione i principi, finora ritenuti sacrosanti, della medicina liberale (libertà d’insediamento per il medico, libera scelta del malato, pagamento all’atto e libertà di prescrizione). Ma alla domanda precisa se la medicina di domani sarà liberale o nazionalizzata, Cabanel risponde che così il problema è mal formulato: solo un processo globale, che tenga conto della trasformazione della società anche a livello culturale e antropologico, può fornire soluzioni realiste. Il politico francese suggerisce che qualsiasi riforma deve ispirarsi al principio del decentramento delle decisioni e condurre a un ripensamento del ruolo dello Stato.
Ma là dove il suo discorso supera decisamente l’ambito della politica sanitaria del suo paese e acquista rilievo per chiunque sia interessato in prospettiva umanistica ai problemi della salute, è nella proposta che il rapporto del singolo con la salute sia considerato nel quadro ideale di un “contratto sociale” (Cabanel riflette l’orientamento teoretico del gruppo “Nouveau Contrat Social”, presieduto da Edgard Faure; sulla riforma dell’assistenza sociale il gruppo ha tenuto un colloquio a Epernay nell’ottobre 1976). Il “contratto” comporta che un professionista della salute vigili sulla considerazione dello stato sanitario delle persone che a lui sono affidate. Il medico generico che assolve a questo compito non si occuperebbe più soltanto dei problemi episodici di terapia: dovrebbe anche svolgere un’opera di prevenzione e sorvegliare la salute sifica e mentale delle famiglie. La chiave di volta del sistema sanitario diventerebbe allora il medico generico, consigliere di famiglia, agente di prevenzione, passaggio obbligato verso le cure mediche più specialistiche e verso l’ospedalizzazione.
Il libro di Cabanel non ci propone panacee per risolvere i problemi ogni giorno più gravi dell’assistenza sanitaria. Sottoponendoci un confronto
195
tra le diverse risposte date da differenti sistemi economico-politici, non annulla il valore degli interventi tecnici di competenza dell’economia politica; ne reclama tuttavia un completamente ad opera di un approccio umanistico del problema della salute. Anche dietro la politica sanitaria indoviniamo il profilo dell’etica medica, che ci invita a cercare risposte che tengano presente tutto l’uomo. La risposta più umana ai problemi della salute verrà da quella società che saprà conciliare la permanenza dei valori morali con la tecnica sicura dell’informatica.
196
Franco Foschi, Salute e società. Ricerche di igiene mentale e psichiatria sociale, Ist. Ital. di Medicina Sociale, Roma 1982, pp. 223
Medicina e società sono realtà correlate. Ogni discorso sulla salute e le sue vicissitudini rimanda al complesso delle strutture sociali, economiche e culturali nelle quali si svolge concretamente la vita dell’organismo umano. La dimensione sociale della salute non è stata certo ignota alla medicina occidentale, a cominciare dalle più antiche intuizioni che risalgono allo stesso Ippocrate. Eppure, in qualche maniera, la medicina tradizionale ha coltivato una certa allergia a inserire malattia e salute nel contesto delle modificazioni socializzate dell’habitat umano. Ha privilegiato il modello individualistico, dove tutto il processo terapeutico si conclude nel rapporto duale medico-paziente. Soprattutto la concezione della medicina come professione liberale ha impermeabilizzato l’arte del guarire dalle provocazioni e dagli stimoli che derivano dal considerare la tutela della salute come fatto collettivo. Molto opportunamente Foschi cita Shelby: “Come non si può considerare un individuo veramente libero se il suo prossimo è in catene, nessuno potrà essere considerato come del tutto sano se gli altri attorno a lui sono malati”. In altre parole, il modello classico della salute — mens sana in corpore sano — va completato con un terzo pannello del trittico: in societate sana. È una questione antropologica, prima ancora che etica. La dimensione legale della tutela della salute, quale preoccupazione dello Stato per la salute dei cittadini, si allarga nel moderno concetto del diritto-dovere alla salute quale bene massimo dell’individuo e interesse della società. Ciò è vero soprattutto per la medicina di domani, chiamata ad essere anzitutto una medicina sociale. In essa gli operatori sanitari — i medici in primo luogo — dovranno svolgere una funzione pubblica. Questo è il tessuto di valori sottostante alla riforma sanitaria. Sempre più chiaramente le carenze evidenziatesi nella sua attuazione e l’inerzia che paralizza il rinnovamento del sistema sanitario italiano appaiono come frutto amaro della mancata assimilazione dei principi ispiratori, più che come deficienze tecniche.
Un buon correttivo alla tendenza a interpretare in chiave riduzionistica il nostro rinnovamento sanitario è la lettura degli scritti di Franco Foschi raccolti in questo volume. Nella duplice veste di politico e di medico, come ricorda Lorio Reale nel presentare il volume edito a cura dell’Ist. di Medicina Sociale, Foschi è stato uno dei protagonisti della riforma. Il suo interesse si è appuntato in modo particolare sui problemi della
197
psichiatria sociale, studiando le conseguenze delle migrazioni rurali e dello sviluppo industriale sull’igiene mentale. Fedele agli assunti di base della medicina sociale, considera le psicosi e le nevrosi in rapporto con le trasformazioni sociali e con l’ambiente. Senza tuttavia cadere nell’altro estremo, come coloro che si limitano alla ricerca sociogenetica delle malattie e vogliono vedere solo le origini socio-economiche dei mali dell’uomo: tra l’uomo e l’ambiente, infatti, esiste una dialettica bilaterale, in cui l’uomo si realizza in dipendenza dall’ambiente, ma al tempo stesso realizza l’ambiente.
Due altre manifestazioni del disadattamento alla società, che si traducono in quadri patologici, sono le condizioni degli handicappati e quella degli anziani. Ad ambedue Foschi dedica un’attenta indagine. Completa il volume una parte documentaristica costituita da studi sulla nuova politica delle attrezzature sociali, sull’organizzazione dei servizi sociali e sul pluralismo della solidarietà sociale, nonché un’informatissima “Relazione sullo stato dell’assistenza in Italia”, che rispecchia l’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Interni della Camera dei deputati nel 1971.
198
Francs-tireurs de la médicine, “Autrement”, n. 9, maggio 1977, pp. 238.
La rivista Autrement è pressoché sconosciuta in Italia. In Francia invece si è conquistata un pubblico d’élite, che ne apprezza la novità della formula e la qualità dei contenuti. Ha come programma di gettare “uno sguardo critico, libero di a priori, sulle mutazioni, innovazioni culturali e sociali che formano l’attualità profonda del nostro tempo”. Appare a scadenza trimestrale, sotto forma di voluminosi dossiers monografici. Il tema scelto viene abbordato con un duplice approccio: inchieste sul terreno e valutazioni di specialisti delle scienze dell’uomo. Un insieme di indizi lascia pensare che l’ispirazione dell’équipe animatrice sia cristiana; ma nessuna apologetica, anzi neppure una esplicita professione di fede. I contenuti, tuttavia, sono quelli promossi dall’antropologia cristiana.
Il numero che presentiamo è dedicato alla medicina. Ma quale medicina? È subito necessaria una precisazione. Non si tratta della medicina scientifica. Ma neppure dell’“altra”, la sua rivale selvaggia, quella che si fregia del titolo di “medicina alternativa”, o “naturale”, o — ad evitar proprio ogni pericolo di confusione — di “anti-medicina”. Niente neppure di ciò che ormai costituisce la trama costante dei dibattiti attuali sulla medicina. Ne siamo preavvisati in apertura di volume: “Non troverete in questo numero gli argomenti abitualmente dibattuti quando si parla di medicina o di salute: l’importanza crescente delle spese mediche e dei rimedi al deficit della Sicurezza Sociale, la disuguaglianza di accesso alla salute, il costo della tecnologia medica, l’orientamento della ricerca, la disumanizzazione e la tecnicità delle relazioni medico-malato (all’ospedale e fuori), la qualità delle cure, lo spreco farmaceutico. Neppure grandi trattazioni sulla morte, l’eutanasia, la contraccezione o l’aborto, le malattie della civilizzazione, le medicine parallele, l'automedicazione...”. Che cosa costituisce, dunque, l’oggetto di questo dossier? È la pratica medica quotidiana di un piccolo numero di professionisti che cercano di reinventare le strutture fondamentali della professione stessa. Il loro scopo: opporsi a una gestione della salute ad opera esclusiva della tecnologia medica, proporre una vera collaborazione tra medici e ausiliari medici, e fare in modo che gli utenti imparino progressivamente a prendere cura di se stessi.
Per completare l’identità dei “nuovi” medici che qui prendono la parola, bisogna aggiungere che si tratta per lo più di giovani (sulla trentina), e che professionalmente sono medici generici. Sono questi, infatti,
199
più che gli specialisti, gli intermediari più adatti tra la popolazione e la medicina scientifica. Provengono da tutta l’area francofona: Parigi e la banlieu, Lione, Tours, Bruxelles, fino a Québec.
La prima sezione del volume è dedicata alla scoperta di nuovi ruoli individuali e nuove pratiche di gruppo. Il comun denominatore dei medici qui presentati è di non voler giocare a fare il dottore... Le rimesse in discussione nel campo della professione sono dure. Ma è preferita l’autocritica, piuttosto che un’ennesima denuncia generica del potere medico e delle disfunzioni del servizio sanitario. Dalle testimonianze rese in prima persona emergono le contraddizioni già note: nei rapporti coi malati e con le istituzioni, tra i diversi stati gerarchici della piramide sanitaria, tra l’azione terapeutica e l’ambiente in cui si svolge la vita quotidiana. Per abolire il mercantilismo medico e uscire dai ceppi di ferro del ruolo, un rimedio di grande efficacia è costituito dal lavoro in équipe. Le iniziative pullulano: “case mediche” di quartiere, centri sanitari, fino all’estrosa “boutique de santé” di Tours. Lo scopo comune è quello di favorire l’accesso alle cure agli strati sociali più sfavoriti. Attraverso queste istituzioni a misura d’uomo si cerca di insegnare alla gente a diventare protagonisti del processo di guarigione. Come primo passo è necessario riconoscere la causa delle malattie insita nelle modalità concrete del lavoro, del cibo, del ritmo di vita, dell’abitazione. Alcuni gruppi sono fortemente ideologizzati — era da aspettarselo —. In qualche iniziativa l’elemento politico sembra prevalere su qualsiasi altra finalità. Ma se non ci si lascia spaventare dalle intemperanze verbali e si guarda più alle cose che vengono fatte che alle parole dette, allora emerge a grandi linee l’abbozzo di una medicina che differisce qualitativamente dalla medicina contemporanea. Una medicina dalla base e per la base; una medicina a qualificazione popolare.
Un’ampia sezione è dedicata alle istituzioni di prevenzione. Prendono la parola coloro che operano nel campo della medicina scolastica, del lavoro, della protezione della madre e del bambino. Anche qui, denuncia dell’ambiguità di questi servizi, timore di fronte all’estendersi di un impero terapeutico che tende a medicalizzare tutta la vita. E proposte nuove. Ne citiamo almeno una, destinata a rinnovare i servizi sociali destinati agli adolescenti: le “free clinics”, o consultazioni di medicina generale. Offrono ai giovani, o all’insieme della popolazione di un quartiere, prestazioni mediche qualificate, in condizioni di accesso facilitato, sprovvisto di formalità amministrative e di tempo di attesa. La loro pratica medica mette l’accento sulla relazione medico/malato, insiste sulla liberalizzazione e l’autonomia
200
di certe categorie di pazienti e si fonda infine su una concezione nuova della medicina sociale. Altro campo di innovazione è quello della formazione dei medici e del personale sanitario. Ancora ben lontani dall’aver trovato soluzioni decisive per questo nodo problematico, rivolgiamo tutto l’interesse ai primi tentativi di formazione alternativa: il centro sperimentale di formazione di Bobigny e l’esplorazione di innovazioni nella facoltà di medicina di Maastricht, in Olanda, che ha iniziato la sua attività nel 1974.
Coloro che sono più interessati alle analisi socio-culturali troveranno le loro esigenze ampiamente soddisfatte dalla quarta sezione del dossier. Un sociologo vi studia la “crisi delle istituzioni e potere medico” (con un’analisi dettagliata della medicina liberale e delle spinte sociali che tendono a superarla); un ricercatore compara i programmi e le rivendicazioni dei partiti francesi e delle organizzazioni sindacali in materia di sanità (“A sinistra, a destra, quale discorso, quale progetto?”); vengono riportati i risultati di un sondaggio tra medici, invitati a esprimersi sui problemi più importanti che oggi il corpo medico francese deve affrontare. E ancora: uno studio volto ad appurare la trasformazione dell’immagine del medico nello spirito dei suoi clienti, realizzato mediante lo spoglio della corrispondenza di una trasmissione radiofonica e mediante inchieste svolte in ambiente rurale; l’analisi della pubblicistica medica degli ultimi dieci anni, per mettere a punto i termini trattati e la concezione di fondo della medicina che emerge da questi libri scritti da medici per un pubblico non professionista (l’indagine prende in considerazione più di 250 opere).
Non si può fare oggi un dibattito sulla medicina senza considerare l’apporto di Ivan Illich. La “rottura Illich”, come è qui chiamata. La rivista ha invitato diverse persone, che conoscono bene sia le tesi di “Nemesi medica” sia i problemi che si pongono oggi in Francia nel campo della salute, a un libero scambio. Nel dossier è riportato un resoconto di quel colloquio.
Il voluminoso dossier contiene molte altre cose ancora. Ma a questo punto, suscitata la curiosità, bisogna pur lasciare qualche spazio alla scoperta personale. “Chapeau!” ai nostri cugini d’oltralpe per aver intrapreso questa coraggiosa rassegna di fermenti di novità nel campo della prassi sanitaria in atto nel loro paese. Speriamo che qualcuno in Italia sia invogliato ad intraprendere un analogo bilancio di ciò che è in sperimentazione da noi. Ce lo. auguriamo, ma non per avere qualcosa da contrapporre, con spirito gretto di sciovinismo, ma perché è necessaria una mobilitazione generale della fantasia creatrice per uscire dall'impasse sanitaria attuale. Si tratta, in fondo, della nostra pelle.
201
Pierre Solignac, Ces malades mal-traités, éd. de Trevise, Paris, pp. 247.
Pierre Solignac non è uno sconosciuto in Italia. Un suo volume è stato tradotto presso le edizioni Boria: La nevrosi cristiana, Roma 1977. Avvalendosi della sua duplice qualifica di medico e di psicoterapeuta, Solignac esplorava in quel lavoro i condizionamenti specifici che possono essere fonte di nevrosi per i cristiani, e concludeva con la prospettiva di “una nuova educazione e una nuova chiesa”, sul modello di “Gesù, uomo libero”. È facile presumere che, nonostante la lusinghiera presentazione di Adriano Ossicini alla traduzione italiana, il nome di Solignac sia stato messo nella lista nera da parte di coloro che non amano abbattimenti di steccati scientifici e commistioni di discipline e prassi diverse: psicologia da una parte, religione dall’altra; e ancora: medicina organica per curare le “vere” malattie, psicologia per le altre (per i malati “che non hanno niente”, o la cui malattia in ogni caso non può essere ricondotta a qualcosa di organico). Chi non è disposto a rimettere in discussione questi schemi non prenda in mano l’ultimo volume di Solignac: si esporrebbe a un penoso dialogo tra sordi.
La tesi di Solignac è già tutta nel titolo: i malati sono “maltrattati”. Non si riferisce ai maltrattamenti dovuti al cattivo funzionamento degli ospedali o all’incuria dei sanitari: quei maltrattamenti, per intenderci, dei quali si occupano da noi i tribunali per i diritti del malato. I malati, sostiene Solignac, sono maltrattati in quanto non sono curati nella maniera giusta, vale a dire secondo le esigenze della persona. Il bersaglio polemico di Solignac è la medicina tecnologica, il cui scopo essenziale è quello di diagnosticare la malattia. Riduce il malato a oggetto, per sottoporlo a esami sempre più numerosi e sofisticati, ma col risultato di allontanarsi sempre di più dalla comprensione della malattia. Qualunque sia l’organo malato, è indissociabile dalla storia della persona. E la persona è inevitabilmente inserita nel tessuto delle relazioni sociali. Per capire la malattia è indispensabile rendersi conto che siamo obbligati a vivere in una società aggressiva e strutturata in modo che, come i topi di Laborit, non abbiamo che tre soluzioni: batterci, fuggire o cadere ammalati. Il malato è essenzialmente una persona in disequilibrio che bisogna aiutare a riequilibrarsi. È quindi la logica stessa della medicina come impresa terapeutica che domanda un approccio della malattia come fatto psico-socio-biologico. La malattia non può essere efficacemente curata se si non tratta la persona nel suo insieme e nella sua totalità.
202
Discorsi già sentiti molte volte, si dirà. È vero: Solignac non è originale nella diagnosi dei mali di cui soffre la medicina moderna. Non è originale neppure nel nome che attribuisce alla sua proposta alternativa (“medicina della persona”: già Paul Tournier aveva fatto ricorso alla stessa etichetta programmatica, col consenso di pensatori “personalisti”, come Jacques Sarano). L’apporto di Solignac è di altro genere: più pratico-operativo, che teoretico. Dimostra, con ampi riferimenti alla propria pratica clinica, l’operatività del modello che auspica. I numerosi dialoghi con i pazienti non sono solo un espediente letterario per dare vivezza al saggio. Man mano che la lettura procede, le considerazioni teoriche passano sullo sfondo, mentre il concreto rapporto medico-paziente basato sull’ascolto diventa la figura. A chiusura del libro, rimaniamo a domandarci: come si può assicurare la qualità di quel rapporto, senza una formazione psicoterapeutica del medico? Se è vero, secondo i calcoli approssimativi di Solignac, che i malati “funzionali a check up normale” affollano i gabinetti medici nella proporzione del 70-80 per cento, viene da pensare che la medicina tecnologica sta andando nella direzione sbagliata. E ci va di corsa.
203
AA. VV., Médicine et expérimentation, Les Presses de l’Univ. de Laval, Québec, 1982, pp. 461.
È il quarto volume di una preziosa collana (Cahiers de bioétique), pubblicata dal «Centre de bioétique» dell’istituto di ricerche cliniche di Montreal. L’impostazione di fondo dell’istituto, e di conseguenza della collana, è dettagliatamente esposta nel volume che inaugura la collana stessa, La bioéthique, Québec 1979. Essa intende offrire un luogo che favorisca la riflessione collettiva di persone differenti per filosofia della vita e complementari per la loro competenza ed esperienza.
Tale riflessione è resa inderogabile dai profondi cambiamenti che si delineano in tutta l’organizzazione della vita sulla terra. Per quanto riguarda la sperimentazione in medicina, l’orientamento prevalente nei diversi autori che collaborano al volume prende le distanze dagli atteggiamenti fondamentalisti, che sono soliti associare la ricerca agli abusi nella sperimentazione e alla necessità di proteggere i soggetti umani. È vero che è richiesta una vigilanza costante per garantire che la dignità, la libertà e il benessere dell’uomo siano rispettati; ma è anche vero che in biomedicina la protezione e il benessere stesso del soggetto esigono ricerche e sperimentazione. La ricerca biomedica è dunque una necessità morale, non solamente una necessità scientifica. Dai diversi saggi che compongono il volume emergono due momenti culturali di preoccupazione dominante nelle ricerche biomediche. Il primo ha insistito particolarmente sull’obbligo di assicurare la protezione del soggetto umano; il secondo, pur continuando a rispettare questo obbligo, mette maggiormente l’accento sulla collaborazione attiva della comunità col mondo della ricerca biomedica.
204
J.P. Escande, La deuxième cellule, ed. Grasset, Paris 1983, pp. 306
Il libro è costruito alla maniera delle bambole russe, inserite l’una dentro l’altra, dalla più grande alla più piccola. Parte da una presentazione generale della medicina moderna, per passare al funzionamento normale del corpo umano (“la pace nel vivente”). Dallo stato di pace l’interesse si sposta a quello di conflitto cellulare, quale si verifica nel cancro. Vengono esposte le basi della cancerologia classica, passando in rassegna le ricerche attuali sul cancro e le prospettive terapeutiche. Solo a questo punto emerge l’ipotesi della “seconda cellula”, come teoria originale per spiegare scientificamente il cancro ricorrendo al modello biologico della simbiosi. L’ultima bambolina per l’A. è talmente importante che le dedica il titolo del libro. J.P. Escande è pienamente consapevole di quanto la sua mossa sia rischiosa. Professore universitario di medicina a Parigi, è noto al grande pubblico francese per dei volumi sui problemi della sanità (Les médecins, 1975; Les malades, 1977) che sono stati dei clamorosi successi editoriali. Come scrittore sa abbinare una precisa documentazione a una consumata abilità di narratore, sciogliendo i nodi teorici e le costruzioni concettuali della scienza in aneddoti che catturano l’immaginazione e si fissano nella memoria. Anche La deuxième cellule è costruita per due terzi con la medesima ricetta. Ma poi Escande fa qualcosa di più: pur non avendo nel proprio credito scientifico ricerche specialistiche sul cancro, si avventura nella proposta di una teoria che individua nel meccanismo simbiotico il fattore decisivo che fa passare dal “terreno” genetico predisponente al cancro costituito. Non pretende di dare un calcio a tutta la ricerca precedente: integrando, piuttosto, gli altri approcci del problema biologico del cancro, propone un passo ulteriore, ricco di conseguenze sia teoriche che pratiche. Da una più solida concezione del cancro ci si può aspettare progressi decisivi nella terapia. Se esiste una “seconda cellula”, partner mascherato ma essenziale di quella cancerogena, la strategia terapeutica più vantaggiosa sarà quella di rompere l’associazione simbiotica (quell’alleanza esclusiva con benefici reciproci di due popolazioni cellulari), piuttosto che il bombardamento della cellula maligna. L’ipotesi della “seconda cellula” resta, tuttavia, sostanzialmente un’intuizione, sulla quale dovrà applicarsi la ricerca, piuttosto che una teoria già solidamente provata con i criteri del metodo scientifico. Perché, dunque, Escande ha rischiato questa sortita, che altri avrebbero evitato come
205
pregiudizievole per il proprio credito scientifico? Una risposta ce la fornisce con le parole di Jean Bernard. L’illustre scienziato avrebbe detto, in sostanza, ad Escande: “O lei ha torto... e ciò non avrà alcuna importanza; oppure lei ha completamente ragione, e allora lei immagina il seguito...; oppure — e ciò è più probabile — lei avrà ragione su un punto, e la nuova prospettiva porterà alcuni a riorientare la ricerca”. Una specie di scommessa pascaliana, in definitiva, in cui non c’è niente da perdere e molto da guadagnare.
La risposta può essere considerata soddisfacente, ma ha il demerito di non far emergere i principi epistemologici che guidano Escande. I quali sono in sintonia con quelli di un grande ricercatore, eminentemente “intuitivo”, che Escande considera come un maître à penser: René Dubos. Al pensiero scientifico di Dubos Escande ha dedicato un libro prezioso, sotto forma di intervista: Chercher (Paris 1979). E, per sua stessa ammissione, l’intuizione che il modello della simbiosi potesse spiegare il cancro l’ha avuta leggendo in un libro di Dubos, Célébrations de la vie, di quella singolare simbiosi di un’alga e di un fungo che dà origine all’esplosiva bio-massa dei licheni. Più formalmente, Escande si rifà alla filosofia della scienza proposta da Thomas Kuhn, per il quale la scienza procede solo quando un nuovo “paradigma” fa saltare i catenacci del sapere scientifico “normale” e crea un modello rivoluzionario sul quale si ricalcherà la scienza del futuro. Il ricercatore creativo fa proposte originali e non conformiste; presenta un nuovo paradigma, non ancora confortato dalla dimostrazione, la quale sarà fornita in seguito da “ricercatori-amministratori”. Il modello insuperato di questo modello di ricercatore creativo è Louis Pasteur, che nel libro di Escande fa ripetutamente capolino, fin quasi a creare il sospetto che Escande gli faccia svolgere la funzione di “alter ego”.
Può darsi, in definitiva, che l’idea preconcetta secondo cui le caratteristiche proprie del fenomeno simbiotico sembrano rendere conto delle caratteristiche essenziali del fenomeno canceroso non si dimostri vera, al vaglio della ricerca, e che quindi non porti a risolvere direttamente il problema del cancro. Anche se ciò avvenisse, La deuxième cellule avrà ugualmente costituito un modello di ricerca scientifica creativa. E ciò — ha l’aria di dire Escande — val bene un’ipotetica “figuraccia”!
206
N. Cousins, La volontà di guarire, Ed. Armando, Roma 1982, pagg. 119.
Appare finalmente in traduzione italiana un libro che gode già una certa reputazione negli ambienti medici. È noto nel suo titolo originale: “Anatomia di una malattia”. Con lo stesso titolo l’A. aveva pubblicato, prima del volume, nell’autorevole rivista (New England Journal of Medicine” un resoconto della propria malattia e della strategia terapeutica che l’aveva condotto alla guarigione (l’articolo è posto ora come primo capitolo del libro). La risonanza era stata immediata, anche fuori degli Stati Uniti. Tremila lettere da una dozzina di paesi diversi hanno portato a Cousins “l’evidenza di un atteggiamento di crescente disponibilità, da parte di numerosi medici, verso l’accettazione di approcci terapeutici innovatori e perfino anticonvenzionali, nel trattamento di gravi malattie”.
Nel 1964 Cousins era stato colpito da una forma acuta di spongilite anchilosante, una malattia che comporta la disintegrazione del tessuto connettivo della colonna vertebrale. La prognosi era infausta: per i medici era condannato a una paralisi progressiva, con dolori lancinanti. Cousins avrebbe potuto arrendersi alla condanna, e sarebbe stato l’inizio della fine. Invece si è ribellato. Fino a quel momento aveva lasciato che fossero i medici a occuparsi delle sue condizioni: aveva portato il corpo in ospedale e l’aveva affidato ai medici, come si lascia una macchina del meccanismo per la riparazione. Ora invece decide di abbandonare il ruolo di osservatore passivo e di entrare personalmente in azione. Lascia l’ospedale (“mi stavo convincendo sempre di più che un ospedale non è il posto adatto per una persona seriamente ammalata”): si installa nell’ambiente più confortevole di un albergo, scoprendo con sorpresa che l’albergo veniva a costare meno dell’ospedale!; e imposta, d’accordo con il suo medico personale, una diversa strategia terapeutica. La quale comprende un’assunzione massiccia di acido ascorbico (la vitamina C), ma soprattutto il ricorso a quella incomparabile medicina che è la volontà di vivere. Se è vero, come ha dimostrato Hans Selye con i suoi classici studi sullo stress, che le emozioni negative hanno un effetto sulla chimica dell’organismo, non si può ipotizzare che sia vero anche il contrario, che cioè le emozioni positive possono provocare modificazioni benefiche? E che l’amore, la fede, la fiducia e la volontà di vivere hanno un valore terapeutico? A cominciare dalla manifestazione più eclatante della volontà di vivere, che è la risata. Per favorire il riso Cousins ricorse all’artificio,
207
facendosi proiettare film comici o leggere libri umoristici: scoprì che dieci minuti di risate a crepapelle avevano un effetto anestetico e gli concedevano almeno due ore di sonno senza dolore (Moody ha dedicato un libro a divulgare gli effetti terapeutici della risata: Il riso fa buon sangue, ed. Mondadori 1979).
Nel riferire la propria vicenda Cousins evita ogni tono trionfalistico. Non pretende di essere l’inventore di qualsivoglia nuova terapia. Ciò che ha imparato, e intende proporre all’attenzione di tutti, è di non sottovalutare mai la capacità di recupero della mente umana e dell’organismo, anche quando le prospettive sembrano le più infauste. Fideismo, il suo? La miracolosità della propria guarigione, come delle tante che costellano la storia della medicina, non supera l’orizzonte che si dischiude quando la medicina si decide a lasciare che i fattori psichici giochino la loro parte nel processo della guarigione. La mente e il corpo possono mettere insieme le loro risorse per attivare quel principio di autoguarigione che è insito in tutti gli organismi. Piuttosto che una proposta di irrazionalismo reazionario, quella di Cousins è una sfida alla medicina moderna a diventare non meno scientifica, bensì più scientifica. Ciò si realizzerà quando la medicina vorrà studiare, con gli strumenti che le sono propri, gli effetti sull'organismo dei fattori morali, psicologici e spirituali. La medicina diventerà più scientifica quando avrà imparato a gestire le forze del corpo e della mente che operano nella vis medicatrix naturae. Quello che è lecito attendersi dalla scienza è nientemeno che la scoperta della “chimica della volontà di vivere”. Proprio così: è legittimo ipotizzare una diretta connessione tra una robusta volontà di vivere e gli equilibri chimici del cervello. In questo progetto Cousins trova un alleato di grande autorità nello scienziato René Dubos, il quale afferma nella prefazione al libro: “Anche se i meccanismi di guarigione spontanea da malattie organiche e mentali non sono completamente corporei, si può supporre che tutti agiscono attraverso alcuni comuni canali organici e che l’organismo ha solamente un limitato repertorio di reazione rispetto ad agenti terapeutici tanto diversi come i tranquillanti, l’imposizione delle mani, la meditazione trascendentale, l’uso delle tecniche di biofeedback, le pratiche zen e yoga, la fede in un santo, in una persona e in medicinale e, ovviamente, la particolare relazione medico-paziente”.
Cousins non ha scritto, dunque, un libro contro la medicina o contro i medici; né i problemi da lui posti vanno visti come una riserva sulla validità della medicina scientifica. Lungi dall’affermare l’inutilità dell’intervento
208
medico, Cousins intende perorare una più stretta corresponsabilità tra medico e paziente rispetto all’obiettivo della guarigione.
Il correttivo che propone alla medicina tecnologica, troppo fredda e frustrante, affinché ritrovi la dimensione dell’uomo, sono i principi evidenziati dal movimento della medicina olistica. Questa parte da una sfiducia verso i farmaci, visti non solo come salvatori, ma anche come potenziali pericoli; accentua il valore profilattico e terapeutico di un’appropriata nutrizione; contrasta la tendenza alla specializzazione, secondo le singole sfere dell’anatomia, privilegiando l’integrazione che si realizza in un rassicurante rapporto medico-paziente; potenzia la capacità della mente umana a svolgere una funzione di primo piano sia nel prevenire la malattia, sia nel debellarla quando essa si verifica. Cousins porta un contributo non trascurabile per il superamento della sterile polemica tra chi rigetta, in blocco, tutta la medicina cosiddetta allopatica e chi, in nome della scienza, si chiude a ogni richiesta di rinnovamento. Con la particolare forza persuasiva che deriva dalla sua esperienza personale, ci ricorda che la cosa più importante da apprendere o insegnare in medicina è la maniera in cui la mente e il corpo possono mettere insieme le loro risorse interiori per affrontare le prove più difficili. La principale alleata del medico è la forza rigeneratrice e di recupero degli essere umani. E se questa forza talvolta è bloccata, è compito della medicina come “arte” saperla risvegliare.
209
J. Kellerhals - W. Pasini, Perché l’aborto?, Mondadori, Milano 1977, pp. 357.
Tra il giugno 1970 e il giugno 1971 le donne residenti a Ginevra che intendevano abortire furono invitate a seguire una procedura speciale. La legislazione ginevrina prevede l’aborto nel caso che subentri un “rischio grave e permanente per la salute della madre”. La prassi abituale è la seguente: quando il ginecologo costata che esistono i motivi di interruzione conformi alle disposizioni del codice penale, indirizza la paziente a un perito medico la cui specializzazione (medicina interna, psichiatria, ginecologia ecc.) riguardi il genere di rischio a cui è esposta la madre. I periti medici sono designati dal Consiglio di Stato del cantone di Ginevra. Se in perito medico conferma i timori del ginecologo, alla gestante viene rilasciato un “parere favorevole” che autorizza l’interruzione della gravidanza. L’aborto viene praticato in un istituto ospedaliero o in una clinica scelti dalla paziente.
Nel periodo in questione le richiedenti, tra la visita del ginecologo e il colloquio col perito, hanno dovuto espletare una formalità non prevista dalla prassi usuale. Sono state invitate a presentarsi a un’équipe costituita per condurre un’indagine socio-psicologica. Una donna su due è stata sottoposta a un’intervista di circa un’ora (campionatura a caso). Ricevuta l’assicurazione che l’intervista era anonima e he le risposte non sarebbero state trasmesse al perito incaricato di decidere circa la loro richiesta (e che quindi non avrebbero interferito in nessuna maniera sulla sua decisione) quasi nessuna rifiutò. L’universo-base dell’inchiesta era costituito, dunque, dall’insieme delle donne residenti a Ginevra (cittadine svizzere e straniere), richiedenti l’interruzione legale della gravidanza. Il campione intervistato comprendeva 906 persone.
Ancora qualche dato tecnico. L’inchiesta non si serviva né di un approccio strettamente clinico, né di un approccio basato interamente su questioni precodificate. Si trattava piuttosto di un miscuglio di diverse tecniche: nel questionario tutti i dati situazionali erano precodificati, ma i motivi della richiesta di interruzione della gravidanza erano contemplati alla luce di domande aperte (procedimento necessario per affrontare i problemi dei motivi della richiesta e del conflitto).
L’inchiesta è stata condotta sotto la direzione di un sociologo, Jean Kellerhals, e del noto psichiatra sessuologo Willy Pasini. Non nuovi, né l’uno né l’altro a questo tipo di indagini. Le ricerche precedenti hanno
210
fornito spunti e problematiche a quella presente. In particolare costituisce un punto di riferimento obbligato l’inchiesta, svolta ugualmente a Ginevra a partire dal 1966, circa gli effetti somatici, psicologici e sessuali legati alla pratica della contraccezione. Pasini stesso ha pubblicato le riflessioni medico-psicologiche sui dati forniti dall’inchiesta in un libro già apparso anche in Italia (Contraccezione e desiderio di maternità, Feltrinelli, Milano 1975). Il legame psicologico tra contraccezione e aborto emergeva già in quell’opera nelle sue componenti principali, che vengono ampiamente confermate in questa indagine.
I promotori dell’inchiesta prima di mettersi al lavoro hanno cercato di documentarsi coscienziosamente sulle analoghe ricerche precedenti. L’indagine bibliografica è stata breve (pp. 78-95). È risultato confermato quanto osservava A.M. Dourlen-Rollier circa la carenza di letteratura scientifica in merito: “Questo problema millenario continua ad essere argomento pressoché inesplorato. Eccezione fatta per qualche saggio medico e giuridico, per qualche indagine filosofica e religiosa, l’aborto sembra dimenticato da ricercatori e sociologi. Si è davvero tentato di spiegarlo o non piuttosto di descriverlo?”. Gli esordi della letteratura scientifica sull’aborto si situano alla fine della prima guerra mondiale, mentre in precedenza non si trovano che prese di posizione politiche e morali. Le ricerche recenti di occupano dei problemi sociodemografici e psicologici. Vertono principalmente sui postumi psichiatrici dell’aborto stesso, sul rapporto tra contraccezione e aborto, e sui motivi e conflitti inerenti alla richiesta d’aborto.
Kellerhals e Pasini hanno inteso dare al loro lavoro la rigida neutralità di un’inchiesta scientifica, che rileva i dati senza entrare nell’ambito dei valori. Hanno anche rinunciato “a prendere una posizione politica o a proporre soluzioni”. Si limitano ad auspicare che la loro opera possa servire ad aiutare i responsabili politici, nonché le donne e le coppie, a “individuare meglio, al di là degli ostracismi, le vie della solidarietà” (p. 37). Tuttavia siamo lontani da quelle ricerche che si riducono ad una pletorica raccolta di cifre. Qui il disegno è chiaro. E il risultato è convincente: si fa un po’ di luce sulla grande incertezza circa l’aspetto psicologico e sociale dell’aborto, cosicché ora ci sembra di avere un’immagine relativamente esatta della richiesta d’aborto. Rimanendo però nei limiti della situazione socio-culturale presa in esame e resistendo alla tentazione di fare delle generalizzazioni.
Al lavoro di Kellerhals e Pasini bisogna riconoscere il merito di obbligarci a una revisione di molti stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi
211
connessi all’aborto. Ciò non vuol dire che d’ora in poi bisognerà sospendere il giudizio morale e assumere come unico parametro per l’azione i risultati delle scienze umane. La tirannia dei dogmatismi pseudo-scientifici è peggiore della soggezione a dei principi religiosi o etici. Ma l’azione politica sarà più efficace se sarà programmata sulla base della reale conoscenza del profilo socio-psicologico dell’aborto, piuttosto che sotto la pressione di prese di posizione passionali, che impervesano a proposito dell’aborto. Cerchiamo ora di verificare in dettaglio questo cambiamento di prospettiva nei cinque grandi settori in cui si articola la ricerca.
Il primo scopo che l’indagine si proponeva era quello di tracciare un ritratto socio-demografico delle donne che richiedono l’interruzione volontaria della gravidanza. La lettura dei dati porta a conclusioni che contrastano totalmente con un numero notevole di stereotipi relativi all’aborto. In particolare deve essere scartata l’ipotesi della marginalità, sia sociale che economica. Spesso si considera infatti l’aborto come la conseguenza di un eccesso di figli, il prodotto della miseria economica delle famiglie, la soluzione di “incidenti” che capitano a donne troppo giovani o troppo anziane per generare. Dalla inchiesta risulta che l’aborto è la manifestazione di una popolazione “normale”. L’identikit della maggioranza delle richiedenti comprendi i seguenti tratti:
― donne comprese tra i 21 e i 30 anni, dunque né minori di età né attempate;
― le quali hanno, per quanto riguarda le coniugate, da uno a due figli;
― il cui reddito familiare può essere definito medio nella maggior parte dei casi, alto nel 20% e basso nel 25% dei casi;
― cui livello di istruzione non è molto basso;
― e ricorrono (nel 45% dei casi qualora si tratti di coniugate e nell’80% qualora si tratti di nubili) all’aborto in maniera congiunturale; in altre parola, le donne in questione si ripromettono di avere uno (o un altro) figlio in avvenire (p. 138).
Questi dati sono ancor più impressionanti di quelli relativi alla frequenza numerica delle interruzioni legali della gravidanza. Nella città di Ginevra, nel periodo preso in esame, si sono avute da 4 a 5 domande di interruzione legale per 10 nascite (una delle percentuali più elevate del mondo occidentale). L’aborto è dunque un comportamento assai diffuso. Ma soprattutto è un comportamento “normale”; nel senso che sociologicamente non si può giustificare un’associazione tra aborto e patologia del comportamento. Gli Autori si sentono autorizzati da questa constatazione
212
ad ammonire di non utilizzare il luogo comune della marginalità per sostenere misure socio-politiche favorevoli alPaborto: “Le opzioni politiche che, per liberalizzare le norme relative all’interruzione, volessero basarsi sulla nozione di situazione marginale (sotto diversi punti di vista) non troverebbero, nei nostri dati, molti argomenti cui far ricorso” (p. 136).
Il secondo settore della ricerca riguarda il controllo preventivo della fecondità. Solo il 3% delle donne intervistate preferisce l’aborto alla contraccezione. Perché dunque nella stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità del campione, che preferisce il controllo preventivo, questo non ha funzionato? Le ragioni sono diverse. C’è anzitutto la mancata accettazione in profondità della pianificazione. Vengono confermate così le osservazioni che aveva già fatto Pasini nel suo precedente volume: esistono numerose resistenze psicologiche, sia consce che inconsce, alla contraccezione. Esse sono state la causa principale dei concepimenti indesiderati che portano alla richiesta di aborto legale. Tra le altre cause che incidono sull’efficacia del controllo delle nascite Kellerhals e Pasini sottolineano il grado di comunicazione tra i partners della relazione sessuale; il grado di informazione obiettiva delle persone interessate al processo di riproduzione e al suo controllo; il conflitto più o meno accentuato tra la volontà effettiva di controllare la propria fecondità e l’eventuale rifiuto, per motivi etici, dei mezzi contraccettivi moderni. A questo proposito, i dati non sono univoci. È stato sottoposto a indagine il ruolo che i fattori ideologici svolgono in materia di contraccezione. Ne sono stati considerati due: la religione e l’immagine che ci fa del feto (p. 162 ss.). La conclusione generale è che le reticenze morali verso l’aborto non sembrano comportare un controllo più efficace della fecondità. Anzi, tra le nubili cattoliche sembra vero il contrario: le praticanti presentano un controllo assai meno rigoroso delle non praticanti. Tuttavia, in generale, il controllo della fecondità sembra dipendere assai più da fattori situazionali concreti (psicologici e sociali) che da fattori ideologici in senso stretto. La rilevazione più carica di conseguenze che ricaviamo da questo capitolo della ricerca è che, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la contraccezione “non va da sé”. La popolazione nel suo complesso è caratterizzata da un tipo di controllo dubbio nelle sue motivazioni e inefficace nei suoi effetti, la cui conseguenza logica è la frequenza del ricorso all’aborto. Finché l’insieme della popolazione non avrà acquisito l’adeguato apprendimento di sistemi di controllo efficaci, lo spettro dell’aborto continuerà ad aggirarsi tra di noi.
213
Il nucleo centrale dell’inchiesta verte sui motivi dell’aborto. Anche qui ci sono degli stereotipi da verificare. È vero che il motivo per cui si ricorre all’interruzione volontaria della gravidanza è una situazione di emergenza, un rischio grave e permanente per la salute della madre? Questa ipotesi è ampiamente smentita dal campione osservato. Per rendere conto della situazione Kellerhals e Pasini ricorrono a un modello evolutivo che comprende “tre età” dell’aborto. I tre momenti riflettono tre diverse concezioni sociali del nascituro e attribuiscono praticamente diversa estensione al diritto di ricorrere all'aborto. Nel primo momento, a cui corrisponde una visione fondamentalista dell’embrione (vale a dire: si ammette che fin dal concepimento esiste un essere umano), non si ammette affatto l’interruzione della gravidanza, oppure si limita a casi di estrema urgenza, come il pericolo di morte per la madre. Il secondo momento è definito da una relativa permanenza delle immagini tradizionali dell’embrione, a cui si accompagna però il permesso di ricorrere all’aborto ogni volta che sussistono condizioni di grave miseria sociale o psicologica. La terza fase è caratterizzata dalla preminenza della funzione affettiva del bambino per la coppia o per la madre, e da un’immagine razionale dell’embrione (si ha vita umana solo allorché gli autori di essa ne prendono coscienza in quanto tale; si tenderà allora a fare degli autori i giudici esclusivi dell’interruzione o del proseguimento della gravidanza). Stabilita una tale ipotesi di lavoro, i ricercatori verificano che, quanto più moderno è il contesto di socializzazione, tanto più spiccata è l’appartenenza dei motivi in base ai quali viene richiesto l’aborto al “terzo momento”. Si nota cioè “un passaggio dalla coercizione oggettivamente riconoscibile (per esempio, pericolo di morte), alla valutazione personale dei fattori del pieno sviluppo, passando per il termine intermedio costituito dalle coercizioni sociali in senso ampio (tabù accanto ad obblighi socioeconomici)” (p. 190). L’“aborto della scarsità” tende, insomma, ad essere progressivamente sostituito dall’“aborto dell’abbondanza”.
Più analiticamente, i motivi della richiesta d’aborto sono raramente (11%) basati su ragioni di salute in senso somatico o psichiatrico. I motivi di marginalità socioeconomica (eccessivo numero di figli, difficoltà economiche, paura dei tabù legati alla gravidanza extramatrimoniale) sono altrettanto minoritari (30% nell’insieme). La maggioranza dei motivi appartiene alla “terza età dell’aborto”. Le ragioni che sono invocate sono quelle che riguardano il microequilibrio personale e familiare: instabilità del rapporto di coppia, immaturità della madre, figli futuri privi di significato
214
perché ne è altrettanto privo il rapporto di coppia, volontà di assicurare al figlio tutte le condizioni di felicità. Gli Autori si sentono autorizzati dai risultati dell’inchiesta ad affermare che il secondo momento dell’aborto è stato già superato e che siamo già nel terzo tempo, quello in cui l’aborto appare legittimo ogni volta che una donna o una coppia si trovano alle prese con una gravidanza che sembra soggettivamente inaccettabile (p. 173). Questo almeno nella società ginevrina da cui è tratto il campione.
L’esame dell’evoluzione dei motivi secondo la nazionalità delle richiedenti rivela che, più cresce la modernità (definita dalla variabile industrializzazione-urbanizzazione) del contesto di socializzazione, più aumenta il terzo tipo di motivi. La condizione economica ha una debole incidenza sulla distribuzione dei motivi, benché i problemi economici tendano a prevalere ai livelli più bassi della scala mobile, mentre ai livelli più alti viene rivolta maggiore attenzione alla fragilità del rapporto di coppia. Un’ultima osservazione di notevole portata: non si rileva alcuna differenza tra donne cattoliche e protestanti per quanto riguarda la motivazione dell’interruzione. L’ipotesi che l’educazione cattolica, notoriamente contraria all’aborto, porti a una maggiore reticenza verso questa pratica, quando si passi nella seconda o terza età dell’aborto, non si trova quindi verificata.
L’incapacità della società occidentale contemporanea di integrare, a livello profondo, la propria ideologia e la propria prassi, emerge anche quando passiamo a considerare il vissuto della situazione abortiva. Molti elementi a questo proposito sono forniti dalla quarta parte dell’inchiesta, dedicata al processo decisionale. Nel 25% dei casi il ricorso all’aborto getta la donna in uno stato di grave conflitto (tra tale decisione e il desiderio di avere un figlio, ovvero le norme etiche o le divergenze coniugali). A questo si aggiunge un conflitto più superficiale nell’11% dei casi. Il conflitto è più accentuato quando la pratica religiosa è regolare o l’immagine del feto è di tipo fondamentalista. Questo caso si verifica con la" frequenza del 20% (la donna ritiene che l’embrione sia un essere vivente dal momento del concepimento). L’immagine è relazionale in meno del 40°7o dei casi (la madre assume soggettivamente coscienza dell’esistenza dell’embrione come essere umano). L’atteggiamento è positivista nel 30% dei casi (l’embrione diventa un essere umano a un certo stadio del proprio sviluppo). La pratica religiosa si associa a una più alta proporzione di prospettive fondamentalistiche. Tuttavia sembra che l’immagine dell’embrione
215
colori di sé il processo decisionale, senza essere però decisamente associata a un maggiore o minore ricorso all’aborto.
Dall’indagine è risultato anche che il ruolo dell’ambiente circostante è assai limitato per quanto attiene alla formulazione della decisione. L’aborto resta un atto clandestino e semiclandestino. Questa situazione di solitudine spiega forse perché più del 60% delle donne interessate affermano che bisognerebbe concedere l’interruzione solo “dopo un’indagine approfondita”, mentre le proposte liberali (“ogniqualvolta una donna lo desidera” o “il più spesso possibile evitando abusi”) raccolgono solo il 35% dei suffragi (p. 265). Questo ricorso a un’istanza decisionale ufficiale può essere letto come un rifiuto ad assumersi le responsabilità. Il fatto che qualcun altro, per esempio un medico o un assistente sociale, si prenda la responsabilità ultima della decisione appare normale. Ciò di cui la donna ha bisogno è qualcuno che si mostri solidale con lei e non la lasci sola di fronte alla decisione.
E veniamo all’ultimo capitolo dell’inchiesta: il ricorso ripetuto all’interruzione della gravidanza. Anche qui una delle attese comuni non trova conferma. Infatti sembrerebbe legittimo che una prima esperienza di aborto, che a molte di coloro che la vivono appare traumatizzante, sia accompagnata da un riorientamento personale dei comportamenti circa la sessualità e la fecondità. Risulta invece che le “recidive” formano un contingente non trascurabile della popolazione che richiede l’interruzione. Più esattamente, il 16% delle donne del campione avevano già subito uno o più aborti prima della richiesta attuale, un terzo di esse nel corso dei due anni precedenti (p. 298). Il caso delle recidive mostra che l’interruzione della gravidanza deve essere interpretata in un contesto assai più ampio di quello costituito unicamente dalla situazione attuale della donna che ci ricorre. L’aborto ripetuto è associato ad alcuni tratti di personalità, come depressione cronica, dipendenza e passività, comportamento “fallimentare”; spesso la marginalità psicosociale ha origini antiche, come un’atmosfera familiare cattiva. Anche il divorzio dei genitori spesso svolge un ruolo destrutturante. Il comportamento contraccettivo delle recidive è carente. Intervengono evidentemente delle resistenze psicologiche che limitano la reale efficacia della contraccezione. Pur mettendo in evidenza che la recidiva è associata a fattori socioculturali e psicologici che creano delle specifiche “situazioni di rischio”, gli Autori sono contrari a una psichiatrizzazione dei casi di recidività. Tuttavia suggeriscono che in alcuni casi potrebbe essere necessaria una vera e propria terapia medico-psicologica,
216
se si vuole sostituire un intervento preventivo all’aborto usato come controllo correttivo. La loro opinione sulla forza deterrente del giudizio morale è piuttosto minimizzante. È vero che la recidiva è meno frequente nelle donne che praticano regolarmente la propria religione (p. 291); ma, a loro giudizio, in questi casi ciò che frena l’aborto non è tanto il giudizio morale, quando le ingiunzioni esteriori.
Questi i risultati principali di questa ampia ricerca socio-psicologica. Va ascritto a merito dei suoi autori l’aver evitato estrapolazioni abusive (le quali sono invece presenti nei due saggi di Laura Frontori e Francesco Saba Sardi, in appendice, che si servono della ricerca stessa per considerazioni psicodinamiche e antropologiche non appoggiate sui fatti stessi). Kellerhals e Pasini hanno però anche fornito un contributo per una lettura più in profondità del fenomeno dilagante dell’aborto. Hanno suggerito che il problema di fondo è quello del posto del bambino nella nostra società; ovvero, per usare una loro espressione, “del posto riservato alla Gratuità in una civiltà dominata dalla Merce” (p. 293). I ruoli concreti e simbolici che il bambino svolge ora per la famiglia e la società sono diversi da quelli che svolgeva fino a poco tempo fa. “Perché l’aborto?”, propone il titolo del libro. I risultati della ricerca nella società ginevrina ci rimandano a una problematica molto più radicale: “Perché il figlio?”, sembra dirsi un numero crescente di persone appartenenti a quel tipo di civilizzazione utilitaria in cui tutti, benché in gradi diversi, siamo immersi. Forse è proprio vero ciò che sostiene il “Movimento per la vita”, promotore della proposta di legge di iniziativa popolare per l’accoglienza della vita umana: il compito più urgente per la nostra civiltà è quello di impegnarsi in una lotta per la vita, reagendo allo scadimento che si è verificato nella coscienza individuale e sociale.
217
J.M. Moretti, O. De Dinachin, Le défi génétique, Ed. du Centurion, Paris 1982, pp. 160.
Il XXI sec. sarà il secolo della biologia? I recenti progressi rendono la previsione più che probabile. La padronanza acquisita sul corpo umano si estende ormai a tutte le tappe della vita, dai primi stadi della fecondazione alle ultime ore dell’esistenza. Ora, tutto ciò che tocca l’uomo interessa l’etica, cioè l’istanza da cui provengono le questioni sul senso e non senso della nostra esistenza umana. Due studiosi, rispettivamente di biologia e di etica, ambedue gesuiti, hanno congiunto le loro forze per affrontare quattro temi centrali della rivoluzione biologica: la manipolazione genetica, le diagnosi precoci (intrauterine), l’inseminazione artificiale e la contraccezione. Su ogni argomento viene costruito un dittico: dapprima il biologo spiega con linguaggio divulgativo le acquisizioni scientifiche; poi il moralista fa emergere la problematica etica e le soluzioni più appropriate. Il referente morale è costituito dalla dottrina tradizionale cattolica. L’argomento di autorità acquista in questi sviluppi dottrinali un tono lieve e convincente, in quanto l’eredità della tradizione cristiana è interpretata con intelligenza e con un’immaginazione creatrice. Se l’esperienza della Chiesa fornisce i grandi assi di riferimento, non dispensa dal cercare le soluzioni morali appropriate per l’uomo d’oggi. Queste emergono quando la tradizione si incontra con la saggezza, vale a dire con quel “saper-fare” che è l’arte di vivere oggi, in un mondo trasformato dalle nuove acquisizioni della scienza.
218
T. Bellelli, Il medico e la morte, Ed. R. Carabba, Lanciano, 1982, pp. 82.
Il tabù culturale che ha portato a rimuovere e nascondere la morte dalla nostra esperienza quotidiana è condiviso anche dai medici? L’A., medico operante nella realtà sociale di una città di media grandezza dell’Italia centrale, si è proposto di verificare l’ipotesi mediante un’indagine sui medici suoi concittadini, interrogandoli sulla morte e sul morire. La pubblicazione riporta i risultati dell’inchiesta, preceduti da considerazioni filosofiche sulla collocazione esistenziale della morte, e seguiti da una prima valutazione dei dati stessi. Emerge uno stimolante paradosso: il fare il medico aumenta la paura della morte; e questa paura la si attenua facendo il medico che guarisce. È convinzione dell’A. che bisogna contrastare il silenzio sulla morte, compreso quello medico: “Non si tratta di costruire l’ossessione del ‘momento mori’, nè di ridursi a vivere con la vita alle spalle e la morte davanti, né di fare un uso terroristico dei discorsi sulla morte. Si tratta invece di individuarsi: Intendendo, con quest’ultimo termine, l’ideale della persona realizzata proposto dalla psicologia di Jung: quella che ha completato la propria integrazione e crescita, predisponendosi così all’incontro con la propria morte.”
219
L. Schwartzenberg - P. Vianson-PONTÉ, Cambiamo la morte, Mondadori, Milano 1980.
La morte come cerimonia pubblica, l’ultima e la più solenne della vita, è quasi tutto scomparsa dai costumi dell’uomo urbanizzato. Oggi il più delle volte colui che muore ignora che sta morendo. È stato privato dei suoi diritti e lo si tratta come un bambino o come un demente: gli si nasconde la verità. La tecnologia ha prolungato il trapasso: morire è un processo che non finisce mai. Anche i più intimi si stancano di andare a visitare quel corpo che, già incosciente, irto di tubi, non è più l’uomo o la donna di prima, ma una specie di robot. Finché, nel cuore della notte, senza nessuno accanto, il morente oltrepassa la soglia. Questa è la morte che oggi attende una persona su due, in un ospedale o in un ospizio per vecchi. Per gli altri la probabilità maggiore è di finire la vita sulla pubblica via, a seguito di un incidente. Ma se questa morte d’ospedale, questa morte meccanica d’oggi, non fosse che una maschera imposta alla realtà umana del morire? Se tutta la segretezza che circonda la morte non fosse che un pretesto per rifiutare di vedere un problema in faccia? E se, tra tanti che promettono di cambiare la vita, qualcuno proponesse di cambiare la morte?
La proposta di cambiare la morte viene da due persone che apparentemente niente predestinava a scrivere un libro a quattro mani. Schwartzenberg è un medico, più precisamente un cancerologo; Vianson-Ponté è un giornalista politico, editorialista Le Monde e redattore capo di L’Exprès. Ma ambedue sanno che la morte è cambiata: l’uno perché vede morire ogni giorno coloro che la sua arte non riesce a guarire; l’altro perché guarda medici e malati, e registra l’orrore e la paura dell’uomo d’oggi, minacciato dal cancro. E poiché sanno che su quattro di noi uno ha avuto o avrà un cancro, e due volte su tre ne morrà, hanno deciso di parlarne.
Su ogni argomento un capitolo ciascuno, secondo la propria angolatura. Il libro si apre con una carrellata su sedici storie vere di malati di cancro, di cui dodici si concludono con la morte. Il medico prosegue spiegando che cosa è il cancro e le strategie terapeutiche oggi usate (chirurgia, radioterapia, chemioterapia e immunoterapia), chi sono ai suoi occhi i medici, e chi i malati. Su ogni tema il giornalista offre un contributo che fa da pendant; all’esposizione tecnica e pratica dello specialista rispondono le constatazioni sociali e politiche del professionista dell’informazione. Quando il medico, per fare un esempio, propone una “giornata di dépistage”, a cui parteciperebbero benevolmente tutti i medici, i dispensari,
220
tutte le cliniche e centri pubblici o privati, il giornalista concede un appoggio incondizionato: l’informazione, quarto potere del mondo d’oggi, può fare per la medicina, per il cancro, più che in qualsiasi altro campo.
Per chi è interessato ai problemi di morale medica il peso specifico del libro aumenta verso la fine. Gli ultimi due capitoli, dedicati rispettivamente alla “verità” e alla “morte”, affrontano di petto le due decisioni più drammatiche che pesano sulle spalle del medico: che cosa bisogna dire al malato, e se si può aiutare il malato a morire. Quanto al primo problema, vengono evidenziati due atteggiamenti, l’uno favorevole e l’altro contrario alla comunicazione della prognosi infausta. La differenza tra i comportamenti cosi schematizzati negli Stati Uniti e in Europa dipende dall’idea ammessa dagli Americani, e rigettata dagli Europei, che un giorno l’uomo potrà accettare di morire. Per gli Americani non esistono problemi posti all’uomo che non possano un giorno essere risolti. Pensano che se può andare sulla luna, conoscere lo spazio, l’uomo arriverà un giorno ad accettare di morire. E supponendo il problema risolto, come dovrà esserlo più tardi, perché non saltare le tappe e risolverlo ora? In Europa, all’opposto, si pensa che certi problemi sono così complessi e dolorosi che hanno poche possibilità di ricevere una soluzione, e che nell’attesa è meglio negarli. In una situazione così complessa la scelta che si pone al medico non è facile. E se Schwartzenberg è deciso personalmente a dire la verità a tutti i suoi pazienti che vogliono conoscerla, si dichiara incapace di giudicare e condannare i medici che rifiutano di dirla. Esplicite riserve susciterà invece in più di un lettore la sua prassi per ciò che concerne l’eutanasia. (“Non trattenete le imposte che si chiudono. Abbassiamo le persiane. E se certi medicamenti chimici nati nel cervello degli uomini possono svolgere il ruolo di persiane che si tirerà lentamente, addormentatori della vigilanza, perché non utilizzarli?”). Egli pretende che questo gesto non equivalga al dare la morte, ma si limiti all’arrestare la vita in una povere cosa umana deteriorata. Basterà questa precisazione terminologica a trasformare la realtà dei fatti? Schwartzenberg si accende di sdegno contro lo scandalo che consiste nel lasciar soffrire; ma a quante violenze, nella realtà quotidiana, potrebbe dar adito una compassione a cui si lasci briglia sciolta? Le riserve e perplessità non ci impediscono di essere grati al medico e al giornalista per le crude realtà che ci costringono a guardare in faccia. Non si può più lasciare la modalità della propria morte in mano ai medici; gli stessi medici più coscienti rifiutano questo potere che li schiaccia. Perché la morte sia cambiata bisogna che i malati e gli stessi sani, malati in potenza, si riapproprino della morte.
221
Rosemary e Victor Zorza, Un modo di morire, ed. Paoline, Roma 1982, pp. 288.
«C’è un solo modo di entrare nella vita, molti di uscirne». La saggezza stoica, contenuta in questa frase di Seneca, risuona nel titolo del libro scritto da Rosemary e Victor Zorza. Lui, giornalista affermato, esperto di politica internazionale, «cremlinologo» come specializzazione; lei ceramista. Rispettivamente padre e madre di Jane, una ragazza di venticinque anni. Assetata di vita, idealista, esigente con gli altri e ancor più con se stessa, piuttosto spigolosa, per i residui di un’adolescenza ribelle ancora non del tutto metabolizzata. Venticinque anni, sui quali improvvisamente cade la mannaia di un cancro incurabile. Nel giro di pochi mesi si consuma il dramma.
Ecco — si penserà — un libro patetico, in cui i genitori privati della loro figlia amata hanno travasato il loro strazio; una lapide scritta non sul marmo della pietra tombale, ma sulla carta, per eternare la memoria di chi non ha avuto il tempo di lasciar tracce del proprio passaggio sulla terra; uno sfogo da ascoltare in omaggio alla pietà. No, niente di tutto questo. Il padre e la madre di Jane non sono disperati, e tanto meno domandano la compassione. Se si osasse usare quella parola tanto esigente, bisognerebbe dire che sono felici, che scrivono per dar notizia della loro felicità; così come, dopo la morte di Jane, hanno organizzato una festa, invitando gli amici e coloro che avevano assistito Jane sino alla fine: una vera festa, un incontro gioioso, non una cerimonia funebre. Sono, allora, dei credenti di fede adamantina, per i quali il morire è un “addormentarsi nel Signore”, per risvegliarsi nella vita eterna? No: Victor e Rosemary si dicono atei; e Jane alla domanda: «Religione?» in un questionario presentatole all’ingresso in ospedale rispose: «Nessuna».
Un motivo del fascino che emana da questo libro è proprio il rovesciamento dei più frequenti luoghi comuni sulla morte: che i credenti muoiano fiduciosi e i non credenti disperati; che il modo più appropriato per aver compassione dei morenti sia quello di nasconder loro la morte; che la morte di una persona cara lasci necessariamente un vuoto incolmabile. La morte di Jane ha lasciato, invece, una pieneza. Ha provocato uno di questi sconvolgimenti esistenziali che in termini religiosi si chiamano conversioni. Victor, il padre, è diventato consapevole di aver vissuto nella menzogna, senza ammetterlo neppure a se stesso; gli ideali umanitari della figlia sono trapassati in lui, tanto che ha abbandonato l’Occidente,
222
si è stabilito in India, e scrive ormai non per far conoscere la politica del Cremlino, ma per risvegliare la coscienza dei paesi civilizzati sui problemi della povertà e dello sviluppo.
Che cosa ha, dunque, di peculiare questo «modo di morire», da essere proposto come una strada esemplare per umanizzare la morte? Un primo punto qualificante è il rifiuto della menzogna. L’orrore di una morte così precoce e rapida ha teso anche attorno a Jane la solita barriera di silenzio, fatta di diagnosi nel linguaggio tecnico della medicina, e quindi incomprensibile, di dissimulazione e di evasive parole di speranza. Risultato: Jane si chiude in se stessa, rompendo anche i legami affettivi con i genitori. Alla menzogna risponde con l’isolamento. Solo quando i suoi, aiutati da un illuminato medico di famiglia, prendono la via della verità, la situazione cambia. Dire la verità al malato non equivale a comunicare, in modo brutale o con maniere ovattate, una sentenza inappellabile. Il modo in cui il medico di famiglia conduce il colloquio decisivo (p. 115) è esemplare: richiede contatto col malato, onestà, empatia. Ma senza barare sull’essenziale: quando una persona muore, bisogna parlare della morte.
Da questo momento nella vita di Jane avviene una svolta. I suoi ultimi giorni sono costellati di dialoghi intensi, nei quali si sciolgono tutti i nodi dei rapporti interpersonali. Il più intricato era quello con il padre. In passato non erano stati capaci di parlare di ciò che li aveva tenuti divisi. Ora, dal momento in cui si decidono a voler parlare della morte, si scoprono in grado di parlare della vita: come se le menzogne a proposito dell’una si riflettessero sull’altra, e le menzogne — comprese quelle «a fin di bene» — impedissero all’amore di manifestarsi (non l’abbiamo sempre saputo? Eppure come ci suonano nuove queste verità al letto dei morenti, dove si è instaurato il costume di negare anche l’evidenza!). Parlare della morte non equivale ancora ad accettarla, ma è la via che vi conduce. «Avendo accettato la mente. Jane si ridestò alla vita»: questa testimonianza lapidaria dei genitori vale più di mille argomentazioni nel rovelloso dilemma se dire o tacere la verità al malato terminale. Gli ultimi giorni dell’esistenza possono essere un’intensità vertiginosa di vita vissuta, purché non siano soffocati dalla mancanza di sincerità.
Un secondo pilastro di questo modo umano di morire è il rifiuto dell’eutanasia. La morte procurata per compassione è una fuga dal vero problema, che è quello di saper restare accanto a chi muore in modo efficace. Il che vuol dire, in concreto, in modo che il dolore non superi
223
la soglia della tollerabilità. Il compito fondamentale della medicina nei confronti dei morenti è quello di controllare il dolore, senza che il paziente perda la lucidità. Quando la famiglia Zorza si trova sull’orlo della disperazione perché si sente tradita da una medicina che, non potendo guarire Jane, praticamente la abbandona al suo destino, riceve aiuto da un hospice. Sono istituzioni ancora sconosciute da noi, ma che cominciano a diffondersi nel mondo anglosassone. Luoghi protetti, per aiutare i malati e le loro famiglie lungo il cammino della morte. Tutta la competenza medica è utilizzata per debellare il dolore, mentre in ogni modo ci si adopera perché al morente siano risparmiati gli insulti alla dignità personale che subisce negli ospedali. Gli hospices sono nati dall’iniziativa cristiana per dare una risposta concreta alla disumanità del morire della nostra società, rifiutando l’alternativa ancora più disumana dell’eutanasia.
224
P. Sporken, Die Sorge um den kranken Menschen, Patmos, Dusseldorf 19812, pp. 314.
È ancora tempo di manuali di etica medica? L’A. — docente di questa disciplina a Maastricht, in Olanda — non è nuovo all’impresa. Dopo un primo manuale (in trad. tedesca: Darf die Medizin, was sie kann? Düsseldorf 1971), ne ha pubblicato un secondo: Die Sorge um den kranken Menschen, già in seconda edizione ampliata. Segno che i manuali “tirano” ancora. A condizione, però, precisa Sporken, che sappiamo rinnovarsi, al ritmo incalzante dei problemi che sconvolgono il territorio della prassi medica. Il confronto tra le diverse redazioni manualistiche di Sporken è istruttivo: ci offre indicazioni sulla direzione in cui spira il vento dell’etica medica. Sempre più chiaramente . moralista rinuncia a stabilire norme etiche di comportamento concrete dettagliate; individua piuttosto il suo compito nell’offrire stimoli di : ' essione (soprattutto una visione antropologica non mutilata, che ponga a> centro l’uomo nella sua interezza), affinché il singolo trovi le giuste decisioni etiche seguendo la propria responsabilità (cfr. soprattutto il paragrafo su “Idee preconcette, atteggiamenti e decisioni etiche”, p. 269 s.).
Una seconda caratteristica saliente è che il moralista cattolico si apre sempre più a una prospettiva ecumenica, ascoltando le voci e le testimonianze provenienti dalle altre chiese cristiane. Per il resto, questo nuovo manuale si articola come quelli tradizionali: dopo le questioni generali (definizione di etica, di salute, di interrelazione tra etica, individuo e società), passa alla trattazione di singole tematiche organizzate intorno alla svolgersi della vita, dell’inizio alla fine.
225
B. Häring, Liberi e fedeli in Cristo, Paoline, vol. 3°, Roma 1981, pp. 570.
P. Häring ha concluso la sua fatica. Lo aspettavamo, questo terzo volume, con trepidazione. Ormai questa rifusione del suo celebre manuale di morale cristiana (La legge di Cristo, ugualmente in tre volumi, pubblicato per la prima volta nel 1953, su cui si sono formate le generazioni di teologi e di pastori che avrebbero vissuto la grande stagione della chiesa conciliare) è troppo nota per dover essere presentata in dettaglio. La trepidazione era legata a quanto lo stesso Häring confidava ai suoi lettori nella prefazione del secondo volume: che era affetto da cancro alla laringe e stava lottando con il tempo per portare a compimento la sua opera. Laringetomizzato nel frattempo, continua con i suoi scritti ad annunciare all’uomo del nostro tempo una morale evangelica: non casistica, con repressiva, ma davvero una morale che è una “buona notizia”. Tra il rigorismo dei legalisti 3 il lassismo di coloro che sono succubi della secolarizzazione, P. Häring ha scelto di percorrere una “via media”; che è però una via eroica, in un tempo di cambiamento e di incertezza.
L’ispirazione evangelica della morale di Häring si riflette nell’impostazione di fondo di questa nuova sintesi. L’impianto è quello tradizionale: il primo volume tratta la morale fondamentale, e gli altri due quella speciale. Un tema unificatore conferisce però omogeneità alle suddivisioni della materia. La morale fondamentale è costruita intorno alla “libertà per la quale Cristo ci ha liberati” (Gal. 5,1). Il primo volume della morale speciale ruota intorno alla “verità con la quale Cristo ci rende liberi” (Giov. 8,32): la verità — insieme alla bellezza — è il volto che acquista l’esistenza del discepolo che vuol vivere nella sequela di Gesù; la fede, la speranza e la carità (le classiche virtù teologali) sono le vie che conducono alla verità. Questo terzo volume è dedicato a quella che, nel linguaggio manualistico, è chiamata “morale sociale”: vale a dire, le nostre responsabilità in ordine alla salute delle persone, delle comunità e della vita pubblica, e in ordine all’instaurazione di rapporti interumani sani e di un ambiente salubre. Per i cristiani si tratta di vivere in consonanza con il mandato evangelico: “voi siete la luce del mondo” (Mt. 5,14), scelto come motto unificante del volume. Un apporto originale di Häring è quello di considerare l’etica sociale cristiana in un’ottica “terapeutica”. Prolungando l’azione di Gesù, la comunità dei suoi discepoli è impegnata in un’opera di risanamento: “I cristiani, come non possono privatizzare
226
la loro fede e speranza, così devono manifestare di essere coinvolti nella presenza e nella venuta sanante di Cristo nel mondo”.
I cultori di morale medica sono particolarmente interessati all’estesa trattazione della materia, collocata in apertura di volume. È chiamata, secondo il neologismo americano, “bioetica”. P. Häring si è già più volte occupato dei risvolti morali della vita fisica. Lo documentano in particolare due volumi: Etica medica, Roma 1972 e Medicina e manipolazione, Roma 1976. Nel primo raccoglieva l’eredità della ricca pubblicistica prodotta dai moralisti cattolici intorno agli anni ’50 in tema di etica medica. La situava però nel nuovo contesto, costituito dai progressi della medicina e della biologia, da una parte, e dai nuovi sviluppi della teologia cattolica durante e dopo il Vaticano II, dall’altra. “Non diamo risposte una volta per tutte, né risposte già pronte per tutti i nuovi problemi. Dobbiamo oggi impegnarci lealmente per restare fedeli alla nostra eredità con le esigenze dei nuovi tempi, soprattutto nel dialogo interdisciplinare”, proclamava P. Häring nell’introduzione. Come criterio fondamentale per valutare i problemi attuali della professione medica e del paziente, assumeva la libertà e l’integrità della persona umana.
Uno sviluppo ulteriore è costituito da Medicina e manipolazione. La manipolazione medica, comportamentale e genetica veniva inserita nell’insieme delle manipolazioni insidiose che minacciano quasi ogni settore della vita moderna; senza però ignorare le possibilità offerte di liberarci da condizionamenti sfavorevoli allo sviluppo del genere umano. “Che cosa significa la manipolazione nella e per la storia della libertà e della liberazione?”, si domandava il teologo moralista. I criteri per il discernimento dei limiti etici della manipolazione venivano cercati nello spirito della teologia della liberazione.
Trattando la bioetica nel contesto della sua nuova sintesi della morale cattolica, Häring adotta un’angolatura che le conferisce maggiore spessore teologico. La sua preoccupazione non è quella di fornire soluzioni morali “allargare” ai problemi tradizionali, e tantomeno compromessi, bensì di acquisire la giusta prospettiva, operando scelte evangeliche di valore e di senso. Situa la promozione e protezione della vita, la salute e la terapia, la morte e il morire del contesto del più ampio dovere, che incombe ai cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà, di unire le forze per la costruzione di un mondo più sano. “Tutta la redenzione è un’opera di risanamento, di guarigione. Di conseguenza tutta la teologia, e segnatamente la teologia morale, ha un’essenziale dimensione terapeutica.
227
Cristo, il Salvatore, è anche Medico, Colui che guarisce. Egli è venuto a guarire la persona singola nelle sue relazioni, ma ha pure proclamato il Regno, un regno che abbraccia tutto, e quindi anche un mondo sano in cui vivere. I cristiani sono, in Cristo, dei terapeuti, della gente che fa opera di guarigione. Essi hanno la missione di guarire se stessi, di guarirsi gli uni gli altri e di lavorare uniti per la creazione di un mondo più sano”. L’etica medica si configura così come una parte dell’etica sociale, cioè della nostra corresponsabilità nel mondo e per il mondo.
“Teologia morale per preti e laici”, è il sottotitolo che specifica l’orientamento di Liberi e fedeli in Cristo. Col superamento degli antichi schemi moralistici, che riservavano la conoscenza della morale ai confessori, affinché questi la trasmettessero poi ai fedeli, cade un ultimo bastione del paternalismo.
228
229
INDICE
5 Introduzione - Salute e cultura, oggi
9 Parte Prima: La normativa etica in campo bio-medico
11 Capitolo Primo - L’ethos ippocratico
11 1. Il giuramento di Ippocrate nel contesto storico
18 2. La tradizione e l’uso moderno del giuramento
22 3. Pro e contro il giuramento ippocratico
25 Capitolo Secondo - La deontologia medica
25 1. Dall’etichetta medica alla deontologia
33 2. I codici di deontologia medica
37 3. Oltre la deontologia professionale
39 Capitolo Terzo - Il riferimento alla coscienza nella professione medica
40 1. La coscienza come istanza etica
47 2. L'obiezione per motivi religiosi
53 Capitolo Quarto - La formazione etica del medico: un bilancio dei nuovi orientamenti
53 1. Una risposta alla crisi della medicina
55 2. L'etica medica, tra ideologia e pragmatismo
59 3. L’insegnamento dell’etica medica: problemi metodologici
63 Parte Seconda: La morale medica cristiana
65 Introduzione: Medico e cristiano: un mestiere difficile
230
71 Capitolo Primo - La morale medica come disciplina teologica
71 1. Profilo storico della morale medica cristiana
75 2. Nuovi orientamenti
79 Capitolo Secondo - Fondamenti antropologico-teologici della morale medica cristiana
79 1. La salute nella storia della salvezza
79 Malattia e salute nella prospettiva dell’alleanza
82 L’attività terapeutica di Gesù
86 Gesù e il male fisico
88 2. La fede che guarisce
93 3. L'integrazione comunitaria
99 Parte Terza: Alcuni problemi di bioetica
101 Introduzione: Il richiamo attuale a un'etica in campo bio-medico
104 1. Sperimentazione e manipolazione genetiche
107 2. Le tecnologie riproduttive
107 Lo stato dell’arte: inventario (provvisorio) delle tecniche
110 Reazione emotiva o giudizio etico?
113 3. La fecondazione artificiale
121 4. La sterilizzazione
121 Motivi di attualità
122 Sterilizzazione e ordinamento giuridico
124 I medici e la sterilizzazione: problemi deontologici
126 Un nuovo orizzonte antropologico
127 Il punto di vista etico
131 5. Transessualismo e identità sessuale
133 La conoscenza scientifica dell’identità sessuale
137 Le turbe dell’identità e dell’orientamento sessuale
139 Orientamenti dell’etica cristiana
143 6. La regolazione delle nascite
143 Il rifiuto della contraccezione
144 La problematica più recente
146 I metodi naturali di regolazione delle nascite
149 7. La boxe
152 8. La morte inflitta
231
152 La pena di morte
154 Il suicidio
158 9. L’eutanasia
158 La chiesa e il diritto di morire umanamente
160 Il rifiuto dell’eutanasia attiva
161 La lotta contro il dolore
165 La verità al morente
166 10. L’assistenza ai morenti
166 La caduta di un tabù
171 Un singolare seminario interdisciplinare
177 Le fasi del morire
183 Parte Quarta: Schede bibliografiche
185 Introduzione
185 O.M.S., La salute e i diritti dell’uomo
187 G. Quaranta, L’uomo negato
189 G.P. Cabanel, Médicine libérale ou médicine nationalisée?
192 F. Foschi, Salute e società
198 Francs-tireurs de la médicine
201 P. Solignac, Ces malades mal-traités
203 AA. VV., Médicine et experimentation
204 J.P. Escande, La deuxième cellule
206 N. Cousins, La volontà di guarire
209 J. Kellerhals - W. Pasini, Perché l’aborto?
217 J.M. Moretti - O. de Dinachin, Le defi génétique
218 T. Bellelli, Il medico e la morte
219 L. Schwartzenberg - P. Vianson-Ponté, Cambiamo la morte
221 R. e V. Zorza, Un modo di morire
224 P. Sporken, Die Sorge um den kranken Menschen
225 B. Häring, Liberi e fedeli in Cristo
1 Ampia documentazione in G.P. Cabanel, Médecine libérale ou nationalisée?, Paris 1979. L’autore presenta un dossier in cui vengono passate in rassegna le soluzioni che hanno dato ai problemi della salute alcune delle grandi nazioni del mondo, adottando differenti sistemi sanitari. La Svizzera è presente come prototipo del liberalismo europeo; la Repubblica federale tedesca ha organizzato anche la salute secondo i principi dell’economia sociale di mercato; la Gran Bretagna e la Svezia hanno spinto l’intervento dello Stato quanto più potevano, senza violare i limiti posti dai principi della vita democratica; gli Stati Uniti hanno scandito il sistema sanitario sui principi fondamentalmente liberali che governano il paese; Russia e Cina rappresentano due esempi eminenti della scelta socio-politica antitetica a quella del liberalismo, affidando allo Stato la gestione del sistema sanitario. Il confronto tra le diverse risposte date da differenti sistemi economico-politici fa emergere quanto sia necessario che gli interventi tecnici, di competenza dell’economia politica, siano pensati nel contesto di un approccio umanistico del problema della salute. Anche dietro la politica sanitaria indoviniamo il profilo dell’etica, che ci invita a cercare risposte che tengano presente tutto l’uomo.
2 Uno dei segni dei tempi più promettenti in questo senso è la formazione di un vasto movimento di opinione che investe l’ospedale, così come nel più recente passato è avvenuto per la fabbrica e per la condizione della donna. I malati, che molto spesso sono afflitti più dalla rabbia per il trattamento umiliante che ricevono che dai loro mali fisici, non vogliono più essere dei “pazienti”. Chiedono in primo luogo che cessi la violazione dei diritti umani nei luoghi adibiti alla cura. In questo spirito è sorto, per impulso del Movimento Federativo Democratico, un “Tribunale per i diritti del malato”: cfr. G. Quaranta, L’uomo negato, Roma 19823.
3 W.H.S. Jones, Hippocrates, London 1923, I, 291-297.
4 L. Edelstein, The Hippocratic Oarh: Test, Translation and Interpretation, in The Bull, of the Historv of Medicine, Suppl. I, Baltimore 1948; id., The Professional Ethics of the Greek Physician, in O. Temkin (ed.), Ancient Medicine, Selected Papers of Ludwing Edelstein, Baltimore 1967, 319-348. Sigerist, il fondatore della moderna storia della medicina, si è occupato a più riprese del giuramento e dell’ethos ippocratico. Segnaliamo i riferimenti principali: H.E. Sigkrist, Grosse Aerzte, Eine Geschichte der Heilkunde in Lebensbildern, München 1923; id., “On Hippocrates”, in Bullettin of the Inst. of Medicine 2 (1934) 190-214, ripreso nella raccolta On the Historv of Medicine, N. York 1960, 97-119; id., Die Heilkunst im Dienste der Menschheit, Stuttgart 1954. La trattazione più completa è quella che Sigerist riserva a Ippocrate nella monumentale storia della medicina, progettata in otto volumi, ma che la morte gli impedì di portare a termine: A History of Medicine, vol. II: Early Greek, Hindu and Persian Medicine, N.Y. 1961.
5 Tradizionalmente l’ethos medico espresso dal giuramento è individuato nella difesa della vita o della salute. “Come lo sportivo di Maratona aveva il dovere di portare e difendere la fiamma olimpica, cosi il medico ippocratico ha il dovere di difendere la fiamma della vita. Se anche nella casistica terapeutica Ippocrate non è aggiornato, sui principi necessari, oggi come allora, egli è di un’attualità morale sorprendente e imprescindibile: medico vuol dire sacerdote della vita; ad altri, se occorre, il compito, a volte il dovere di limitare la vita. A noi quello di facilitarla, di difenderla e di salvarla”: L. Gedda, Il giuramento di Ippocrate oggi, Roma 1954, p. 19.
6 W.H.S. Jones, The Doctor’s Oath: an essay in the history of medicine, Cambridge 1924. Vedi anche l’introduzione alle opere di Ippocrate, cit. n. 1.
7 H.E. Sigerist, A History of Medicine, cit. p. 303.
8 Cfr. L. Edelstein, The Hippocratic Oath, cit.
9 Cfr. Gregorio di Naz., PG. xxxv, col 767A: Girolamo, Epist. 52,15 PL xii, col. 539.
10 Vedi specialmente H.E. Sigerist, On Hippocrates, cit.
11 Per il medico che arrivava come straniero il modo migliore per guadagnare la fiducia era di fare una prognosi corretta. Ciò rende ragione, secondo Edelstein, della posizione centrale che ha la prognosi nella medicina ippocratica.
12 Seguiamo soprattutto il saggio di L. Edelstein, The Professional Ethics of Greek Physician, cit.
13 Cfr. i risultati del colloquio di Strasburgo, tenuto nell'ottobre 1972: La collection hippocratique et son rôle dans l’histoire de la médecine, Leiden 1975, La stessa attenzione è presente in W.D. Smith, The Hippocratic Tradition, Ithaca-London 1979.
14 Una visione d’insieme, basata sull’analisi di un certo numero di trattati composti dal v al xii sec., nel saggio di L.C. Mac Kinney, Medical Ethics and etiquette in the early Middle Ages: The persistance of hippocratic ideals, in C.R. Burns (ed.), Legacies in ethics and medicine, New York 1977, 173-203.
15 Il giuramento modificato in senso cristiano è riprodotto in tre codici. Due di essi — l'Urbinate 64 della Bibl. Vaticana e l'Ambrosiano B113 — dispongono il testo in modo che ne risulti una croce. La cristianizzazione del giuramento di Ippocrate risulta cosi anche graficamente. Queste versioni del giuramento sono state pubblicate per la prima volta da W.H.S. Jones, The Doctor’s Oath: an essay in the historv of medicine, Cambridge 1924.
16 Per riferimenti più dettagliati, cfr. D. Konold, “Codes of medical ethics”, in Encyclopedia of medical Ethics, N. York 1978, i, 162-171.
17 Gravitz (a cura), Hippokrates, Gedanken ärztlicher Ethik aus dem Corpus Hippocraticum, Prague 1942.
18 La discussione sul ruolo giocato dalle organizzazioni professionali dei medici nel realizzare la politica sanitaria del Terzo Reich comincia solo oggi, dopo un silenzio di parecchi decenni. Il “Gesundheitstag” tenutosi a Berlino nel maggio 1980 ha scelto, per la prima volta, come tema di discussione il rapporto tra medicina e nazionalsocialismo. Un’attenzione particolare è andata all’etica professionale come ideologia vincolante che ha messo i medici a servizio del regime. Cfr. gli atti dell’assemblea: G. Baader e V. Shultz (a cura), Medizin und Nationalsozialismus. Tabuisierte Vergangenheit-Ungebrochene Tradition? Berlin 1980.
19 E. Luther e B. Thaler (a cura), Das hippokratische Ethos. Untersuchungen an Ethos und Praxis in deutschen Aerztenschaft, Halle (Saale) 1967.
20 L. Edelstein, The Professional Ethics., cit. Nella nota 43 adduce abbondante materiale a sostegno dell’informazione.
21 E. Luther e B. Thaler, cit. p. 156.
23 H.E. Sigerist, Die Heilkunst im Dìenste der Menschheit, Stuttgart 1954.
24 Th. Percival, Medical Ethics, or a Code of Institutes and Precepts Adapted to the Professional Conduct of Physicians and Surgeons, London 1803. L’opera è stata ristampata nel 1975 con un’introduzione storica di C.R. Burns dedicata a Percival come prodotto dell’Illuminismo.
25 Jeffrey L. Berlant, Profession and Monopoly: study of Medicine in the United States and Great Britain, Berkeley 1975.
26 R. Savatier, “Déontologie”, in Encyclopaedia Universalis, Paris 1971, vol. v, pp. 436-439.
27 Sul “Popular Health Movement” cfr. R.H. Shyock, Medicine in America: Historical Essays, J. Hopkins Press 1966; J. Kett, The Formation of the American Medical Profession: The Role of Institutions, 1780-1860, Yale University Press 1968; più brevemente, e da un’ottica femminista: B. Ehrenreich-D. English, Witches, Midwives, and Nurses. A History of Women Healers, The Feminist Press, New York 1974.
28 Cfr. D. Konold, “Codes of Medical Ethics. Historv”, in Encycl. of Bioethics, New York 1978, i, 162-171.
29 G. Caro, La médicine en question, Paris 1974, p. 58.
30 Cfr. H. Cleempoel, “De la déontologie medicale à une étique de la santé”, in AA.VV., Pour une politique de la santé, Bruxelles 1968, pp. 101-105.
31 Cfr. V.W. Sidel e R. Sidel, Serve the People, New York 1973.
32 J. Piaget, Le jugement moral chez l’enfant, Paris 1932.
33 Hampden Turner, The Radical Man, Cambridge (Mass.) 1970.
34 M. Rokeach, The Open and the Closed Mind, New York 1960. Il dogmatismo per Rokeach compare sotto forma di “totalità cognitiva di idee e rappresentazioni, che sono organizzati in sistemi relativamente chiusi".
35 G. Davanzo, Obiezione di coscienza, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, Roma 1973, pp. 676-681.
36 A.H. Maslow, Verso una psicologia dell’essere, Roma 1971. Tutto il libro, costruito sulle esperienze e i momenti più sani nella vita della gente comune, vuol dimostrare che gli esseri umani possono essere nobili e creativi, che sono capaci di seguire i valori e le aspirazioni più elevate.
37 I.T. Ramsey, Il linguaggio religioso, Bologna 1970; specialmente pp. 17-76.
38 Cfr. M.D. Basson (ed.), Ethics, Humanism, and Medicine, New York 1980.
39 Un ruolo analogo ha svolto, e svolge ancora, l’insegnamento della deontologia medica nelle nostre facoltà di medicina. Gli interventi italiani al congresso europeo sulla formazione del medico tenutosi nel 1969 auspicavano un potenziamento dell’insegnamento della deontologia — attuale monopolio della medicina legale —, al fine di fornire al giovane medico “la conoscenza degli obblighi legali, morali e consuetudinari indispensabili per il buon esercizio della professione medica, delle potestà e dei diritti che fanno capo al medico”: Atti del congresso europeo sulla formazione del medico, Roma 1969.
40 Tra le numerose pubblicazioni dedicate alla situazione americana, cfr. soprattutto R.M. Veatch (ed.): The Teaching of Medical Ethics, New York 1973; R.M. Veatch e D. Fenner, “The Teaching of medical ethics in the United States of America'’, in Journal of Medical Ethics I (1975) 99-103; R.M. Veatch, “Medical ethics education", in Encyclopedia of Bioethics, vol. ii, 870-875.
41 Cfr. soprattutto E. Luther e B. Thaler, Das hippokratische Ethos. Untersuchungen zu Ethos und Praxis in deutschen Aerztenschaft, Halle 1967. L’opera raccoglie diversi studi della sezione marxismo-leninismo della facoltà di medicina. Si propone di smitizzare l’ethos medico, denunciandone la determinazione sociale, vale a dire la sua dipendenza dai rapporti economici e politici prevalenti nella società. Per una visione d’insieme della biblioteca nei paesi influenzati dalla filosofia marxista, cfr. B. Page, “Historv of Medical Ethics: Eastern Europe in the Twentieth Century”, in Encyclopedia of Bioethics, vol. ii, 977-982.
42 I. Jakobovits, Jewish Medical Ethics: a Comparative and Historical Study of the Jewish Religious Attitude to Medicine and its Practice, New York 1975; F. Rosner, Modern Medicine and Jewish Law, New York 1972.
43 La quantità di pubblicazioni autorevoli in materia, dovute a teologi moralisti, non permette indicazioni bibliografiche, neppure sommarie. Non si può però mancare di segnalare il magistero di Pio xii, per il ruolo di stimolo e di guida che ha avuto nelle questioni emergenti dell’etica medica. Cfr. Pio XII: Discorsi ai medici, ed. Orizzonte medico, Roma, 1963.
44 D. Dooly-Clarke, “The teaching of medical ethics: University College, Cork, Ire- land”, in Journal of Medical Ethics 4 (1978) 36-39.
45 Cfr. C. Blomquist, “The teaching of medical ethics in Sweden”, in Journal of Medical Ethics 1 (1975) 96-98; P. Sporken, “The teaching of medical ethics in Maastricht”, in Journal of Medical Ethics 1 (1975) 181-183.
46 S. Sontang, La malattia come metafora, tr. it. Torino 1979.
47 Cfr. R.M. Veatch, “Medical ethics education”, in Encyclopedia of Bioethics, vol. ii, 873.
48 La teoria più elaborata sul processo decisionale in medicina (medical decision making) è quella di Edmond A. Murphy, The logic of Medicine, Baltimore 1976; cfr. anche D.V. Lindley, Making decision, N.Y. 1971. Mentre in passato l’etica medica si è espressa in termini sillogistici, ora si preferisce ripensarla nel quadro di una teoria più generale della decisione probabilistica. Sia i benefici (sollievo da un’infermità, bellezza, fecondità, accresciuto senso del benessere), sia le penalità (perdita della vita, dolore, infermità, vergogna, perdita di denaro ecc.) possono essere condensate in una funzione matematica delle variabili sulle quali la decisione deve basarsi. Alla formula matematica che ne deriva si dà il nome tecnico di cost function. Se il costo eccede il beneficio, il trattamento non sembra autorizzato.
49 A illustrazione di questo modo di procedere si veda l’ottimo “readings” a cura di S.J. Reiser, Ethics in Medicine. Historical Perspectives and Contemporary Concerns, Cambridge-London 1977. Il materiale è distribuito in sezioni che comprendono: La protezione degli utenti nella medicina clinica; La verità nel rapporto medico-paziente; La sperimentazione medica con soggetti umani; Le decisioni procreative; Soffrire e morire; Diritti e priorità nel fornire l’assistenza medica.
50 Cfr. H. Brody, “Teaching Medical Ethics”, in Journal of the American Medical Association 229 (1974) 177-179; A.H. Keller, “Ethics Human Values Education in the Family Practice Residency, in Journal of Medical Education 52 (1972) 107-116.
51 Gli esperimenti più istruttivi in questo senso sono stati fatti in Olanda. Sia nella nuova facoltà in medicina di Maastricht, in cui si sperimenta un tipo completamente nuovo di formazione medica, sia in quella più tradizionale di Nimega, l’insegnamento dell'etica medica è inserito organicamente nel curriculum fin dall’inizio degli studi. Per maggiori informazioni, cfr. P. Sporken, “The teaching of medical ethics in Maastricht, The Netherlands; in Journal of med. ethics 1 (1975) 181-183; M. De Wachter, “Theaching medical ethics: University of Nijmegen, the Netherlands”, in Journal of medical ethics 4 (1978) 84-88.
54 I principali interventi sono raccolti nel volume Pio XII: Discorsi ai medici, Roma 1963. Praticamente tutti i punti nevralgici della morale medica sono stati trattati da Pio XII: il valore e l’inviolabilità della vita umana in riferimento all’aborto, alla contraccezione e alla sessualità coniugale; la fecondazione artificiale; la sterilizzazione; i limiti nella ricerca e nella sperimentazione sull’uomo; la chirurgia in rapporto alle mutilazioni anatomiche e funzionali; la rianimazione e i problemi dell’analgesia; il parto indolore; problemi etici della neuropsicofarmacologia; principi di morale applicati alla psicoterapia.
55 “Queste direttive proibiscono quei procedimenti che, allo stato attuale di conoscenze, sono riconosciuti come chiaramente erronei. I valori morali assoluti di fondo che queste direttive sottolineano non sono soggetti a cambiamento, benché possano essere modificate delle particolari applicazioni, nella misura in cui la ricerca scientifica e lo sviluppo teologico schiudono nuovi problemi o gettano una nuova luce su quelli vecchi”: il preambolo delle direttive statunitensi riflette un approccio della problematica medico-morale secondo cui le decisioni mediche sono una diretta applicazione delle norme ecclesiastiche, ed escludono il pluralismo. Per un esame critico, con un utile raffronto con l’approccio diverso che anima la Guida Medico-Morale dei vescovi canadesi del 1970, cfr. B. Häring, “Religious Directives in Medical Ethics, Roman Catholic Directives”, in Enc. of Bioethics, cit., IV, 1431-1435.
56 Per un abbozzo sistematico della morale medica di Häring, con particolare attenzione al metodo e ai principi a cui si ispira, vedi B. Soane, “The literature of medical ethics: B. Häring”, in Journ. of med. ethics, 1973/3, pp. 85-92. Nella miscellanea in onore di P. Häring, Chiamati alla libertà, Roma 1980, si può consultare con utilità il saggio di P. Beretta, “Sintesi e sviluppo della teologia di B. Häring”, pp. 379-391.
57 B. Häring, Liberi e fedelli in Cristo, vol. iii, Roma, 1981, p.13.
58 I due documenti sono riprodotti, con un commento, in S. Spinsanti, Umanizzare la malattia e la morte, Roma 19822.
59 Cfr. G. Crespy, “Maladie et guérison dans le N.T.”, in Lum. et Vie, 86 (1968) 45-69.
60 Cfr. J. L’Hour, La morale dell’Alliance, Paris 1966.
61 Una buona sintesi degli studi storico-esegetici dei racconti di guarigione nei Vangeli in G. Crespy, La guérison par la foi, Neuchâtel 1952; sulle implicazioni etiche del rapporto di Gesù col male fisico, cfr. S. Spinsanti, Etica cristiana della malattia, Roma 1971.
62 Il concetto latino di patientia esprime, secondo il suo valore etimologico, l’atteggiamento di disponibilità al dolore, che si estrinseca nell’accettazione e nella sopportazione del dolore. Invece l’equivalente greco — “hypomoné” —, usato nella traduzione greca dei Settanta e nel N.T., ha un significato prevalentemente attivo: cfr. G. Bornkamm, “Geduld”, in R.G.G.3, II, col. 1242; vedi anche G. Spicq, “Patientia”, in R.S.Ph.Th., 19 (1930) 95-106.
63 Gli aspetti apologetici e teologici del miracolo sono studiati correlativamente da L. Monden, Miracle, signe de salut, Paris 1963.
64 Un bilancio storico delle esperienze di guarigione carismatiche negli ambienti di lingua inglese della Riforma è offerto da L.D. Weatherhead, Psychology, Religion and Healing, New York 1951. Nella sua rassegna sul fattore terapeutico nelle religioni indugia soprattutto sulla Christian Science. Di contro a tanti abusi, tende a elaborare norme equilibrate per l’esercizio della funzione terapeutica nel cristianesimo.
65 Per il dono delle guarigioni, cfr. F. Mac Nutt, Il carisma delle guarigioni, Alba 1947; M. Scanlan, Inner Healing, New York 1974; per una valutazione del movimento carismatico nel suo insieme, cfr. R. Laurentin, Il movimento carismatico nella chiesa cattolica. Rischi e avvenire, Brescia 1976.
66 La riflessione teologica più approfondita sul rapporto tra “salvezza” e “guarigione” è quella di P. Tillich, Systematic Theology III, Chicago 1963, pp. 277-282. Tratta dell’esistenza di una guarigione spirituale, della sua correlazione con altre vie di guarigione, e in particolare con quel genere di guarigione che nel linguaggio religioso è chiamata “salvezza”. Si può ricondurre la trattazione molto articolata di Tillich a due principi: 1) L’impatto terapeutico della Presenza Spirituale non sostituisce le vie di guarigione valevoli nelle differenti dimensioni della vita. Nel campo della salute, della malattia e della guarigione si rende evidente l’unità multidimensionale della vita umana. Le differenti dimensioni che costituiscono l’essere umano non sono solo unite; sono anche distinte, e capaci di reagire con relativa indipendenza. Non c’è assoluta dipendenza nella dinamica delle differenti dimensioni, ma non c’è neppure un’assoluta indipendenza. Il grado in cui prevale l’unità o l’indipendenza decide il modo più adeguato di guarigione. Un approccio unilaterale alla guarigione deve essere risolutamente respinto; ma anche un approccio da più o da tutti i lati è inadeguato in alcuni casi. Anche quando vi fosse una linea di causa-effetto tra un comportamento peccaminoso e la malattia, la guarigione non è una questione di solo perdono, ma anche una questione di cure mediche e psicologiche. 2) Le altre vie di guarigione non possono sostituire il potere terapeutico dello Spirito. Ciò va tenuto presente soprattutto nei confronti della psicoterapia, che si è venuta a costituire come via di guarigione indipendente tanto dalla medicina quanto dalla religione. La pretesa psicoterapeutica di superare la negatività nella situazione esistenziale dell’uomo — ansia, colpa, disperazione, vuoto — può giungere fino a negare la linea verticale dell’incontro dell’uomo con la realtà.
67 Cfr H.Y. Vanderpool, “Miracle and Faith healing”, in EncycL of Bioethics, vol. iii, pp. 1120-1125.
68 Il mito di Filottete è stato utilizzato da V.E. von Gebsattel, Der Bogen des Philiktet, per la sua riflessione antropologica centrata sulla persona.
69 Esauriente documentazione in J. Jeremias, Teologia del Nuovo Testamento: I La predicazione di Gesù, Brescia 1972, pp. 199-205.
70 “Nell’atmosfera del tempo, il fatto che Gesù guarisse i malati doveva passare per una specie di empietà: anche se non li guariva tutti in senso quantitativo e statistico, ne guariva di ogni sorta, di tutti gli ambienti, ed è questo che era scandaloso per i suoi avversari”: P. Bonnard, L’évangile selon St. Mathieu, Neuchâtel 1963, p. 52. Lo stesso Bonnard fa notare che questa e simili pericopi, in cui Gesù è rappresentato come guarente tutti in massa, indistintamente, hanno la funzione di ricordarci che Gesù aveva ricevuto la missione di esercitare il suo ministero presso il popolo intero. Questa prassi era in stridente contrasto con la teologia dei farisei e degli esseni (ibi, p. 224).
71 R.A. Lambourne, Community, Church and Healing, London 1965.
72 Cfr AA. VV., Il sacramento dei malati. Aspetti antropologici e teologici della malattia, Torino 1975.
73 Cfr. AA. VV., Riforma sanitaria e comunità cristiana, Varese 1979; R. Ziglioli, Volontariato socio-sanitario. Una proposta, Varese 1980; Volontariato d’ispirazione cristiano (a cura della Caritas italiana), Bologna 1979; A. Oberti, Il volontariato segno di liberazione, Roma 1978.
74 Cfr. C.P. Sporken, Darf die Medizin, was sie kann? Probleme der medizinischen Ethik, Düsseldorf 1971.
75 Per una panoramica degli aspetti fenomenologici socio-culturali che hanno fatto crescere l’esigenza di un riferimento più articolato con i valori e le norme morali, cfr. A. Autiero-G. Mattai, Medicina e società, in L. Lorenzetti (a cura), Trattato di etica teologica, vol. 3, Bologna 1980, pp. 279-309.
76 W.T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, vol. 1, New York 1978, p. xix.
77 Su questa definizione di salute U. Eibach, Salute e malattia, in AA. VV. Chiamati alla libertà, Roma 1980, pp. 205-234, sviluppa riflessioni antropologiche ed etiche sul concetto e sul senso di salute e di malattia.
78 Tra le numerose pubblicazioni dedicate alla situazione americana, cfr. soprattutto R.M. Veatch (a cura), The Teaching of Medical Ethics, New York 1973; una rassegna della situazione comprendente anche l’Europa in S. Spinsanti, “La formazione etica del medico: nuovi orientamenti”, in Laboratorio di scienze dell’uomo, 1 (1981), 81-86; 2 (1981), 197-200.
79 L’inseminazione che prendiamo qui in considerazione è quella eterologa, con donatore (A.I.D., secondo la terminologia inglese ormai entrata in uso). L’inseminazione omologa, cioè con il seme del marito, è consentita legalmente in Italia e anche i moralisti cattolici la considerano con atteggiamento possibilista: cfr. M.D. Janni, “Fecondazione artificiale”, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, Roma 1973, pp. 401-412; R. Troisfontaines, “L’insémination artificielle. Problèmes éthiques”, in Nouvelle Revue Théologique, 95 (1973), pp. 764-778.
80 Secondo stime ufficiose, si calcola che circa 300 bambini nascono in Italia da inseminazione artificiale eterologa. Cfr. G.B. Garbelli, “Fecondazione artificiale”, in Diz. enciclopedico di teologia morale, (Supplemento), Roma 1976, p. 1341. La stima esatta è tuttavia difficile, perché l’inseminazione è praticata clandestinamente. L’A.I.D. è invece fiorente, negli Stati Uniti; G. Leach (The Biocrats Implication of Medical Progress, 1970) dà la cifra di 8000 candidati all’A.I.D. in quel paese. Da un inchiesta realizzata negli U.S.A. risulta che la metà delle coppie infeconde (per infecondità del marito) preferiscono l’A.I.D. all’adozione.
81 R. Simon, in un pregevole articolo apparso in Recherches de Sciences Religieuses, 62 (1974) 515-539: “Expérimentations et déplacements éthiques. A propos de l’insémination artificielle”, si spinge ancor più lontano, presentando la pratica inseminatoria come uno di quei settori estremamente adatti, per la loro novità, a provocare la riflessione sulle questioni di etica fondamentale. Essa illustrerebbe che la morale non si alimenta dal cielo etereo delle idee, bensì prende radice nell’esperienza e nell’azione come suo terreno privilegiato. L’inseminazione permette inoltre di discutere a quali condizioni e per quali motivi una sperimentazione accede alla dignità etica.
82 Le informazioni sul CECOS provengono da una visita al centro e da colloqui personali col dott. David. Esiste però anche sufficiente letteratura sul centro stesso. G. David: “Les banques de sperme en France”, in Archives Françaises de Pédiatrie, 32 (1975), 401-404; Id.: “L’insémination artificielle ou l’entrée de la prévention dans la reproduction humaine”, in Concours Médical, 8.11.1975, pp. 6270-6273; Id.: “Le couple donneur, le couple receveur”, in Echanges, n. 115, aprile 1974, pp. 26-27.
83 A titolo esemplificativo accenniamo alla situazione inglese. Due commissioni si sono occupate dell’inseminazione artificiale, delle quali una ha fornito i suoi risultati nel 1948 e l’altra nel 1960; ambedue si sono dichiarate ostili al procedimento. Un rapporto più recente (rapporto Peel, aprile 1973) è stato più favorevole, suggerendo che l’inseminazione fosse assicurata dal servizio sanitario nazionale. A tutt’ora resta accessibile solo in alcune aree scelte e dipende in ampia misura dalla decisione dei singoli medici. Cfr. W.F. Bodmer: “I progressi biomedici: una benedizione ambigua?”, in Rivoluzioni scientifiche e rivoluzioni ideologiche (a cura di R. Harré), Roma 1977, pp. 37-54.
84 P. Pohier, in Information Catholiques Internationales, n. 500, marzo 1976, p. 35.
85 Cfr. R. Mises - G. Semenov-Segur, “Approche psychologique de la demande”, in Echanges, n. 115, pp. 21-22.
86 F. Mantovani, “La sterilizzazione consensuale irreversibile alla luce del principio personalistico”, in Medicina e Morale, 19 (1979), pp. 191-198.
87 H.I. Shapiro, Manuale per il controllo delle nascite, Milano 1979, p. 271.
88 Una sintesi del problema dal punto di vista della teologia morale tradizionale è offerta da C. Caffarra, “Il problema morale della sterilizzazione”, in Medicina e Morale, 19 (1979), pp. 199-208.
89 Sacra Congregazione per la dottrina della fede, Documento sulla sterilizzazione negli ospedali cattolici, in Osservatore Romano 12.XII.1976.
90 B. Häring, Etica medica, Roma 19754.
91 E. Chiavacci, Morale della vita fisica, Bologna 1977.
92 Per una rassegna dei più recenti interventi in tal senso, cfr. la voce “Sterilization" in Encyclopedia of bioethics (W.T. Reich ed.), New York 1978, vol. IV, pp. 1606-1618.
93 Può essere considerata un’eccezione la posizione di alcuni moralisti cattolici che giustificano la sterilizzazione — considerata “indiretta” — nel caso di una ragazza ritardata mentale che potrebbe rimanere incinta nel caso che qualcuno abusi di lei. Cfr. Charles E. Curram, “Sterilization: Exposition, Critique and Refutation of Past Teaching”, in New Perpectives in Moral Theology, Notre Dame 1974, pp. 194-211.
94 John Fletcher, “The Brink: The Parent-Child Bond in the Genetic Revolution”, in Theol. Studies, 33 (1972), pp. 457-485.
95 La catechesi settimanale di Giovanni Paolo II sulla “teologia del corpo” è stata raccolta in un volumetto: Teologia del corpo (edizioni Paoline; collana “Magistero”), Roma 1982.
96 Da segnalare soprattutto l’opera di J. Money e della “Clinica per l’identità di genere” fondata alla Johns Hopkins University. Si è dedicato soprattutto allo studio di individui che mostrano una discordanza tra le varie componenti del sesso biologico, in particolare degli ermafroditi, che possiedono gli organi di ambedue i sessi. Nel presentare le acquisizioni scientifiche sul processo di acquisizione dell’identità sessuale e sulle sue disfunzioni seguiamo la opera di J. Money e A.A. Ehrhardt, Uomo, Donna, Ragazzo, Ragazza, Milano 1976, concepita in una prospettiva interdisciplinare.
97 “La nostra percezione di noi stessi quali individui unici — della nostra identità — è l’essenza di noi medesimi, al cui centro sta la nostra percezione di noi medesimi quali maschi o femmine, vale a dire la nostra identità di genere. È l’àncora della nostra salute emozionale, presente nell’amore e nel gioco, nei rapporti con gli altri. La nostra identità di genere informa di sé tutto quanto facciamo e diciamo. La nostra comprensione di noi medesimi e degli altri è limitata dall’intendimento del significato che ha — per noi e per loro — “essere uomo o essere donna”: J. Money e P. Tucker, Essere uomo, essere donna, Milano 1980, p. 6 s.
98 “È prematuro attribuire tutti gli aspetti dell’identità di genere al periodo postnatale della differenziazione sessuale. Abbiamo però prove sufficienti, forniteci dall’ermafroditismo umano, per affermare che la maggior parte della differenziazione dell’identità di genere nell’uomo avviene durante il periodo post-natale. Ciò avverrebbe come nello sviluppo del linguaggio... I casi studiati erano costituiti da coppie di ermafroditi, identici dal punto di vista cromosomico e gonadico e per altre caratteristiche, ma discordanti per assegnazione del sesso, storia biografica e identità di genere. Il contrasto tra i due individui di ciascuna coppia, per quanto concerne il ruolo e l’identità di genere, è tale che difficilmente si riesce a comprendere che essi abbiano una situazione analoga di patologia sessuale”: J. Money e A.A. Ehrhardt, cit., pag. 35. Il confronto dimostra quanto sia determinante la fase post-natale nella differenziazione dell’identità di genere. Si potrebbe quasi dire che dalla stessa creta si può formare un uomo o una donna...
99 Le turbe dell’identità e dell'orientamento sessuali sono molto più frequenti tra gli uomini che tra le donne. Dagli studi comparativi di natura clinica e sociologia sull’incidenza dei disordini dell’identità sessuale risulta una proporzione di 3 o 4 maschi per una donna. Sono statistiche che riguardano sia i transessuali che gli omosessuali. Le parafilie, poi, sono distorsioni quasi esclusivamente maschili. È come se per la natura fosse un compito più difficile differenziare l’identità maschile rispetto a quella femminile. Qualunque sia la spiegazione che si voglia adottare, resta un fatto incontestabile la maggiore fragilità psicosessuale del maschio.
100 Per un’analisi delle conseguenze morali e giuridiche della nuova legislazione, cfr. G. Perico, “Il fenomeno della transessualità. Rilievi clinici, giuridici e morali”, in A. Bottani (a cura), Educazione alla sessualità, vol. II, Milano 1982, pp. 987-999.
101 La resistenza dei medici ad adire le richieste dei transessuali può ricevere una spiegazione anche dal biologismo che predomina nel mondo medico, rendendo cosi i sanitari incapaci di valutare in modo appropriato l’importanza dell’identità sessuale. I medici tendono a privilegiare la sessualità morfologico-ormonale. In tal modo rischiano di cadere sotto la tirannia delle gonadi.
102 Cfr. B. Haering, “Omosessualità”, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, Roma 1974, pp. 628-689. Prevale attualmente nel discorso teologico la tendenza a evitare il ricorso alla nozione di “legge naturale”, a favore di una fondazione dei valori mediante categorie personaliste. Tuttavia l’uomo è, oltre che culturale per natura, anche “naturale per cultura”, secondo l’espressione di E. Morin: con nuove giustificazioni culturali continua a riferirsi alla natura come fondamento stabile dell’essere e dei comportamenti.
103 Cf. J. Money e P. Tucker, Essere uomo, essere donna, Milano 1980, p. 9. La funzione dello stereotipo sessuale viene considerata neH’ambito dell’identità di genere: “Allorché il nostro schema si adatta allo stereotipo, otteniamo il supporto della società per il nostro senso di identità, e per la stessa ragione un mutamento nello stereotipo fa stridere il senso che abbiamo di noi stessi. Come la colonna vertebrale, i nostri schemi dovrebbero essere abbastanza rigidi da sostenerci, ma anche abbastanza flessibili da permetterci di piegarci”.
104 J.M. Aubert, La donna: antifemminismo e cristianesimo, Assisi 1976.
105 Per quanto riguarda la revisione dei ruoli sessuali in modo conforme alla proposta originaria di Gesù, seguiamo H. Wolff, Gesù, la maschilità esemplare, Brescia 1979. È una rilettura del profilo psicosessuale di Gesù fatta sulla base della psicologia junghiana.
106 J. Spieler, “Interesse dell’O.M.S. per i metodi naturali di regolazione della fertilità. Valutazione clinica dell’efficienza del metodo dell’ovulazione”, in A. Cappella (a cura), Liberi e responsabili collaboratori di Dio Creatore, Roma 1981, pp. 75-93.
107 Esula dalla prospettiva di questo capitolo presentare una rassegna degli sviluppi del pensiero filosofico e teologico contemporaneo sulla morte. Basterà ricordare l'umanizzazione e personalizzazione della morte operata da M. Heidegger col comprendere l’uomo come “essere-per-la-morte”. I teologi, da parte loro, non sono rimasti indietro in questo recupero esistenzialista della morte e hanno proposto di vedervi P “adempimento” con cui l’uomo dà il volto definitivo alla propria esistenza (K. Rahner e L. Boros). Cfr. M. Bordoni, Dimensioni antropologiche della morte, Roma 1969 e S. Spinsanti, “Morte”, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, Roma 1973.
108 E. Morin, L’homme et la mort devant l’histoire, Paris 1951; una riedizione dell’opera, con notevoli modifiche, è stata pubblicata nel 1970; R. Caillois, Quatre essaies de sociologie contemporaine, Paris 1951.
109 G. Gorer, The Pornography of Death, London 1955.
110 Ph. Ariès, Essais sul l’histoire de la mort en Occident du Moyen à nos Jours, Paris 1975, p. 186 s. Ariès si occupa delle trasformazioni della mentalità occidentale verso la morte da una quindicina d’anni. I suoi studi, raggruppati di recente in questa raccolta, hanno contribuito a sensibilizzare gli studiosi già nel corso degli anni ’60.
111 E. Waugh, The Loved One, London 1948; tr. it. Il caro estinto, Milano 1966.
112 J. Mitford, The American Way of Death, New York 1963.
113 B.G. Glaser e A.L. Strauss, Awareness of dying, Chicago 1965.
114 B.G. Glaser e A.L. Strauss, Time for dying, Chicago 1968.
115 The dying Patient (a cura di O.G. Brim), New York 1970.
116 In un’opera successiva a quella già citata, G. Gorer, Death, Grief and Mourning, New York 1963, individua in numerose forme della patologia sociale d’oggi le conseguenze di una sofferenza morale repressa. Il prezzo dell’interdizione del lutto e del diritto a piangere i propri morti consisterebbe in un aumento della solitudine, della disperazione e della morbosità. È preoccupante l’aumento di nevrosi, il cui scoppio si situa al momento dell’arresto o della repressione di processi emotivi dopo il decesso di una persona amata.
117 The Meaning of Death (H. Feifel ed.), New York 1959. Alla raccolta Feifel ha partecipato col saggio: “Attitudes toward Death in Some Normal and Mentally Ill Populations”. Allo stesso Feifel è dovuta la voce “Death” in Taboo Topics (Farberow ed.), 1963, pp. 8-21; e ancora: “The function of attitudes toward death”, in Death and Dying: Attitudes of Patient and Doctor, New York 1965, pp. 632-641; Death Attitudes in Older Person Related to Proximity to Death, New York 1969.
118 Il titolo completo in inglese suona: On Death and Dying (What the dying have to teach doctors, nurses, clergy and their own families), New York and London 1969. La traduzione italiana, curata da Clara di Zoppola, è stata pubblicata dall’ed. Cittadella col titolo: La morte e il morire, Assisi 1976. Citeremo da questa edizione. Circa la traduzione non mancherebbe qualche rilievo critico. Le interviste, che trascrivono lo stile parlato, tradotte letteralmente — comprese le espressioni idiomatiche — risultano pesanti alla lettura. La traduzione di qualche termine è impropria. È una svista tradurre, p. 66, l’inglese coffin con “cofano”, dal momento che l’originale significa inequivocabilmente “bara” (con la traduzione inesatta si perde, del resto, il senso della fantasia ossessiva del malato in questione, che era appunto quella di essere rinchiuso da vivo in una bara, non in un “cofano”!).
119 Cfr. E. Kübler-Ross, Confrontation with dying (comunicazione a un seminario del Centro Gerontologico E.P. Andrus, Los Angeles 1971) e pubblicata a cura del Centro stesso nel 1972; una trad. franc., si può trovare nel numero speciale Rencontre avec les mourants della rivista Laënnec, 23 (1974), n. 2.
120 In uno studio su quaranta medici, accuratamente confrontati con altrettanti non medici, H. Feifel ha stabilito che i medici evitano l’idea della morte significativamente più degli altri e che vi reagiscono per paura più di altri gruppi. Gli studenti di medicina manifestano già gli stessi tratti; cfr. H. Feifel, Physicians consider death, New York 1967.
121 La “scientificità” dell’opera di E. Kübler-Ross è stata criticata dallo psicologo A. Godin, “La mort a-t-elle changé?”, in Mort et présence. Etudes de psychologie, Cahiers de Lumen Vitae, Bruxelles 1971, p. 242.