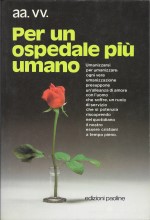
- Documenti di deontologia e etica medica
- Bioetica
- Bioetica in sanità
- Etico bio-medica
- Etica medica
- Le ragioni della bioetica
- Fondamenti di bioetica
- L'etica per una medicina umana
- La quotidiana fatica di essere razionali in medicina
- Le stagioni dell'etica in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina
- Die Medizinische anthropologie
- Verso una medicina della persona
- Bioetica global o la sabiduria para sobrevivir
- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche
- De la nature et de la personne en bioéthique
- Il valore della complessità e la metodologia clinica
- Quale etica per l'ebm?
- Cattivi pensieri sugli errori in medicina
- Il medico: servo di tre padroni?
- Il medico servo di tre padroni
- Ethical foundations for a culture of safety
- Etica e malattie rare
- Interessi plurali, interessi in conflitto nella pratica clinica
- Conflitto di interessi
- Commento a "Problemi etici nel trapianto renale da vivente"
- La bioetica: una via per la crescita della coscienza
- L'incertezza medica incontra la bioetica
- Il giudizio morale è fuori dall'emotività
- Legge, deontologia ed etica
- Implicazioni etiche dell'obiezione di coscienza nella professione medica
- La boxe: un problema di etica medica?
- L'etica in medicina
- Cancro e persona umana: considerazioni etiche
- Tecnologie riproduttive ed educazione al giudizio etico
- La professione del medico in un contesto nuovo
- Istruzioni per boicottare la bioetica
- L'etica nella vita del medico
- Quale etica per la medicina?
- Bioetica: problematiche emergenti e prospettive
- L'etica all'ombra del «tao»
- Obtaining Consent from the Family: A Horizon for Clinical Ethics
- La bioetica clinica
- Le regole del gioco
- Verso la medicina delle scelte
- La qualità nel Servizio Sanitario
- Domande a Sandro Spinsanti
- Bioetica clinica per operatori sanitari
- Etica e terapia
- La decisione in medicina come problema etico
- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche
- Scienza e coscienza come responsabilità morale
- Troppe domande ancora senza risposta
- Un diritto gentile
- L'antropologia medica di Viktor v. Weizsäcker
- Guarire «tutto» l'uomo
- Come si diventa bioeticisti: il cammino di una professione discussa
- L'etica per una medicina umana
- Die Medizinische anthropologie
- Curare e prendersi cura
- «Dottore, sto male» - «Mi racconti»
- L'occhio clinico e l'occhio dell'artista
- Medical Humanities
- Sotto il segno di Giano
- L’antropologia medica di Viktor von Weizsäcker: conseguenze etiche
- Verso una medicina antropologica
- La riflessione antropologica in medicina
- Per una medicina più umana
- L'educazione alla salute come sfida per una medicina umanistica
- La formazione in bioetica come emergenza
- La formazione etica del medico 1
- La formazione etica del medico 2
- Servizio di bioetica: che cos'è?
- Il processo di cambiamento nella sanità italiana
- Formarsi alla nuova sanità
- Guaritori da guarire
- Se la cura è di genere femminile
- Bioetica e formazione permanente del personale sanitario
Sandro Spinsanti
L'ETICA PER UNA MEDICINA UMANA
in AA.VV., Per un ospedale più umano
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985
pp. 59-88
1. L’etica in medicina? No, grazie!
Per qualcuno l’accostamento tra l’etica e la medicina va da sé: può immaginarsele addirittura come due sorelle che procedono mano nella mano, mentre la più grande e saggia — l’etica, beninteso! — ammaestra la seconda... Per altri, invece, la prima reazione è di rifiuto: l’etica è sentita come un’ingerenza indebita nell’ambito della medicina. Specialmente tra i sanitari italiani è questa la reazione più diffusa. Le argomentazioni sono varie. Il più sovente l’etica è rifiutata in nome di una concezione scientifico-positivista e tecnologica della medicina. Si presume che la scienza, compresa quella medica, sia obiettiva e abbia a che vedere solo con i fatti, e che sia suo unico interesse tenersi lontana da ogni commistione con le ideologie: i dibattiti vanno lasciati ai filosofi e agli avvocati! Anche se la massiccia fede positivistica del XIX secolo si è da tempo dissolta alla luce dell’epistemologia e della filosofia della scienza contemporanea, la concezione di una scienza medica indipendente dai valori continua a motivare il rifiuto dell’etica. L’inizio dell’era tecnologica in medicina sembra avere radicalizzato la tendenza.
Ancor più polemica contro ogni idealizzazione della professione è la rappresentazione della medicina come una forma di artigianato; magari dotata delle sofisticate tecnologie moderne, ma in sé niente più che
60
abile artigianato. In quest’ottica, essere un «buon» medico equivale a fare «bene» il proprio lavoro, valutando tale bontà col criterio dell’efficienza e della qualità della prestazione tecnica. Posizioni di questo genere sono riconducibili al cosiddetto «codice Hemingway». Secondo lo scrittore, infatti, una delle ripercussioni sulla vita morale delle situazioni in cui non si vede via d’uscita — quella a cui si riferisce più specificamente è il carnaio della guerra in Spagna, descritto in Per chi suona la campana — è quella di portare a concentrare tutto il proprio impegno nel fare ciò che si fa così come deve essere fatto, astraendo del tutto la questione dal suo significato (combattere «bene» è tutto l’ideale morale del combattente, mettendo completamente tra parentesi la domanda circa il perché si spara; di qui il consiglio che riceve il protagonista del romanzo: «Quando spari non pensare che spari a un uomo, ma a un bersaglio!»).
Mentre la prima ragione del rifiuto dell’etica può essere etichettata come scientismo, la seconda può esserlo come efficientismo. La medicina evoca spontaneamente un ambito in cui il primato non spetta al pensare, ma al fare; in cui si è chiamati a rimboccarsi le maniche e a mettere le mani in pasta, piuttosto che a prendere le distanze e riflettere. I risultati della medicina si misurano nelle guarigioni: queste monopolizzano tutto l’interesse del sanitario. «L’essenziale è guarire: tutto il resto non conta», si sente spesso ripetere da parte di chi opera nella sanità. Lo slogan serve a giustificare sia le grossolane o sottili trasgressioni che avvengono nella prassi medica e ospedaliera ai danni dei diritti del malato, sia la programmatica esclusione di ogni preoccupazione di ordine morale.
Non sempre il rifiuto dell’etica assume toni così drastici. Un modo più elegante è quello di circoscriverne talmente la portata, da renderla praticamente
61
irrilevante. Possiamo riferirci, come esemplificazione, alla posizione che troviamo rappresentata dalla voce che l'Enciclopedia Britannica dedica alla base etica della pratica medica 1. Nella pratica quotidiana della medicina — afferma l’articolo — i medici dedicano poco tempo a considerare la base etica del loro lavoro. Si limitano ad accettare come scontati alcuni principi morali, sia che li facciano derivare da Ippocrate, o dalla legge naturale, o da quella divina, o semplicemente dal buon senso. Fanno del loro meglio a vantaggio dei loro pazienti: con metodi curativi se possibile, altrimenti ricorrendo al sollievo palliativo dei sintomi; dicono la verità (eccetto quando questa ferisca troppo); non rivelano le confidenze dei loro pazienti. I problemi etici sorgono solo in circostanze speciali, e sono quindi sostanzialmente eccezionali. L'Enciclopedia Britannica ne menziona tre: l’aborto, il prolungamento artificiale della vita in pazienti con danni cerebrali irreversibili e il conflitto di un medico d’azienda, chiamato a visitare dei potenziali impiegati, tra la lealtà verso il datore di lavoro e la solidarietà verso l’individuo, nel caso in cui avesse diagnosticato una malattia che lo rende meno abile al lavoro.
Questa posizione restrittiva è istruttiva sia per quello che dice, che per quello che presuppone implicitamente. Dà infatti per acquisito che nella nostra cultura non si dia di fatto una pratica medica che non si ispiri a un certo ideale etico. Facendo ricorso a una formula consacrata del passato, si può dire che il medico è sempre concepito come vir bonus sanandi peritus. La morale del tempo ha variamente determinato come vada intesa la «bonitas». Un elemento costante
62
di essa, malgrado tutte le fluttuazioni culturali, è l’ideale filantropico, tradizionalmente riconosciuto come l’anima della medicina stessa. L’ethos ippocratico, a cui i medici amano richiamarsi, ha storicamente svolto il compito di tenere desto quell’ideale. Più che gli specifici impegni compresi nel giuramento — culturalmente condizionati e datati —, è l’ispirazione generale che conta, quella che fa concepire la professione sanitaria come un servizio a tutta l’umanità, come un impegno interpersonale, al di sopra di tutti i particolarismi e le divisioni tra gli uomini.
Dalla stessa matrice ippocratica derivano, oltre all’ideale filantropico, anche delle norme comportamentali connesse con la professione, che bisogna osservare per essere un «buon» medico. Si tratta della deontologia professionale. Nella storia della professione medica è emersa precocemente la convinzione che fosse opportuno codificare non solo le conoscenze patologiche e terapeutiche, ma anche le regole relative al comportamento che il medico deve tenere con il paziente. Indicazioni sul comportamento corretto sono frequenti nei trattati medievali di medicina. Non mancano neppure abbozzi di una regolazione dei rapporti con gli altri medici, all’interno della professione. Col tempo si è formato un corpo di regole pratiche che costituiscono ciò che potremmo chiamare l’«etichetta» medica. Questo corpo precettistico, a partire dal secolo XIX, sarà a più riprese codificato nei codici deontologici.
Nella deontologia confluiscono tanto l’ethos filantropico quanto le norme che regolano il comportamento dei medici tra di loro e con i pazienti. Le norme non sono dedotte da un’etica, religiosa o laica che sia, ma derivate da un corpo sociale intermedio tra lo Stato e l’individuo, e con cui il medico si identifica: il gruppo professionale. La codificazione del comportamento
63
serve agli interessi del gruppo; e indirettamente a quelli degli utenti dei servizi medici. La deontologia comprende un insieme specifico di doveri (il termine significa appunto «scienza dei doveri») ai quali sono tenuti i membri di una professione, diversi da quelli imposti dalla legge o derivanti dall’etica alla quale l’operatore sanitario si riferisce. Sono i doveri che derivano dal fatto di esercitare una determinata professione 2. Aderendo alla professione, i membri del gruppo si impegnano a rispettare le norme ritenute essenziali per il buon esercizio della professione stessa. Le norme deontologiche sono dunque, più che un semplice regolamento: le si potrebbe chiamare uno «spirito» comune, che deriva da una percezione collettiva dell’attività svolta, nel senso di questa attività e del suo articolarsi con l’organizzazione sociale.
Questo riferimento alla deontologia, al suo significato e alla sua funzione, va tenuto presente per capire l’appassionato richiamo ad essa da parte dei medici. Tra le diverse professioni, quella medica è stata la prima che, in modo quasi esemplare, ha elaborato una propria deontologia. Essa si è espressa in una quantità di prese di posizione da parte di organismi professionali e assemblee autorevoli, nazionali e internazionali: giuramenti, codici, dichiarazioni, carte dei diritti, raccomandazioni 3. Questa preoccupazione per il «giusto» comportamento professionale esaurisce, secondo alcuni, tutto l’ambito della normatività in medicina. Di fronte alla prospettiva di una riflessione etica sulla pratica medica, diversi sanitari motivano il loro rifiuto riferendosi alla deontologia.
64
Alcuni usano il termine semplicemente come sinonimo di «etica» e di «morale»; altri, pur ammettendo una distinzione, ritengono che non sussistono motivi per introdurre l’etica accanto alla deontologia: semmai quest’ultima va ampliata e potenziata, inglobando tutto ciò che si presenta come un dovere per il medico: sia che derivi da norme del diritto positivo che da esigenze etiche, da fattori consuetudinari o validati come correttezza professionale 4.
L’etica, dunque, si vede contestato il suo diritto di cittadinanza in medicina. Rifiutata in nome dell’oggettività della scienza, o ritenuta superflua nella prospettiva dell’efficienza tecnologica, o ricondotta al diritto codificato e alla deontologia professionale, appare come un ospite indesiderato accanto al letto del malato. Devono pur esserci dei motivi più profondi in questa resistenza all’etica e varrà la pena indagarli: niente è più istruttivo che cogliere la parte di verità contenuta nella posizione di chi dissente. Prima, tuttavia, è opportuno registrare la vivace spinta verso il ricorso all’etica per umanizzare la medicina che si registra in alcuni paesi.
65
2. E venne infine la «bioetica»...
«Più veloce va il mondo, più forte è la tentazione dell’ignoto, e più dobbiamo saper prendere tempo: il tempo della misura che chiamerei il tempo dello scambio e della riflessione, cioè il tempo della morale». Non è un «moralista» di professione che parla, bensì François Mitterand, il presidente della Repubblica francese, in occasione di un’assemblea (Parigi, 6-7 dicembre 1984) in cui si faceva il bilancio di un anno di lavoro del «Comitato nazionale di etica per le scienze della vita e della salute», da lui stesso istituito.
Il tempo della morale per la biologia e la medicina in altri paesi sembra giunto da tempo. Un ruolo d’avanguardia in questo settore hanno giocato gli Stati Uniti. Nell’ultimo ventennio vi si è delineato un vivace movimento di reazione a una medicina senza interessi etici e umanistici, una medicina unicamente impegnata nel versante scientifico e tecnologico. Qualcuno afferma che quella che si è messa in moto è una rivoluzione nel modo di concepire la medicina (una rivoluzione che, come le rivoluzioni più riuscite, non è solo innovazione, ma anche recupero di valori del passato che erano stati negati).
Il nuovo interesse per i problemi etici in medicina risale agli inizi degli anni ’60. All’inizio vede come primi protagonisti soprattutto assistenti spirituali e cappellani di campus universitari e delle facoltà di medicina. Un certo numero di loro, di diverse confessioni religiose, cominciò a preoccuparsi della tendenza sempre più accentuata in medicina a separare il fatto tecnico da quello umano. Li affiancava uno sparuto gruppo di medici, contrari anch’essi all’esclusivo orientamento tecnicistico. Non si limitarono a registrare passivamente o a denunciare l’emorragia di anima
66
nella professione sanitaria, ma decisero di reagire. Nel 1968 fu fondata una «Society for health and human values» (Società per la salute e i valori umani), particolarmente sostenuta dalla chiesa presbiteriana. La Società si prodigò con un impegno senza pari in campo educativo, venendo a svolgere la funzione di università specializzata senza pareti.
L’obiettivo di questo periodo pionieristico era quel lo di suscitare l’interesse e di stimolare progetti concreti all’interno delle scuole di medicina. Grazie a quel lavoro di sensibilizzazione, sembra ormai universalmente recepito nella società americana che non si può formare buoni medici e infermieri trascurando l’insegnamento dei valori umani implicati nell’azione terapeutica. E mentre, fino a una quindicina di anni fa, tale insegnamento formale non era contemplato da quasi nessuna scuola di medicina, ora, agli inizi degli anni 80, non esiste scuola medica o infermieristica in America che non faccia posto all’etica come parte integrante del curriculum di formazione dei professionisti della sanità 5.
La rapida diffusione del movimento non va fatta risalire unicamente all’entusiasmo degli idealisti; anche gli investimenti economici vi hanno giocato una parte rilevante. Un imponente aiuto è stato fornito dal governo federale tramite il «National endowment for the humanities», il fondo creato appositamente per incrementare lo sviluppo della prospettiva umanistica nelle scienze. La parte del leone nella suddivisione del fondo l’ha fatta la medicina. Sono stati forniti sussidi e borse di studio alle scuole di medicina per creare nuovi programmi di insegnamento di
67
discipline umanistiche, che comprendono, oltre all’etica, la sociologia, la storia, l’antropologia ecc.
Oltre ad aver conquistato una solida testa di ponte nel curriculum degli studi medici, il punto di vista dell’etica ha trovato un’udienza attenta negli ambienti scientifici e presso l’opinione pubblica. Un’azione impareggiabile in tal senso ha svolto una Commissione appositamente stabilita dal Presidente degli Stati Uniti per studiare i problemi etici della medicina e della ricerca scientifica. La Commissione, dotata di un fondo di 20 milioni di dollari e costituita da eminenti personalità del mondo del diritto, della medicina, della filosofia e della teologia, ha lavorato dal gennaio 1980 al marzo 1983. In tre anni sono stati prodotti 11 volumi, di cui 9 relazioni su problemi specifici e una guida per comitati locali che si occupano della ricerca con gli esseri umani. Alla luce dei valori che costituiscono il tessuto di fondo della vita civile americana — libertà, onestà, rispetto per la dignità umana — sono stati sistematicamente presi in considerazione i problemi più inquietanti del campo biomedico che turbano la vita degli americani nell’ ultimo quarto di secolo: quanto devono essere protratti i trattamenti che prolungano la vita umana? La società deve assicurare a ogni cittadino l’assistenza sanitaria, e in che misura? Devono i sanitari dire la verità ai pazienti, anche se è infausta? Chi deve pagare i danni che subiscono i soggetti umani sui quali si fa la ricerca? Che cosa si deve tentare nel campo delle manipolazioni genetiche, e dove eventualmente arrestarsi?
La Commissione presidenziale non era autorizzata a dare risposte conclusive o direttive moralmente obbliganti. Ha fatto una capillare opera di sondaggio, tastando le reazioni etiche della nazione ai progressi realizzati dalla biologia e dalla medicina. Su alcuni
68
problemi sembra delinearsi facilmente un consenso di fondo; su altri invece le opinioni divergono in maniera significativa. Sfogliando i rapporti della Commissione, gli argomenti più delicati appaiono essere quelli dell’intervento medico nella produzione umana, del prolungamento artificiale della vita e dei progressi delle neuroscienze, con la possibilità di alterare non solo l’umore, ma anche i pensieri e le emozioni. Quanto al primo ambito di problemi, basti citare il dato numerico di 10.000 bambini che nascono ogni anno per inseminazione artificiale. La Commissione, oltre a registrare il disaccordo sulla valutazione etica di questa pratica, denuncia la situazione caotica della legislazione a tale riguardo. Il caos giuridico ed etico che circonda l’inseminazione artificiale si amplia per ciò che riguarda la fertilizzazione in vitro, l'embryo-transfer, il dono di ovuli e gli uteri in affitto.
All’America spetta anche il merito di aver creato il neologismo per designare il nuovo campo di interessi e di studi. Si è cominciato a parlare di bioethics, con un termine che attualmente si sta diffondendo anche in altri ambiti linguistici. Una parola nuova per creare un’aura di curiosità intorno a un vecchio prodotto? Ancora alcuni rimangono perplessi di fronte al termine e non capiscono immediatamente di che cosa si tratti. La definizione che ne fornisce l’autorevole Encyclopaedia of Bioethics circoscrive accuratamente l’ambito della disciplina: «lo studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della sanità, in quanto questa condotta è esaminata alla luce dei valori e dei principi morali» 6. La problematica tradizionale concernente le norme per essere un «buon» medico è inclusa, ma
69
anche trascesa. Oltre alla professione medica, vengono coinvolte anche altre professioni che fanno riferimento alle scienze biomediche e alla cura della salute: ricercatori biologi e amministratori, psichiatri-psicoterapeuti e infermieri, dentisti e assistenti sociali. Nella sensibilità sociale del nostro tempo, inoltre, l’ottica da cui affrontare i problemi etici non è più solo quella che fa capo al medico e alla sua ricerca di essere un «vir bonus»: oggi questa prospettiva viene per lo più sospettata di paternalismo. L’approccio deontologico, basato sui doveri del sanitario, è corretto e integrato dalle rivendicazioni che partono dai «diritti del paziente» e dalle esigenze della giustizia sociale 7. La questione tradizionale di ciò che è permesso e di ciò che non lo è, in riferimento ai valori ai quali ci si orienta, assume un’altra formulazione: è lecito fare tutto ciò che la tecnologia biomedica è in grado di fare? La domanda è particolarmente pressante se dal campo della terapia ci spostiamo a quello ella ricerca (si pensi solamente al campo dell’«ingegneria genetica»).
Un altro ampliamento favorito dalla bioetica, rispetto all’etica medica tradizionale, è l’inclusione di problemi che trascendono il rapporto interpersonale
70
medico-paziente. La bioetica ci porta a interrogarci sulle nostre responsabilità nei confronti di tutti gli organismi viventi e dei processi della vita. Dobbiamo conformare a ragionevolezza e senso di responsabilità anche i nostri comportamenti nei confronti della vita subumana, animale e piante incluse, dal momento che siamo diventati più consapevoli dell'interdipendenza di tutti i viventi. La mentalità ecologica provoca un allargamento della portata dell’etica, includendovi i problemi dell’ambiente e la responsabilità verso le generazioni future. La rottura degli equilibri ha infatti effetti cumulativi che potrebbero compromettere la salute e la qualità della vita di coloro che ci seguiranno sul pianeta.
Di tale ampiezza è la portata della bioetica. La novità dell’impianto giustifica la novità del nome. La bioetica non va semplicemente equiparata, né per contenuti né per metodo, con la tradizionale etica medica, e tanto meno con la deontologia professionale. Strumento privilegiato dell’affermazione della bioetica è stata l'Encyclopaedia of Bioethics sopra citata. L’opera — quattro volumi di grande formato, più di 1.900 pagine, con i contributi di 290 autori e il lavoro di 500 persone tra consulenti e revisori di ogni parte del mondo — è apparsa nel 1978, dopo 6 anni di elaborazione. La fucina dell’enciclopedia, diretta da Warren Reich, è stato il Kennedy Institute of Ethics della Georgetown University di Washington. Fatto più unico che raro, l’enciclopedia non è stata creata successivamente al costituirsi della disciplina di cui raccoglie il sapere, ma contemporaneamente ad essa; anzi, l’affermarsi del termine «bioetica» deve molto all’enciclopedia che lo ha diffuso prima ancora che diventasse di uso corrente. L’enciclopedia ha dato largo spazio alla fondazione concettuale della disciplina stessa. Nell’impianto dell’opera, oltre alla trattazione
71
monografica dei singoli problemi, sono compresi articoli circa la posizione delle grandi religioni mondiali relativamente all’etica delle scienze e della medicina; include anche le grandi filosofie secolari e i concetti antropologici fondamentali, come salute, malattia, morte, guarigione, normalità ecc. L’impostazione è pluralistica: rispecchia tutte le posizioni etiche, religiose e laiche, senza prendere posizione a favore dell’una o dell’altra. Questa scelta metodologica è più che una caratteristica dell’opera: è un tratto distintivo della bioetica in quanto disciplina. Non vuol essere uno strumento di indottrinamento, né di imposizione di una determinata convinzione religiosa o morale: essa nasce e cresce in una dimensione di pluralismo ideologico. Questa caratteristica ha favorito l’accettazione della bioetica da parte del mondo medico, a cominciare dalle facoltà di medicina. Lo prova il fatto che nelle scuole mediche americane il corso di bioetica è tra i più frequentati tra i corsi che gli studenti hanno nello stesso semestre. E attualmente tra le 125 scuole mediche americane ben 116 hanno introdotto corsi di etica o di «Humanities».
È solo la società americana, democratica e pluralista nei suoi valori e nei suoi sistemi, che può accettare il rischio di introdurre l’etica in biologia e in medicina? E un fatto che, anche nel vecchio mondo, mai in ambito biomedico la «morale» è stata sollecitata in modo così immediato come ai nostri giorni, dietro la spinta dell’aprirsi di nuove frontiere. Il tema del giorno sarà, volta a volta, il trapianto di un cuore di babuino su un neonato, o il diffondersi delle pratiche di concepimenti extracorporei e maternità per procura, o le proposte di una nuova legislazione in tema di eutanasia. I mezzi di comunicazione sociale rafforzano la sollecitazione, promuovendo talvolta i giornalisti al ruolo di moralisti... In queste situazioni
72
l’emotività rischia di prendere il sopravvento sulla ragione. E, non avendo più l’abitudine di riflettere, nel confrontare le esperienze troppo frammentarie che sono le nostre tendiamo a cadere vittime dell’intolleranza. Nessuno, d’altra parte, nell’attuale società pluralista gode di un’autorevolezza morale indiscussa, che permetta di far convergere su un’opinione l’unanimità dei consensi.
Come tentativo di supplire a tale carenza può essere considerata l’iniziativa francese di costituire un Comitato nazionale per le scienze della vita e della salute. È stato istituito dal presidente della Repubblica nel dicembre 1983. Sotto la presidenza del prof. Jean Bernard, il comitato di «saggi» ha esaminato alcuni, dei problemi più scottanti del momento. Su ognuno è stata organizzata dapprima una consultazione sulle diverse opinioni; il Comitato ha poi espresso il suo parere, cui spetta l’autorità morale che ognuno vuole attribuirgli. I pareri del primo anno di attività hanno preso in considerazione successivamente: i prelievi di tessuti di embrioni o di feti umani morti a fini terapeutici, diagnostici e scientifici; le pratiche dette di «affitto dell’utero»; l’uso di nuovi farmaci sugli esseri umani nell’ambito della terapia e della ricerca. Nel programma di lavoro per il 1985 sono previsti interventi della Commissione sulla diagnosi prenatale, sulla schedatura medica (in particolare dei malati di cancro ai fini di uno studio epidemiologico), sulla ricerca relativa alle malattie mentali e al cervello.
Abbiamo riferito dettagliatamente le vicende del movimento americano che ha portato la bioetica sulla cresta dell’attualità e abbiamo menzionato la Commissione etica francese per le scienze biomediche. Senza pretesa di completezza, volevamo solo documentare che, in giro per il mondo, ci sono altre risposte
73
alla richiesta attuale di considerare i problemi della sanità dal punto di vista dell’etica, che non scelgono la chiusura e la diffidenza pregiudiziale. Tuttavia le resistenze ad aprire le porte all’etica devono avere anche delle buone ragioni. Proprio queste vogliamo ora prendere in considerazione.
3. Dapprima, umanizzare l’etica
L’etica per umanizzare la medicina? Sì, ma a condizione che sia un’etica per l’uomo, e non contro l’uomo! L’etica e la morale evocano associazioni mentali le più svariate; alcune di queste sono recepite come disvalori. Bisogna quindi intendersi sul significato che si vuol attribuire al progetto di introdurre l’etica in medicina. Quale etica? Alcune resistenze sono più utili di un’accettazione acritica, perché ci offrono l’occasione per purificare il nostro concetto di etica.
Il discorso sull’umanizzazione della medicina viene fatto per lo più a partire dalla morale. Ciò che il più sovente si intende con questo termine non è la disciplina filosofica che considera il comportamento umano alla luce del bene e del male, bensì, in senso molto riduttivo, ci si riduce in pratica a «fare la morale» ai medici e al personale sanitario. Si richiamano i medici e gli infermieri agli ideali umanitari e filantropici tradizionalmente connessi con le professioni terapeutiche, accusandoli di allontanarsi da essi in modo più o meno vistoso. Anche l’esaltazione della professione medica, considerata come «missione», conduce allo stesso risultato: confrontato con un modello troppo idealizzato — qualcuno si spinge fino a considerare le professioni sanitarie come una specie di «sacerdozio» della salute — il medico tende a ripiegare
74
sulla rassegnazione o il cinismo 8. I risultati di simili campagne di moralizzazione sono per lo più nulli. Quando non addirittura controproducenti: i sanitari, sentendosi sotto accusa, si chiudono in se stessi corporativisticamente, oppure rispondono alle critiche, percepite come aggressione ostile, con altrettanta ostilità. Sulla base di una tale reciproca incomprensione non si può costruire nessun progetto di riumanizzazione della medicina. Si scava, piuttosto, un fossato sempre più ampio di indifferenza, proprio in un ambito in cui il rapporto di fiducia è tutto.
Per una questione di giustizia, e non per tattica, a coloro che lavorano nell’ambito della sanità bisogna anzitutto tributare il riconoscimento che non svolgono un lavoro come gli altri: per la particolare situazione del malato — talvolta in lotta drammatica per la vita e la salute, in stato di particolare tensione emotiva sempre — i sanitari sono coinvolti e sollecitati a una partecipazione umana che supera quella di qualsiasi altro lavoro. Quando per umanizzare la medicina si pigia esclusivamente il pedale dei sentimenti, colpevolizzando al tempo stesso i sanitari di non mettere abbastanza cuore in quello che fanno, la morale, da terreno saldo di consenso sulla base della condivisione degli stessi valori umanitari, rischia di tramutarsi in insidiose sabbie mobili.
Una particolare insidia è insita nelle argomentazioni moraleggianti di tipo religioso. Quando, ad esempio, si presenta unilateralmente il lavoro sanitario sotto la metafora del buon samaritano, e a medici e infermieri
75
viene richiesto un comportamento tutto modulato sull’oblatività, l’abnegazione e l’amore del prossimo, si incrementa al tempo stesso il senso di inadeguatezza e quello di colpa. Ciò che ne consegue è per lo più una brusca interruzione di contatto con chi si presenta con la proposta di un ideale così manifestamente lontano da ogni applicabilità. E ciò a discapito, ovviamente, della causa dell’umanizzazione della medicina che si intende servire. Da questo punto di vista, più che di rifiuto dell’etica bisognerebbe parlare del rifiuto delle «prediche», nel senso angustiante e oppressivo del termine.
Un altro motivo di allergia all’etica in medicina è l’equiparazione dell’etica a un sapere dogmatico. Si ha paura che l’insegnamento dell’etica si risolva nella trasmissione di un sapere precostituito, elaborato in altra sede: la sede, appunto, dove le istituzioni totalitarie forgiano le loro certezze. I medici temono che la loro coscienza e il loro operato siano in qualche modo colonizzati da un’istanza esterna, unica accreditata a giudicare ciò che è bene o male, morale o immorale, conforme o no alla natura umana. Ciò spiega in parte perché i medici preferiscono privilegiare l’aspetto tecnico della loro professione rispetto a quello umano, e tendano a navigare lontano dagli insidiosi dibattiti sui principi etici, appellandosi al pragmatismo. Temono che l’etica sia il cavallo di Troia che può introdurre nella medicina la violenza dell’ideologia.
In concreto, il dogmatismo può presentarsi sotto due forme: le ideologie politiche totalitarie e la morale religiosa. Non è per caso, del resto, che in ambito europeo le uniche istituzioni che prevedono l’insegnamento dell’etica medica obbligatorio per tutti gli studenti di medicina sono alcune università cattoliche e le università della Repubblica Democratica
76
Tedesca, dove viene insegnata l’etica medica alla luce della dottrina di stato, cioè il marxismo-leninismo.
Nelle pubblicazioni accademiche dei paesi socialisti si incontrano attacchi sistematici alla medicina borghese, alla quale viene contrapposta la medicina veramente «scientifica», cioè quella che si basa sull’interpretazione marxista-leninista della realtà. L’etica marxista è incorporata sistematicamente nella medicina, determinandone le scelte e gli orientamenti. Troviamo un riscontro di questa impostazione nel giuramento che il Presidium del Soviet Supremo ha imposto nel 1971 a tutti i medici russi. Il modello del giuramento ippocratico è abbandonato, per dare rilievo al significato politico del gesto. Al posto del dovere umanitario e filantropico nei confronti del singolo paziente subentra l’impegno del medico a servire gli interessi della società. Il giovane medico si impegna ad esercitare là dove la società ha bisogno della sua opera e ad aderire internamente ai principi marxisti e all’etica comunista che regolano la società: («Giuro... di lasciarmi guidare in tutte le mie azioni dai principi della morale comunista, di ricordarmi sempre dell’alta vocazione del medico sovietico e della responsabilità nei confronti del popolo e del governo sovietici»).
La paura di cadere nelle mani di chi vuol imporre certezze dogmatiche nei paesi democratici dell’Occidente induce ad atteggiamenti difensivi soprattutto nei confronti della morale religiosa. I diversi gruppi confessionali hanno da tempo appuntato la loro attenzione sui problemi che derivano dalla medicina moderna. Prima di prendere piede in modo così esuberante nelle scuole di medicina americane, l’etica medica è stata una disciplina coltivata esclusivamente nelle facoltà teologiche e nei luoghi di formazione dei pastori. Soprattutto la morale cattolica ha seguito con
77
attenzione e preoccupazione l’accelerazione del progresso in medicina e ha formulato tempestivamente risposte etiche precise ai nuovi problemi che emergevano 9.
Ora, lo scopo di questa morale è di applicare ai problemi di coscienza che sorgono nella prassi medica la visione antropologica ed etica derivante dal sistema dottrinale cristiano, fondato su una rivelazione divina e mediato da un Magistero autorevole. A livello operativo quest’etica mira a normare il comportamento dei credenti, vuol portarli ad agire in modo consono con la morale della Chiesa. Tratto caratteristico della morale medica cattolica è la sua tendenza a presentarsi come corpo dottrinale monolitico, garantito in toto dall’autorità ecclesiastica. Il peso del magistero papale si è fatto sentire in tutte le questioni più cruciali. La linea dominante è stata sempre quella della rigidità. Sulla questione dell’aborto, per esempio, già fin dalla fine del secolo scorso il Sant’Uffizio con numerosi interventi escluse la legittimità di alcuni interventi eccezionali che in passato non erano stati espressamente condannati. Si venne così a delineare quella posizione di fedeltà assoluta ai principi che presso l’opinione pubblica veniva spesso equiparata a un rispetto della legge morale che offuscava l’amore per le persone. Nella risposta al dilemma: la madre o il bambino?, la morale cattolica rispondeva: né l’una, né l’altro, se l’intervento consiste in un’uccisione
78
diretta. Le encicliche papali Casti Connubii (1930) e Humanae Vitae (1968) presero dettagliatamente posizione sulla regolazione delle nascite e condannarono tutti i metodi contraccettivi, salvo i metodi naturali.
Benché fosse generalmente riconosciuto che l’insegnamento nell’area dell’etica medica non rientra nella categoria dell’insegnamento infallibile, l’autorevolezza magisteriale concludeva, in pratica, i dibattiti ed escludeva le opinioni divergenti dei teologi moralisti. Lo spirito della Humani Generis (1950) — secondo cui, dopo un pronunciamento pontificio su un argomento controverso, i teologi non possono più dibatterlo liberamente — ha gravato anche sulla morale medica cattolica. Anche le direttive religiose ed etiche promulgate più di recente dalla gerarchia di alcuni episcopati tendono a presentarsi alla coscienza del fedele come legge apodittica, che impone decisioni uniformi nei casi concreti e domanda solo di essere tradotta in atto senza eccezioni. Citiamo, a titolo d’esempio, le Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Facilities dei vescovi americani promulgate nel 1971, relativamente alla contraccezione, alla sterilizzazione, alla masturbazione per analisi dello sperma, all’inseminazione artificiale e alla gravidanza ectopica. Simili direttive mirano a modellare la convinzione personale dei cattolici sui problemi dibattuti e a influenzare la posizione delle istituzioni sanitarie cattoliche, affinché rifiutino le pratiche condannate 10.
79
Questa morale medica insegnata dai teologi, ed elaborata talvolta anche in modo maldestro e apodittico, senza le conoscenze biomediche requisite, è stata veramente così invadente come si vuol far credere? Ci sono forti ragioni per dubitarne. Secondo una formula coniata da J.F. Malherbe, si può dire piuttosto che tra morale medica religiosa e medicina si sia instaurata una «coesistenza non interattiva». La normazione del comportamento dei medici credenti e dei fedeli cristiani è stata più velleitaria che reale. Resta tuttavia il fantasma di una morale precostituita che, dall’esterno del mondo sanitario, tenti di imporsi alla coscienza e quasi di sostituirsi ad essa, influenzandola in un senso prevaricatore. Quando si parla di etica in medicina, si alza in volo la paura di «chierici» (ideologi e funzionari di partito, oppure teologi, progressisti o integristi che siano) che vengano a dire ai sanitari che cosa devono fare in questo o quel caso. Purtroppo l’etica e la morale sono sinonimi — soprattutto in Europa, terra di inveterati conflitti ideologici — di intolleranza. Evocano il tentativo di imporre agli altri la propria visione, di tracciare sentieri obbligati per la verità, di eliminare il pluralismo e le divergenze. Ciò induce persone di buona volontà, e tutt’altro che «immoralisti», a respingere l’etica dall’ambito della medicina.
Prima di acquistare il diritto di cittadinanza nella sanità l’etica deve liberarsi dai sospetti che gravano su di essa. Quest’opera di depurazione è obiettivamente più difficile nel contesto della tradizione culturale del nostro paese, in cui pluralismo e tolleranza
80
non sono mai stati valori coesivi nella vita sociale. Sarà accettata solo un’etica che non equivalga a indottrinamento; che non sostituisca le regole della coscienza; che metta in pieno valore i soggetti: tanto il malato in quanto soggetto che riceve il servizio terapeutico, quanto il sanitario che lo fornisce.
4. Un’etica della responsabilità in medicina
L’appello all’etica viene fatto oggi per lo più in situazioni che si presentano sotto il segno dell’eccezionalità e dell’urgenza, e sono inoltre fortemente cariche di emotività. Si sente il bisogno di interrogarsi dove sta andando la medicina solo in occasione di casi clamorosi che arrivano sulle prime pagine dei giornali: la lotta dei genitori di Karen Quinlan per ottenere la sospensione del trattamento rianimatorio; il trapianto del cuore di babuino a Baby Fae; Kim Cotton e l’affitto del suo utero per dare un figlio a un’altra donna; il trapianto di un cuore artificiale; il dott. Hackethal che mostra il filmato dell’aiuto offerto a una paziente cancerosa per mettere fine alla propria vita; lo scandalo, vero o presunto, dell’utilizzazione dei feti per fabbricare cosmetici; la notizia della creazione di una «pillola di fine ciclo»... In queste e in analoghe circostanze viene invocata l’etica, quasi a porre dei limiti a una medicina che si inebria dei suoi successi e amplia sempre più gli interventi sull’inizio e la fine della vita, dimenticando i confini del lecito e dell’illecito. Questa è una funzione dell’etica medica che pur è necessaria. Considereremo in particolare l’utilità che possono avere i comitati etici per portare chiarezza in tali situazioni problematiche ed eccezionali. Tuttavia questo è un modo riduttivo di considerare
81
il contributo che può offrire l’etica per una medicina più umana.
Un punto di partenza più radicale per affrontare la questione etica in medicina è quello costituito dal rapporto fra medico e paziente, che sostiene la struttura della medicina scientifica. Questo rapporto è andato sempre più caratterizzandosi come una trasmissione di responsabilità al medico. I casi tipici di dilemmi etici (dire o non dire la verità al malato grave? fare ancora un estremo tentativo disperato o lasciare che il morente concluda in pace la sua vita? intervenire chirurgicamente su un neonato malformato, dandogli così delle possibilità di sopravvivere, oppure lasciare che la natura faccia il suo corso?) non fanno che acuire e rendere più evidente una modalità di strutturare la relazione terapeutica che sottende la prassi medica anche più quotidiana e banale. Il modello che prevale in medicina prevede uno spostamento di tutto il sapere e il potere, e quindi della responsabilità, sul medico, mentre al malato non resta che la docile passività.
Il presupposto implicito di ogni azione sanitaria è che solo l’esperto — vale a dire il medico che ha ricevuto la formazione accademica ed è stato abilitato all’esercizio della professione con esame di Stato; naturalmente tanto più esperto se ha acquisito dei diplomi di specializzazione! — sa spiegare la malattia, mentre il malato è all’oscuro di ciò che sta avvenendo in lui. Inoltre quest’ultimo non ha praticamente rapporto con la propria malattia, né con la propria salute. Se cade malato, è perché diventa «vittima» di un capriccio della natura, di un germe patogeno, oppure di un programma genetico sbagliato... Anche la guarigione, in questa prospettiva, è qualcosa che avviene al di fuori della persona del malato. Essa va attribuita al medico che ha fatto la diagnosi giusta,
82
o ha prescritto l’antibiotico appropriato, o al chirurgo che ha fatto l’intervento necessario. Il solo contributo richiesto al malato per la propria guarigione è di attenersi alle prescrizioni del medico e di non intralciare la sua opera. L’azione sanitaria è tutta rivolta all’eliminazione del disturbo: quando ciò avviene, l’individuo torna in salute. La malattia? Un inutile incidente! In questa concezione tutto ha una sua coerenza interna: «La medicina diventa una scienza degli errori, la clinica un’officina per le riparazioni, la tecnica lo strumento per eliminare i disturbi, l’obiettivo da raggiungere uno stato ideale» 11.
Questa descrizione lapidaria è di Viktor von Weizsäcker, un medico clinico che ha molto riflettuto sulle conseguenze dell’eliminazione del soggetto dalla medicina concepita come scienza della natura. Evacuando il soggetto si è persa contemporaneamente la possibilità di dare un senso personale alla malattia. Lo stesso von Weizsäcker parla di una «posizione Es» (Es-Stellung) nei confronti della malattia: essa è un non-Io, qualcosa di spiacevole che capita, che aggredisce l’organismo dall’esterno, senza un reale rapporto col soggetto. In questa concezione della malattia viene privilegiato l’aspetto oggettivo-razionale. Al polo opposto troviamo la «posizione Io» (Ich-Stellung), che si realizza quando il malato accetta di essere il soggetto «strutturante», tanto della propria malattia quanto della propria salute 12. Quando la malattia è assunta nell’io, non ci troviamo più nell’ambito dell’«essere» e «non essere», bensì del «poter essere», «dover essere»..., cioè di quelle categorie che sono il fondamento dell’esistenza etica. La malattia diventa allora un elemento costitutivo di una particolare
83
biografia, nella sua unicità e irripetibilità. Anche nella malattia si manifesta in questo modo la tensione dell’ambivalenza che è propria della nostra esistenza umana. La mia malattia non la ricevo e non l’ho solamente, ma la faccio e la strutturo anche; non solo la sopporto e voglio eliminarla, ma ne ho anche bisogno e la desidero; non «ho» solamente una malattia, ma «sono» anche la mia malattia.
La teoria e la prassi della medicina adottano esclusivamente la «posizione Es», allontanando cioè la medicina dal soggetto. Chi si scopre un disturbo che intralcia il proprio benessere, si aspetta dal medico che glielo elimini; e il medico attende da se stesso la capacità di togliere al malato la sua malattia. È giusto gettare esclusivamente sui medici la colpa di questa voluta cecità nei confronti del significato personale della malattia e del sintomo? È frequente l’accusa rivolta loro di preferire il galleggiamento su acque basse, piuttosto che il tuffo in profondità. Ed è vero che per lo più i medici rispondono con sufficienza o ironia a ogni invito a considerare la loro opera come rivolta al malato, piuttosto che alla malattia. La resistenza dei medici ad accettare il soggetto è tuttavia solo una parte della verità. L’altra metà del fallimento di ogni programma di rendere umana la malattia va attribuita ai malati stessi. Sono essi che vogliono semplicemente liberarsi di un sintomo e non scendere fino alle radici della malattia, là dove si incontra la propria partecipazione all’essere malato e dove si è chiamati ad assumere la propria responsabilità nei confronti sia della malattia che della guarigione. Mentre il medico seduce il malato con la spiegazione «scientifica» della malattia, il malato esercita una seduzione sul medico perché gli risparmi un confronto personale con se stesso e gli faccia percorrere la strada che offre una minore resistenza. La seduzione è
84
dunque reciproca. L’opposizione a interpretare psicologicamente la malattia va considerata piuttosto come il risultato di una collusione tra il medico e il paziente. I medici si comportano da medici perché tanti pazienti desiderano rinunciare alla loro responsabilità per la propria salute.
Questa prospettiva integra e corregge quella troppo polemica di Ivan Illich, che attribuisce ai medici tutta la colpa di quel fenomeno che egli ha chiamato «espropriazione della salute». Se si tiene presente la volontà di delega e spersonalizzazione del vissuto che parte dal malato, si può sottoscrivere l’analisi di Illich: «La negazione della salute da parte della medicina ha inizio quando l’impresa medica distrugge nella gente la volontà di soffrire la propria condizione reale. [...] La medicina organizzata professionalmente è venuta assumendo la funzione di un’impresa morale dispotica tutta tesa a propagandare l’espansione industriale come una guerra contro ogni sofferenza. Ha così minato la capacità degli individui di far fronte alla propria realtà, di esprimere propri valori e di accettare il dolore e la menomazione inevitabili e spesso irrimediabili, la decadenza e la morte» 13.
Il compito fondamentale dell’etica è quello di ripensare la pratica stessa della medicina nell’orizzonte delle esigenze dell’uomo intero, e non mutilato o diminuito. Solo a questa condizione la medicina non diventa luogo di «maltrattamenti». Le operazioni chirurgiche inutili, le cure sbagliate, i disagi gratuiti a cui sono sottoposti i pazienti negli ospedali, sono so lo alcuni dei maltrattamenti: quelli più clamorosi. Ma ne esistono anche altri; non così evidenti ma non per questo meno perniciosi. I malati vengono «maltrattati» quando la medicina si occupa di loro in modo
85
che non corrisponde ai loro veri bisogni 14. Il dibattito sull’umanizzazione della medicina raggiunge il suo baricentro quando si spinge a individuare le esigenze umane che sono disattese dalla medicina corrente e dalla concreta organizzazione sanitaria delle cure, per rivendicarle in nome di una «medicina dell’uomo». E ciò anche quando la rinuncia sia fatta con l’approvazione e la connivenza del malato. La medicina cambia aspetto se fa suo il programma di Saint-John Perse: «Et si un homme auprès de vous vient à manquer à son visage de vivant, qu’on lui tienne de force la face dans le vent».
L’amputazione esistenziale di una parte dell’essere umano è il rischio intrinseco dell’atto medico; e talvolta è richiesta dal malato stesso. L’etica della responsabilità domanda che ciascuno faccia la sua parte. La parte del malato è di appropriarsi della «sua» malattia, condizione per diventare protagonista della «sua» guarigione. La parte del medico non è di guarire il malato: solo questi lo può fare. Il malato può intendere la guarigione come semplice eliminazione di un sintomo, oppure, più profondamente, come crisi biografica che gli permette di diventare se stesso. Il medico che agisce entro i limiti della propria responsabilità non sovrappone i suoi fini a quelli del malato; si tiene quindi lontano da ogni forma di «accanimento terapeutico». Quando medico e malato smettono di raccontarsi la favola che è il medico a procurare la salute al malato, cessano anche di vivere secondo le aspettative l’uno dell’altro. Il paziente può completare la sua parte, facendo della malattia un’esperienza di apprendimento, che può anche trasformare la vita. E il medico porta a termine la sua, senza pretese di grandiosità, senza paludamenti missionari
86
o filantropici, nell’umile grandezza di un’arte tecnica che ha per soggetto l’uomo. Dall’etica, con la sua esigenza di responsabilità, viene quindi il principale impulso a costituire una scienza medica come scienza del soggetto.
5. Uno strumento operativo: i comitati etici
Dall’etica ci attendiamo un decisivo contributo perché all’azione sanitaria venga riconosciuto tutto lo spessore che le compete, in quanto atto che intercorre tra soggetti responsabili. Oltre a questo compito di fondo, essa non può sottrarsi a quello, più limitato e contingente, di intervenire in modo casistico quando, di fronte a situazioni nuove o eccezionali, sanitari fanno appello ad altri lumi, al di là di quelli del proprio sapere tecnico e magari della deontologia professionale. L’apporto dei singoli cultori dell’etica medica è ovviamente indispensabile. Ma sempre più oggi, in clima di pluralismo e in assenza di magisteri etici che raccolgano l’unanimità dei consensi, si vede come via praticabile quella dei comitati etici.
Un autorevole impulso alla formazione di comitati etici è venuto dagli organismi ufficiali, creati per chiarire i problemi sollevati dalla medicina contemporanea. La Commissione presidenziale americana in uno dei rapporti pubblicati — quello relativo al prolungamento delle cure ai malati terminali — caldeggia la formazione e l’utilizzazione di comitati etici nell’ambito degli ospedali, per venire incontro ai processi decisionali di tali situazioni. Né la legge penale, né quella civile, secondo il documento, precludono la mutua consultazione di sanitari, pazienti e loro familiari, per prendere le decisioni relative al malato terminale. Una particolare attenzione deve essere prestata
87
al processo decisionale, quando sono coinvolti pazienti non in grado di decidere per se stessi o neonati con gravi malformazioni. In questi casi l’apporto di un comitato etico può essere considerato quasi indispensabile 15.
Indicazioni analoghe provengono dal «Comitato consultivo nazionale di etica per le scienze della vita e della salute», stabilito in Francia. Già nel suo primo parere sul prelievo dei tessuti di embrioni o di feti umani morti si consiglia che i poteri pubblici limitino l’utilizzazione terapeutica o scientifica alle istituzioni sanitarie che siano dotate di un comitato etico. Intervenendo successivamente sulla questione della sperimentazione dei farmaci sull’uomo, lo stesso Comitato suggerisce che la Francia dovrebbe dotarsi di una rete di comitati etici, ripartiti sull’insieme del territorio e coordinati dal Comitato nazionale, al cui parere bisognerebbe obbligatoriamente ricorrere nel caso di sperimentazioni condotte su soggetti sani; al Comitato nazionale spetterebbe il ruolo di struttura di appello in caso di difficoltà particolari.
In America i comitati etici hanno cominciato ad essere istituiti fin dalla fine degli anni 70. Un forte impulso alla loro costituzione è venuto dai pubblici dibattiti sul caso di Karen Quinlan: né la legge, né la deontologia professionale fornivano direttive soddisfacenti; neppure il buon senso o «senso comune» indicava se fosse più umano continuare il prolungamento artificiale della vita vegetativa o arrestarlo. Si è sentita la necessità di un’istanza non di parte, che contribuisse a frazionare il peso della decisione. Attualmente solo l’uno per cento degli ospedali americani
88
ha in funzione un comitato etico, con una forte prevalenza degli ospedali cattolici, nei quali esistono circa il quaranta per cento dei comitati etici istituiti.
Se molti ospedali sono ancora riluttanti a formare comitati ciò va attribuito principalmente al timore che tale strumento serva ad accrescere il contenzioso tra classe medica e utenti dei servizi sanitari. La finalità dei comitati è, al contrario, quella di favorire un dialogo e una comprensione. La loro struttura opera in tal senso. Tali corpi consultivi sono costituiti da medici, personale amministrativo degli ospedali, pazienti e loro familiari. Sono chiamati a non prendere decisioni, ma a esprimere un loro parere su questioni in cui emergono considerazioni di valori umani o di etica. Possono eventualmente stabilire delle linee comuni da seguire in occasione di certe decisioni mediche cruciali.
I primi beneficiari del lavoro dei comitati etici sono i pazienti stessi. Dal confronto dei diversi punti di vista può derivare una chiarificazione della prognosi e un esame spassionato delle possibili alternative. I pazienti ricevono inoltre un sostegno psicologico, che si estende anche ai loro familiari. Non ultimi si avvantaggiano dei comitati etici i sanitari stessi, che sono messi in grado di condividere con altri il peso di alcune gravi decisioni e di avvicinarsi verso una maggiore obiettività, dal momento che nel comitato si esprimono orientamenti di valore più ampi rispetto a quelli che predominano nel mondo medico.
NOTE
1 «Practice of Medicine and Surgery», nella New Encycl. Britannica, vol. XI, p. 847.
2 Savatier, «Déontologie», in Encyclopaedia Universalis, Paris 1971, vol. V, pp. 436-439.
3 Cfr. Documenti di deontologia ed etica medica, a cura di S. Spinsanti, ed. Paoline, Milano 1985.
4 È la posizione rappresentata da M. Barni - G.A. Norelli, «L’insegnamento dei diritti dell’uomo: tra etica e deontologia medica», in Federazione Medica XXXVII (1984), n. 1, pp. 83-85. Trattandosi di una relazione ufficiale alla XXXV Assemblea Medica Mondiale, nella giornata di studio dedicata all’etica medica (Venezia, 28 ottobre 1983), la posizione può essere considerata rappresentativa del mondo medico italiano. La tesi sostenuta è che, essendo la deontologia la disciplina di quanto realizza un dovere per il medico, «anche i principi che si ispirano all’etica e alla morale medica devono essere in essa ricompresi»; alla deontologia va ricondotto «ogni argomento che ispiri ed obblighi un “giusto” comportamento professionale». La preoccupazione concreta che trapela dietro la difesa della portata onnicomprensiva della deontologia è quella che non venga introdotto un insegnamento autonomo dell’etica medica, accanto a quello della medicina legale: «È alla medicina legale, in estrema sintesi, che spetta il compito di insegnare la deontologia medica, e quindi l’etica medica che in essa si esprime».
5 Una completa rassegna della diffusione dell’insegnamento dell’etica medica negli Stati Uniti si può trovare in E.D. Pellegrino - Th.K. McElhinney, Teaching Ethics, the humanities, and human values in medical scbools: A tenyears overview, Washington 1984.
6 La definizione è contenuta nell’introduzione, p. XIX, del vol. dell’Encyclopaedia of Bioethics, Washington 1978.
7 Un lucido contributo in questo senso è stato offerto dal cardinale C.M. Martini con la sua relazione su «Tecnologie biomediche e giustizia sociale», tenuta in occasione del convegno «Milanomedicina» (novembre 1984). Oggi diventiamo sempre più consapevoli che il maggior incremento della salute deriva dalla lotta contro la povertà e da una migliore distribuzione della ricchezza, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita; ovvero — nei termini classici della morale sociale cattolica — dalla giustizia sociale che promuove il bene comune. Invece le nostre politiche sanitarie sembrano accecate dalla convinzione che una migliore salute si ottiene investendo in tecnologie sempre più sofisticate. Nella realtà dei fatti le abitudini di vita annullano i vantaggi del progresso scientifico. Compito dell’etica non è quello, riduttivo, di far cadere condanne morali su questa o quella pratica medica. Essa deve, piuttosto, dare un contributo per instaurare una nuova cultura economica, un nuovo stile di vita, un nuovo senso della comunità. Nella prospettiva del card. Martini la trasformazione si riassume nel passaggio dall'homo consumans all’homo serviens. Etica e umanizzazione, in definitiva, vengono a coincidere.
8 Da inchieste condotte in diversi paesi risulta che tra gli studenti di medicina l’emorragia di idealismo lungo il strada della formazione è più vistosa che altrove: «All’inizio dei suoi studi lo studente si sente ancora chiamato ad aiutare l’ammalato, ma alla loro conclusione è diventato uno che raramente, come nessun membro di altri gruppi studenteschi, nutre pensieri di preoccupazione per gli altri uomini» (H. Küng, Vita eterna?, Milano 1983).
9 Di particolare importanza per il costituirsi della morale medica cattolica è stato il magistero di Pio XII. I suoi principali interventi sono raccolti nel volume Pio XII: Discorsi ai medici, Roma, 1963. Praticamente tutti i punti nevralgici della morale medica del tempo sono stati trattati da Pio XII: il valore e l’inviolabilità della vita umana in riferimento all’aborto, alla contraccezione e alla sessualità coniugale; la fecondazione artificiale; la sterilizzazione; i limiti nella ricerca e nella sperimentazione sull’uomo; la chirurgia in rapporto alle mutilazioni anatomiche e funzionali; la rianimazione e i problemi dell’analgesia; il parto indolore; problemi etici della neuropsicofarmacologia; principi di morale applicati alla psicoterapia.
10 «Queste direttive proibiscono quei procedimenti che, allo stato attuale delle conoscenze, sono riconosciuti come chiaramente erronei. I valori morali assoluti di fondo che queste direttive sottolineano non sono soggetti a cambiamenti, benché possano essere modificate dalle particolari applicazioni nella misura in cui la ricerca scientifica e lo sviluppo teologico schiudono nuovi problemi o gettano una nuova luce su quelli vecchi»: il preambolo delle direttive statunitensi riflette un approccio della problematica medico-morale secondo cui le decisioni mediche sono una diretta applicazione delle norme morali ecclesiastiche, ed escludono il pluralismo. Per un esame critico, con un utile raffronto con l’approccio diverso che contraddistingue la Guida medico-morale dei vescovi canadesi del 1970, cfr. B. Häring, «Religious Directives in medical Ethics, Roman Catholic Directives», in Enc. of bioethics, IV, 1431-1435.
11 V. von Weizsäcker, Pathosophie, Göttingen 1967, p. 346.
12 Cfr. V. von Weizsäcker, Der kranke Mensch, Stuttgart 1951, p. 352.
13 I. Illich, Nemesi medica, Milano 1976, p. 139s.
14 Cfr. P. Solignac, Ces malades mal-traìtés, Paris 1981.
15 U.S. President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research; Deciding to forego Life-sustaining Treatment: Ethical, Medical, and Legal Issues in Treatment Decisions, Washington 1983.